Il mondo oggi ha bisogno di Testimoni di fede ( parte2)

"E' tra il tempo e l'infinito, metatemporale e non ancora eterno, che sta la mistica e sta la poesia"
Adriana Zarri
Uno speciale percorso.. attraverso lo sguardo di donne e uomini cogliendo la grazia che ha illuminato la loro esistenza facendone ragione di vita, dono per gli altri e una proposta di vita per tutti noi!
Perché dovrei desiderare di vedere Dio meglio di quanto non lo veda oggi?
Vedo qualcosa di Dio in ogni ora delle ventiquattro, in ogni momento di esse,
nei volti di uomini e donne vedo Dio, e nel mio volto riflesso allo specchio,
trovo lettere inviate da Dio per le strade, ognuna firmata col nome d’Iddio,
e le lascio dove si trovano, perché so che, ovunque mi rechi,
altre puntuali verranno, per sempre e per sempre.
W.Whitman

Clemente Rebora..inquieto cantore del senso religioso
CURRICULUM VITAE
Per Te, con Te, in Te, Gesù, ch’io veda
il Padre: e coi fratelli: un cuore solo;
sii Tu, Spirito, l’ultimo respiro.
Clemente Rebora

POESIA E SANTITÀ
Mentre il creato ascende in Cristo al Padre,
nell’arcana sorte
tutto è doglia del parto:
quanto morir perché la vita nasca!
pur da una Madre sola, che è divina,
alla luce si vien felicemente:
vita che l’amor produce in pianto,
e, se anela, quaggiù è poesia;
ma santità soltanto compie il canto
Clemente Rebora

Mentre lavoro nei miei giorni scarsi,
Mi pare deva echeggiar imminente
Una gran voce chiamando: Clemente!
Per un’umana impresa ch’è da farsi...
E perché temo che risuoni quella
Quando dai miei fratelli io fossi assente,
Monto, senza sostar, di sentinella
Nel cuor disposto a servire la gente.
Clemente Rebora

Fra trilli d’uccelli e fremiti e fruscii:
fresca appare la quiete del verde:
al Creatore amante tutto s’intona.
O Gesù, aver sete,
anelarti così!
O anima, alla grazia
del Suo amor che si dona,
così, anima, indiata, ringrazia.
Clemente Rebora
E doni amor onde chi ama è nato
a quella vita che in morir s’espande.
Clemente Rebora

“Tra gli autori che testimoniano in versi il tormento profondo dell’uomo alienato ed esposto all’angoscia delle estreme domande esistenziali, Clemente Rebora è colui che più di tutti ha trasfuso in poesia esistenzialità e moralità, disperazione e speranza, rifiuto dell’esistente e ansia di assoluto, fino a costruire il più autentico monumento di poetica espressionistica della nostra letteratura primonovecentesca”. Descrive così il sacerdote rosminiano e poeta citato oggi da Papa Francesco nella catechesi che ha preceduto il Regina Caeli, Elio Gioanola, critico letterario e scrittore, che ha insegnato per trent’anni Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere dell’Università di Genova.
Negli anni ’30, prima della conversione che lo portò al sacerdozio e ad un’intenso ministero di direzione spirituale (Padre Pio gli inviava quanti andavano a S. Giovanni Rotondo dal Nord Italia, perchè poi fosse lui a seguirli nel cammino di fede), Rebora, rampollo di una famiglia anticlericale (il papà aveva seguito Garibaldi a Mentana) era stato un intellettuale inquieto ma unanimemente stimato: i sui scritti comparivano su importanti riviste fra cui “la Voce”; nel 1913 pubblicò “Frammenti lirici” e nel 1922 “Canti anonimi”, dopo l’esperienza come combattente nella Prima guerra mondiale, che lo aveva segnato ingenerando in lui il rifiuto di ogni violenza e sporaffazione. Traduceva inoltre opere di grande interesse letterario, soprattutto dal russo, lingua che condivideva in quegli anni con la sua compagna Lidya Natus, un’artista ebrea russa.
E proprio alla sua inquietudine esistenziale si riferiscono le parole della sua autobiografia in versi “Curriculum vitae” rilette oggi da Papa Francesco: “E la Parola zittì chiacchiere mie!”.
“La Parola di Dio – ha commentato il Pontefice – zittisce le nostre chiacchiere superficiali e ci fa dire parole serie, parole belle, parole gioiose. Ascoltare la Parola di Dio fa tacere le chiacchiere. Ecco come dare spazio in noi alla voce dello Spirito Santo. E poi nell’Adorazione – non dimentichiamo la preghiera di adorazione in silenzio – specialmente quella semplice, silenziosa, come è l’adorazione. E lì dire dentro di noi parole buone, dirle al cuore per poterle dire agli altri, dopo, gli uni per gli altri. E così si vede che vengono dalla voce del Consolatore, dello Spirito”.
Nel suo cammino di conversione, nell’immediato dopoguerra torna all’insegnamento, optando per le scuole serali, frequentate da operai: da quel popolo semplice che egli, con slancio umanitario, ama. Si autoimpone un regime di vita molto austero, devolvendo gran parte dello stipendio ai poveri e spesso ospitandoli in casa. Appare a molti come una specie di santo laico, ma in realtà, “l’ignorato Battesimo operando”, egli è sempre più attratto dalla religione. Lo si evince anche dai Canti anonimi: il suo secondo libro di poesia, del 1922.
Nella stessa direzione va la sua iniziativa editoriale: I sedici Libretti di vita attraverso cui divulga opere di mistica occidentale e orientale (e su tali argomenti è anche apprezzato conferenziere).
Sono questi, diversi segnali che preludono all’approdo: la conversione al cattolicesimo, nel 1929. Decisiva è per lui la figura dei card. Schuster, da cui riceve il sacramento della Cresima. Rebora adesso capisce che la via alla totalità passa attraverso la sequela di un carisma particolare: nel suo caso è quello rosminiano, con il “voto di annullamento” – perdersi per ritrovarsi -, con la mistica prospettiva di “patire e morire oscuramente scomparendo polverizzato nell’amore di Dio”.
Nell’opera “Curriculum vitae” il poeta, ormai anziano, ricorderà Rosmini come il maestro cui filialmente si era affidato, forma attraverso la quale la novità di Cristo aveva investito e cambiato la sua persona: “l’ossa slogate trovaron lor posto, scoprì l’intelligenza il primo dono, come luce per l’occhio operò il Verbo, quasi aria al respiro il Suo perdono”.
“Care sorelle e fratelli – ha riassunto Papa Francesco – leggere e meditare il Vangelo, pregare in silenzio, dire parole buone, non sono cose difficili, no, le possiamo fare tutti. Sono più facili che insultare, arrabbiarsi… E allora ci chiediamo: che posto hanno queste parole nella mia vita? Come posso coltivarle, per mettermi meglio in ascolto dello Spirito Santo, e diventarne un’eco per gli altri? Maria, presente a Pentecoste con gli Apostoli, ci renda docili alla voce dello Spirito Santo”.
Sante Cavalleri
Mario Luzi..servitore della parola


Infine crolla
su se medesimo il discorso,
si sbriciola tutto
in un miscuglio
di suoni, in un brusio.
Da cui
pazientemente
emerge detto
il non dicibile
tuo nome. Poi il silenzio,
quel silenzio si dice è la Tua voce
Mario Luzi

Amici dalla barca si vede il mondo
e in lui una verità che procede
intrepida, un sospiro profondo
dalle foci alle sorgenti;
la Madonna dagli occhi trasparenti
scende adagio incontro ai morenti,
raccoglie il cumulo della vita, i dolori
le voglie segrete da anni sulla faccia inumidita.
Le ragazze alla finestra annerita
con lo sguardo verso i monti
non sanno finire d’aspettare l’avvenire.
Nelle stanze la voce materna
senza origine, senza profondità s’alterna
col silenzio della terra, è bella
e tutto par nato da quella
Mario Luzi

Come un risveglio a noi stessi illumina la parola
In Luzi la parola accade. Come in un risveglio apre lo sguardo al mondo e a noi stessi. Illumina questo scomposto agitarsi di ombre, questa frenetica danza di immagini, questo vuoto chiacchiericcio a perdere. La poesia di Mario Luzi viene dal silenzio e nel silenzio ritorna. Non aggiunge, sottrae: via la superficie, via l’ansia, via il sotto, via il sopra. In questo sottrarre, in questo farsi necessaria, unica, gravida, la parola libera. Torna a essere viva. Di più: a essere vita. E genera. Come la più bella e la più buona delle madri.
Mario Luzi non era un maestro della parola. Era un servitore della Parola. L’amava profondamente. E viveva con lei e per lei quasi eremita inebriato di bellezza, tra il Lungarno di Firenze, la città della vita, e la Val d’Orcia, il paesaggio prediletto. «Un eremita che però apriva la porta a tutti, in particolare ai giovani», ricorda con affetto l’amico e segretario Nino Petreni. Amava l’essenziale fino alla privazione. Nella casa di Pienza, dove trascorreva tutte le sue estati, possedeva solo due pentole. Sapeva che l’abbondanza rende ciechi e la comodità ci fa sordi. La rinuncia è la porta stretta, quella che apre alla bellezza dell’anima, alla sapienza del giudizio, all’amicizia vera. E in questo rinunciare alle cose, e insieme essere radicato al reale e al vero, c’è lo stile di una vita.

L'Italia celebra il grande poeta, nato cento anni fa. Dalle prime raccolte alla fine, indagò la complessità del mondo, la resistenza al tempo, la fragilità, il dialogo fra vita e morte. Nel 1999 Giovanni Paolo II gli chiese di scrivere i testi per la Via Crucis.
Luzi negli anni Trenta fu uno dei protagonisti dell’ermetismo fiorentino: la definizione critica allude a una poesia preziosa e sonora, arcana e febbricitante, legata almeno in parte alla grande matrice del surrealismo.
È curioso che quella etichetta di ermetico gli sia rimasta attaccata tanto a lungo, quasi come una categoria esaustiva. Curioso perché Luzi, come del resto i due compagni di strada citati, Bigongiari e Parronchi, ebbe modo di compiere un lunghissimo viaggio poetico, che lo portò a riattivare zone della tradizione e possibilità espressive ben lontane da quell’originaria esperienza. Essa, del resto, non è priva di fascino, né di interesse, abbeverandosi attraverso Leopardi anche al grande filone lirico della nostra poesia.
Del resto, nel libro dell’esordio di Luzi, La barca (1935), c’è già, accanto alla preziosità aerea di vari testi, qualche germe del futuro discorso di Luzi, del suo ragionare sulla complessità del mondo inteso come cosmo in divenire. Penso alla poesia più programmatica del libro, Alla vita, in cui si legge ad esempio: «Amici dalla barca si vede il mondo / e in lui una verità che procede / intrepida, un sospiro profondo / dalle foci alle sorgenti; / […]». Vero è, ad ogni modo, che nella Barca e nel seguente Avvento notturno (1940) prevalgono figure sparenti di giovinette («le fanciulle finitime dell’ombra»), il motivo della fragilità, il «dolore della giovinezza».
Più avanti, nel dopoguerra, Luzi avrebbe impugnato questi motivi, in particolare quello dell’evanescenza della vita, in raccolte impegnate a ridefinire lo statuto del poeta e della poesia. Il processo ha un primo compimento in una raccolta rocciosa e severa come Onore del vero (1957), titolo parlante come tanti altri del poeta. Qui si propone, dopo raccolte in qualche modo di transizione come Un brindisi (1946), Quaderno gotico (1947) e soprattutto Primizie del deserto (1952), una sorta di sorda resistenza all’onda del tempo, di sospensione sopra l’abisso, di tenacia nell’aderire al compito dell’essere nel mondo («[…] è qui / non altrove che deve farsi luce»).
È un libro a suo modo eloquente, scandito, che si fissa nella memoria con le sue iterazioni, le sue formule. Ma – si potrebbe dire – non è che l’inizio di un’altra lunga ‘giornata di lavoro’. Seguono due libri entrambi decisivi: Nel magma, che esce in prima edizione alla fine del 1963, e Dal fondo delle campagne, che va a stampa nel 1965, pur essendo cronologicamente antecedente.
In Dal fondo delle campagne importa soprattutto, ed ha un ruolo essenziale nella stessa poetica luziana, la sezione ispirata alla morte dell’amatissima madre Margherita (avvenuta nel 1959). La sezione, intitolata Morte cristiana, contiene un testo in cui il poeta chiarisce la direzione della propria ricerca, proseguendo quanto intrapreso in Onore del vero. Si tratta di Il duro filamento: alla scomparsa, all’evocazione di un altrove, al delirio della perdita, il poeta contrappone in qualche modo l’operante comunione di vivi e morti, la coscienza del compito della vita nella sua trama e continuità, nel suo senso complessivo («[…] Solo / la parola all’unisono di vivi / e morti, la vivente comunione / di tempo e eternità vale a recidere / il duro filamento d’elegia. / È arduo. Tutto l’altro è troppo ottuso»).
D’altra parte, la raccolta Nel magma, che non a caso viene pubblicata per prima, quasi a segnare l’urgenza del suo nuovo dettato, irrompe con la forza di una rivelazione nel laboratorio del poeta. È questo il libro di più forte rottura nella carriera di Luzi: qui si scardina la stessa predominanza dell’“io” poetico, che diventa uno dei personaggi del dramma, del «magma» del reale. È chiara in questa acquisizione l’impronta della Commedia dantesca (lo stesso Luzi fin dal 1946, nel saggio L’inferno e il limbo, aveva riflettuto sull’opposizione tra una linea petrarchesca ed una dantesca): gli incontri, i dialoghi e le schermaglie con personaggi appartenenti alla biografia del personaggio-poeta sono modellati sulla falsariga degli incontri con le anime dell’aldilà dantesco. Ciò significa anche che da una parte Luzi amplia l’orizzonte del poetabile, ambientando le scene di alcuni testi in luoghi quotidiani come un caffè, un ufficio, l’abitacolo di un automobile, con una lingua a tratti aperta all’uso e depressa, ma dall’altra trasporta queste scene sul piano di una epifania.
Sono testi dialogici e narrativi, che sembrano svolgersi qui e ora e al tempo stesso in un luogo assoluto, quasi fossero schegge purgatoriali (cito da Nel caffè, che registra l’incontro con un personaggio «forato nella gola», il quale da una zona liminare tra vita e oltretempo illumina il poeta e allarga il suo orizzonte: «“So quel che pensi, eppure hai torto” dice / con un sorriso divenuto blando / mentre guarda fuori, mentre l’ora si fa tarda, / “non posso non sentire in questo scalpiccio un che di santo.” / E frattanto penso con un brivido / a noi quando saremo sull’uscita / sul punto di dirci addio sotto la pioggia / e sotto il pigolio degli uccelli tramato fitto»).
La scoperta del dialogo, dell’alterco porta Luzi verso il teatro di parola (Ipazia, il primo dramma pubblicato, esce all’inizio degli anni Settanta); d’altronde la messa in luce di una verità che procede e matura dentro la contrapposizione e attraverso il suo superamento spalanca il poeta a una nuova possibilità di conoscenza: non più asseverazione, rigida contrapposizione di opposti, ma tensione, inclusione dinamica. Muovendo da qui Luzi elabora i tre poemi di Su fondamenti invisibili: tema e punto di fuga della poesia è non il dramma individuale, ma quello cosmico, la vicenda complessiva del creato, dell’essere. È l’inizio di una nuova ascesa verticale nell’opera di Luzi, che attraverso divisioni e tormenti tenta di risalire all’unità divina del mondo. Passando per continue interrogazioni (si pensi al titolo del libro del 1978, Al fuoco della controversia), il poeta scopre l’indivisa matrice dell’essere, che è e insieme diviene, rivelandosi nella metamorfosi e nella promessa di un compimento pieno.
Poesia filosofica, certo, ma preoccupata di non vanificare l’umano, la sostanza e il calore del creato: è l’epoca di titoli ultimi e magnanimi come Per il battesimo dei nostri frammenti (1985), Frasi e incisi di un canto salutare (1990), Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini (1994), tutti rifluiti in L’opera poetica, curata da Stefano Verdino per i “Meridiani” Mondadori nel 1998. I titoli seguenti, Sotto specie umana (1999), Dottrina dell’estremo principiante (2004) e il postumo Lasciami, non trattenermi (2009), sono stati da poco riuniti nel volume di Garzanti, ugualmente a cura di Verdino, Poesie ultime e ritrovate, che comprende anche i 32 inediti risalenti all’epoca della Barca (pubblicati per la prima volta nel 2003) e varie poesie disperse.
Il discorso di Luzi arriva in questi libri culminanti del suo percorso a una inedita altezza conoscitiva, raggiunta attraverso strumenti formali e metrici che cooperano alla liberazione di una parola plenaria, in cerca della totalità del senso, della risalita dalle foci alle sorgenti, come suggeriva l’antica poesia della Barca. Dal 1978 Luzi trascorre le estati a Pienza, dove conosce, attraverso l’amico Leone Piccioni, don Fernaldo Flori: nato nel 1915, Flori coltiva una intensa riflessione teologica e poetica che si incontra con quella luziana. Mario gli dedica tra l’altro (Flori sarebbe morto nel 1996) una poesia di Frasi e incisi di un canto salutare, intitolata (Église), che recita: «Alta, lei. Alta / sopra di sé. / Scavata / in che miniera / di luminosità / quell’altezza, dico, / che la eleva – / la alza vertiginosamente // e la spiomba su se medesima / a formare la basilica, / la nostra, lasciata / al putiferio della mortalità – e che pure, / e che pure mortale non ci sembra… // […]».
Il Luzi che medita sulla Parola (la citazione sulla soglia di Per il battesimo dei nostri frammenti proviene dal Prologo del Vangelo di Giovanni) riceve da Giovanni Paolo II nel 1999 il compito di scrivere i testi per la Via Crucis al Colosseo (i componimenti tra teatrali e poetici, in cui è per lo più Cristo a parlare, vengono pubblicati con il titolo La Passione). D’altra pare la sua lunga riflessione sul senso della nazione, sulla comunità, sulla repubblica (“Muore ignominiosamente la repubblica” suona l’incipit di un testo insieme profetico e di protesta che appartiene a Al fuoco della controversia) e il suo lavoro sulla lingua italiana fanno sì che nell’autunno 2004 il Presidente Ciampi lo nomini senatore a vita. Luzi morirà pochi mesi dopo, il 28 febbraio 2005.
Don Maurizio Patriciello.." sono solo un prete di periferia"

Dalla parte degli ultimi. Dona gioia ai piccoli. E anche tu potrai gioire
Maurizio Patriciello
La nostra vita è unica e irripetibile. Farsi prossimi di chi è più indifeso e a rischio di essere scartato riempie la vita come nient'altro. E la vita che ci chiede più protezione è quella nascente
Don Maurizio Patriciello con due bambini della sua parrocchia di Caivano
Don Maurizio Patriciello con due bambini della sua parrocchia di Caivano
Maggio 2020, siamo in piena pandemia. Invitato a partecipare a una trasmissione televisiva, mi reco alla sede Rai di Napoli. Ho il permesso di viaggiare. Per la strada realizzo di essere terribilmente solo. Tutt’intorno il vuoto, il silenzio, il deserto. Come un bambino in preda al panico, piango. Procedo lentamente, guardo i palazzi muti, incolori, inespressivi. Ho paura per i miei cari, per l’Italia, per l’umanità. Penso alle stupide e feroci lotte fratricide per essere più ricchi, agli inutili e costosissimi orologi d’oro, ai conti in banca e le pellicce ad ammuffire negli armadi. In questo scenario desolante, tutto mi appare insignificante. Penso agli esseri umani. A te, a me, alla mia mamma, al tuo figliolo; al nostro vicino di casa, ai colleghi di lavoro, ai miei amici aggrediti dal Covid. Penso all’essere umano. Quando il sole si spegnerà - perché un giorno si spegnerà - le stelle nemmeno se ne accorgeranno.
Il nostro peggior nemico, contro cui non dobbiamo mai stancarci di lottare, è l’abitudine. Quello stato d’animo, cioè, che riesce a non farci meravigliare più di niente. E tutto colora di grigio, tutto fa apparire vecchio, scontato. Proviamo a pensare se, per un qualsiasi motivo, per i prossimi decenni, non dovesse nascere più un solo bambino. Che accadrebbe? Quando l’umanità andrebbe assottigliandosi, le case rimarrebbero disabitate, le industrie chiuderebbero i battenti; quando trovare un idraulico, un pizzaiolo, un dentista, un panettiere, un netturbino sarebbe un’impresa colossale; quando non ci sarebbe più un bambino da accarezzare, una badante ad accudirci, di certo cadremmo nello sconforto più totale. Fantasia? Non ci farebbe male esercitare un po’ di fantasia. E, in fondo, non ci vuole molto.
Basta fermarci, ovunque ci troviamo, pensare a noi stessi, al nostro futuro, alle persone che amiamo e dalle quali non sappiamo fare a meno. Basta riflettere sulla nostra vita e la vita di chi, come noi, ama e si aggrappa alla vita. Basterebbe poco per farci inorridire di fronte allo scempio che l’uomo fa di tanti esseri umani innocenti e indifesi.
Ho celebrato la Messa di Natale alla facoltà di scienze infermieristiche di Napoli, nell’ospedale dove anch’io ho studiato per svolgere quella professione benedetta. Ho incontrato tanti giovani pieni di entusiasmo e di buona volontà. «C’è un solo modo per svolgere al meglio la nostra professione. Ed è tanto facile trovarlo. Accudite e curate sempre l’ammalato come se fosse la persona che amate di più nella vita...», ho detto loro. Facile. Se chi, al caldo della sua dimora, protetto dal proprio esercito, sta pensando alle bombe da lanciare sul nemico questa sera - il nemico? Chi è il nemico? Perché è diventato mio nemico? - provasse a immaginare che quei disumani ordigni andrebbero a dilaniargli i figli, i genitori e la donna che ama, ci penserebbe su duecentomila volte prima di dare il diabolico ordine. «Non fare all’altro ciò che non vorresti fosse fatto a te».
Non è solo un comando divino cui obbedire, ma la più elementare forma della ragione umana. Non fargli male, potresti avere bisogno di lui e non lo troverai; non fargli male, perché poi farà del male a te; non fargli male perché, pur ridotta al minimo, c’è in te una vocina che, quando meno te lo aspetti, si farà sentire. Non credere che il volto di quei bambini straziati cadranno in oblio. Non succederà. Non è mai successo. Quelle faccine pallide e terrorizzate diverranno, durante le tue notti insonni, un incubo al quale non potrai sfuggire. E ti tormenteranno. Si confonderanno col volto del tuo nipotino, quando, davanti al caminetto acceso, ti si accoccola tra le braccia per essere accarezzato. E ti porrà domande alle quali non potrai rispondere se non facendo ricorso alla menzogna. Ma, soprattutto, si ripresenteranno con le loro faccine spente nelle ore solenni che precedono il tuo trapasso. Per la mia professione prima e la mia vocazione dopo, ho avuto modo di assistere centinaia di persone che si appressavano a lasciare questo mondo. Non ho visto mai nessuno, dico nessuno, soddisfatto per il male fatto. Gli ultimi pensieri delle donne che avevano ceduto alla tentazione di abortire è stato per quel figlio che non fecero nascere.
Ricordo quando, in carcere, incontrai Vincenzo, un assassino, ormai anziano. Quante lacrime. Quanti rimpianti. Quanti rimorsi. Che desiderio di poter ritornare indietro. « Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore», implora il salmista. Preghiera che recito anch’io, ogni giorno, a tutte le ore del giorno. Per non illudermi - inutilmente, pericolosamente - e rischiare di aver camminato invano. Dopo tante esperienze vissute, tante confessioni rese, tanti libri letti, osservazioni e studi fatti, dovremmo aver imparato a non cadere nella menzogna che la felicità, che tutti cerchiamo, abiti nell’esercitare più potere, possedere più vestiti da indossare, più case da abitare, più ori da sfoggiare. O nel moltiplicare a dismisura i piaceri che, per loro natura, hanno vita breve e che, se vissuti male, potrebbero trasformarsi nel loro esatto contrario. Pensiamo ai piaceri della buona tavola, a quelli dell’alcol, delle droghe, o ai piaceri sessuali. L’uomo è una meraviglia che per essere goduta appieno deve sapersi stupire e dei suoi simili. Ho visto Napoli deserta: era orribile. L’ho rivista nei giorni di Natale, piena di vita e di schiamazzi: era uno spettacolo. Solo l’uomo rende felice l’uomo. Lavora, impegnati, soffri per la vita e troverai la vita.
Fatti compagno del tuo prossimo e non rimarrai mai solo. Coccola, dona gioia ai bambini più poveri e umiliati e sarai a tua volta accudito e coccolato. No, non sono, e non saranno mai, le cose e il potere a riempirci il cuore, ma l’amore. «Dio è amore», afferma san Giovanni. Il che vuol dire che solo amando avremo fatto centro. Viceversa, tutto ciò che va contro l’amore: la diffidenza, l’indifferenza, la violenza, il rancore, l’odio, la sopraffazione, la prepotenza, l’invidia, la gelosia, ci scaraventa lontani da Dio, e quindi da noi stessi e dalla verità della nostra breve permanenza in questo mondo. Questa nostra vita è unica, stupenda, irripetibile, preziosa allo stesso modo di quella dei bambini che scalciano nel grembo delle mamme; come quella dei bambini dilaniati dalle bombe di queste stupide, ottuse e disastrose guerre cui, inorriditi, siamo costretti ad assistere in questi mesi.

Il racconto. C'è Dio nelle lacrime di Loredana per la sua Prima Comunione
Maurizio Patriciello
Dio parla. Quante volte lo abbiamo detto, quante volte ci abbiamo creduto davvero? Dio continua a parlare. Lo fa, però, seguendo uno stile collaudato nei secoli con tanti suoi amici, a bassa voce, con discrezione, non volendo interferire nelle nostre scelte. Aveva argione Blaise Pascal: «Dio ha messo nel mondo abbastanza luce per chi vuole credere, ma anche lasciato abbastanza ombre per chi non vuole credere». Dio vuole essere amato, ma l'amore non si impone, si dona, si sceglie, si accoglie. Tutto ciò che alla persona amata è lecito mettere in pratica, è l'antica arte della seduzione. Sedurre, farsi bella, interessante, coinvolgente, per attrarre, liberamente, l’altro a sé.
Giugno, da noi, mese delle Prime Comunioni. Momenti inenarrabili da salvaguardare, difendere dal consumismo, dalla superficialità. Eucarestia, mistero che si fa toccare. I bambini capiscono. Arrivano in chiesa di buon mattino, emozionatissimi, vestiti di bianco, con il giglio profumato in mano. Cercano sguardi, abbracci, vogliono essere rassicurati. Nei mesi trascorsi, insieme, catechisti, genitori, suore, parroci, abbiamo tentato di donare loro quello che, senza merito alcuno, ricevemmo. Certo, si può fare meglio; basta volerlo, crederci. Ben vengano le feste e i regali; i filmini, le bomboniere e il pranzo al ristorante. Tutto concorre al bene quando le cose sono fatte bene. Tutto, però, è da considerare una semplice cornice di fronte alla vera opera d'arte: l'incontro tra Gesù nascosto nel pane e i bambini di cui è gelosissimo. Per questo - e solo per questo - genitori e nonni fanno festa. Nessuno si permette di giudicare la fede di nessuno, importante, però, è lasciare spazio allo Spirito che soffia, seguendo itinerari sempre originali. Perciò occorre farsi attenti, responsabili. Domenica scorsa, anche nella nostra parrocchia, arrivano i bambini per la Prima Comunione. Insieme - come sempre - facciamo l'omelia. Qualche adulto chiacchierone viene educatamente richiamato. I veri protagonisti della celebrazione sono Gesù e i bambini. Noi adulti siamo invitati a prendere parte alla loro gioia. Lasciamogli il tempo e lo spazio necessari. Mettiamoci in ascolto. Impariamo.
Oggi, oltre a dare, siamo chiamati a ricevere. Momento culminate. Dopo la consacrazione, uno alla volta, i bambini, salgono i gradini dell'altare. Silenzio profondo. Occhi del povero prete in quelli del bambino. Sorriso rassicurante. Poi, ad alta voce: «Il corpo di Cristo». E l'intera comunità risponde con un solenne «Amen». Eccoli inginocchiati ai piedi del Tabernacolo. Li raggiungo. Un breve dialogo a bassa voce, protetti dall'altare. Dagli occhi di una bambina, grosse lacrime sgorgano incessanti. Le asciugo. So che stanno per essere raccolte negli otri del paradiso. «Loredana, sei contenta?», «Si, tanto». Loredana non singhiozza, semplicemente piange. Che cosa stia accadendo in quel cuoricino non lo saprà mai nessuno, forse nemmeno la stessa Loredana. Aguzzo lo sguardo, spalanco le orecchie. Dio parla, mi conviene ascoltare. Prego. Così: «Fa, Signore, che anch'io possa piangere ogni qualvolta che mi accingo a celebrare la Messa. Fa che possa essere sempre pronto ad asciugarle, le lacrime, ma mai - mai! - a provocarle. Soprattutto nei più piccoli, negli indifesi, nei poveri».
Fine della Messa. Una dolcezza immensa si respira per la chiesa. Poi la sorpresa, qualcuno m'invia una foto “rubata” mentre Loredana piange. Troppo bella. Che le lacrime di questa bambina possano convertire il cuore mio e quello di tanti credenti dalla fede un po’ appannata. Che possano contribuire a spegnere i micidiali fuochi dell'odio, delle gelosie, degli orgogli personali e nazionali all'origine di ogni guerra e discordia.

Vado avanti con gratitudine
Don Patriciello: «Festeggio il mio compleanno... e un anno sotto scorta»
È passato un anno. Era la notte tra l’11 e il 12 marzo quando una bomba carta fu fatta esplodere davanti al cancello della mia parrocchia, a Caivano. Un messaggio dei camorristi per dire al parroco: «Taci. Non impelagarti in cose che non ti riguardano». Non era la prima volta. «In questo quartiere - mi disse una volta un “capo” con fare minaccioso, dopo avermi fatto “sequestrare” e portare al suo cospetto - non devi mai fare riferimento alle forze dell’ordine, per qualsiasi cosa vieni a casa mia».
Chiedere al boss di tutelare la tua persona? Nemmeno a pensarlo. Un quartiere come il mio, definito “una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa” non può essere considerato un quartiere qualsiasi. Non lo è. Tutti, in particolare i bambini, gli adolescenti, i giovani, debbono sapere da che parte stanno il parroco e la comunità parrocchiale. La demarcazione con la camorra, soprattutto quella ammantata di falso e ipocrita devozionismo, deve essere netta. Senza ambiguità. La camorra vive della e nella menzogna più assoluta. È nemica giurata dell’evangelico “si si, no no”. Ai camorristi piace addirittura fare il bene. Hai bisogno di un prestito? Tuo figlio, tuo marito, in carcere, non possono permettersi l’avvocato? Non riesci a mettere il piatto a tavola o mandare i bambini a scuola? Eccoli che arrivano. Si fanno avanti. Ti aiutano.
Durante i mesi più bui della pandemia, improvvisarono addirittura una sorta di “Caritas”. Ovviamente, gli interessi da pagare dopo sono esorbitanti. Non tanto in denaro, quanto in sottomissione. Per meglio controllare il territorio. Il povero deve diventare funzionale al sistema. Deve tacere o parlare a comando. La sua casa deve essere sempre a disponibile per occultare un involucro, una valigia, una somma di denaro, una pistola, con tutti i rischi che ne seguono. Soprattutto, devono fornire la manovalanza necessaria, i figli, perché la macchina maledetta continui a funzionare. Il povero viene comprato e venduto come se fosse merce. Più è nella necessità meglio è.
Il parroco, invece? Come deve essere il parroco? Misericordioso, buono, comprensivo, generoso, sottomesso. Soprattutto deve rimanere muto nei confronti della stampa e degli inquirenti. Deve stare zitto. Non il silenzio orante del credente, ma quello omertoso del don Abbondio. Glielo ricordano in tanti modi. Se, però, è testardo e si ostina a non capire, loro calcano la mano. Come? Si inizia con le solite intimidazioni, si prosegue con le offese, le calunnie, le minacce; poi, seppure a malincuore, fanno il salto di qualità. Fanno esplodere una bomba carta alle porte della chiesa. Non in una data qualsiasi, ma la notte del suo compleanno. Dettaglio importante. Don Pino Puglisi viene ucciso la sera in cui compie 56 anni. Don Peppino Diana, la mattina del suo onomastico. Lui capisce, la paura prende il sopravvento, e tira i remi in barca. Questo il loro programma.
E, invece, non succede. Lo Stato si fa avanti e mette il parroco sotto scorta. La vita del povero prete, ancora una volta, viene stravolta. Gli sembra di stare dentro un sogno. I primi tempi sono stati duri. Poi ci si abitua. I poliziotti che si prendono cura di te, hanno un nome, un volto, una famiglia. Lentamente diventano tuoi amici, tuoi fratelli. Imparare a vivere in simbiosi. Scrivo anche per ringraziarli. Fare la scorta a un prete è diverso dal farla a un magistrato, a un imprenditore, a un giornalista. Farla a un parroco lo è ancora di più. Occorre avere tatto, pazienza, comprensione, delicatezza verso il luogo sacro e i credenti che lo frequentano. Ai miei “angeli custodi”, queste qualità non mancano. Ringrazio i loro superiori. Un pensiero, carico di affetto e di preghiera, va al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a papa Francesco, che, in più occasioni, mi hanno espresso solidarietà e stima.
Un anno è passato. Un anno sotto scorta. Un anno in compagnia di persone che per me rischiano la vita. Le prime che vedo la mattina, le ultime cui stringo la mano la sera. A questi uomini invisibili, discreti, e ai loro colleghi sparsi per l’Italia, che permettono il sereno svolgimento del lavoro e della missione di chi è minacciato dalla malavita, va la nostra gratitudine.
Franco Battiato cercatore del divino


"In occasione della morte di Franco Battiato, vogliamo ricordare il grande maestro, oltre che nella preghiera, anche attraverso un'intervista fattagli dal nostro fr. Alfredo Scarciglia nel 1989, che volentieri pubblichiamo"
Sono andato a trovarlo alle pendici dell’Etna, a Milo, in provincia di Catania. Qui Franco Battiato vive con la mamma, la gentile signora Graziella, in una splendida casa baciata dal caldo sole del sud circondata da castagneti e vigneti. È stata proprio la sua mamma a ricevermi e a farmi accomodare in casa e lì, insieme agli amici che mi hanno accompagnato, ho atteso il noto cantautore.
È nato in Sicilia quarantaquattro anni fa e fin da piccolo manifestò una forte passione per la musica che ha sempre coltivato e studiato a fondo passando attraverso varie esperienze musicali, dal melodico, al pop sperimentale e trasgressivo fino ai grandi ultimi successi di Bandiera Bianca, Fisiognomica e Giubbe Rosse in cui riesce a fondere le varie esperienze passate in una sintesi quanto mai interessante e felice che permette alla sua poliedrica personalità di occupare un posto di primo piano all’interno della musica italia, con lusinghieri successi anche all’estero. Con alcune canzoni dell’album Fisiognomica ha cantato per il papa Giovanni Paolo II nel marzo del 1989, nell’aula “Paolo VI”, in Vaticano per aprire l’ormai tradizionale incontro tra il Papa e i giovani della Chiesa di Roma. Ma ora lascio parlare proprio lui della sua vita, e soprattutto della sua vita interiore e della ricerca del divino.
Franco, come armonizzi la tua fede cristiana e l’amore per la mistica islamica?
Non mi sono mai posto questo problema. Sono una di quelle persone che credono, ma che, allo stesso tempo, non sanno che cosa sia la fede, non so che cosa sia la fede intesa nella chiarezza di una conoscenza immediata.
Mi piace parlare di concretezza delle realtà spirituali per non rimanere nell’astratto e nel vago, questo avviene nella tua vita?
Vivo quasi da vent’anni nella pratica quotidiana della ricerca del divino intorno a me e in me.
Come mai ti sei appassionato più alla spiritualità orientale che a quella occidentale?
Io sono di più per l’Oriente. L’Occidente si è allontanato troppo dalla realtà religiosa. Se mi trovo per esempio in un monastero del Medio Oriente e partecipo alla loro liturgia sento una partecipazione totale del mio corpo, in Occidente c’è meno senso religioso.
Ma, hai mai partecipato alla Liturgia in qualche Monastero d’Occidente?
Questa domanda è giusta, prima mi riferivo al poco senso religioso che hanno i laici. Per quanto riguarda gli Ordini religiosi, ho partecipato alle vostre liturgie e posso dire che ho trovato lo stesso livello del Medio Oriente.
Il Rosario è una bellissima forma di preghiera. Può sembrare monotono e meccanico ripetere le Ave Maria. Etimologicamente «ripetere» vuol chiedere «chiedere desiderando», chieder di diventare ciò che dobbiamo essere veramente. Cosa ne pensi?
Sicuramente è così anche per me, ma in un modo leggermente diverso. Io medito, ed è una strada per avvicinarmi al silenzio. È chiaro che all’interno di vari metodi si possono usare tecniche diverse. Uno sceglie ciò che gli è più congeniale. A me piace molto la preghiera del Padre Nostro che, se pronunciata bene e capita bene, è una delle massime preghiere.
battiato
fr. Alfredo insieme a Franco Battiato
Che differenza trovi tra i mistici d’Occidente e quelli d’Oriente?
Pochissima, perché in realtà sono tutti dei colossi e al vertice tutto converge. No, non trovo sostanziale differenza.
Conosci le opere di S. teresa d’Avila, S. Caterina da Siena, S. Giovanni della Croce?
Si, tutte.
Perché parli spesso di mistica islamica? Non sei cristiano?
Io sono fortemente legato alle nostre tradizioni, ho avuto un’educazione cattolica, non a caso, come hai potuto vedere tu stesso, sto facendo costruire una piccola chiesa nel mio giardino e non una moschea. Mi piace però avere uno sguardo ampio, ecumenico.
Giorgio La Pira profeticamente diceva che le tre grandi religioni del Mediterraneo (cristiani, ebrei, musulmani) hanno un progetto in comune da portare avanti, quello della pace nel mondo. Sei d’accordo?
Giustissimo, soprattutto adesso che ci stiamo avviando verso una società multirazziale.
Maria, come è presente nella tua vita?
Ho dipinto un’immagine di Maria, come hai potuto vedere, la sento sofferente, accomunata alle sofferenze del Figlio.
La preghiera elimina le distanze e mette in comunione con la realtà al di là dello spazio e del tempo. Tutto questo avviene nella tua vita?
Sì, solo vorrei distrarmi sempre meno.
Quali sono i tuoi prossimi programmi di lavoro?
Uno spettacolo teatrale sul misticismo. L’idea è nata dal ritrovamento di un manoscritto di un mistico siciliano del X secolo dal titolo “Luci sulla scienza dei segreti e sugli stati mistici dei puri”. È veramente disarmante per la sua semplicità e immediatezza. Gilgamesh è a lunga scadenza e dovrei debuttare nell’ottobre del 1992.
Cosa ti piacerebbe dire ai lettori?
Vorrei parlare della morte: abbiamo quasi esorcizzato la morte, questo si fa quando ci si dimentica di una cosa. Lo shoc può essere poi tanto e tale che ci porta lontano da questa realtà. Dovremmo avere come gli antichi egizi il culto dei morti, loro esageravano un po’, non deve diventare necrofilia, ma consapevolezza dell’appuntamento con la vera vita che ci aspetta.
Ringrazio Franco Battiato che gentilmente ha condiviso con me parte del suo tempo perché si potesse realizzare questa intervista e lo faccio con una frase di Silvano dal Monte Athos che il cantautore ama moltissimo: «desidero soltanto pregare per gli altri come lo faccio per me stesso. Pregare per gli altri vuol dire dare il sangue del proprio cuore»
fr. Alfredo Scarciglia O.P.
Convento S. Domenico, Siena
Il viaggio spirituale di Battiato
Merita attenzione quello che potremmo definire, tra virgolette, il Battiato cristiano, ovverosia il Battiato che cita Isacco di Ninive, che ha musicato una messa, che ha fatto la cresima da adulto, che ha visitato il monte Athos ed altri luoghi cristiani.
Va anche ricordata inoltre che il suo migliore amico e collega, Juri Camisasca, è stato monaco benedettino. Non è un caso, quindi, che negli ultimi anni, anche attraverso l’amicizia con Padre Guidalberto Bormolini, Battiato sia tornato a cantare i padri del deserto.
Si deve dunque pensare a una conversione al cristianesimo nella vecchiaia? Non è chiara in realtà la sua consapevolezza dei dogmi cristiani. Invitato a suonare in Sala nervi davanti a Giovanni Paolo II, si affrettò a dire che non era cattolico. In una recente intervista, è arrivato persino a dire che papa Bergoglio «non parla di teologia, non affronta i massimi sistemi della fede». Affermazione che appare assai superficiale.
Battiato dissociava il cattolicesimo come religione istituzionale dalla spiritualità cristiana, apparentemente senza rendersi conto che senza la prima non avremmo nemmeno la seconda, e che Cristo ha comunque istituito e lasciato un rito. L’eventuale cristianesimo di Battiato, quindi, ha un carattere anticlericale, individualista, poco dogmatico. Senza riferimenti alle dottrine e all’eucarestia, però, il cristianesimo si avvicina al quietismo, allo gnosticismo, all’essere una mera esperienza culturale.
Senza dubbio Battiato ha apprezzato il cristianesimo dialogico, vegetariano, mistico, semplice, meditativo e sensibile dell’India, che ha incontrato negli ultimi anni, quando si è avvicinato alla comunità dei Ricostruttori nella preghiera. La scoperta di un tale cristianesimo è stata per lui una vera sorpresa. Quale sia il Cristo di Battiato, però, non è dato saperlo, e comunque sappiamo che insieme al cristianesimo egli credeva tante altre cose difficilmente conciliabili con esso.
Icona del nostro tempo
Alla luce di quanto detto, Battiato appare in tutto un uomo del nostro tempo, appartenente a una post modernità relativista che appiattisce le religioni, che le distingue dalla spiritualità e che le abbraccia tutte e nessuna.
Per valutare il pensiero religioso di Battiato si deve analizzare il panorama spirituale contemporaneo. Dal punto di vista teologico, lo si può definire un «pluralista teocentrico». Egli non pone l’accento sulla chiesa o su Cristo, ma su Dio. Non essendo teologo, Battiato non disponeva di queste chiavi di lettura, e avrebbe senza dubbio considerato certi discorsi teologici dei bizantinismi noiosi e cerebrali. Non c’è dubbio, però, che la sua riflessione su Dio avrebbe tratto giovamento da un discernimento esegetico e teologico. Alla sua riflessione è senza dubbio mancato l’approccio scientifico e sistematico che lo avrebbe aiutato a comprendere e valutare le differenze tra le religioni.
È significativo che egli sia andato in Catalogna per intervistare un pluralista come Raimon Panikkar. Ma nemmeno Panikkar ha risolto il problema della diversità religiosa e della verità. Il suo pensiero teologico, infatti, finisce per sfociare in un apofatismo. E lo stesso Battiato è stato un apofatico. In Polvere del branco, parlando di Dio, afferma appunto che «nessun uomo ha mai sollevato il suo velo» (ascoltala qui).
La ricerca del religioso in Battiato denuncia limiti metodologici. E tuttavia merita rispetto. La forma migliore per rispettarla a noi sembra quella di criticarla, di prenderla sul serio e pensarla. Sarebbe un errore passare troppo in fretta dalla sua musica alla sua teologia, perché Battiato è e rimane un artista. La teologia che nasce dall’arte è spesso profetica, ma richiede di essere vagliata e integrata.
da Settimananews
Antonietta Potente ogni cosa è illuminata


“La fede non serve per essere arroganti di fronte a quelli che non l'hanno o che l'hanno in altro modo, ma serve "per entrare dentro" e scoprire che la vita ha dimensioni più profonde di quelle che possiamo percepire superficialmente.”
Antonietta Potente
“L'umanità e la creazione hanno solo una vocazione, diventare casa.”
Secondo Antonietta Potente, la dimensione della preghiera è strettamente legata a quella del sogno, inteso come percezione dei percorsi misteriosi dell'interiorità, che si dilatano a esplorare i confini del mondo umano cosmico, alla ricerca di Dio, al quale affidare il nostro desiderio di libertà, armonia, comunione.
Chissà che la preghiera non assomigli al sogno? Non illusione, non sguardo retrospettivo su un accumulo di passato depositato, ma veglia inquieta sulla realtà. Raccolta di frammenti di desideri profondi. Tutto si svolge in quei meandri più profondi della vita dove le percezioni sonore diventano lampi di luce, idee e pratiche di vita, poetiche profezie e verità splendenti. E come abbiamo già detto, se qualcuno domanda di essere iniziato alla preghiera, in realtà sarà accompagnato nei luoghi più profondi di se stesso; allo stesso tempo sente che quelle dimensioni si dilatano fino a ritrovarsi in quel mondo umano-cosmico che appartiene a tutti. Chissà se la preghiera non è lo spazio del sogno o il sogno è alimentato dalla preghiera?
La mia risposta è questa: tutte e due le cose, sono come vasi comunicanti o alambicchi collegati tra di loro il cui fluido si alimenta contemporaneamente. Nella preghiera è come se in qualche modo sognassimo e la preghiera alimenta il sogno. Ma di che sogni parliamo? Per spiegarmi mi soffermo davanti a uno dei quadri più belli disegnato nelle Scritture ebraiche e divenuto tradizione anche per i cristiani: il Salmo 126. In questo salmo, proprio come nel sogno, il tempo fluisce tra ciò che avvenne e ciò che dovrebbe avvenire. Si mantiene viva la memoria, perché anche Dio si ricordi e sospinga il presente verso una condizione umana.
Si tratta di un'esperienza di esilio, andate e ritorni costanti dell'umanità; esodi dei popoli, prigionie, forze contrarie alla costruzione di un mondo-casa comune. Sembra che il salmo sia stato composto da qualcuno che ha ben conosciuto l'esilio e che ancora ricorda quei brividi che attraversarono i corpi degli esiliati quando ebbero sentore della liberazione. Leggendo attentamente questo salmo ci si accorge di quanto esso sia sonoro: non solo canti di gioia ma anche il rumore di quella trepidante corsa verso la liberazione. Infatti, nella logica del popolo ebraico assomiglia ad altri canti di uscita dall'Egitto. Tutto servì a quel gesto di liberazione, il mare si ritrasse, il Giordano si volse indietro: «Quando Israele uscì dall'Egitto, i figli di Giacobbe da una terra straniera (...) il mare vide e fuggì via, il Giordano tornò indietro, come capre saltarono i monti, come agnelli le colline» (cfr. Sal 114,1.4).
Allora è vero, forse il Salmo 126 è un sogno, un intreccio di tempi cronologici: da una parte ciò che l'anima si portava dentro e dell'altra ciò che il corpo, nel presente, avrebbe voluto vedere. Tutto cospira perché qualcosa avvenga. E ciò che deve avvenire è che altri ritornino (cfr. Sal 126,4-6). Il rumore si fa assordante: come i torrenti del Negheb. In ebraico, infatti, l'immagine del torrente rende davvero l'idea della liberazione: nessuno può trattenere gli esiliati, il loro cammino e il loro corso. Fare sogni allora è visione profetica, ma non per aspettare passivamente che si avveri qualcosa, ma per sospingere la storia.
Ogni profeta e profetessa hanno sognato. Ma se noi oggi proviamo a ripetere questo salmo dovremmo farlo non con le bocche piene di gioia ma con una grande amarezza. Oggi la nostra è una storia di esilio e di esiliati; ovunque ti giri vedi persone che non possono stare dove vorrebbero. Eppure, nel Talmud Babilonese si legge che il ritorno degli esiliati è importante come il giorno in cui furono creati il cielo e la terra. Come mai non ce la facciamo? Come mai rendiamo il mondo-casa così inospitale? Se almeno Dio ci aiutasse a ricondurre la realtà in un altro modo.
Nel salmo si parla di semi da gettare, ma è davvero un sogno dell'anima desiderante? Oggi chi parte, non porta nulla con sé; non ha nessuna semente da gettare, anzi non la lascia nemmeno nella propria terra, perché la maggior parte dei territori abbandonati, oggi come oggi, sono già dei deserti. Questo salmo per me va letto al rovescio, partendo dall'ultimo versetto: chi parte piangendo sogna.
E cosa sogna?
Sogna che la sua fatica, il suo dolore si trasformino in qualcosa da raccogliere. La preghiera è questa: « ristabilisci la nostra sorte », ristabilisci questa umanità destinata alla guerra e alla violenza. Dacci la forza di scorrere liberi come dei torrenti nella primavera. Nell'andare, questi popoli lo sanno che il Signore – Dio degli ebrei o degli arabi o dei cristiani o di chiunque sussulti nella fede – aveva fatto grandi cose per loro, lo dicono e lo ripetono anche per chi non lo sapesse. Si ricordano che tante volte la loro bocca si era aperta per cantare e le loro labbra si erano dischiuse al sorriso. In quei momenti gli era sembrato di sognare.
Dal libro: Ci sembrava di sognare di Antonietta Potente, Paoline
Alcune pubblicazioni

Nata in Liguria dove è vissuta per tanti anni a pochi metri dal mare. È il mare una delle sue prime ispirazioni che ama, non per attraversarlo ma per starci dentro. In una prima svolta esistenziale della sua vita decide di cercare un cammino che dia da bere al suo spirito e lo trova nella scia della spiritualità domenicana. Così, fino ad oggi, condivide la sua vita con altre donne che prima e dopo di lei hanno seguito questa stessa spiritualità (Suore Domenicane Unione di San Tommaso D'Aquino).
Alla sua ricerca ha contribuito anche il percorso di studio che l’ha portata a conseguire il dottorato in teologia morale. In Italia ha insegnato all’Università Pontificia “Angelicum” e a Firenze nella Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. In un successivo salto esistenziale, ha lasciato l’Italia e si è recata in America Latina.
Ha vissuto in Bolivia per quasi vent’anni. Quei luoghi sono diventati per lei un’intensa ispirazione. Passata da una periferia del tropico a una valle altiplanica, per vivere ha continuato a insegnare in differenti università e centri di studio di teologia e di filosofia. Insieme al popolo boliviano ha condiviso la cosiddetta “guerra dell’acqua” e accompagnato il sogno politico per un processo di cambiamento, sfociato in seguito, nel governo indigeno del Presidente Evo Morales. Quella terra dice -mi ha insegnato molte cose-. A causa di un ulteriore salto esistenziale, è tornata in Italia, dove risiede tutt’ora. Oggi vive a Torino con altre compagne di cammino.
Vivendo la quotidianità più assoluta, pensa e scrive. Le fonti principali del suo pensiero sono le Scritture ebraico-cristiane; il pensiero filosofico e teologico sapienziale -soprattutto quello delle donne-, le culture ancestrali, la vita di donne meno note e la realtà più semplice e quotidiana di ogni essere umano e di ogni essere vivente, anche il più piccolo.
Chiara Amirante risorgere da ogni disagio
"Dio dell’impossibile, se mi metti nel cuore questa spinta io ti dico sì, ma tu mettimi nella condizione."


Chiara Amirante: si può risorgere da ogni disagio
La risposta alla disperazione con un percorso di riscatto: «Dico il mio grazie a Dio per tutti coloro che sono stati nella morte e sono risorti spiritualmente».
«Sono stata una bambina vivace e impegnativa, di quelle che bombardano i genitori di “perché?” e non si accontentano di risposte preconfezionate... Ma ho avuto la grazia di nascere da due genitori che si erano convertiti da poco, quindi nel momento della massima scoperta di questa grande notizia che troppo spesso si dà per scontata. Mi è andata bene». Ed è tuttora impegnativa, Chiara Amirante, 52 anni, ogni definizione le va stretta: laureata in scienze politiche alla Sapienza di Roma, autrice di bestseller e personaggio televisivo, soprattutto fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, nata 25 anni fa nei meandri della Stazione Termini per salvare 27 ragazzi dai loro inferni personali e oggi divenuta la casa spirituale di 700mila testimoni di luce nei cinque continenti. Lei sarà anche premiata alla Festa di Avvenire a Lerici, il 31 luglio.
Chiara, un quarto di secolo di Nuovi Orizzonti è un giro di boa non indifferente. Come lo sta vivendo?
Venticinque anni ti portano a riguardare indietro e contemplare con stupore quello che Dio ha operato. In realtà ogni giorno faccio questo esercizio di ringraziare il Padre, ma certamente farlo tutto insieme per i 25 anni mi ha colmato il cuore di commozione. Ho ripensato a quei primi giorni in cui, da ragazza, mi sono immersa nell’inferno della strada, tra tanti fratelli sofferenti, nella droga, nella disperazione, nell’abbandono dopo il carcere, nella prostituzione, e poi a quanti di loro sono passati dalla morte alla vita. Nel 1994 cominciavamo con la prima piccola comunità, in una villetta familiare mandata senza preavviso dalla Provvidenza, i materassi sparsi ovunque. Da quei 27 su cui nessuno avrebbe scommesso, vero popolo della notte, è poi fiorito questo popolo di “cavalieri della luce”, testimoni della risurrezione nelle stesse strade in cui prima vivevano di espedienti. Il giorno di Pentecoste a Frosinone eravamo in tremila a festeggiare questo anniversario, una folla di persone, ciascuno un miracolo. Ho visto le lacrime di tanti mentre a 82 ragazzi consegnavo quella piccola croce simbolo dell’essere consacrati come “Piccoli della gioia”, sapevo che quasi tutti i presenti erano stati nella morte ed erano risorti spiritualmente, e da lì è salito il nostro grazie a Dio di questa grande famiglia che sempre più ci chiama a essere testimoni di gioia per chi ha perso la speranza.
Lei è una consacrata, ma Nuovi Orizzonti è una realtà che ha molti volti ed esperienze diverse. Che cosa vi accomuna?
Per lo più noi abbiamo una consacrazione laicale, ci sono anche “Piccoli della gioia” sposati, sposi chiamati al servizio del Padre anche nel lavoro quotidiano, oppure nelle missioni, ovunque, le “Famiglie di Nazareth” che vivono una dedizione totale a Dio, aperte all’accoglienza. È questa la nostra caratteristica specifica, anche se poi abbiamo pure sacerdoti, religiosi e religiose: la consacrazione come “Piccoli della gioia” è per tutti gli stati di vita. Credo che sia un segno dei tempi se lo Spirito Santo sta mandando tanti carismi e chiama i laici là dove sono. Riflette ciò che già il Concilio chiariva, e cioè che la santità è una chiamata per tutti, non è qualcosa che possiamo delegare a sacerdoti e religiosi. Oggi soprattutto, in un mondo spesso radicato in «strutture di peccato », come le chiamava Giovanni Paolo II, c’è un’urgenza assoluta di sposi santi, di santi immersi nel mondo del lavoro, di professionisti santi, capaci di rinnovare la società da dentro. Va detto però che come Chiesa siamo un po’ indietro nel riconoscere il contributo che ciascun laico può portare: colpa di quel clericalismo duro a morire di cui parla papa Francesco. Il sacerdozio è un dono immenso, ma poi siamo tutti corpo di Cristo.
Quei genitori che lei da bambina bombardava di domande hanno fatto in tempo a vedere il suo cammino?
Poverini, sì. Sentirsi dire da una figlia che va a vivere in strada non è facile. Avevo sentito la chiamata a lasciare tutto per andare a vivere in strada con la mia nuova famiglia, ero anche guarita all’improvviso da una malattia incurabile... In una giornata di spiritualità, quando erano sotto l’azione dello Spirito Santo, ho detto loro che avrei lasciato la casa e il lavoro per seguire Gesù nei bassifondi della città... Per la grande stima che avevano di me mi hanno dato la loro benedizione, sapevano che se facevo delle pazzie era perché Dio me le metteva nel cuore, essendo io molto razionale. Ma poi papà ha cercato di farmi ragionare, diceva che per una ragazza era troppo pericoloso. Mamma ha capito subito che era una chiamata e niente mi avrebbe distolto, ma lui ha vacillato, «Se vuoi diventare santa fallo lontano da me, perché non posso morire di crepacuore », mi ha detto. Ma Dio non si lascia mai vincere in generosità e proprio il giorno in cui dovevo trasferirmi in strada con la mia nuova famiglia di disperati è arrivata dalla Provvidenza la prima struttura per iniziare l’accoglienza residenziale. Mamma e papà sono poi venuti a vivere nove giorni di ritiro spirituale con i 27 arrivati tutti da esperienze estreme...
Che cosa proponeva a questi ragazzi?
Di fare un’esperienza di risurrezione. «Non importa se credete che Gesù è figlio di Dio – dicevo loro –meditate almeno le parole di questo grande uomo che mi hanno portato a rischiare la vita per voi». Meditavamo la promessa di Gesù, che se chiediamo al Padre lo Spirito Santo egli ce lo dona: avevano i cuori tanto spezzati che nessun percorso umano avrebbe potuto trasformare i loro cuori di pietra in cuori di carne. Il nono giorno era la festa del Battesimo di Gesù. La maggior parte di loro non aveva mai pregato, ognuno ha chiesto lo Spirito in modo molto semplice, balbettando qualche parola. Non piangevano da quando erano bambini, ci siamo trovati tutti in lacrime e in quella cappellina siamo rimasti fino a sera, nessuno riusciva ad allontanarsi. Mio papà, vedendo questi lupi trasformarsi in angeli, si è tranquillizzato, innamorato di ciò che Dio stava operando non ci ha più lasciati.
Tra tanti salvati, è andata incontro a sconfitte?
Non credo nelle sconfitte. Quando Gesù ha vissuto il più grande fallimento, ha ottenuto la più grande vittoria per l’umanità. Dio è morto, ma da quella morte è avvenuto il miracolo dei miracoli. C’è nella nostra vita la terribile possibilità di dire “no” all’amore di Dio, il che è la tragedia della nostra esistenza ma anche la forza del libero arbitrio. La cosa bella è che ogni “no” può sempre ritornare a essere un “sì”. Poi è vero che quando perdi per strada qualcuno lì per lì ti arriva la spada nel cuore, ma per la mia lunga esperienza so che, se Dio ha seminato il suo amore in un cuore, quel cuore resta segnato e il più delle volte prima o poi ritorna. Certo, c’è sempre un Pietro che rinnega o un Giuda che tradisce, ma se un tempo mi scoraggiavo e soffrivo, ora è più forte la certezza che le tenebre non prevarranno.
A volte si sente sola?
Da 25 anni porto la croce terribile di raccogliere il grido lancinante dei fratelli, e non si arriva a tutti. Nonostante il Papa chieda di uscire nelle periferie esistenziali, l’indifferenza è ancora un grave peccato di omissione da parte di troppi. Ci sono poi tanti che attaccano il Papa: come si può avere la presunzione, da cattolici, di saperne più del Pontefice? Il Divisore è abile...
Come si spiega la presenza di tanti attori, cantanti, vip, attratti da Nuovi Orizzonti, da Nek a Bocelli a molti altri?
Me lo chiedo spesso. Certo nel mondo dello spettacolo c’è grande sete di spiritualità, di uscire dalle apparenze per trovare rapporti veri. Vedere in Nuovi Orizzonti le realtà di ragazzi rinnovati dal Vangelo, toccare con mano i miracoli di tante risurrezioni interiori, riaccende in loro una nostalgia. Il mondo ci propone una gioia patinata. Quando vedono la luce negli occhi dei nostri ragazzi, dicono: «La voglio anch’io questa luce, se ce l’ha fatta lui allora posso anch’io ». E da personaggi tornano a sentirsi persone.

L’AVVENTURA DI NUOVI ORIZZONTI
INIZIA NEL ’91 QUANDO CHIARA AMIRANTE DECIDE DI RECARSI DI NOTTE ALLA STAZIONE TERMINI PER INCONTRARE TANTI GIOVANI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO CHE HANNO FATTO DELLA STRADA LA LORO "CASA".
«Quando ho iniziato a percorrere i ‘deserti’ della nostra splendida Roma e ad entrare in punta di piedi nelle dolorosissime storie del ‘popolo della notte’ – afferma Chiara – non immaginavo davvero di incontrare un popolo così sterminato di disperati, di persone sole, di emarginati, di mendicanti di amore, sfregiati nella profondità del cuore dall’indifferenza, dall’abbandono, dalla violenza, vittime dei terribili tentacoli di piovre infernali.
Missioni di Strada
Quanti giovani splendidi, assetati di amore, ridotti, dalle seduzioni del mondo e dalle terribili sferzate della vita, a creature dallo sguardo di ghiaccio e dal cuore di pietra. Quanti ragazzi nel pieno della loro giovinezza attanagliati da una nausea sottile, da un vuoto esistenziale terribile, da un’angoscia mortale! Quanti giovani distrutti, ingannati, defraudati della loro innocenza. Quanti fratelli disperati con le lacrime agli occhi mi hanno abbracciato chiedendomi: “Ti prego, Chiara, portami via da questo inferno!”… e che dolore nel non riuscire a trovare un posto dove portarli».
Mi sentivo troppo piccola fragile impotente dinanzi al grido lancinante del popolo della notte… Poi un raggio di luce, una certezza: L’Amore è più forte, l’amore vince. L’Amore fa miracoli perché Dio è Amore!
Mi è venuta cosi l’idea di una comunità di accoglienza dove proporre un cammino di conoscenza di sé, di guarigione del cuore e di rigenerazione psico-spirituale”.
Nel marzo del ’94 Chiara apre a Trigoria (Roma) la prima comunità di accoglienza Nuovi Orizzonti, dove centinaia di giovani, provenienti da esperienze estreme, iniziano a ricostruire se stessi attraverso il programma terapeutico riabilitativo da lei ideato.
La risposta dei ragazzi accolti è fin dal primo momento davvero sorprendente ed entusiasmante.
Nel maggio del ’97 si apre a Piglio, in provincia di Frosinone, una Comunità di formazione e di accoglienza che diverrà la sede centrale di Nuovi Orizzonti.
Dal 1998 si moltiplicano le iniziative di solidarietà, le comunità di accoglienza, i centri di formazione e di reinserimento, i progetti sociali e le iniziative di promozione umana, i progetti in paesi in via di sviluppo.
In breve tempo la comunità si trasforma in una vera e propria ‘factory dell’amore’, un colosso della solidarietà e dell’accoglienza. Infatti, gli stessi ragazzi accolti, dopo un periodo trascorso in Comunità, sentono l’urgenza di impegnarsi in prima persona in azioni di solidarietà a sostegno di chi è in grave difficoltà.
Alla fine degli anni ’90, la Comunità Nuovi Orizzonti sperimenta nella città di Roma una nuova metodologia pastorale di evangelizzazione di strada che si presenta particolarmente efficace: sono le cosiddette ‘missioni di strada’.
A contatto con tanti giovani nelle varie situazioni di disagio, Chiara va anche elaborando un percorso pedagogico riabilitativo per quanti si rivolgono a lei e all’Associazione per liberarsi dalla dipendenza, per uscire da diversi tunnel infernali e per riscoprire la gioia di vivere la vita in pienezza. Vivere il vangelo nella quotidianità ‘alla lettera’ rimane il centro dell’esperienza di vita, ma attorno ad esso si colloca un cammino di conoscenza di sé e guarigione del cuore (l’Arte d’amare) che diventa la peculiarità della sua proposta anche nel mondo delle comunità di recupero.
Chiara, nella Pasqua del 2006, di ritorno dalla terra santa, lancia una nuova proposta: I Cavalieri della Luce. In pochi anni in più di 500.000 aderiscono a questo impegno: testimoniare la gioia di Cristo Risorto a chi è più disperato, provare a vivere il vangelo alla lettera per rinnovare il mondo con la rivoluzione dell’Amore! I Cavalieri della Luce, pur essendo sparsi in diversi paesi, restano uniti tramite l’iniziativa della parola di luce pubblicata quotidianamente sulla pagina pubblica facebook di Chiara Amirante: l’impegno di vivere insieme una frase del vangelo del giorno.
Cresce l’impegno anche nel portare messaggi di speranza a chi l’ha persa tramite i media e i new-media.
Chiara Amirante con dei Bambini nella Cittadella di Fortaleza (Brasile)
Udienza papa Benedetto XVI - Cavalieri della Luce
In questi anni la Comunità Nuovi Orizzonti ha visto migliaia di giovani, provenienti da esperienze estreme o in cerca di senso per la loro vita, ricostruire se stessi alla luce dell’amore e passare dalla ‘morte’ alla vita. Da quella prima casetta a Trigoria, con materassi sparsi per terra, si è arrivati alla realizzazione di circa 1000 equipe di servizi, numerosi Centri e Opere in Italia e all’estero e la realizzazione delle Cittadelle Cielo, piccoli villaggi di accoglienza e formazione dove si vuole vivere la legge dell’amore, il ‘come in cielo così in terra’.
Un’incredibile impresa, un vero miracolo che non avrebbe potuto realizzarsi senza l’aiuto di Dio, di centinaia di volontari e di tantissimi amici. Nuovi Orizzonti è stata approvata anche dalla Santa Sede, come Associazione privata internazionale di fedeli, l’8 dicembre del 2010.
Don Antonio Mazzi..prete di strada

"Il Dio delle periferie è il Dio della domanda, della casa sul marciapiede, delle famiglie distrutte. È insieme il dio della tragedia e della dolcezza. Dio, diventando Cristo, ha scelto la “periferia”, il deserto, la grotta, la strada, la barca, il profumo della prostituta.
Anzi, per dirla più vera e meno teologica, Cristo è la periferia, è la strada. Non è il tempio e nemmeno va al tempio. Si accontenta di essere parola, e non basilica. Frequenta la gente che lo ascolta per strada, che lo incontra di notte: la vedova, il cambiavalute, la pecorella smarrita, il figliol prodigo, il giovane ricco, la vedova di Nain, i pescatori.
Il Vangelo è il libro della periferia; insegna come evitare le affabulazioni dei farisei, le ipocrisie dei dottori della legge. Per citare Daniel Pennac, “Cristo ha evitato la confisca della parola”. E per non correre rischi, l’ha addirittura incarnata, l’ha mangiata trasformando la parola in ciascuno di noi.
La sua missione si concentra sulla cosa più semplice, l’unica creativa: liberare le persone, liberando la loro parola. Ha seminato la parola e, da lì, ne è uscito il pane che genererà la “notizia nuova”.
Con un “fiat” Dio ha fatto il mondo; Cristo, diventando Verbo, l’ha rifatto. La Creazione del mondo e la notte di Natale si equivalgono. Allora, con una parola, Dio è diventato il Signore. Ora, con una parola, è diventato il povero.
Non solo Cristo è diventato parola, ma ha voluto che la parola più forte e dolce insieme, la possedessero i miti: l’arma dei miti. La parola più potente, quella che perfora le tenebre, non viene dall’alto, ma emana, sbalorditiva, dalla terra e dal camminare tenace degli ultimi.
La parola più intensa diventa pace. Ha come vincenti i fuggitivi e promana dai dodici camminanti della nuova carovana evangelica; da quella carovana che incominciò chiamandosi Exodus, e che continua chiamandosi “Popolo”.
Dobbiamo cercare un Dio e un uomo nuovi, credibili, capaci di sedurci, di rapinare i nostri sentimenti sepolti dalle ceneri dei templi… moderni. Il Dio nuovo, non facciamolo passare dalla teologia, dalla catechesi, dall’etica… ma dalla periferia.
Il Dio delle periferie non solo è uomo tra gli uomini, ma è anche POESIA, cantico, pellegrino."
Don Mazzi
Don Mazzi parla più al cuore che al cervello: «La fede non ti cerca, non è ragione. Bisogna lasciare uno spazio a ciò che non si capisce. Per me è speranza, quella di poter incontrare il Padre e il padre che non conobbi».
Spiega così i pilastri del suo impegno: «Innanzitutto il rispetto degli altri, il perdersi per ritrovarsi di nuovo insieme e vivere e lavorare nel presente per vedere il passato e interpretare il futuro».
Poi una lezione di vita, interiore e sociale: «Dico ai miei ragazzi: a volte piangere è più efficace che ridere, anche perché il colore rosso del dolore è lo stesso dell’amore, che deve vincere su ogni cosa. Gli uomini, quelli veri, come ci ha detto papa Francesco, sono quelli che sanno parlare e non fare chiacchiere. Servono meno regole, meno controlli e più autenticità e lavoro interiore».
Sull’educazione: «Bisogna dire anche dei no, ma nessuna persona va pensata o trattata come fosse “scartino”. Nel Vangelo non esistono peccatori».

DON ANTONIO MAZZI: I RAGAZZI VANNO ASCOLTATI CON IL CUORE
Quest’uomo ha qualcosa di magnetico. Devono essere quegli occhi chiari, due luci azzurre che sembrano scrutarti, frugarti qualcosa dentro, mentre sei lì che piuttosto aspetteresti una sua risposta. Forse sono stati la sua arma, per quanto forse non sia la parola giusta, un’arma affiata in anni e anni di esperienza, per guarire le ferite dei ragazzi che tentava di salvare. Forse li ha usati, quegli occhi, per agganciare, dal basso della sua minuta statura, la verità di quelli che si trovava di fronte, interle nostre parole sgrammaticate, scarabocchiate, ma oneste, che vengono dopo aver letto e riletto le piccole via crucis di questo nostro mondo». Per dire che «non tutto è tragedia», e fare qualcosa affinché non si cada nella tentazione di «allargare troppo gli spazi tenebrosi».
Don Antonio, perché un libro sugli adolescenti? «La gente pensa che i ragazzi di oggi siano peggiori di quelli di una volta. Io volevo raccontare invece come anche tra le righe più macabre si aprano piccoli spiragli inaspettati. Il cettarne il dolore, provare a guarirlo. Prima i ventenni tossici, presi per i capelli al parco Lambro con l’ago ancora infilato in vena, poi i giovani più complessi e fragili di oggi, affascinati dalle nuove droghe e deragliati in brutti reati.
Le storie che ha raccolto, le confessioni e le notti in bianco, sono così tante che è incredibile che all’età di 93 anni sia ancora qui, capace di intrappolarti nel suo sguardo e di spostarti qualcosa dentro quando parla. Perché il carisma che emana non viene solo dal suo sguardo ma anche e soprattutto bene è sempre maggiore del male». Ma è vero che i giovani di oggi sono peggio? «Sono solo più fragili. Se sono aggressivi, se fanno cose sbagliate, è perché dentro mancano le fondamenta». Come fa un uomo di 93 anni a capire gli adolescenti di oggi? «Non lo so se li capisco o se quello che penso di capire è solo quello che sento io. Però una cosa la vedo». Che cosa? «I ragazzi di una volta erano pieni di cattiveria. Era una cattiveria che gli veniva dall’uso della sostanza, che gli ammazzava tutto quello che avevano dentro.
Quelli di adesso invece hanno dentro ancora tutto. E se si fidano, si aprono». E quando si fidano? «Quando li ascolti. Io lo dico sempre agli operatori: lasciamoli parlare. Non saltiamo loro addosso con le nostre domande: cosa hai fatto? Perché lo hai fatto?». Però qualcosa va anche detta. Che cosa? «Il punto è avere il coraggio di non avere in testa delle risposte predalle cose che dice. E da come lo fa. Don Antonio Mazzi, fondatore e presidente della comunità di recupero Exodus di Milano, ha appena pubblicato per le Edizioni San Paolo il libro Se grandina a primavera. Amare e educare gli adolescenti (e noi stessi) in un tempo di crisi. Un saggio, scorrevole e diretto, che raccoglie gli articoli che ha scritto negli anni su Famiglia Cristiana: «Di tutto quel lavoro», dice, «ho scelto i pezzi che parlavano di adolescenza».
Una specie di diario «per anime che vogliono cambiare almeno qualcosa, fatto con le nostre parole sgrammaticate, scarabocchiate, ma oneste, che vengono dopo aver letto e riletto le piccole via crucis di questo nostro mondo». Per dire che «non tutto è tragedia», e fare qualcosa affinché non si cada nella tentazione di «allargare troppo gli spazi tenebrosi».
Don Antonio, perché un libro sugli adolescenti? «La gente pensa che i ragazzi di oggi siano peggiori di quelli di una volta. Io volevo raccontare invece come anche tra le righe più macabre si aprano piccoli spiragli inaspettati. Il bene è sempre maggiore del male».
Ma è vero che i giovani di oggi sono peggio? «Sono solo più fragili. Se sono aggressivi, se fanno cose sbagliate, è perché dentro mancano le fondamenta».
Come fa un uomo di 93 anni a capire gli adolescenti di oggi? «Non lo so se li capisco o se quello che penso di capire è solo quello che sento io. Però una cosa la vedo».
Che cosa? «I ragazzi di una volta erano pieni di cattiveria.
Era una cattiveria che gli veniva dall’uso della sostanza, che gli ammazzava tutto quello che avevano dentro. Quelli di adesso invece hanno dentro ancora tutto. E se si fidano, si aprono».
E quando si fidano? «Quando li ascolti. Io lo dico sempre agli operatori: lasciamoli parlare. Non saltiamo loro addosso con le nostre domande: cosa hai fatto? Perché lo hai fatto?».
Però qualcosa va anche detta. Che cosa? «Il punto è avere il coraggio di non avere in testa delle risposte prefissate. Bisogna ascoltare le loro, di domande. E per farlo, bisogna restare umili: l’educatore è sullo stesso piano del ragazzo che ha davanti».
Lei ha cominciato a lavorare coi giovani più di 40 anni fa. Com’è cambiato lei da allora? «I ragazzi dell’ultimo periodo mi hanno reso più umile. Ho meno voglia di vincere. Devo accettare che a volte perdo».
Quando si vince? «Quando un ragazzo va via e l’hai convinto».
Intende: l’hai convinto a fare del bene? «No. Intendo: l’ho convinto a volersi bene.
Perché il loro problema è questo: sono pieni di quei tatuaggi, quelle scritte sul corpo, tutte frasi fatte, ma dentro poche certezze».
C’è qualcosa che non ha mai capito dei ragazzi? «Più che capirli noi, dovremmo aiutare loro a capire sé stessi».
E loro si capiscono? Lo capiscono quello che stanno vivendo, quello che hanno fatto? «A volte qui arrivano ragazzi che hanno fatto cose così brutte che io ho quasi paura che capiscano davvero. Ne ho paura per la loro salute mentale. E quasi, mi ritrovo a sperare che non ci arrivino mai».
Come si relazionano con lei? Che atteggiamento hanno? «I primi anni mi minacciavano. L’eroina li lasciava orfani di loro stessi e loro si difendevano con l’offesa. Questi invece non ti offendono. Urlano un po’ di più, usano parole forti, ma dentro sono fragili». In comunità è passata quella ragazza che all’epoca uccise madre e fratellino, e ora avete quel ragazzo che ha ucciso suo padre.
«Quel ragazzo che ha ammazzato il padre, per esempio, ha paura ad andare in metropolitana. Dice che vuole studiare Teologia ma ha paura di andare all’Università da solo». Quando lei è solo, che pensieri fa? «Che sono stato fortunato a fare questo lavoro. E non perché ho ragionato più degli altri ma perché ho colto le occasioni che mi sono arrivate dalla vita».
Ha cominciato facendo il preside in una scuola vicino al parco Lambro ed è stato lì che si è accorto di cosa stava facendo l’eroina ai ragazzi.
«Pensi che neanche ci volevo venire a Milano. Se avessi seguito la testa non sarei qui».
Ha paura di morire? «Ho paura di soffrire. Di fare una morte sofferente. Ma è un pensiero umano. E non voglio far soffrire chi ho intorno. Però il Padreterno fino ad adesso è stato bravo: ho avuto degli incidenti in macchina, minac [1]ce di morte nel parco, un infarto... e sono ancora qui».
Perché si è dedicato così tanto ai ragazzi? «Ho perso il papà che avevo 15 mesi e l’ho vissuta sempre come un’ingiustizia. E se sono diventato prete è stato per la grande mancanza che avevo di una figura paterna. Sono diventato io padre degli altri».
Se non avesse fatto questo, cosa avrebbe voluto fare? «Il musicista. Avrei fatto il conservatorio e suonato l’organo».
Qual è la figura religiosa che le piace di più? San Francesco d’Assisi. Da adolescente era un bel furbo, era un tipo sveglio, si godeva la vita, la sera aveva il suo giro ed era persino il capo. Però ha saputo vivere la fede alla sua maniera: ha vissuto amando».
Che cosa la fa arrabbiare? «La Chiesa di oggi. Certi preti, che sono impiegati dell’impero ecclesia stico e non discepoli di un uomo che amava la strada. Perché Cristo è l’uomo della strada, non delle basiliche. Il Papa lo dice: “Abbiate il coraggio di spalancare le porte e andate per strada”. E a me invece sembra che oggi siamo tornati nel tempio di Gerusalemme, quel tempio che Cristo ha tanto combattuto»
Enzo Bianchi..il monaco che non smette mai di camminare con Dio

Ecco, in estrema sintesi, il fulcro della fede cristiana: credere all’amore attraverso il volto e la voce di questo amore, cioè attraverso Gesù Cristo.
Enzo Bianchi

Gesù educa alla fede
Enzo Bianchi
In tutta la vita noi uomini dobbiamo avere fede, fare fiducia, credere a qualcuno. Quando accediamo alla pienezza delle relazioni, in quelle più personali e intime come in quelle sociali e pubbliche, dobbiamo fidarci, fare credito, credere a qualcuno. In breve, non si può essere uomini senza credere, perché credere è il modo di vivere la relazione con gli altri; e non è possibile nessun cammino di umanizzazione senza gli altri, perché vivere è sempre vivere con e attraverso l’altro. Proprio per questa umanità della fede, oggi dobbiamo confessare che la crisi della fede incomincia dalla crisi dell’atto umano del credere, che è diventato difficile e sovente contraddetto. Abbiamo difficoltà a credere all’altro, siamo poco disposti a fare fiducia all’altro, non osiamo credere all’altro fino in fondo. Lo constatiamo ogni giorno: perché si preferisce la convivenza al matrimonio? Perché è diventata così difficile la storia perseverante nell’amore? Perché così spesso soffriamo a causa della separazione, del venire meno dell’alleanza nell’amore umano o dell’alleanza stretta all’interno di una vita comunitaria? La verità è che non siamo più capaci di porre, nella nostra vita, l’atto umano del credere. Tanto che ormai, di fronte a quella celebrazione della fede e della promessa che è il matrimonio, il pensiero che ci attraversa la mente è: «Fino a quando durerà?». Noi non crediamo all’amore, contraddicendo così quella definizione lapidaria dei cristiani data dall’apostolo Giovanni: «Noi crediamo all’amore» (1Gv 4,16)! A chi si lamenta della crisi della fede in Dio, mi viene da rispondere: «Ma com’è possibile credere in Dio che non si vede, se non sappiamo credere all’altro, al fratello che si vede (cf. 1Gv 4,20)?». Per questo è decisivo cogliere come Gesù educava alla fede, come generava alla fede gli uomini e le donne che incontrava lungo le strade della Palestina. Gesù sapeva che non ci può essere vita umana senza fede e per questo aveva come prima preoccupazione quella di destare fede, di mostrare un atteggiamento capace di comunicare e di generare la fede. Diventare credente è un compito mai portato a termine, allo stesso modo che diventare un soggetto responsabile e libero. Ma per molti uomini non è facile avere fiducia, credere a qualcuno – così come non è facile accedere a una vera soggettività – a causa delle contraddizioni patite nella vita. La vita è attraversata dal male in varie forme: malattia, sofferenza, malessere, separazioni, morte… E quando ci si dispone a leggere la vita passata, si trovano molte ragioni per non credere. Come contrastare queste forze di morte che ci abitano? E soprattutto, ciò che più conta, come Gesù ci insegna a contrastarle e ci educa dunque alla fede?
Gesù, educatore alla fede
a) Gesù, uomo credibile e affidabile
Gesù ci ha mostrato innanzitutto una necessità: chi inizia alla fede o a essa vuole generare, deve essere credibile, affidabile. Del resto – lo sappiamo per esperienza – anche i genitori che vogliono educare un figlio possono farlo solo se sono credibili, affidabili. La credibilità di Gesù nasceva principalmente dal suo avere convinzioni e dalla sua coerenza tra ciò che pensava e diceva e ciò che viveva e operava. Non erano solo le sue parole che, raggiungendo l’altro, riuscivano a vincere le sue resistenze a credere; non era un metodo o una strategia pastorale a suscitare la fede: era la sua umanità contrassegnata – secondo il quarto vangelo – da una pienezza di grazia e di verità (cf. Gv 1,14). Grazia e verità che dicevano l’autenticità e la coerenza di Gesù, non lasciando alcuno spazio tra le sue convinzioni e ciò che egli diceva e viveva. Incontrando Gesù, tutti percepivano che non c’era frattura tra le sue parole e i suoi gesti, i suoi sentimenti, il suo comportamento. Ed è proprio da questa sua integrità che nasceva la sua exousía, la sua autorevolezza, che spingeva gli uomini a esclamare con stupore: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorevolezza!» (Mc 1,27); e a constatare che egli non insegnava come gli scribi (cf. Mc 1,22), come chi lo fa per mestiere, come chi ha solo una competenza tecnica. Se avveniva una persuasione di uomini e donne in ascolto di Gesù, questa era soprattutto causata dalla testimonianza, non da una somma di parole. Si può anche dire che in Gesù c’era la capacità di testimoniare con le sue azioni, anche senza le parole; per parafrasare un detto tradizionale dei padri del deserto, «bastava vederlo»… Nella pedagogia, nell’educazione alla fede, l’iniziatore deve dunque essere affidabile. Certo, per noi non è possibile raggiungere la coerenza vissuta da Gesù, quest’uomo in cui traspariva Dio; ma anche per noi l’essere affidabili dipende dalla nostra coerenza, e la nostra affidabilità è decisiva nell’educare alla fede e nel trasmetterla. E se è vero che la nostra fede è sempre fragile, basta metterla nella fede di Gesù Cristo, lui che è «la fede perfetta» (he teleía pístis), secondo la bella definizione di Ignazio di Antiochia.
b) Gesù, uomo che si è «spogliato» per entrare in dialogo
È innegabile nella pratica della relazione e dell’incontro da parte di Gesù la dimensione dialogica, che è sempre accompagnata dalla dimensione kenotica, di condiscendenza. Gesù non consegna mai a chi incontra una verità astratta, ma instaura innanzitutto con lui/lei una relazione umana, nella quale il momento concreto dell’incontro è un kairós, nel pieno senso della parola biblica (cf., per es., 2Cor 6,2). Il suo è un comunicare «in situazione» e apre un dialogo, ma è sempre preceduto da un cammino di abbassamento, di condiscendenza, che rinnova quel cammino di kénosis da lui percorso per passare dalla forma di Dio alla forma di uomo come noi (cf. Fil 2,6‐7). Gesù si fa viandante assetato al pozzo di Sicar dove incontra la donna samaritana (cf. Gv 4,5‐30); si fa pellegrino sulla strada di Emmaus dove incontra i due pellegrini (cf. Lc 24,13‐35); si fa frequentatore della tavola dei pubblicani e dei peccatori, per incontrarli e poter annunciare loro la buona notizia (cf. Mc 2,16 e par.; Lc 7,34)… Gesù percorre dunque un cammino di abbassamento, si mette in dialogo – il che significa innanzitutto ascolto dell’altro – e si confronta con l’interlocutore. Primo effetto dell’incontro con lui è l’interrogarsi su cosa si cerca, su cosa si vuole, su cosa brucia nel cuore. Basta ricordare alcune domande che Gesù rivolge a quanti incontra: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38); «Donna, chi cerchi?» (Gv 20,15); «Che discorsi state facendo?» (Lc 24,17). A partire da domande come queste nel dialogo avviene un vero incontro, un’esperienza condivisa, un parlare e un rispondersi reciprocamente. Anche questo è un tratto dell’educazione alla fede praticata da Gesù: accettare di «scendere», di «svuotarsi» per stare accanto all’altro; accettare di rinunciare a certi diritti e privilegi che rischiano di essere un ostacolo, per proporre la fede in modo credibile. Sì, perché la buona notizia del Vangelo non può risuonare né esistere senza un’incarnazione concreta, senza che si inscriva nella vita di uomini e donne. In questo senso è significativo che i discepoli da Gesù siano da lui chiamati «amici» (Gv 15,15), in una vera e propria relazione di amore.
c) Gesù, uomo capace di accogliere e di incontrare tutti
Un’altra caratteristica di Gesù, che emerge dai suoi incontri, è la sua capacità di accoglienza verso tutti. Gesù sapeva incontrare veramente tutti: in primo luogo i poveri, i primi clienti di diritto della buona notizia, del Vangelo; poi i ricchi come Zaccheo (cf. Lc 19,1‐10) e Giuseppe di Arimatea (cf. Mc 15,42‐43 e par.; Gv 19,38); gli stranieri come il centurione (cf. Mt 8,5‐13; Lc 7,1‐10) e la donna siro‐fenicia (cf. Mc 7,24‐30; Mt 15,21‐28); gli uomini giusti come Natanaele (cf. Gv 1,45‐51), o i peccatori pubblici e le prostitute presso i quali alloggiava e con i quali condivideva la tavola (cf. Mc 2,15‐17 e par.; Mt 21,31; Lc 7,34.36‐50; 15,1). Com’era possibile questo? Perché Gesù sapeva non nutrire prevenzioni, sapeva creare uno spazio di fiducia e di libertà in cui l’altro potesse entrare senza provare paura e senza sentirsi giudicato. Sulle strade, lungo le spiagge, nelle case, nelle sinagoghe, Gesù creava uno spazio accogliente tra se stesso e l’altro che veniva a lui o che lui andava a cercare; si metteva sempre innanzitutto in ascolto dell’altro, cercando di percepire cosa gli stava a cuore, qual era il suo bisogno. Mi si permetta di dire: Gesù non incontrava il povero in quanto povero, il peccatore in quanto peccatore, l’escluso in quanto escluso. Ciò avrebbe significato porsi in una condizione in cui l’altro veniva rinchiuso in una categoria, avrebbe significato ridurre l’altro a ciò che era solo un aspetto della sua persona. No, Gesù incontrava l’altro in quanto uomo come lui, membro dell’umanità, uguale in dignità a ogni altro uomo. E nell’incontrare e ascoltare un uomo Gesù sapeva coglierlo, questo sì, come una persona segnata da povertà, da malattia, da peccato… Quando Gesù incontrava l’altro, cercava di creare un clima relazionale, consentiva all’altro di emergere come persona e soggetto, non lo giudicava mai, ma sapeva accogliere il linguaggio di cui l’altro era capace: il linguaggio corporeo della prostituta (cf. Lc 7,37‐38.44‐47), il linguaggio espresso dalla donna emorroissa con il fugace tocco del suo mantello (cf. Mc 5,25‐44; Lc 8,43‐48), il linguaggio sconnesso di tanti malati di mente. Più in generale, quando incontrava l’altro colpito da ogni sorta di malattia, Gesù si prendeva cura di tutto l’uomo – nella sua unità di corpo, psiche e anima –, fino ad «assumere le nostre debolezze e ad addossarsi le nostre malattie» (cf. Mt 8,17; citazione di Is 53,4). Sì, Gesù era veramente un uomo di compassione, capace di sentire‐con fino a patire‐con, dunque un uomo per il quale ogni relazione era aperta alla comunione.
Solo avvicinandoci all’altro nel modo insegnatoci da Gesù, anche noi possiamo vivere un incontro ospitale, un incontro all’insegna della gratuità e teso alla comunione. E così possiamo giungere a fare spazio non solo all’altro che vediamo davanti a noi, ma all’Altro per eccellenza, Dio, che allora ci può veramente parlare.
d) Gesù, uomo che cerca e fa emergere la fede dell’altro
Gesù era capace di compiere un ulteriore passo per iniziare, per educare alla fede. Nel rispondere a chi incontrava, Gesù cercava la fede presente nell’altro, come se volesse risvegliare e far emergere la sua fede. Egli sapeva infatti che la fede è un atto personale, che ciascuno deve compiere in libertà: nessuno può credere al posto di un altro! Gesù sapeva che a volte negli uomini c’è l’assenza di fede, atteggiamento che lo stupiva e lo rendeva impotente a operare in loro favore (cf. Mc 6,6); era anche consapevole che ci può essere una fede non affidabile nel suo Nome, suscitata dal suo compiere segni, miracoli, come annota il quarto vangelo: «Molti, vedendo i segni che faceva, mettevano fede nel suo Nome; ma Gesù non metteva fede in loro» (Gv 2,23‐24), perché l’uomo diventa rapidamente religioso, ma è lento a credere… Gesù cercava invece in chi incontrava la fede autentica, e quando essa era presente poteva dire: «La tua fede ti ha salvato». Si noti che Gesù non ha mai detto: «Io ti ho salvato», bensì: «La tua fede ti ha salvato» (Mc 5,34 e par.; 10,52; Lc 7,50; 17,19; 18,42); «Va’, e sia fatto secondo la tua fede» (Mt 8,13); «Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri» (Mt 15,28). Ecco come Gesù rendeva possibile la fede, ecco come faceva emergere la fede già presente nell’altro: attraverso la sua presenza di uomo affidabile e ospitale, che non dice di essere lui a guarire e a salvare, ma la fede di chi a lui si rivolge. Ha scritto Benedetto XVI nel prologo della sua Enciclica Deus caritas est: All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro … con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Purtroppo noi dimentichiamo questa verità e rischiamo così di rendere sterile la nostra missione e il nostro sforzo per comunicare il Vangelo. Proprio perché il Vangelo è buona notizia, esso vuole raggiungere l’uomo nel suo cuore e suscitare in lui in primo luogo la fede nella bontà della vita umana, in modo che egli possa intraprendere l’avventura dell’esistenza credendo all’amore. È in questo senso che Gesù insegnava che nulla resiste alla fede, anche quando essa è nella misura di un granello di senape (cf. Mt 17,20; Lc 17,6), «il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra» (Mc 4,31); che occorre non dubitare (cf. Mc 11,23; Mt 21,21), perché «tutto è possibile a colui che crede» (Mc 9,23); e si diceva addirittura impegnato a pregare affinché la fede di uno dei suoi discepoli, Simone, non venisse meno (cf. Lc 22,32).
e) Gesù, uomo che annuncia il Regno e si decentra rispetto a Dio
Infine, va messo in rilievo come l’educazione alla fede da parte di Gesù tenda all’annuncio del Regno di Dio, alla buona notizia che Dio regna. Gesù non faceva riferimento a se stesso, ma nell’opera di evangelizzazione appariva sempre decentrato rispetto a Dio, al Padre che, con fiducia assoluta, chiamava: «Abba, Papà» (Mc 14,36). Gesù è l’evento in cui Dio ha potuto parlare in un uomo senza alcun ostacolo! Di più, con l’intera sua vita, fatta di azioni e di parole, Gesù cercava di raccontare Dio, di rendere il Dio dei padri un euanghélion, una buona notizia distruggendo tutte le immagini perverse di Dio elaborate dagli uomini. Gesù parlava di Dio soprattutto nelle parabole, narrando vicende umane, mostrando come il Regno di Dio sia buona notizia per uomini e donne, buona notizia nelle loro storie quotidiane, reali. Attraverso la sua vita umanissima, da vero uomo, l’autentico adam voluto da Dio (cf. Col 1,15‐16), Gesù ha raccontato e annunciato Dio; ha mostrato come Dio regnava su di lui e, regnando, combatteva e vinceva la malattia, il male, la sofferenza, la morte. È per averlo visto vivere in questo modo che Giovanni ha potuto scrivere alla fine del prologo del quarto vangelo: «Dio nessuno l’ha mai visto, ma proprio lui, Gesù, ce ne ha fatto il racconto (exeghésato)» (cf. Gv 1,18). Gesù ha, per così dire, «evangelizzato» Dio, e ha mostrato l’uomo autentico, chiamato a essere a sua immagine e somiglianza. Con la sua umanità piena e non segnata dal peccato – che è sempre philautía, amore egoistico di sé –, Gesù è dunque riuscito a raggiungere l’intimo dell’uomo e a generarlo alla fede in un Dio che ama per primo (cf. 1Gv 4,10.19), un Dio il cui amore ci precede sempre, un Dio il cui amore noi non dobbiamo meritare, perché è il suo stesso essere: «Dio è amore» (1Gv 4,8.16). Ciò che Gesù chiedeva, o meglio destava in chi incontrava, era nient’altro che la possibilità di credere all’amore. Ecco il fulcro della fede cristiana: credere all’amore attraverso il volto e la voce di questo amore, cioè attraverso Gesù Cristo.
Conclusione
Educare alla fede è per la chiesa, per noi, il compito primario; ma nel tentativo di riuscirvi possiamo imboccare molte strade, alcune decisamente sbagliate, altre poco efficaci. Tutto dipende in verità, e non può essere diversamente, dalla nostra capacità di assumere la stessa pedagogia vissuta da Gesù nell’incontrare gli uomini e le donne. Anche oggi la fede può essere generata, destata, fatta emergere da chi, volendosi testimone ed evangelizzatore di Cristo, sa incontrare gli uomini in modo umanissimo; sa essere una persona affidabile, la cui umanità è credibile; sa essere presente all’altro, sa fare il dono della propria presenza; sa, in un decentramento di sé, fare segno a Gesù e, attraverso di lui, indicare Dio, il Dio che è amore. Può darsi – come molti affermano – che oggi il discorso su Dio lasci gli uomini indifferenti: io stesso penso che questa osservazione contenga del vero. Può darsi che oggi «la chiesa» – come scriveva quarant’anni fa il teologo Joseph Ratzinger – «sia divenuta per molti l’ostacolo principale alla fede»15. Ma rimane vero che gli uomini sono sensibili all’avere fede o al non avere fede nell’amore, al credere o non credere all’amore, perché da questo dipende il senso dei sensi della vita. Resto convinto che ancora oggi molti ci chiedono: «Vogliamo vedere Gesù!» (Gv 12,21), perché sentono che la sua umanità li riguarda, li intriga, li interroga. Ma noi cristiani, noi chiesa, sappiamo rispondere a questa domanda, a questo anelito profondo, oppure non lo ascoltiamo, lo evadiamo? Forse noi per primi non sappiamo vedere Gesù, oppure lo conosciamo poco. Sappiamo noi cristiani che tutto quello che possiamo conoscere di Dio ce lo ha narrato Gesù Cristo? Sappiamo che nessuno ormai può andare a Dio se non attraverso di lui (cf. Gv 14,6)? Se verifichiamo tanta sterilità nel nostro educare gli altri alla fede, perché non ci impegniamo noi per primi a essere ri‐educati alla fede, attraverso l’incontro con Gesù? «Ciò che Gesù aveva di eccezionale non era di ordine religioso, ma umano» (Joseph Moingt): egli, la vera «immagine del Dio invisibile» (Col 1,15), a somiglianza del quale siamo stati creati e diventiamo uomini, ci ha insegnato a vivere in questo mondo (cf. Tt 2,12), ci ha lasciato delle tracce umanissime sulle quali camminare per essere suoi fratelli e figli di Dio.
Dobbiamo soltanto credere all’amore che lui, Gesù, ha vissuto «fino alla fine», fino all’estremo (cf. Gv 13,1). Questa è la nostra fede cristiana.
Enzo Bianchi

Sovente mi ritrovo a ridire una poesia di William Wordsworth
imparata da piccolo da mia nonna ormai vecchia:
“Se nulla può far che si rinnovi all’erba il suo splendore
e che riviva il fiore
della triste sorte non ci dorremo
ma ancor più saldi in petto godremo di quel che resta!”
Enzo Bianchi

Enzo Bianchi è nato a Castel Boglione (AT) in Monferrato il 3 marzo 1943. Dopo gli studi alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino, alla fine del 1965 si è recato a Bose, una frazione abbandonata del Comune di Magnano sulla Serra di Ivrea, con l’intenzione di dare inizio a una comunità monastica. Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle, ha scritto la regola della comunità la quale è giunta a contare novantadue membri tra fratelli e sorelle di cinque diverse nazionalità ed è presente, oltre che a Bose, anche a Gerusalemme (Israele) (1981-2016), Ostuni (BR), Assisi (PG), Cellole-San Gimignano (SI) e Civitella San Paolo (RM). È stato priore della comunità dalla fondazione fino al 25 gennaio 2017.
Nel 1983 ha fondato la casa editrice Edizioni Qiqajon che pubblica testi di spiritualità biblica, patristica, liturgica e monastica. Nel 2000 l’Università degli Studi di Torino gli ha conferito la laurea honoris causa in “Scienze Politiche” e nel 2016 anche l’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo gli ha conferito la Laurea Honoris Causa.
• Membro a vita del Consiglio della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna
• Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani
• Membro dell’Académie Internationale des Sciences Religieuses (Bruxelles)
• Membro dell’International Council of Christians and Jews (Londra)
• Membro della redazione della rivista teologica internazionale Concilium
• Membro della redazione della rivista biblica Parola Spirito e Vita, di cui è stato Direttore fino al 2005
• Collaboratore dell’Osservatore Romano Opinionista e recensore per i quotidiani La Stampa, La Repubblica
• Redattore delle riviste Jesus e Vita Pastorale
Ha insegnato teologia biblica alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Membro del Consiglio del Comitato cattolico per la collaborazione culturale con le Chiese ortodosse e orientali del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, ha fatto parte della delegazione nominata e inviata da papa Giovanni Paolo II a Mosca nell’agosto 2004 per offrire in dono al patriarca Aleksij II l’icona della Madre di Dio di Kazan. Ha partecipato come “esperto” nominato da papa Benedetto XVI ai Sinodi dei vescovi sulla Parola di Dio (ottobre 2008) e sulla Nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana (ottobre 2012). Papa Francesco l'ha nominato "uditore" (con possibilità di intervento) al Sinodo dei vescovi sui Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale (ottobre 2018).
Nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. Nel 2007 ha ricevuto il “Premio Grinzane Terra d’Otranto”, nel 2009 il “Premio Cesare Pavese” e il “Premio Cesare Angelini” per il libro Il pane di ieri, nel 2013 il “Premio internazionale della pace”, nel 2014 il “Premio Artusi”, nel 2016 il "Premio Europeo Emmanuel Heufelder per l’opera di Ecumenismo e Dialogo". Dal 2014 è cittadino onorario della Val d’Aosta e di Nizza Monferrato, dal 2017 della città di Palermo. Nel 2019 ha ricevuto il premio Resistenza Città di Omegna, e il premio Persona Fraterna dalla diocesi di Lanusei. Nel 2022 ha ricevuto il Premio letterario Giampaolo Rugarli.
Nadia Toffa portavoce dei deboli



L'abbraccio più grande. Nadia Toffa e la fede: così imparò a vivere per saper morire
Don Maurizio Patriciello
«Voglio imparare. Il tempo stringe e io debbo imparare. Imparare a vivere per saper poi morire». Nella vita non sempre ci rendiamo conto dell’importanza del dover imparare a vivere. Si vive e basta. Un fatto scontato, istintivo, naturale. E questo è grande errore. Sono passati pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice tv bresciana, che ha scosso l’Italia. In tanti ci siamo chiesti il perché. Qualcuno, grossolanamente, ha liquidato la faccenda parlando di una sorta di reazione emotiva. Le emozioni hanno la loro importanza, non c’è dubbio, ma da sole dicono ben poco.
La parabola di Nadia Toffa – discendente secondo una logica solo umana; ascendente secondo la logica di Dio – inizia da lontano, da quando per le prime volte la vedemmo affacciarsi sullo schermo. Una ragazza bella, slanciata, cocciuta, intraprendente. Schietta, brava, coraggiosa. I più giovani si specchiavano in lei, magari con un pizzico di benevola invidia. I più anziani la consideravano alla stregua di una figlia da proteggere. Una giovane destinata al successo, Nadia. Simpatica, brava, coinvolgente. Sarebbe arrivata lontano. Una mattina, come un fulmine a ciel sereno, in un albergo di Trieste, perse i sensi. Sarebbe stata lei stessa, mesi dopo, a confessare di avere il cancro. I telespettatori rimasero sconcertati.
Cancro, parrucca, chemio, sono parole da esorcizzare, lei invece ne parlava con serenità. Era finta, calcolata, per chissà quali scopi quella serenità, o faceva sul serio quella giovane giornalista? No, Nadia, non stava barando, non era capace di barare. In lei si specchiarono migliaia di ammalati di cancro, i loro parenti, i loro amici. E ancora una volta, Nadia accettò di diventare la portavoce dei malati. Un popolo al quale non sempre i cosiddetti sani assicurano la giusta comprensione e i diritti cui hanno diritto.
Nadia capì che le veniva chiesto molto perché molto le era stato dato. Accolse come una sorta di "vocazione" il male che l’affliggeva e dal quale fece di tutto per guarire. Intanto, però, da quel male si lasciava ammaestrare. Nulla doveva andare perduto. Dalla sofferenza imparava. E le giornate, quando il dolore le dava tregua, le sembrarono più lunghe, le sere più dolci, il cielo più azzurro, gli amici più cari. Imparò che tutto viene da Dio. E gridò al mondo la sua fede. «Dio non è cattivo, credetemi, Dio non è cattivo». Nadia, inchiodata in un letto di dolore, stava evangelizzando il dolore.
Con Dio iniziò a dialogare e litigare, come sapeva fare lei, cocciuta, ma mai cattiva. E comprese che la preghiera, da noi cristiani tante volte trascurata quando la vita ci sorride, era un "abbraccio". L’abbraccio caldo e rassicurante di Dio alla sua creatura. E volle comunicare ai fratelli in umanità la scoperta fatta. Imparava a vivere, Nadia. O, meglio, andava perfezionando la lezione iniziata tanti anni prima. Imparò ad amare la vita anche nei giorni del dolore. Capì che la Nadia di un tempo andava sfiorendo, non sarebbe tornata più. Ma non ne fece un dramma.
Con lei ho avuto un rapporto limpido, onesto, discreto, che si è andato intensificando negli ultimi mesi. «Continuo la chemio e non mollo. Sorrido e accetto tutto quello che Dio ha disegnato per me. Porto nostro Signore nel cuore e vedremo cosa deciderà per me. Porgo la mia anima vicino al suo immenso cuore. Grazie di esistere, padre. Le voglio bene».
Per gli auguri di Natale, le scrissi: «Nasconditi, Nadia sempre cara, come un uccellino, nelle fenditure della Roccia. La tempesta, il freddo, la neve, il gelo, le raffiche di vento, nulla potranno contro la Roccia che ti ripara. Lasciati cullare come un bambino sul seno della mamma. Non opporre resistenza. Dio è più grande del nostro povero cuore. Ti ama. Sei sua. Gli appartieni. Ti brama. In questa certezza, riposa». Poche ore dopo, la brillante giornalista, chiamandomi per la prima volta col solo nome di battesimo, rispondeva: «Grazie, Maurizio. Mi metterò al riparo tra le sue braccia. Io non ho paura per me ma per la mia cara mamma».
Papa Paolo VI, bresciano come lei, ci disse che «il mondo, oggi, non ha bisogno di maestri ma di testimoni». Nadia Toffa lo è stata. Per questo l’Italia intera ha pianto la sua morte e continua a volerle bene.
Michela Murgia credente inquieta con la sete di assoluto


Michela Murgia. Ribelle sì, ma non senza causa
Gennaro Ferrara
Il ricordo del giornalista e presentatore di Tv2000: "Era il 2001, finiva il triennio di Azione Cattolica e le chiesi 'cosa farai'?". Mi rispose: "Farò l'allevatrice di lumache"
Era il 2001, Michela non era ancora famosa. Ci trovavamo al termine di un triennio in Azione Cattolica, che ci aveva visto lavorare insieme: lei come responsabile dei giovani della Sardegna, io come responsabile nazionale. “Che farai ora?”, le chiesi. “Farò l’allevatrice di lumache”, mi rispose. La salutai frastornato da un misto di nostalgia anticipata (pensavo infatti che difficilmente ci saremmo rivisti) e di rabbia (ma come è possibile – riflettevo – che una persona di così grande talento non trovi altro spazio nel nostro paese che quello di allevare gasteropodi?). Fortunatamente mi sbagliavo su entrambi i fronti: il talento di Michela è esploso rapidamente e io ho avuto la fortuna di continuare a frequentarla. Non credo che Michela abbia mai allevato lumache, di mestieri però ne ha fatti tanti: i più noti sono quelli di portiere di notte in un albergo e di venditrice attraverso un call center.
C'è una costante però nelle diverse vite (la definizione è sua) che ha vissuto: quella di brillare e illuminare. Così quando lavorava in albergo ha incontrato Vinicio Capossela e insieme hanno registrato un brano a due voci, che spero un giorno avremo modo di ascoltare; il racconto dell'esperienza nel call center invece è diventato il suo primo grande successo letterario, quello che le ha aperto nuove e inaspettate vite: scrittrice, sceneggiatrice, saggista, attivista, candidata alla presidenza della regione Sardegna e tante altre ancora. Quando le ricordavo quello che pensavo sarebbe stato il nostro ultimo dialogo, lei spiegava tutto con una metafora da campagna sarda: ho fatto la mossa del topo, quello che costretto in un angolo da una scopa, non avendo più vie di fuga, per evitare il colpo ferale, aggredisce.
Ecco allora un'altra costante che ho trovato in Michela dagli anni giovanili ad oggi: la ribellione. Parola quest'ultima che però non va fraintesa. Michela sulla scena pubblica è stata troppo spesso interpretata come una barricadera, un'icona di posizioni ideologiche di un'area ben precisa. Un ritratto falso e semplicista questo, che non dice nulla di chi è stata Michela Murgia. Torno alla metafora del topo: Michela ha lottato per quelli che via via ha ritenuto fossero i più deboli, lo ha fatto con la forza delle sue parole, della sua prorompente personalità, a volte in maniera urticante, nella società come nella Chiesa, ma non è mai stata un'intellettuale da salotto. Le battaglie che ha sostenuto (al di là della valutazione di merito che ciascuno di noi può dare) le ha fatte sulla base di una ricerca, di uno studio, mai attraverso scorciatoie ideologiche. Michela si è esposta e ha pagato di persona. Michela ha detto parole dure non per odio verso qualcuno, né per compiacere circoletti intellettuali, Michela ha parlato in coscienza e consapevolezza, attirandosi per questo, oltre ad ammirazione, anche l'odio di molti. Circostanza per cui ha sofferto. Il sogno di trasferirsi in Corea, coltivato negli ultimi anni, veniva proprio da questo: dalla sofferenza di essere insultata, magari mentre era in fila al supermercato, in ragione delle sue idee.
C'è poi un'altra dimensione meno conosciuta di lei che, per questo, vale la pena di raccontare: quella della fede. Michela ha studiato teologia, animata da quella che Ignazio chiamava la santa inquietudine. Michela ha polemizzato e fatto a botte con la religione, non con la fede che mai ha rinnegato. Michela è stata un'intellettuale credente che ha provato sempre, nella sua coscienza come nelle pagine scritte, a far dialogare la cultura e le istanze del nostro tempo con il Vangelo, con tutta la fatica e le incongruenze che questo comporta. Non spetta a nessuno giudicare il suo percorso, per quanto mi riguarda sento di ringraziarla anche per la testimonianza, profondamente evangelica, di come ha vissuto la malattia, per averci dimostrato, come ha scritto Chiara Valerio, che “i legami tra le persone sono più persistenti delle persone stesse” e per averci lasciato una delle più belle definizioni di Paradiso che mi sia toccato di ascoltare: “una comunione continua senza intervalli”.

La vita, la teologia e le polpette. Un ricordo di Michela Murgia
Marinella Perroni
Il 10 agosto è morta, a 51 anni, la scrittrice Michela Murgia. Ne pubblichiamo un ricordo personale della teologa Marinella Perroni.
L’ultimo suo post su Instagram è stata una piccola ode alle polpette. Ho scaricato Instagram negli ultimi mesi solo per seguire lei, perché mi aveva detto che era quello il modo che aveva scelto per restare in contatto con tutti coloro che le volevano bene, le erano cari, la seguivano. E io mi sono sempre sentita soltanto una dei tanti, innumerevoli, suoi amici. Per me, però, averla conosciuta è stata anche una sorta di “grazia di stato”. Sì, dato che la passione per la riflessione teologica è sempre stato uno dei fili portanti delle nostre, purtroppo rare, ma lunghissime conversazioni. Perché per Michela fede e teologia non potevano che convergere, l’una a sostegno e garanzia dell’altra, ma anche l’una in grado di far deflagrare l’altra.
Lei lo ha raccontato diverse volte nei suoi libri. Ci siamo conosciute quando ancora intorno a lei non si era andato raccogliendo il mondo intero, scrittori e stilisti, scienziati e politici, intellettuali e giornalisti. E, con loro, un numero incalcolabile di “amici” che hanno goduto della sua capacità davvero unica di esprimere in parole acute e taglienti, scevre da qualsiasi preziosismo, la sua intelligenza delle cose, del mondo e delle persone. Una intelligenza limpida, che andava alla velocità della luce, che mai si piegava al male della banalità, che sempre intravvedeva la ricaduta politica di ciò che siamo e facciamo.
Era la sera dell’8 marzo 2010 e da un paese della provincia di Nuoro di qualche centinaio di abitanti mi avevano invitato a tenere una tavola rotonda su “donne e chiesa”, uno dei tormentoni che va avanti ormai da decenni. Mi avevano contattato dicendomi che, accanto a due teologhe che venivano dal continente (insieme a me c’era Cristina Simonelli), ci sarebbe stata una giovane scrittrice sarda.
Michela aveva 38 anni e per 13 anni — tanti per quanto è stata capace di darmi, troppo pochi per quanto mi avrebbe potuto ancora regalare — mi ha fatto sentire sempre la sua presenza, anche se riuscivamo a vederci troppo poco. Era questa la sua forza: esserci con tutta la potenza della sua vitalità, sapendo che nessuna lontananza può mai dividere ciò che Dio ha unito. Perché per lei le relazioni erano espressione di Dio: non avrebbe certo potuto scrivere in God Save the Queer quelle pagine davvero magiche di teologia trinitaria se non avesse fatto questa esperienza di Dio e degli umani. Una Trinità che si espande a dismisura in tutto ciò che uomini e donne fanno per rendere il mondo degno di loro, ma anche di Dio.
Poi è venuta Accabadora, la sorpresa di Ave Mary in risposta a una mia richiesta che pensavo ormai archiviata dato il suo prorompente e incalzante successo. Mai però in lei il successo ha avuto il sopravvento sulle relazioni. Poi sono venuti tutti gli altri libri di cui, a volte, mi leggeva lei stessa capitoli interi. Ultimamente, anche passando ore sedute al tavolino del ristorante Il cambio, a Trastevere, dove si sentiva tra amici fraterni, protetta almeno un po’ dalla cattiveria che le si rovesciava contro giorno dopo giorno in modo direttamente proporzionale a ogni sua parola pubblica.
Era diventata instancabile: la “causa” per la quale investiva tutte le sue energie, cioè non rinunciare mai alla qualità politica di ciò che siamo, pensiamo, diciamo e facciamo, era per lei fuoco che brucia senza consumarsi perché la vita genera sempre altra vita. Questo era il “credo politico” di Michela e lei sapeva, per di più, che il tempo si era fatto breve. Paradossalmente — ma non per lei — la malattia non l’aveva vinta ma le aveva piuttosto fatto accelerare il ritmo. E ha voluto mangiare tutti i frutti che la vita le ha messo tra le mani, li ha saputi gustare perché avevano il sapore della complessità della vita.
Le polpette, sì. «Metafora del queer», così le chiama in quell’ultimo saluto con cui si è congedata dalla vita. Perché tra le tante cose che Michela ha insegnato ai suoi figli c’è anche l’arte del cucinare. Michela cara, anche per me sarà sempre metafora quel piatto di spaghetti con mazzancolle e zucchine che hai imbandito per me il sabato di Pasqua di quest’anno e che ci siamo gustate, sedute nella mia cucina a parlare di morte e risurrezione. Metafora della vita, della fede, dell’amicizia. Ma anche del dolore e del mistero.
di MARINELLA PERRONI
FONTE: L’OSSERVATORE ROMANO

Era credente, e non ne aveva mai fatto mistero. Non le dispiaceva definirsi "teologa". La sua simpatia per papa Francesco non aveva niente di ideologico. Il ricordo di chi l'ha conosciuta da vicino
L'ultima volta che ci siamo visti, Michela Murgia aveva appena donato a papa Francesco una copia della rivista di cui era stata direttrice per un solo numero. In copertina c’era lei, elegantissima e sorridente come sempre appariva da quando, nel maggio scorso, aveva deciso di rendere pubblica la fase terminale della sua malattia. “Aspetta, ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, aveva detto mentre cercava uno sgabello. Era affaticata ma orgogliosa: di quel giornale che era diventato un manifesto delle sue convinzioni (“La famiglia è di tutti”, annunciava il titolo principale) e del fatto di averlo potuto consegnare nelle mani del Papa che proprio lei, conosciuta come iconoclasta, aveva difeso dalle accuse piovutegli addosso all’indomani dell’elezione (a proposito di titoli, quel “Bergoglio e pregiudizio” scelto per sintetizzare le sue posizioni resta memorabile).
Michela Murgia era credente e non ne aveva mai fatto mistero. Fin dal suo libro di esordio, Il mondo deve sapere del 2006, non le dispiaceva definirsi teologa, una qualifica poi rivendicata in modo militante attraverso i suoi saggi, in particolare Ave Mary del 2011 e il controverso “catechismo femminista” God Save The Queer del 2022. Non erano mere provocazioni, anche se come tali si è cercato di farle passare. Tutto sommato, anche a Michela Murgia sarebbe convenuto metterla sul piano del paradosso intellettuale, dell’esagerazione argomentativa. Alla peggio, la si poteva buttare in politica, che in certi casi è il modo migliore per chiudere il discorso. Il punto è che la narratrice di Accabadora (il suo libro più celebre e compiuto, pervaso da un’incombenza del sacro per la quale è difficile trovare corrispettivi nella recente letteratura italiana) non si limitava a essere orgogliosa. Era anche una persona esigente, con gli altri e con sé stessa, con la propria scrittura e con le proprie convinzioni, sempre messe alla prova. Prendeva sul serio la fede e proprio per questo si aspettava molto dalla Chiesa.
La sua simpatia nei confronti di Francesco non aveva niente di ideologico. Era la condivisione intima e istintiva di una dottrina della misericordia dalla quale nessuno, per nessun motivo, può sentirsi escluso. Su questi, che erano i temi che più le stavano a cuore, sapeva essere polemica come sono a volte gli adolescenti, che alzano la voce e sbattono le porte solo per essere sicuri di essere amati nonostante tutto, senza condizioni. A volte esagerano, d’accordo, ma hanno dalla loro la certezza che un amore che ponga condizioni semplicemente non è amore.
Di tutto il resto si può discutere, ma a questo desiderio di assolutezza non si può né si deve aggiungere nulla. “Ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, diceva Michela Murgia l’ultima volta che ci siamo visti. Ne abbiamo bisogno tutti, sempre, solo che spesso non abbiamo il coraggio di ammetterlo. Lei, invece, non ha voluto nascondere la sua fragilità finale. “Voglio andare avanti così, fino alla fine”, ripeteva. “Riesco a scrivere solo quando mi sento minacciata, quando il cuore mi impazzisce per la paura”, aveva confidato in un’altra occasione. Non so se fosse intenzionale, ma stava citando san Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, “quando sono debole, è allora che sono forte”. È una bella definizione della fede. Senz’altro, è la definizione migliore per la fede di Michela Murgia, che sorrideva al Papa e si aspettava tanto – tutto – dalla Chiesa.
Padre Paolo Dall'Oglio...maestro di umanità
Essere prete nella Chiesa in dialogo

“Per ragioni che hanno a che vedere con l’impegno della mia vita, questa è una guerra civile che lacera la mia anima. Vorrei fare qualcosa per fermarla… Ma non voglio vivere una vita che sia altro da un dono radicale”
Paolo Dall'Oglio


Padre Paolo Dall’Oglio: un messaggio che vive
Cade oggi il compleanno del gesuita, sequestrato in Siria nel 2013. Nell’occasione, la sua famiglia torna a chiedere verità verso di lui e verso migliaia di persone rapite e di cui da tempo non si sa più nulla
Benedetta Capelli
Sessantasei anni, gli ultimi sette dei quali lontano dalla famiglia, dalla sua comunità di Deir Mar Musa, il monastero fatto rinascere in Siria e divenuto espressione della cultura della convivenza, del dialogo e della riconciliazione. Oggi è il compleanno di padre Paolo Dall’Oglio, scomparso a Raqqa nel luglio 2013. “Sette anni lunghi e dolorosi – scrive la sorella Francesca in un messaggio - anche se sempre accompagnati dalla consapevolezza che Paolo si sentiva chiamato ad una missione che sentiva profondamente dentro di sé”. Missione che aveva ben definito nel suo libro “Collera e luce. Un prete nella rivoluzione siriana”:
“Per ragioni che hanno a che vedere con l’impegno della mia vita, questa è una guerra civile che lacera la mia anima. Vorrei fare qualcosa per fermarla… Ma non voglio vivere una vita che sia altro da un dono radicale”
Sete di verità
E’ in questa occasione che la famiglia di padre Paolo intende ribadire l’importanza della verità nella vicenda del gesuita e per la sorte di “migliaia di siriani scomparsi perché arrestati, sequestrati o peggio, uccisi”. Una domanda di verità all’Italia e alla comunità internazionale che è un diritto per chi chiede risposte e un dovere da assolvere. Solo nella verità, infatti, si possono “innestare i semi dell’armonia”, “gettare le basi per una futura pacificazione”, “guarire tutte le ferite che in questi nove anni di conflitto si sono aperte”.
Padre Dall'Oglio: 7 anni di silenzio tra dolore e speranza
“Riportare a casa – scrive Francesca Dall’Oglio - chi è ancora segregato e dare sepoltura a chi è stato ucciso, offrire finalmente sollievo alle famiglie che da anni aspettano, è un dovere che chiama in causa anche i Paesi occidentali”. Solo nella comprensione di quanto accaduto si può continuare a camminare sulla strada della speranza che viene, oggi, anche dalle recenti liberazioni di Silvia Romano, Padre Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, “tutte persone – evidenzia la sorella di padre Paolo - su cui le speranze cominciavano a indebolirsi”.
Ed è con questo tipo di ottimismo che si rinnova l'appello a non lasciare intentata nessuna strada. Sarebbe il più bel regalo che si potrebbe fare a Paolo e al suo impegno per l'armonia su questa terra.

Paolo Dall'Oglio, maestro di umanità
«Prendersi cura di una persona di qualsiasi classe sociale, simpatia o pesantezza, aveva la precedenza su tutto, perfino sull’appuntamento della preghiera. Paolo aveva davvero a cuore le persone, che considerava sacre perché espressione diretta di Dio». Padre Jihad Youssef, 47 anni, è il superiore della comunità monastica di Deir Mar Musa al-Habashi (monastero di San Mosè l’Abissino) in Siria, fondata nel 1991 da padre Paolo Dall’Oglio.
Al gesuita, di cui non si hanno notizie dal 29 luglio 2013, quando venne rapito da un gruppo di estremisti islamici vicino ad al-Qāida, è legato in maniera indissolubile: «In me, Paolo, tu vivi», scrive nella toccante prefazione al libro Paolo Dall’Oglio. Il mio testamento, appena pubblicato dal Centro Ambrosiano. «In noi, tua comunità, tuoi amici, sei vivo. Uno come te, Paolo, non può morire. Anche se fossi morto nel corpo, rimani vivo in Dio».
L’INCONTRO CON DIO
La vita di padre Youssef è stata del tutto trasformata dall’incontro con la comunità di Mar Musa. Siriano, originario della Chiesa maronita, da ragazzo Jihad fa parte dei giovani del gruppo di preghiera Equipes Notre Dame.
«A 19 anni siamo stati a Mar Musa trascorrendo lì una notte in un ambiente primitivo, non c’era nemmeno l’elettricità. Abbiamo celebrato Messa e il Signore mi ha pescato: il mio cuore non è più tornato a casa», ricorda. «Dopo qualche mese sono stato nuovamente a Mar Musa e ho confidato a padre Paolo il desiderio di diventare monaco.
Siamo rimasti d’accordo che prima avrei portato a termine gli studi». Il tempo di concludere il corso di laurea in Scienze motorie e Jihad, violino e zaino in spalla, è di nuovo a Mar Musa: «Volevo fare il ragazzo di mondo, tutto muscoli e musica, ma a casa non ero più in pace: sono tornato al monastero il giorno dopo la laurea». Accolto a Mar Musa nel 1999, nel 2008 diventa sacerdote. Studia poi Sacra Scrittura al Pontificio istituto biblico di Roma e consegue il dottorato in Teologia biblica alla Gregoriana.
LA VITA COMUNITARIA
Gli anni con padre Paolo lo formano come uomo e come cristiano. E se la comunità di Mar Musa è consacrata al dialogo islamo-cristiano, padre Youssef non ha remore nell’ammettere che «la vita comunitaria è in sé la sfida più grande, più grande anche del dialogo interreligioso»:
«La comunità è la fornace che ci purifica dai nostri limiti e iniquità, è il posto dove nascono le difficoltà e in cui germoglia l’armonia. Paolo non desiderava l’obbedienza cieca quanto il confronto, non aveva segreti e capitava che ci riprendesse davanti a tutti. La trasparenza nelle relazioni era per lui la via per non accumulare nel cuore amarezza e rammarico. Credeva poi fermamente nell’uguaglianza fra tutti: uomini e donne, grandi e piccoli, forti e deboli, intellettuali e no, superiori e novizi».
L’esperienza comunitaria – prosegue il monaco – è scuola di vita: «Essere superiore costa fatica e chiede tanta disponibilità, d’altra parte non siamo stati battezzati per riposare ma per servire. Il nostro desiderio è rimanere a Mar Musa fino alla seconda venuta di Cristo, portando avanti ciò che il Signore ha seminato nei nostri cuori, lavorando sulla nostra vita spirituale in comunità. Il combustibile è la grazia del Battesimo, che ci dà la forza di sopportare una vita gomito a gomito con persone diverse da noi».
PADRE PAOLO, UNO SPIRITO LIBERO E PROFONDO
Nato a Roma nel 1954, padre Paolo Dall’Oglio entra nella Compagnia di Gesù a 21 anni. Dopo trent’anni in Siria al lavoro per il dialogo interreligioso, nel 2012 è espulso dal Paese per le sue posizioni contro il regime. L’anno successivo rientra due volte in Siria impegnandosi nelle trattative per la liberazione di alcuni ostaggi fra cui due vescovi, uno siro-ortodosso, l’altro greco-ortodosso. Di lui non si hanno più notizie dal rapimento, il 29 luglio 2013 a Raqqa. Lo scorso ottobre la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sul sequestro per l’impossibilità di accertarne la sorte dal punto di vista giudiziario. «Uno sguardo non fondamentalista, ma lieve, pieno di quella speranza che non delude perché riposa in Dio. Sempre aperto al sorriso»: così papa Francesco parla di lui nella prefazione a Paolo Dall’Oglio. Il mio testamento (Centro Ambrosiano), ricordandolo come uno «spirito libero» con «grande profondità di visione».
IL LASCITO DI PADRE PAOLO
Oggi la comunità di Mar Musa, che si trova a circa 80 chilometri a nord di Damasco, è composta da otto monaci, «nove con Paolo»: «Quattro monache, tre monaci e un novizio. Siamo cinque siriani, una libanese, una tedesca e uno svizzero». Fino allo scorso marzo ne faceva parte anche padre Jacques Mourad, co-fondatore della comunità, da marzo arcivescovo di Homs, Hama e Nebek.
«Noi monaci e monache abbiamo lasciato tutto per seguire Dio, ogni giorno ci chiediamo come fare per camminare verso un discepolato vero. Non bisogna aggrapparsi a piani immodificabili ma, data la velocità dei cambiamenti, rimodulabili ogni anno», spiega Youssef. «Andiamo avanti cercando di essere aperti alla grazia dello Spirito, cercando di capire che forma prenderà la fratellanza islamo-cristiana e cercando di innescarla, ad esempio, con progetti per i giovani e l’ambiente».
A Mar Musa la giornata comincia con il caffè delle 7. «Prima ciascuno prega, legge o medita. Poi alle 7.30 recitiamo le Lodi e ci intratteniamo per un’ora di catechismo», racconta ancora Youssef. Ed è proprio in questi momenti di catechesi che, fra il novembre 2011 e il giugno 2012, padre Paolo commentò la Regola di Mar Musa.
Le riflessioni di allora oggi sono raccolte nel già citato Il mio testamento. «In quelle conferenze Paolo desiderava consegnare a noi, e alla Chiesa, l’essenza del suo pensiero. Ci intrattenevamo per un paio d’ore: gli argomenti erano tanti, legati ai tre voti di povertà, castità e obbedienza, e al nostro carisma. A riprendere in mano Il mio testamento, emerge come al centro di tutto ci sia la relazione con Dio e come l’uomo avanzi nella maturazione dell’amore per Dio e per il prossimo.
Si riflette sul dialogo islamo-cristiano, la sacralità dell’ospite, e si affronta anche la questione antropologica: dalla sessualità alla relazione uomo-donna, dall’omosessualità alle questioni di genere, che in tante società non si vivono in modo sereno e sono un tabù anche per la Chiesa».
LA SPERANZA OLTRE LA GUERRA
Sono passati dieci anni da quando di padre Paolo si sono perse le tracce. Da allora la situazione in Siria non è certo migliorata, anzi. Nel Paese, squassato da più di dieci anni di guerra civile e dalla violenza cieca del regime di Bashar al-Assad, nonché dall’ultima disgrazia del terremoto dello scorso febbraio, le Nazioni unite stimano in oltre 15 milioni le persone che necessitano di aiuti umanitari, su un totale di 22 milioni abitanti.
«Il popolo è angosciato e depresso» commenta Youssef. «Non puoi pensare ad altro se non al pane e alla scuola dei ragazzi. Nel cuore umano la speranza c’è ancora, resiste perché siamo un popolo vivo e creativo, ma l’incertezza rende la vita un sopravvivere». Nonostante tutto, padre Youssef è un uomo sereno: «Paolo mi ha insegnato che il Signore viene prima di tutto e non c’è che un solo Signore. A tenere alta la speranza è Dio, l’immagine di Dio in noi. Non trovo altra giustificazione a questa nostra resistenza».
di Laura Bellomi
DUE LIBRI L’ATTUALITÀ DI PADRE DALL’OGLIO
Nel decimo anniversario del rapimento di padre Paolo Dall’Oglio sono stati pubblicati due libri utili per conoscere meglio la sua figura e la sua storia. Il libro Il mio testamento, a cui accenniamo nell’intervista con padre Jihad Youssef, è pubblicato dal Centro Ambrosiano con la prefazione di papa Francesco. Si tratta di un vero e proprio testamento spirituale, da cui emergono chiari i temi più cari a Dall’Oglio.Verrà presentato il 29 luglio alla chiesa di Sant’Ignazio a Roma alla presenza, tra gli altri, proprio di padre Youssef. Una mano sola non applaude di Riccardo Cristiano è invece il testo pubblicato da Àncora. Come da sottotitolo, ripercorre la storia di padre Paolo Dall’Oglio letta nell’oggi. Viene presentato il 24 luglio alle 18.30 alla Biblioteca europea di Roma alla presenza – tra gli altri – di Francesca e Immacolata Dall’Oglio, sorelle di padre Paolo, e di Jacques Mourad, arcivescovo di Homs e cofondatore della comunità di Mar Musa.
Beato Carlo Acutis..il coraggio di credere

Appunti inediti di Carlo Acutis: “Così si ascolta la voce di Dio”
CARLO ACUTIS
«Invocare Dio? Si fa presto a dire. Ci vuole tanta energia, fiducia, amore, assiduità, diligenza, sofferenza, se si vuole invocare con profitto il Signore. È vero, si può farlo spontaneamente, istintivamente, emotivamente, ma si corre il rischio di non riuscire. Si può fare un buco nell’acqua».
«Se umanamente ci si mette in ghingheri per parlare con un’autorità, perché non cercare di fare altrettanto quando ci si vuol mettere in contatto con il Signore? Certamente i canoni non sono gli stessi, ma i sistemi di approccio possono benissimo somigliarsi. Dunque rivolgersi. E come? Pensando chi? L’Essere. Un piccolo essere si rivolge all’Essere. Un finito all’Infinito. Un momento all’Eterno. Un ignorante all’Onnisciente».
Dio e il silenzio
Questo pensiero «fa tremare le vene e i polsi» a Carlo. «Mi si dice che Dio vuole essere chiamato Padre. Ha pensato l’uomo, l’ha voluto, l’ha creato, l’ha elevato e adottato. Rimescolio di sentimenti, confusione di parole, farfugliamenti, balbettii. E poi…? E poi ci si rivolge».
Il migliore modo per rivolgersi a Dio, allora, è il «silenzio». «Silenzio di eternità. Silenzio di attesa. Silenzio di amore.Grande cosa è il pregare. Accolgo dalla bocca del Signore la parola di consolazione. Parola di consolazione, parola che consola. Parola che conforta, parola che fortifica, parola che illumina, parola che riscalda, parola che rinsavisce, parola che risuscita».
La “grande grazia”
Dio, «è la verità, e questa non ha bisogno di vocaboli, si esprime da sé. Da sé rivela ogni verità. La voce dell’uomo è aspra, è prepotente, è arrogante, è superba, è impaziente, è intrattabile, è violenta. Avvezzarsi alla voce di Dio è una grande grazia. Significa dare retta alla Verità».
«Allora l’intelligenza, il cui oggetto è il vero, viene a trovarsi nella sua area, consuona finalmente con il Cielo. Si fa cittadina ante tempus dell’Eternità. Sostanziandosi di verità, l’intelligenza viene ad essere potenziata al massimo e al meglio; raggiungendo il suo scopo viene a trovarsi in zona di ricezione dell’Infinito. La verità diventa il suo cibo, la sua bevanda».
«Bisogna convincersi che Dio da sempre comunica con noi e vuole essere sempre in contatto con noi. Se questo invito a comunicare con Lui è vero perché non accettarlo? Rispondiamo a questo invito. Come? In ogni maniera. Quando? Sempre. Dove? Ovunque. Per quanto? Per sempre. Attivare il contatto è facile, quasi istintivo Tendere l’orecchio, cioè lo spirito, e ascoltare e parlare al momento giusto e non interrompere, lasciar parlare, dialogare, colloquiare, essere presenti, essere disponibili».
“Gesù mi invita a lasciare tutto e farmi suo seguace”
Fuori del Signore, osserva il giovane beato, «è rumore, scompiglio, lite, guerra. Con Dio tutto è ordine, tutto è in ordine. Dio è l’Essere e con l’Essere la vita. Non l’esistenza, che è un qualcosa a tempo, al limite, ma la vita che è essere in eternità. Che altro sono le cose corporali se non illusioni? E a che gioveranno tutte le creature se sarai abbandonato dal Creatore? Gesù mi invita a lasciare tutto e a farmi suo seguace. Gesù Cristo ci parla dentro e dovremmo ascoltarlo e seguirlo in tutto».
Le altre voci sono veramente nulla, inane è il loro esistere. Vibrazioni d’aria, sollecitazione al nulla, sollecitazioni da nulla. La coscienza svegliata dalla voce di Dio si sente estremamente interessata perché capisce che si è nel vero e che bene si fa ad ascoltarla e seguirla. Seguire questa voce è impostare l’esistenza in direzione della vita eterna.
Ci sono vite che scorrono, apparentemente normali. E ci sono vite eccezionali. Quello che sorprende di più, nella storia di Carlo, è come abbia saputo essere profondamente originale: offrendo a tutti quelli che lo hanno conosciuto il ritratto di un’eccezionale sorridente normalità.
Carlo era un ragazzo come tutti gli altri, e allo stesso tempo faceva cose fuori del comune. Senza apparente sforzo, senza alcuna contraddizione. Suonava il sassofono, e – ancora giovanissimo – insegnava catechismo ai bambini. Giocava a pallone con gli amici, e un’ora dopo faceva volontariato alla mensa dei poveri dei Cappuccini e delle suore di madre Teresa.
Si divertiva con i videogiochi, e insieme usava Internet per fare opere di apostolato. Guardava polizieschi e girava filmini con i suoi cani e i suoi gatti, e soccorreva i più sfortunati del quartiere. Progettava programmi al computer e aiutava gli altri bambini in difficoltà con i compiti.
Illuminato, acceso, animato da una fede straordinaria e che aveva vissuto fortissima fin da bambino. Che ha fatto di lui un esempio, capace di coinvolgere e ispirare gli altri all’azione. E che oggi porta la Fondazione Carlo Acutis a volerne valorizzare la testimonianza e l’eredità morale e spirituale. In coerenza con quegli stessi valori senza tempo che al giovane Carlo erano stati insegnati in casa: da sempre parte di una storia di famiglia, oggi tradotti su più vasta scala dall’azione sociale della Fondazione Carlo Acutis.

Intervista alla madre del beato. Carlo Acutis: Dio è semplice. Anzi semplicissimo
Roberto I. Zanini
Dio è semplice. Anzi, Dio è semplicissimo. Incontri i santi e ti rendi conto proprio di questo. Non serve cultura, non serve teologia, non serve particolare preparazione. Dio è lì che ti aspetta e non devi desiderare altro che di accoglierlo nel tuo cuore. Carlo Acutis diceva che «il santo vive la semplicità», la nostra società, invece, ci riempie di inutili sovrastrutture che impediscono di essere semplici, spesso, anzi, ci rendono superbi. Così superbi da ritenere, più o meno consciamente, che semplice faccia rima con sprovveduto e l’umile vada a braccetto con l’ingenuo. «Mio figlio Carlo era semplicissimo», sottolinea Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis. Una semplicità immediata che si traduceva tale e quale nella sua relazione con Dio: «Diceva che Gesù è alla portata di tutti, si incontra nell’essenzialità e la vicinanza di Carlo con Gesù era immediata e forte al tempo stesso. Più siamo semplici più diventiamo capaci di vederlo, ma anche di mostrarlo». «E se lei mi chiede del volto di Dio, posso dire di averlo incontrato attraverso Carlo, che mi ha mostrato un Gesù misericordioso, accogliente. Un Gesù dal cuore grande come nelle apparizioni di Margherita Maria Alacoque. Vedeva Dio negli ammalati, nei poveri. Chiunque incontrava era il suo Volto».
Antonia Salzano Acutis quando comincia a parlare di suo figlio non conosce ostacoli narrativi o verbali. Le parole fluiscono precise ed efficaci al ritmo del pensiero e di frequenti associazioni di idee. In qualche modo è l’impressione che si ha leggendo il libro scritto da lei stessa con Paolo Rodari "Il segreto di mio figlio" (Piemme, pagine 299, euro 17,90). La differenza è che di persona ci si rende subito conto che quel segreto (se ci può essere segreto nella vita di un santo) è destinato a svanire alle prime battute, nel sorriso coinvolgente di questa mamma, che è davvero difficile non incrociare con quello sereno e penetrante delle foto di suo figlio. Soprattutto se hai la ventura di incontrarla nel giardino del nascente "Centro Carlo Acutis", sulla strada che dalle mura di Assisi sale all’Eremo delle Carceri. Un luogo per l’accoglienza e l’accompagnamento all’incontro con Dio, voluto dalla famiglia Acutis così che possa diventare una sorta di estensione della spiritualità di Carlo che della città di san Francesco era innamorato. Di fronte, a perdita d’occhio, c’è la piana che si stende sotto Assisi con i luoghi in cui iniziò l’avventura francescana, da Santa Maria degli Angeli con la Porziuncola ai tuguri di Rivotorto. Entusiasmo e concretezza. Esattamente come il modo in cui la mamma racconta del figlio: «Per lui niente accadeva per caso, credeva nella Provvidenza. Diceva che "la conversione non è un processo di aggiunta, ma di sottrazione: meno io per lasciare posto a Dio". "Non io ma Dio". "Non l’amor proprio, ma la gloria di Dio". In questo era esigente: "A che mi giova vincere mille battaglie - diceva - se poi non sono capace di vincere me stesso?"».
Prima ha ricordato la semplicità di Carlo...
Poneva la sua vita in Dio e aveva compreso molto presto che più si è semplici meglio si riesce a vedere e mostrare il suo Volto. Il suo modo di avere fede era semplice, umile. Già a pochi anni se vedeva una chiesa mi tirava dentro e non voleva più uscire: «Restiamo ancora un po’, mamma». Ha fatto la comunione a 7 anni e sul suo computer ha scritto: «Essere uniti a Gesù, questo è il mio programma di vita». E poi tutti i giorni andava a messa, faceva adorazione eucaristica e la preghiera del rosario. Diceva: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Di fronte al sole ci si abbronza, ma di fronte a Gesù Eucaristia si diventa santi».
L’Eucaristia era il suo riferimento?
Diceva che con l’Eucaristia il Signore entra a fare parte del nostro corpo, che ogni volta che facciamo la comunione non siamo più le stesse persone. Diceva che come Mosé scendendo dal monte Sinai dopo aver incontrato Dio era luminoso così capita anche a noi dopo aver fatto adorazione: non ce ne rendiamo conto, ma il Signore ci trasforma, ci divinizza.
Faccia a faccia con Dio...
Diceva proprio così: «L’Eucaristia ci mette faccia a faccia. Noi siamo come una stanza buia: ognuno con la sua oscurità e l’Eucaristia è un fascio di luce che entra e ci fa vedere il pulviscolo che normalmente non vediamo» e ci chiama a migliorare. «Se la gente - sottolineava - fosse consapevole dell’importanza dell’Eucaristia, in Chiesa ci sarebbero più persone che ai grandi concerti che alle partite di calcio». E con la mostra sui miracoli eucaristici, che gira ancora il mondo, voleva condurre le persone a Dio, accompagnarle a vedere il suo Volto, a visitare un tabernacolo con la stessa devozione con cui si fa un pellegrinaggio a Gerusalemme. Diceva che noi siamo molto più fortunati di chi visse in Palestina al tempo di Gesù perché non abbiamo bisogno di farci largo fra la folla per vederlo, ma ci basta entrare in un chiesa e abbiamo la certezza che Lui è lì, nel tabernacolo. Desiderava che tutti amassero l’Eucaristia e credeva molto alla necessità della preghiera riparatrice per le offese a Gesù eucaristico, come indicato dall’angelo ai Pastorelli di Fatima.
Amare l’Amore come scelta di vita?
Per Carlo era la scelta strategica. Tutto per lui ruotava intorno a questo. Se sono in un deserto sotto il sole cocente, diceva, e da un giorno non bevo, vedo un’oasi e corro verso l’acqua, se ho un bicchiere piccolo prendo quella per me, se ho un contenitore grande ne posso prendere anche da dare agli altri. La differenza è nella capacità di amare, di contenere l’amore da donare, perché è l’amore accolto e donato che ci realizza, ci rende a immagine e somiglianza.
Siamo sempre lì: fede semplice, amore, umiltà...
Semplice, lineare: «Il Padre ha un trono in cielo, il Figlio ha il trono dell’Agnello, ma lo Spirito Santo ha il trono nei nostri cuori. E noi dovremmo sentirci come tabernacoli viventi». Questa era la sua logica. E aggiungeva che Cristo lo si vede nell’umiltà, Lui che dalla condizione di infinito è passato a una condizione di finito. Si è incarnato in Maria che, umile anch’ella, è diventata il primo tabernacolo vivente. Incontrare gli umili è vedere Dio. Nella debolezza vediamo il suo Volto. Siamo andati tre volte a vedere la Sindone e lui era sempre molto emozionato, colpito dalla regalità di quel volto sofferente: «Trasuda divinità», diceva. Conosceva il Volto di Manoppello ed è voluto andare a vedere il sudario di Oviedo.
Si sentiva un tabernacolo vivente?
Era impegnato a far emergere il volto di Dio che era in lui in un costante lavoro di ascesi. Tutto ciò che era bene lo riferiva a Dio, tutto ciò che in sé trovava di male lo riferiva a se stesso. Ogni sera era il suo esame di coscienza... e si metteva i voti. Il tempo lo considerava come una creatura di Dio e spiegava che Gesù, l’eterno, aveva assunto il tempo e lo aveva divinizzato mostrandoci come viverlo in chiave di eternità. Per questo il tempo non va sciupato per fare cose che non servono ad avvicinarci a Dio.
Fare di ogni momento, di ogni incontro un passo sulla strada della fede?
Lui lo chiamava incrociare la fede con la vita quotidiana. Oggi quasi sempre separiamo la fede dalla vita come se fossero cose distinte. Ma come suggeriva Carlo bisogna cominciare a incrociare fede e vita partendo dalle piccole cose, poi per le grandi cose ci pensa Dio. E poi nutrirsi di amore attraverso l’Eucaristia, perché la mia capacità di amare aumenta nella misura in cui Lui mi aiuta. «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui»: questo Carlo lo prendeva alla lettera ricordando che dobbiamo diventare Vangelo vivo se vogliamo che in noi si mostri il Volto di Dio; che in ognuno c’è un progetto di originalità che possiamo attuare solo restando con Dio, che ci è vicino, che desidera stare con noi. Se perdo quella vicinanza perdo anche la mia occasione di essere originale e finisco, come diceva lui, per diventare una fotocopia. Ma ogni giorno, in ogni momento posso sempre ricominciare da zero.
Con quali strumenti?
Credeva ciecamente nella Misericordia di Dio e per questo invitava a non disprezzare gli strumenti di salvezza che ci sono stati messi a disposizione attraverso la Chiesa: per prima cosa i Sacramenti, in particolare la Confessione, l’Eucaristia, l’Unzione degli infermi, che Carlo prendeva tutti gli anni perché, diceva, l’Unzione guarisce le nostre ferite. Poi i sacramentali come l’acqua benedetta, ma anche le indulgenze, l’acqua che sgorga nei luoghi delle apparizioni mariane... La preghiera del rosario che più volte la Madonna ha indicato come fonte di grazia...
Cosa ha significato vivere con un figlio così?
Mi ha cambiato da subito. Venivo da una vita che come per tanti di noi è lontana dalla fede vera. Io nel seguirlo mi stupivo ogni giorno. Correva avanti nel tempo, non ne sprecava un attimo. A tre mesi ha detto la prima parola, a 4 anni leggeva e scriveva. Aveva gli occhi luminosi. Era di una purezza straordinaria. Ogni volgarità, ogni bestemmia gli dava fastidio, ma non era bacchettone, anzi risultava simpatico e questo gli consentiva di avvicinare e aiutare tutti. Quando nel ’95 è morto mio padre mi sentivo svuotata. Carlo mi ha aiutato anche in questo. A 5 anni mi ha detto di averlo visto in Purgatorio. Ecco, mi ha mostrato un Gesù misericordioso, accogliente, semplice, essenziale, vicino, alla portata di tutti. Una semplicità, una vicinanza che andrebbe rivalutata anche nella Chiesa.

Il coraggio di credere!
Gabriele P. 14 anni
“La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio”
Carlo Acutis
Carlo nasce a Londra il 3 Maggio del 1991 e muore a Monza tra l’11 e il 12 Ottobre del 2006, a causa di una leucemia fulminante. Amava ripetere che “la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio”. “Non io ma Dio”, “Non l’amor proprio ma la gloria di Dio”. Per Carlo “la nostra Meta deve essere l’Infinito non il finito”. A questo proposito scriveva che: “La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l’alto, basta un semplice movimento degli occhi”.
Tutta la sua vita fu una lotta per vincere i suoi difetti e vivere sempre più eroicamente le virtù della Fede, della Speranza e dell’amore per Dio e per il prossimo. La madre ha raccontato che il figlio adolescente andava a prestare conforto, nel tempo libero, ai senzatetto di Milano.Diceva Carlo: “Che giova all’uomo vincere mille battaglie se poi non è capace di vincere se stesso con le proprie corrotte passioni?” Il suo cammino spirituale si reggeva su due colonne: l'Eucaristia e la Madonna.
Carlo aveva una grande passione per l' informatica e per internet e riteneva che la rete potesse diventare un strumento di evangelizzazione e di diffusione di bellezza e valori positivi. Da autodidatta dimostrò di essere un vero genio dell'informatica. Sul web è presente (www.miracolieucaristici.org), la mostra virtuale progettata e realizzata da lui a 14 anni, che sta facendo il giro del mondo e che testimonia come davvero per Carlo l'Eucaristia è stata la sua "autostrada per il cielo", come lui stesso la definiva.
E' il primo beato della generazione dei millennial, la nostra, e già in tanti lo considerano come il "patrono" di Internet che indica una strada possibile per tutti noi.
Già dichiarato venerabile nel luglio 2018 da papa Francesco, che nell'esortazione apostolica «Christus vivit» lo ha proposto ai giovani come modello di santità dell'era digitale, Acutis diviene beato dopo che la Congregazione delle cause dei Santi ha esaminato un suo miracolo, avvenuto nell’ottobre 2010 nella chiesa di San Sebastiano a Campo Grande, in Brasile: dopo avere toccato una reliquia di Acutis un bambino che soffriva di una grave anomalia al pancreas è risultato completamente guarito.
La memoria liturgica del beato Carlo Acutis sarà celebrata ogni anno il 12 ottobre, giorno della sua morte.
Wisława Szymborska..come mi batte forte il cuore

Dio doveva finalmente credere nell’uomo
buono e forte,
ma il buono e il forte
restano due esseri distinti.
Come vivere? – mi ha scritto qualcuno
a cui io intendevo fare la stessa domanda.
Da capo e allo stesso modo di sempre,
come si è visto sopra,
non ci sono domande più pressanti
delle domande ingenue.
Se osserviamo il mondo, potremmo farci prendere dal pessimismo. Eppure il tempo non è abbandonato, l’uomo non è perduto. A noi spetta continuare ad attraversare il nostro quotidiano secondo le nostre strade.
E così, da domani, riprenderemo le nostre vite, continueremo a mettere alla prova i nostri propositi, tenteremo ancora di coltivare speranze e desideri, a scrutare gli orizzonti e a vivere il nostro quotidiano, per quanto potremo e per quanto ci sarà dato, con impegno incostante, con fedeltà zoppicanti e con inciampi più o meno frequenti. Ma tenteremo.
Da domani ancora e ancora non ci arrenderemo, dando spazio alle domande che ci abitano e cercando le risposte; da domani, ancora e ancora «da capo, e allo stesso modo di sempre», faremo ritorno a casa.
Confidando in un’altra strada.
Wislawa Szymborska


100 anni di Wislawa
I versi di Wislawa Szymborska
Raccolti sotto il titolo “Canzone nera”, contengono già anche i germi che germoglieranno in futuro, tra il tragico assoluto e lo sguardo verso la speranza
La poetessa polacca Wislawa Szymborska (1923-2012) premio Nobel nel 1996
«Non omnis moriar », “non morirò del tutto”, scrisse Orazio, credendo di avere eretto con la poesia un monumento perenne più del bronzo, nella gloria che sfugge alla dèa morte. Più ironicamente, con un doppio gioco tanto serio, quanto dissimulato, una giovane poetessa, Wislawa Szymborska, lo nascondeva in Viandanze: suite pubblicata su piccole riviste polacche, tra il 1947 e il 1949. C’è un ragazzino – lei stessa – in cui confidano la parola poetica e la luce del giorno, in cerca della verità. Non è alleato di nessuno. Pensa che l’alba di oggi assomigli a quelle di ieri e di domani. La stradina fragile all’alba, salda la campagna alla città, con il suo mercato, dove i vivi si incontrano. Il ragazzino pensa alla statua eroica del poeta che profetizzava: «Insieme a loro calpesto pietre/ più durature del bronzo». Forse dalla pietra del poeta che è anche soldato, si risveglierà la musica, non in vendita. Il ragazzino su una soglia, dentro un sogno, saluta solenne la bandiera. Ma che strana quest’uscita improvvisa: «è dallo stupore / che sorge il bisogno di parole/ e perciò ogni poesia/ si chiama Stupore». Si rannuvola: «il mio dire/ sarà sempre come il pathos. Troppo poco». Infine una soluzione. Ripete per sempre il ricordo della casa, l’esplosione, il cielo, l’edificio devastato. Restano tre dimensioni dissolte, ma la quarta, il tempo? Di lì, dal suo solo amore, dal pensiero troppo grave e incessante, cosa resta, se non il taglio della quarta vuota parete? «Un doppio vuoto: tu – tuo figlio, /che mai darò alla luce». Tutto si confonde in una biografia di perdite, nel cielo e bosco cuciti da fili di spari – il sangue sulla tempia di chi cade, rievocato nell’ipnotica musica della Canzone nera, distraente dall’orrore: «sarà rossetto »? «Qui non è successo nulla». Né lo stile, né l’ironia sono quelli della poetessa futura, ma si presagiscono paradossi, dislocazioni, litoti, doppie antitesi, dissociazioni, elusioni, obliquità, trasferimento dell’orrore e del lutto, in una “forma” elegante dell’intelligenza e della “grazia”. C’è già un’acerba Saffo che sa che «Non è permesso il canto funebre/ nella dimora dei seguaci delle Muse». Canzone nera, che dà il titolo odierno alla raccolta (Adelphi, pagine 156, euro 14,00), ed era più semplicemente Poesie, non uscì, perché forse non allineato con il sistema della “liberazione” russa, al cui partito Szymborska aderì credendoci, e non uscendone se non nel 1966. Ma i primi libri, anche i rifiutati, sono indispensabili per capire un poeta. Oggi lo leggiamo nella bella traduzione di Linda Del Sarto, che raccoglie l’eredità di Pietro Marchesani. Andrea Ceccherelli, autore di numerosi libri sulla Szymborska, lo cura con filologia impeccabile, e ne corregge l’edizione polacca del 2014. Il 13 giugno, annunciandolo al Centro di poesia dell’Università di Bologna, che presiede, mi parlò di questo esordio, che Adam Wlodek (primo marito della Szymborska) aveva salvato: mostrava registri diversi rispetto al seguito, compresi i due libri ideologici del 1952 e 1954, dai quali lei avrebbe preso distanza. Era sorprendente. Scritto dal 1944 al 1949, Canzone nera contiene patria e anarchia, ma anche i germi futuri. Sta tra il tragico assoluto, e lo sguardo quasi verso la speranza, perché la morte è maldestra, come scriverà: «Non c’è vita / che almeno per un attimo/ non sia immortale. / La morte è sempre in ritardo su quell’attimo » ( Sulla morte senza esagerare). A ventun anni la prima poesia, 1944: riguarda la terrificante insurrezione dei bambini di Varsavia, che accompagna la più grande tragedia nella storia della Polonia. «Costò circa 200.000 vite, tra militari e civili, e la completa distruzione della città», ricorda Czeslaw Milosz nel Trattato poetico, dove racconta la storia della Polonia attraverso i poeti. Dopo l’invasione di Hitler, «la Shoah aveva portato allo sterminio di un’intera nazione di ebrei polacchi». In seguito, nel regime comunista, «gli anni peggiori, gli anni del terrore, furono quelli dal 1949 al 1953». Di dodici anni più anziano della Szymborska, e sebbene abbracci una poesia poematica, le è vicino. Entrambi si sono fidati delle speranze dell’utopia e dell’ideologia, in fasi e luoghi diversi, e se ne sono pentiti. Appena uscita dall’occupazione nazista, Szymborska si fida della “liberazione” russa. Però riesce sempre ad essere se stessa. Così può maturare. È paziente, si mette in discussione. Rimane bloccata per anni, quando riceve critiche, che la fanno riflettere. Ma crede nella poesia: la mette in primo piano insieme alle persone, alla bellezza di ciò che ci sorprende, in ogni attimo della vita. Connesso a ciò, un principio essenziale: a ciascun poeta la poesia chiede un linguaggio proprio. La sua intelligenza la guida, in uno scintillio che rinnova l’agudeza, il witz, l’eccellenza dello spirito che può volare. Di fronte al più inarrivabile orrore, non basta la parola, nemmeno se le si chiede la potenza del vulcano. I tragici avevano avuto ben in mente il problema, ma andavano dritti sulle loro strade. La poesia è necessaria, proprio dopo Auschwitz. Bisogna andare oltre, trovare altre parole, altri mattini. Nel suo modo di reagire alla tragedia, Szymborska afferra per sé dissimulazione, scarto, tutto ciò che significa rimozione e taglio. Fin da questo libro si può intuire la strada adatta a lei, tra quelle infinite della poesia. Ceccherelli mette a epigrafe del proprio saggio alcuni versi di Amore a prima vista: «Li stupirebbe molto sapere / che già da parecchio tempo / il caso giocava con loro. / Non ancora pronto del tutto / a mutarsi per loro in destino». Come un fulmine che illumina il buio, l’intelligenza che sa stupirsi e stupire, diventa il filo salvifico del destino. Montaigne, così amato, è un miracolo di sopravvivenza alle insidie: il suo destino di sopravvissuto è un simbolo. Non diversamente, forse, da ogni istante della vita che ci circonda, che va attesa, come il farsi giorno. Una nobile reticenza, è distacco dai sentimenti propalati. Generazioni di antenati della Szymborska, sia paterne sia materne, legate alle famiglie polacche regali Lubomirski e Zamoyski, si erano sacrificate nelle insurrezioni ottocentesche. Non era una novità, allora come oggi, essere travolti da guerre costanti: lo smembramento della Polonia, il coinvolgimento nelle insurrezioni nazionali europee. A sedici anni, il giorno in cui scoppiò la guerra, Szymborska vide passare sotto casa un carro di contadini che trasportava soldati insanguinati; dentro di lei qualcosa disse «ecco che ci siamo daccapo »: qualcuno che aveva visto scene simili tante altre volte, prima di lei. A queste scene, fin dalla Canzone nera, Szymborska affianca un ardore, una disponibilità verso il capire, che diventerà sempre di più il suo anti-credo: il socratico “non so”. Non importa che qui la sua “poetica” sia in formazione, né che i versi non siano perfetti, come lo saranno a partire dall’Appello allo Yeti del 1957. Per noi questo plasma è prezioso. Vi è già la persona che nel discorso al Nobel conversa con l’Ecclesiaste, dicendogli che no, non è vero che non c’è nulla di nuovo sotto il sole

Poteva accadere.
Doveva accadere.
È accaduto prima. Dopo.
Più vicino. Più lontano.
È accaduto non a te.
Ti sei salvato perché eri il primo.
Ti sei salvato perché eri l’ultimo.
Perché da solo. Perché la gente.
Perché a sinistra. Perché a destra.
Perché la pioggia. Perché un’ombra.
Perché splendeva il sole.
Per fortuna là c’era un bosco.
Per fortuna non c’erano alberi.
Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno,
un telaio, una curva, un millimetro, un secondo.
Per fortuna sull’acqua galleggiava un rasoio.
In seguito a, poiché, eppure, malgrado.
Che sarebbe accaduto se una mano, una gamba,
a un passo, a un pelo
da una coincidenza.
Dunque ci sei? Dritto dall’animo ancora socchiuso?
La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì? Non c’è fine al mio stupore, al mio tacerlo.
Ascolta
come mi batte forte il tuo cuore.

La gioia di scrivere
Dove corre questa cerva scritta in un bosco scritto?
Ad abbeverarsi ad un'acqua scritta
che riflette il suo musetto come carta carbone?
Perché alza la testa, sente forse qualcosa?
Poggiata su esili zampe prese in prestito dalla verità,
da sotto le mie dita rizza le orecchie.
Silenzio - anche questa parola fruscia sulla carta
e scosta
i rami generati dalla parola "bosco".
Sopra il foglio bianco si preparano al balzo
lettere che possono mettersi male,
un assedio di frasi
che non lasceranno scampo.
In una goccia d'inchiostro c'è una buona scorta
di cacciatori con l'occhio al mirino,
pronti a correr giù per la ripida penna,
a circondare la cerva, a puntare.
Dimenticano che la vita non è qui.
Altre leggi, nero su bianco, vigono qui.
Un batter d'occhio durerà quanto dico io,
si lascerà dividere in piccole eternità
piene di pallottole fermate in volo.
Non una cosa avverrà qui se non voglio.
Senza il mio assenso non cadrà foglia,
né si piegherà stelo sotto il punto del piccolo zoccolo.
C'è dunque un mondo
di cui reggo le sorti indipendenti?
Un tempo che lego con catene di segni?
Un esistere a mio comando incessante?
La gioia di scrivere
Il potere di perpetuare.
La vendetta d'una mano mortale.
Don Gallo..il prete degli ultimi


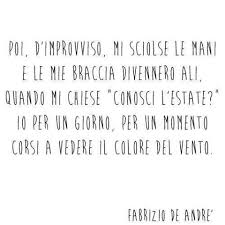
“Chi riconosce l’appartenenza alla famiglia umana, come fa a non aprire le porte?
Poi io, come cristiano, come faccio a non essere accogliente?
E io ti accolgo come sei"
Don Gallo

Don Gallo a dieci anni dalla morte: «Continuiamo le sue battaglie»
Il prete di strada scomparso nel 2013 non è stato dimenticato. I suoi valori di accoglienza e solidarietà vivono nonostante il vento politico contrario nella Comunità di San Benedetto da lui fondata. E che continua a essere meta del pellegrinaggio di politici e intellettuali
di Massimiliano Salvo
Nella trattoria A’ Lanterna, a Genova, è ancora tutto identico: il chiasso, l’odore di fritto, le foto di vip alle pareti. E le citazioni: Don Gallo di qua, Don Gallo di là. Perché fu proprio il prete di strada, all’inizio degli anni ’80, a immaginarsi in queste tre stanze qualcosa di impensabile per l’epoca: un ristorante gestito da persone con problemi di dipendenza. «E oggi eccoci qui», dicono gli eredi del progetto, una ciurma un po’ incasinata tra i fornelli e la sala. Maura, capello bianco, da dietro al bancone allunga il dito: «Don Gallo si sedeva lì, in quel tavolo ovale».
Il 22 maggio saranno dieci anni dalla morte del prete di strada, educatore, attivista, saggista e fondatore della Comunità di San Benedetto al Porto. «Non una comunità di recupero, ma una comunità di accoglienza», ripete Domenico Chionetti detto “Megu”, che di Don Gallo è stato portavoce ed è da sempre in prima linea nel portare avanti le sue battaglie.
Non è stato semplice: subito dopo la morte del “Gallo” nella stessa Comunità c’era il timore che fosse difficile continuare con lo stesso slancio. E invece l’associazione ha resistito ed è ancora protagonista della vita sociale e politica di Genova, dove il 22 maggio doveva tenersi una giornata di eventi per ricordare il sacerdote, rinviata a luglio dopo la tragedia dell’Emilia Romagna. Hanno aderito Moni Ovadia, Dori Ghezzi, Africa Unite e Walter Massa (presidente nazionale di Arci). A volere la giornata è stata la Comunità, non le istituzioni locali: anche perché rispetto agli ultimi anni della vita di Don Gallo il contesto politico è completamente cambiato.
Dieci anni dopo: la destra dilaga, gli amici rimangono
Quando Don Gallo morì, a 84 anni, Genova e la Liguria erano in mano al centrosinistra mentre oggi il centrodestra del sindaco Marco Bucci e del presidente Giovanni Toti non hanno rivali; a livello nazionale Fratelli d’Italia aveva il 2% e la Lega il 4%, ora governano. La Comunità però è ancora in prima linea nelle lotte per diritti civili e sociali, ed è una tappa simbolica nelle visite genovesi per una certa sinistra politica e culturale. Tanto per dire: il comizio di Elly Schlein, il venerdì sera prima delle primarie del Pd, è stato in piazza Don Gallo, nel “ghetto” di Genova, zona dimenticata popolata da spacciatori e prostitute.
A metà aprile, come tradizione, il segretario della Cgil Maurizio Landini è stato a Campoligure nell’entroterra di Genova, paese natale della famiglia di Don Andrea, dove il prete è sepolto e dove ogni anno la Comunità ricorda la Liberazione. «Don Gallo era cattolico, ma anche partigiano e militante comunista: e non ci vedeva nessuna contraddizione», lo ricorda il suo caro amico Moni Ovadia, attore e scrittore. «Dal punto di vista cristiano era un santo, dal punto di vista ebraico un “giusto”. Si batteva per l’uguaglianza e la giustizia sociale e lo faceva con una passione vibrante». Tra battute e sbuffi di sigaro Don Gallo era un uomo di relazioni, ed è infatti lunga la lista di amici e sostenitori della Comunità: da Vasco Rossi e Ilaria Cucchi a Nicola Fratoianni e Vauro, passando per Vito Mancuso, Dario Vergassola, Fiorella Mannoia, Però Pelù, i Subsonica, Caparezza, Erri De Luca, Dori Ghezzi.
Per rendersi conto degli intrecci del sacerdote basta fare un salto nel suo archivio: tra le decine di agende spicca quella del 2001, anno del G8 di Genova. In quei giorni di manifestazioni gli appuntamenti del Don erano senza sosta: “intervista con Mario Monicelli”, “cena con Manu Chao”, “marcia con Franca Rame”, “intervista a Porta a Porta”. «Don Gallo andò al concerto di Manu Chao, il giorno dopo Manu Chao venne nella nostra sede», ricorda la storica aiutante del sacerdote, Liliana “Lilly” Zaccarelli. «Aveva un assegno per noi. “Serve per dar da mangiare alla gente”, ci disse».
La Comunità oggi
Oggi la Comunità ha una trentina di dipendenti ma non ama dare numeri, memore di quando in passato tutti chiedevano a Don Gallo: «Quanti ne salvate?». E lui piccato rispondeva: «Che importa? Degli altri cosa facciamo, li ammazziamo?», per sottolineare una visione non salvifica, ma di rispetto anche per chi non riusciva a liberarsi dalla dipendenza. L’impegno della Comunità in questo campo è intanto diventato meno rilevante, tanto che delle cinque comunità di un tempo oggi ne sopravvivono tre: dal dilagare dell’eroina negli anni ’70 il mondo delle dipendenze è cambiato: «Ma la vocazione è identica», spiega Marco Malfatto, presidente della Comunità. «Ci occupiamo di persone e di bisogni, di essere umani, luoghi, quartieri».
I bisogni cui risponde la Comunità si sono quindi ampliati: verso le vittime della tratta, delle nuove povertà e del gioco d’azzardo, oppure con l’aiuto ai migranti; ma anche con l’offerta di servizi in zone problematiche, e con la solidarietà in ottica di economia circolare grazie alla raccolta di abiti usati e la lotta agli sprechi del cibo. «La persona resta al centro: ma davvero, non per modo di dire», spiegano Malfatto e “Megu” Chionetti. «La grande eredità di Don Gallo è la sua pedagogia: è importante la scelta, la motivazione di ognuno».
Il fulcro di questo mondo continua a essere la trattoria di fronte al porto, in via Milano 134r, luogo di emancipazione e incontro, laboratorio politico e di riflessione. Dove il cuoco o il cameriere possono essere un richiedente asilo un ex carcerato, e a tutti i commensali è data la stessa importanza: che si tratti di un magistrato, un cantante, un politico, un portuale. «Qui non c’è una classe sociale, non si fanno distinzioni», ripete chi ci lavora, con orgoglio. «Perché questa è A’ Lanterna di Don Gallo. E a tavola, come diceva Don Andrea, siamo tutti uguali».

Don Andrea Gallo
“Un prete che si è scoperto uomo”
Andrea nasce a Genova il 18 Luglio 1928 e viene immediatamente richiamato, fin dall’adolescenza, da Don Bosco e dalla sua dedizione a vivere a tempo pieno “con” gli ultimi, i poveri , gli emarginati, per sviluppare un metodo educativo che ritroveremo simile all’esperienza di Don Milani, lontano da ogni forma di coercizione.
Attratto dalla vita salesiana inizia il noviziato nel 1948 a Varazze, proseguendo poi a Roma il Liceo e gli studi filosofici.
Nel 1953 chiede di partire per le missioni e viene mandato in Brasile a San Paulo dove compie studi teologici: la dittatura che vigeva in Brasile, lo costringe, in un clima per lui insopportabile, a ritornare in Italia l’anno dopo.
Prosegue gli studi ad Ivrea e viene ordinato sacerdote il 1 luglio 1959.
Un anno dopo viene nominato cappellano alla nave scuola della Garaventa, noto riformatorio per minori: in questa esperienza cerca di introdurre una impostazione educativa diversa, dove fiducia e libertà tentavano di prendere il posto di metodi unicamente repressivi; i ragazzi parlavano con entusiasmo di questo prete che permetteva loro di uscire, poter andare al cinema e vivere momenti comuni di piccola autogestione, lontani dall’unico concetto fino allora costruito, cioè quello dell’espiazione della pena.
Tuttavia, i superiori salesiani, dopo tre anni lo rimuovono dall’incarico senza fornirgli spiegazioni e nel ’64 Andrea decide di lasciare la congregazione salesiana chiedendo di entrare nella diocesi genovese: “la congregazione salesiana, dice Andrea, si era istituzionalizzata e mi impediva di vivere pienamente la vocazione sacerdotale”.
Viene inviato a Capraia e nominato cappellano del carcere: due mesi dopo viene destinato in qualità di vice parroco alla chiesa del quartiere Carmine dove rimarrà fino al 1970, anno in cui verrà “trasferito” per ordine del Cardinale Siri.
Nel linguaggio “trasparente” della Curia era un normale avvicendamento di sacerdoti, ma non vi furono dubbi per nessuno: rievocare quel conflitto è molto importante, perché esso proietta molta luce sul significato della predicazione e dell’impegno di Andrea in quegli anni, sulla coerenza comunicativa con cui egli vive le sue scelte di campo “con” gli emarginati e sulle contraddizioni che questa scelta apre nella chiesa locale.
La predicazione di Andrea irritava una parte di fedeli e preoccupava i teologi della Curia, a cominciare dallo stesso Cardinale perché, si diceva, i suoi contenuti “non erano religiosi ma politici, non cristiani ma comunisti”.
Un’aggravante, per la Curia è che Andrea non si limita a predicare dal pulpito, ma pretende di praticare ciò che dice e invita i fedeli a fare altrettanto: la parrocchia diventa un punto di aggregazione di giovani e adulti, di ogni parte della città, in cerca di amicizia e solidarietà per i più poveri, per gli emarginati che trovano un fondamentale punto di ascolto.
Per la sua chiara collocazione politica, la parrocchia diventa un punto di riferimento per molti militanti della nuova sinistra, cristiani e non.
L’episodio che scatena il provvedimento di espulsione è un incidente verificatosi nel corso di una predica domenicale: lo descrive il settimanale “Sette Giorni” del 12 Luglio 1970, con un articolo intitolato “Per non disturbare la quiete”.
Nel quartiere era stata scoperta una fumeria di hashish e l’episodio aveva suscitato indignazione nell’alta borghesia del quartiere: Andrea, prendendo spunto dal fatto, ricordò nella propria predica che rimanevano diffuse altre droghe, per esempio quelle del linguaggio, grazie alle quali un ragazzo può diventare “inadatto agli studi” se figlio di povera gente, oppure un bombardamento di popolazioni inermi può diventare “azione a difesa della libertà”.
Qualcuno disse che Andrea era oramai sfacciatamente comunista e le accuse si moltiplicarono affermando di aver passato ogni limite: la Curia decide per il suo allontanamento dal Carmine.
Questo provvedimento provoca nella parrocchia e nella città un vigoroso movimento di protesta ma, la Curia, non torna indietro e il “prete scomodo” deve obbedire: rinuncia al posto “offertogli” all’isola di Capraia che lo avrebbe totalmente e definitivamente isolato.
Lasciare materialmente la parrocchia non significa per lui abbandonare l’impegno che ha provocato l’atteggiamento repressivo nei suoi confronti: i suoi ultimi incontri con la popolazione, scesa in piazza per esprimergli solidarietà, sono una decisa riaffermazione di fedeltà ai suoi ideali ed alla sua battaglia “La cosa più importante, diceva, che tutti noi dobbiamo sempre fare nostra è che si continui ad agire perché i poveri contino, abbiano la parola: i poveri, cioè la gente che non conta mai, quella che si può bistrattare e non ascoltare mai.
Ecco, per questo dobbiamo continuare a lavorare!”
Qualche tempo dopo, viene accolto dal parroco della chiesa di San Benedetto, Don Federico Rebora, ed insieme ad un piccolo gruppo nasce la comunità di base, la Comunità di San Benedetto al Porto.
Dopo tanti anni, la nostra porta è sempre aperta!
Don Lorenzo Milani..il prete che scuoteva la Chiesa


Il testimone
Lorenzo Milani
Una fede scomoda
Dalla testimonianza di don Renzo Rossi, amico di don Lorenzo Milani fin dagli anni del seminario e per tutta la vita, conosciamo il primo atto della sua vita da priore nell'esilio di Barbiana. La possiamo leggere nel volume Lorenzo Milani, «Perché mi hai chiamato?». Lettere ai sacerdoti, appunti giovanili e ultime parole (San Paolo, Cinisello Balsamo 2013), curato da Michele Gesualdi, uno dei primi ragazzi della scuola di Barbiana e attuale Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. Il libro presenta testi inediti (con lettere a don Bensi, don Renzo Rossi, mons. Loris Capovilla, Primo Mazzolari, Barsotti e altri ancora), a cui sono opportunamente affiancati brani già noti ai lettori per favorire la lettura e la comprensione degli inediti. Scrive don Renzo Rossi: «Il giorno dopo il suo arrivo a Barbiana, Lorenzo venne a trovarmi nella canonica di Vicchio e mi chiese di accompagnarlo in Comune perché voleva comprarsi subito la tomba nel piccolo cimitero di Barbiana. Io gli feci in faccia una bella risata! "Quanto sei bischero!". Ma lui mi disse che con quel segno (la tomba) voleva sentirsi legato totalmente, nella vita e nella morte, alla sua nuova gente! La sua scelta "per tutta la vita fu immediata" !» (p. 94). Davanti alla miseria di quella minuscola parrocchia sperduta sul monte Giovi, quasi irraggiungibile all'epoca (6 dicembre 1954), non pochi amici protestarono auspicando un suo rapido trasferimento altrove. Tra questi, oltre alla madre, il giudice Gian Paolo Meucci e don Raffaele Bensi, suo confessore. Proprio dal carteggio con il parroco di San Michelino Visdomini veniamo a sapere la sua reazione, davanti alla proposta di considerare Barbiana come un posto da abbondare al più presto: «La prego dí non parlare più né con me né con altri di questa parrocchia come se fosse un banco di prova provvisorio in attesa di qualcos'altro. La sua lettera mi ha talmente turbato che son stato due o tre giorni a pensare al suicidio. Poi per fortuna le ho dato del bischero e poi l'ho anche perdonato» (p. 21). La lettera è del 29 dicembre, venti giorni dopo il suo arrivo a Barbiana, e ci dà subito l'idea della radicalità e della libertà interiore di don Lorenzo, del suo coraggio nel difenderla dicendo, senza mezze misure, al suo amato amico e confidente don Bensi, che gli è di scandalo, distogliendolo dalla sua missione, dalla sua vocazione. Comprando la tomba nel piccolo camposanto antistante la chiesa, don Lorenzo si confrontava col senso ultimo della sua esistenza dí credente e di sacerdote, agendo coerentemente con quanto aveva scritto, un anno prima, nella traccia della sua omelia per la festa dei morti: «questa vita non è tutto, ma solo un passaggio o un esame» (p. 191). La vita di don Lorenzo si è svolta sotto questo esame, sotto lo sguardo di Dio, e da qui derivano il suo coraggio, la sua radicalità per certi aspetti violenta, la percezione in lui chiara e inequivocabile della abissale differenza che corre tra lo stare sotto lo sguardo degli uomini oppure sotto lo sguardo di Dio. In questo senso, parla di sé come di un «eserciziante perpetuo» o anche come di un «rigido rabbino tradizionalista». Tanto rigoroso con se stesso, quanto capace di dedicarsi instancabilmente agli altri, facendo sua l'espressione di Gesù citata da Paolo e ripresa da Francesco di Assisi, «c'è più gioia nel dare che nel ricevere». Tanto esigente con i suoi allievi e nel rapporto dialettico con i suoi interlocutori o avversari, quanto capace di ammirare la generosità della sua perpetua, Eda, e dei suoi ragazzi nell'assisterlo fino alla fine.
Nella lettera a don Bensi che abbiamo citato, emerge anche con forza il senso, che via via prenderà un contorno sempre più definito, del suo modo di intendere il sacerdozio e la sua missione nella nuova situazione in cui si è venuto a trovare. Si tratta della sua ben nota opposizione contro l'ideologia della ricreazione, su cui tornerà più volte nel tempo con argomentazioni molto stringenti. «Voglio scrivere un libro contro la ricreazione. Lo intitolerò: L'Eresia del secolo. E sarà diretto in parti uguali contro i preti e i comunisti». Vorrebbe predicare gli esercizi spirituali ai diaconi proprio su questo argomento: «Do loro ospitalità quassù per tutta la settimana e li rimando in giù riformati» (p. 20). Circa un anno dopo, vorrebbe parlarne ai teologi, come scrive sempre al suo confessore: «Da anni covo in cuore il segreto desiderio di parlare ai teologi. Naturalmente parlerei della ricreazione e della scuola. Non chiedo di farmi dei seguaci, ma solo di poter turbare per mezz'ora le loro coscienze, seminare un dubbio, una necessità di revisione degli slogans» (p. 25). L'unica ricreazione buona, che don Milani ammette, è quella che ha un carattere educativo e che di fatto ha accolto con entusiasmo nella sua scuola. Vorrebbe, dunque, parlare ai diaconi in formazione e ai teologi professionisti, e mentre rivendica questa attenzione esprime, al contempo, pieno distacco da se stesso e dalle sue prese di posizione. Prenderà sempre le distanze, a più riprese, da chi si fa difensore delle sue idee («qualcuno – scrive – si è buttato accanitamente per difendere le mie affermazioni cui io stesso non credo più da mesi o da anni»), perché non cerca seguaci né tanto-meno di affermare un "metodo don Milani", per così dire, da applicare altrove. Scrive, nel 1956, a don Renzo Rossi: «Sarebbe bello che io potessi assolvere la funzione di serbatoio di pensiero per tutti gli indaffaratissimi preti che non han tempo per pensare a quel che fanno, ma vedo questa cosa assolutamente impossibile e del resto anche immorale per parte loro. Ognuno deve pensare quello che fa e siccome ognuno fa cose diverse e incontra persone diverse, nessuno può valersi, sull'apostolato, del pensiero d'un altro. Così son giunto alla conclusione che sia mia specifica missione non il distribuire pensieri prefabbricati ai preti, ma solo turbarli e farli pensare» (p. 108). Nella dedizione instancabile alla sua missione di "conturbatore di coscienze", non cerca le luci della ribalta o il conforto di un ampio consenso, ma lascia trasparire la verità irresistibile del Vangelo, quella buona notizia che facendosi lievito nella cultura cresce, inevitabilmente, generando una controcultura rispetto agli slogan e alla mentalità più diffusa e accolta acriticamente. Del resto, secondo don Lorenzo, un parroco non deve avere la preoccupazione di "piacere". «Ecco dunque l'unica cosa decente che ci resta da fare: stare in alto (cioè in grazia di Dio), mirare in alto (per noi e per gli altri) e sfottere crudelmente non chi è in basso, ma chi mira basso. Riceffargli ogni giorno la sua vuotezza. La sua miseria, la sua inutilità, la sua incoerenza» (Lettera a don Ezio Palombo, del 25 marzo 1955, cit. da N. Fallaci, Vita del prete Lorenzo Milani, Bur, Milano 1993, p. 231).
La sua lotta per una vita coerente e fedele è an- che il suo dramma umano e di sacerdote: come fare un cammino non solitario né eccentrico e arbitrario, se ci si trova isolati e in esilio, di fatto quasi extra ecclesiam? Le sue parole sulla curia fiorentina, e sul crudele esilio in cui è stato relegato, sono durissime e non solo perché espresse senza accomodamenti e con il suo linguaggio diretto e molto toscano (che ancora forse scandalizza qualcuno e che è stato un facile bersaglio dei suoi detrattori, che non sono mai mancati nell'ambiente dei cristiani di facciata). Per don Lorenzo non era possibile una via mediana: aderire alla fede senza aderire alla Chiesa, senza un'obbedienza piena, equivale per lui a farsi una fede su misura, una fede fai-da-te. Ne scrive in proposito con grande chiarezza già nel 1953: «Quelli che scelgono e preferiscono e alla fine si creano la verità da credere si fanno la religione in casa a conto proprio. Sì, vedete, il mondo moderno che ci ha educati alla democrazia e alla fiducia nelle opinioni degli uomini ci ha dato anche questa tendenza di volerci fare su misura anche la fede. [...] Fede è entrare in casa d'altri, non costruirsi la casa. Entrare in una casa che non abbiamo costruita, che non è nostra, che non ci viene donata in proprietà ma in cui è già troppo alto onore di poter entrare. Ospiti del gran re. Non per mutar di posto a qualche mobile che non ci piace, ma per piegarci, accettare di umiliarci e accettare di soffrire qualcosa per amor di lui che tanto ci ha amato. Tutto dunque crederemo o nulla» (pp. 184-185). Al di fuori di questa prospettiva radicale e senza sconti, le parole di don Milani possono sembrare prese di posizione eccentriche o ideologiche o, per qualcuno, opinioni personali. Il priore di Barbiana, invece, sa bene di non aver aderito ad alcun partito, ad alcuna "ditta", ed è disposto a pagare fino in fondo il prezzo della solitudine per la sua coerenza. La fede professata deve, dunque, avere la sua verifica in un'etica vissuta, altrimenti è falsa.
Del resto, scrivendo a don Bensi nel 1965, rivendica di essere una «persona estremamente matura di cui ogni parola è misurata e frutto di anni di meditazione e di silenzio» (p. 65). In quel silenzio, la sua fede è cresciuta, fino a esprimere in poesia la forma della sua sequela senza sconti, del suo paradossale amore per Gesù: «Gesù ti odio / tu non mi dovevi chiamare. / [...] Gesù ti adoro / mi sei restato tu solo / Gesù m'aggrappo / alla tua unica mano / Gesù m'aggrappo / perché non voglio sparire / Ahi! // la tua mano è cosparsa di spine / Accidenti alle spine / della tua corona / Gesù ti odio / maledetta la tua croce / Gesù ti odio / ma non mi lasciare solo / Gesù ti odio / ma tu sai se è amore» (p. 209).
Bernardo Artusi

I CARE!
“L’arte dello scrivere è la religione. Il desiderio di esprimere il nostro pensiero e di capire il pensiero altrui è l’amore. E il tentativo di esprimere le verità che solo si intuiscono e le fa trovare a noi e agli altri. Per cui essere maestro, essere sacerdote, essere cristiano, essere artista e essere amante e essere amato sono in pratica la stessa cosa.”
Don Lorenzo Milani

Gianfranco Ravasi "Don Milani, una voce profetica nel deserto"
Don Milani. Il prete che scuoteva la Chiesa mostra tutta la sua attualità grazie all’amore per la persona umana, soprattutto se emarginata
All’anagrafe fiorentina era stato registrato come Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti, nato il 27 maggio 1923 da una famiglia borghese e intellettuale di matrice ebraica. Negli archivi parrocchiali apparirà come battezzato solo dieci anni dopo, successivamente a una lunga parentesi milanese dei genitori, che si erano trasferiti nel capoluogo lombardo nel 1930, ove il figlio avrebbe seguito tutto il cursus scolastico fino all’Accademia di Brera. Lorenzo ritornerà con loro a Firenze nel 1943 e fu là che si aprì il suo percorso spirituale che lo condusse al sacerdozio il 13 luglio 1947.
A questo punto sciogliamo del tutto l’enigma: stiamo parlando di don Lorenzo Milani, relegato dall’incomprensione ecclesiastica nel Mugello, a Barbiana, modesta frazione del comune di Vicchio che diverrà nota proprio per la genialità e la fede di questo prete. Là rimase fino alle soglie della morte, che avverrà a Firenze per grave malattia nel 1967.
La sua è stata una voce profetica che risuonava nel deserto, scuoteva le coscienze, anticipava i tempi collocandosi nei crocevia più roventi della società attraverso i suoi scritti, a partire dalle Esperienze pastorali del 1958, passando a L’obbedienza non è più una virtù per approdare all’indimenticabile dittico epistolare della Lettera a una professoressa (1967) su un originalissimo progetto educativo e della Lettera ai cappellani militari (1965) sull’obiezione di coscienza che gli costò una condanna per apologia di reato postuma, perché la sentenza fu pronunciata a un anno dalla sua morte avvenuta nel 1967. Sempre fermo e sereno, dichiarava ai suoi accusatori: «Dove è scritto che il prete debba farsi volere bene? A Gesù o non è riuscito o non è importato».
Ai ragazzi della scuola di Barbiana confessava nel suo testamento: «Ho voluto più bene a voi che a Dio; ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto sul suo conto».
Il suo amore per la persona umana, soprattutto se povera ed emarginata, era totale: «Il cuore dell’uomo è qualcosa che i libri non sanno leggere né catalogare. Un’anima non si muta con una parola», scriveva a quella “professoressa” così rigida nel suo ottuso sapere e inesorabile nel suo giudizio su un’esperienza didattica creativa. Lapidario era don Lorenzo anche nell’ammonire che il «massimo della diseguaglianza è fare parti uguali tra diseguali», convinto com’era che «un atto coerente isolato è la più grande incoerenza» e che «non dobbiamo avere paura di sporcarci le mani.
A che servirà averle pulite se le avremo tenute in tasca?».
La sua fede era appassionata: «Se dicessi che credo in Dio, direi troppo poco perché gli voglio bene.
E volere bene a uno è qualcosa di più che credere nella sua esistenza». Pur incompreso, come si diceva, dalle autorità ecclesiastiche, rimase sempre fedele alla Chiesa. Un suo compagno di seminario che sarebbe poi divenuto proprio arcivescovo di Firenze, il cardinale Silvano Piovanelli, anni fa mi confidava che, a quanti chiedevano a don Milani perché non lasciasse una Chiesa così dura verso di lui, rispondeva: «E dove mai troverò chi mi perdona i peccati?», rivelando anche un temperamento da asceta, consapevole della fragilità umana e della necessità del perdono divino.
La sua opera principale a livello di elaborazione della sua esperienza è stata certamente il volume citato Esperienze pastorali, le cui righe sono già stilisticamente di un’essenzialità assoluta e programmatica, come egli stesso affermava in una sua lettera: «Lo stare per mesi su una frase sola togliendo via tutto quello che si può togliere», spogliando la verità da ogni paludamento retorico e dal manto dorato dell’ipocrisia. Infatti, «siamo in un mondo in agonia che Dio forse sta accecando per castigarlo per aver troppo e troppo male usato l’intelletto, oppure di non averne fatto parte agli infelici».
E alla fine il bilancio del suo impegno di pastore e di educatore era stato sorprendente: «Devo tutto quello che so ai giovani operai e contadini cui ho fatto scuola. Quello che loro credevano di stare imparando da me, son io che l’ho imparato da loro. Io ho insegnato loro soltanto a esprimersi mentre loro mi hanno insegnato a vivere». Alla base, infatti, del suo insegnamento c’era soprattutto la ricerca condotta in comune tra insegnanti e discepoli. Il magister (da magis, più) si trasformava sempre in minister (da minus, meno) che procede spalla a spalla con l’altro. È ciò che avrebbe ribadito una figura lontana da don Lorenzo in tutti i sensi come Roland Barthes quando riconosceva che «vi è un’età in cui si insegna ciò che si sa; ma poi ne viene un’altra in cui si insegna ciò che non si sa, e questo si chiama cercare».
In questo che non è un ritratto ma solo un’evocazione simpatetica di un sacerdote e testimone dalla storia tormentata e gloriosa, nel centenario della sua nascita, è stato naturale lasciare soprattutto a lui la parola, come abbiamo fatto intarsiando il nostro testo con l’eco della sua voce. La conclusione, però, dovrebbe essere affidata a un’immagine del 20 giugno 2017: papa Francesco in piedi, a capo chino e in silenzio, davanti alla tomba di don Milani in quel piccolo e semplice camposanto di campagna. Enzo Biagi aveva scritto: «È sepolto nel cimitero di Barbiana, sperduto e vuoto paese abitato dagli spiriti. Ma don Lorenzo parla ancora».
di GIANFRANCO RAVASI

Sergio Mattarella "Don Milani, battistrada di una cultura nuova"
Rivolgo un saluto a tutti i presenti, che vorrei poter salutare singolarmente (...) Ricordiamo oggi, nel centenario della nascita, don Lorenzo Milani. È stato anzitutto un maestro. Un educatore. Guida per i giovani che sono cresciuti con lui nella scuola popolare di Calenzano prima, e di Barbiana poi.
Testimone coerente e scomodo per la comunità civile e per quella religiosa del suo tempo. Battistrada di una cultura che ha combattuto il privilegio e l’emarginazione, che ha inteso la conoscenza non soltanto come diritto di tutti ma anche come strumento per il pieno sviluppo della personalità umana. Essere stato un segno di contraddizione, anche urticante, significa che non è passato invano fra noi ma, al contrario, ha adempiuto alla funzione che più gli stava a cuore: fare crescere le persone, fare crescere il loro senso critico, dare davvero sbocco alle ansie che hanno accompagnato, dalla scelta repubblicana, la nuova Italia.
Don Lorenzo avrebbe sorriso di una sua rappresentazione come antimoderno se non medievale, della sua attività. O, all’opposto, di una sua raffigurazione come antesignano di successive contestazioni dirette allo smantellamento di un modello scolastico ritenuto autoritario. Nella sua inimitabile azione di educatore — e lo possono testimoniare i suoi “ragazzi” — pensava, piuttosto, alla scuola come luogo di promozione e non di selezione sociale. Una concezione piena di modernità, di gran lunga più avanti di quanti si attardavano in modelli difformi dal dettato costituzionale.
Era stato mandato qui, a Barbiana, in questo borgo tra i boschi del Mugello — con la chiesa, la canonica e poche case intorno — perché i suoi canoni, nella loro radicalità, spiazzavano l’inerzia. La sua fede esigente e rocciosa, il suo parlare poco curiale, i suoi modi, a volte impetuosi, lontani da quelli consueti, destavano apprensione in qualche autorità ecclesiastica.
In tempi lontani dalla globalizzazione e da internet, da qui, da Barbiana — allora senza luce elettrica e senza strade asfaltate — il messaggio di don Milani si è propagato con forza fino a raggiungere ogni angolo d’Italia; e non soltanto dell’Italia. Don Milani, aveva una acuta sensibilità circa il rapporto — che si pretendeva gerarchico — tra centri e periferie.
Come uscire da una condizione di emarginazione? Come sollecitare la curiosità, propulsore di maturità? Come contribuire, da cittadini, al progresso della Repubblica? Il motore primo delle sue idee di giustizia e uguaglianza era proprio la scuola.
La scuola come leva per contrastare le povertà. Non a caso oggi si usa l’espressione “povertà educativa” per affermare i rischi derivanti da una scuola che non riuscisse a essere veicolo di formazione del cittadino. La scuola per conoscere. Per imparare, anzitutto, la lingua, per poter usare la parola.
«Il mondo — diceva don Milani — si divide in due categorie: non è che uno sia più intelligente e l’altro meno intelligente, uno ricco e l’altro meno ricco. Un uomo ha mille parole e un uomo ha cento parole». Si parte con patrimoni diversi. Da questa ansia si coglie il suo grande rispetto per la cultura. La povertà nel linguaggio è veicolo di povertà completa, e genera ulteriori discriminazioni.
La scuola, in un Paese democratico, non può non avere come sua prima finalità e orizzonte l’eliminazione di ogni discrimine.
Lettera a una professoressa, scritta con i suoi ragazzi mentre avanzava la malattia — che lo avrebbe portato via a soli 44 anni — è un atto d’accusa, impietoso, di tutto questo. Lettera a una professoressa ha rappresentato una lezione impartita a fronte delle pigrizie del sistema educativo e ha spinto a cambiare, ha contribuito a migliorare la scuola nel mezzo di una profonda trasformazione sociale del Paese.
Ha aiutato a comprendere meglio i doveri delle istituzioni e sollecitato a considerare i doveri verso la comunità. Sempre più gli insegnanti, hanno lavorato con passione per attuare i nuovi principi costituzionali. Perché a questo occorre guardare.
La scuola è di tutti. La scuola deve essere per tutti. Spiegava don Milani, avendo davanti a sé figli di contadini che sembravano inesorabilmente destinati a essere estranei alla vita scolastica: «Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo di espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose». Impossibile non cogliere la saggezza di questi pensieri. Era la sua pedagogia della libertà.
Il merito non è l’amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e per non far perdere all’Italia talenti; preziosi se trovano la possibilità di esprimersi, come a tutti deve essere garantito. I suoi ragazzi non possedevano le parole. Per questo venivano esclusi. E se non le avessero conquistate, sarebbero rimasti esclusi per sempre.
Guadagnare le parole voleva dire incamminarsi su una strada di liberazione. Ma chiamava anche a far crescere la propria coscienza di cittadino; sentirsi, allo stesso tempo, titolare di diritti e responsabile della comunità in cui si vive. Aveva un senso fortissimo della politica don Lorenzo Milani. Se il Vangelo era il fuoco che lo spingeva ad amare, la Costituzione era il suo vangelo laico. «Ho imparato che il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia». Difficile trovare parole più efficaci. Difficile non riscontrare lo stretto legame del suo insegnamento con la fede che professava: prima di ogni altra cosa, il rispetto e la dignità di ogni persona. Qui si intrecciano il don Milani prete, l’educatore, l’esortatore all’impegno.
L’impegno — educativo, e di crescita — richiede sempre, per essere autentico, coerenza. Spesso sacrificio. Al pari di tanti curati di montagna che hanno badato alle comunità loro affidate, Don Milani non si è sottratto. Era giovane. Chiedeva ai suoi ragazzi di non farsi vincere dalla tentazione della rinuncia, dell’indifferenza.
La scuola di Barbiana durava tutto il giorno. Cercava di infondere la voglia di imparare, la disponibilità a lavorare insieme agli altri. Cercava di instaurare l’abitudine a osservare le cose del mondo con spirito critico.
Senza sottrarsi mai al confronto, senza pretendere di mettere a tacere qualcuno, tanto meno un libro o la sua presentazione. Insomma, invitava a saper discernere. Quel primato della coscienza responsabile, che spinse don Milani a rivolgere una lettera ai cappellani militari, alla quale venne dato il titolo L’obbedienza non è più una virtù e che contribuì ad aprire la strada a una lettura del testo costituzionale in materia di difesa della Patria per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
Padre David Maria Turoldo, amico di don Milani, disse di lui che «diventando disobbediente» in realtà obbediva a principi e regole ancora più profonde e vincolanti. Non certo a un capriccio o a una convenienza.
Non c’era integralismo nelle sue parole, piuttosto radicalità evangelica. Sapeva di avere in mano un testimone. Un testimone che doveva passare di mano, a cui poi i suoi ragazzi “aggiungessero” qualcosa.
Un grande italiano che, con la sua lezione, ha invitato all’esercizio di una responsabilità attiva. Il suo “I care” è divenuto un motto universale. Il motto di chi rifiuta l’egoismo e l’indifferenza. A quella espressione se ne accompagnava un’altra, meno conosciuta. Diceva: «Finché c’è fatica, c’è speranza». La società, senza la fatica dell’impegno, non migliora. Impegno accompagnato dalla fiducia che illumina il cammino di chi vuole davvero costruire. E a don Lorenzo ha percorso un vero cammino di costruzione. E gli siamo riconoscenti.
di SERGIO MATTARELLA

"Signore, io ho provato che costruire è più bello che distruggere, dare più bel che ricevere, lavorare più appassionante che giocare, sacrificarsi più divertente che divertirsi. Signore Gesù fa che non me ne scordi più"
Don Lorenzo Milani

Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio
Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo non è più tempo delle elemosine, ma delle scelte
Chi non sa amare il povero nei suoi errori non lo ama.
Voler bene al povero è proporsi di metterlo al posto che gli spetta
Don Lorenzo Milani

La lezione di don Lorenzo
Giovanni Meucci
In dialogo con il documentario Barbiana '65. La lezione di don Lorenzo Milani (Italia 2017), del regista Alessandro G.A. D'Alessandro, cinque verbi per raccontare un possibile incontro con don Milani: visitare, leggere, ascoltare, imitare, essere.
Salire a Barbiana
La prima volta che sono salito a Barbiana è stato, forse, più di venti anni fa, insieme ad alcuni membri della mia Comunità, l'amico don Bruno Forte, attuale arcivescovo di Chieti-Vasto e don Renzo Rossi. Ricordo l'accoglienza di Michele Gesualdi, il suo dialogo con don Bruno Forte, riguardo alla paura che don Lorenzo Milani potesse essere trasformato in un "santino" perdendo la propria umanità e quella severità di carattere con cui, in tante agiografie, difficilmente si presentano i santi. Mentre parlavano, osservavo le pareti della Scuola di Barbiana dove tutto era rimasto a quei giorni in cui don Milani, a causa dell'aggravarsi del tumore, aveva dovuto abbandonare i monti del Mugello per concludere la sua esistenza nella casa della madre, in via Masaccio a Firenze. Tutto molto semplice, povero, essenziale, ma pieno di vita, di profezia, di attualità. La piccola piscina, simbolo borghese di ricchezza trasformato in strumento per abbattere le paure dei suoi giovani alunni. Era una giornata di primavera o autunno, non ricordo, però si stava bene fuori e abbiamo potuto concludere la breve visita scendendo verso il piccolo cimitero dove Lorenzo Milani è sepolto. Tornando poi lungo la strada sterrata nel bosco verso la Pieve, in quanto la scorciatoia per risalire era alquanto difficoltosa, avevo incontrato un grosso cane fortunatamente seguito a poca distanza dalla sua padrona. Mi ero, comunque, leggermente spaventato perché ero solo. Ecco la sensazione più forte di quella prima visita: la solitudine, la sofferenza, la paura che la figura di don Milani potesse continuare a essere fraintesa nella sua unicità e irripetibilità anche dopo la morte. Non tanto dalla società civile, dal mondo intellettuale e della cultura, dalle scuole e da educatori e docenti, ma dalla Chiesa, dai cristiani stessi. Segno di una ferita ancora profondamente aperta, quella con una parte dell'ambiente ecclesiale fiorentino, per un sacerdote che aveva semplicemente deciso di attuare e vivere il Vangelo fino in fondo, fino alla passione nell'orto del Getsemani. Obbediente al suo Vescovo in cui vedeva adempiersi la volontà di Dio Padre.
Leggendo il libro di Michele Gesualdi Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana, si percepisce proprio una grande sofferenza non tanto per le incomprensioni tra don Milani e i suoi due Vescovi, ma per lo scandalo causato nei giovani del tempo. Anche se questo può sembrare assurdo, Gesualdi esprime la consapevolezza che quell'esilio sia stato un evento di grazia che ha permesso alla vocazione di don Lorenzo di manifestarsi nella sua pienezza. Come testimonia il ricordo di questo sacerdote: «Mi sembra di sentirla ancora la sua voce: "bisogna innamorarsi di tutti quelli che fanno parte della nostra famiglia, di tutto ciò che facciamo e l'amore deve essere un amore carnale. Non esiste un uomo migliore di un altro, non esiste posto al mondo che io possa amare di più. È Dio che mi ha messo qui. Questa certezza è il simbolo di una predilezione sconfinata di cui sono stato oggetto. [...] Non ci sono rimpianti nella mia vita, né nostalgie. I miei superiori io li amo: nessuno può dimostrarmi di essere stato punito o di non aver ubbidito. Della verità non si deve aver paura; un sacerdote non ha nulla da perdere; ovunque vada, troverà sempre qualcuno da amare, non a parole che sarebbe un mostruoso misfatto e una ignobile falsità, ma con i fatti. Amare non significa dare qualcosa, significa dare noi stessi, significa essere e i poveri sono quelli che Dio oggi in particolare, ha gettato sul nostro cammino; essi sono il segno di contraddizione; di fronte a loro bisogna scegliere. Non ci sono vie di mezzo, né possibili compromessi. Non si può vivere senza innamorarsi. La soluzione che io ho trovato è una nelle infinite. Vedi questi bambini io li amo. Essi hanno riempito il mio cuore"» (cfr. M. Gesualdi, Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2016, pp. 232-233).
Ritirato sul monte è diventato un faro che ha rischiarato la notte indicando la strada per un rinnovamento del modo di vivere il Vangelo e di essere cristiani nell'oggi. Se il seme gettato non muore, non dà frutto. E più veniva ufficialmente isolato, più salivano alla Scuola persone importanti per incontrarlo, giudici, politici, giornalisti, professori, uomini di spettacolo. Più cercavano di nasconderlo più il suo pensiero sí diffondeva tra le persone. La forza della sua azione stava nella scelta di amare i ragazzi di Barbiana, senza cercare visibilità per se stesso, riconoscimenti pubblici o spazi di carriera. Umiliato, offeso, calunniato, per le parole di verità contenute nelle sue lettere e nei suoi scritti, non rispondeva con oltraggi, ma spiegava e rispiegava il senso del suo pensiero. Ed era questo che certamente non piaceva a tanti delatori: la capacità di non cedere all'ira, di obbedire sempre alla Chiesa, di rimanere fedele alla verità nell'oggettività del suo rivelarsi. E quando si esponeva e decideva di scrivere le sue lettere, come Risposta ai Cappellani militari, era a scopo educativo, di esempio per i suoi ragazzi affinché imparassero a rimanere fedeli alla propria coscienza in ogni occasione della vita. A sviluppare il proprio senso critico conservando sempre la libertà interiore ed esteriore. In quei giorni, infatti, sul quotidiano «La Nazione» di Firenze era riportato un documento dei cappellani militari contro l'obiezione di coscienza «in cui si leggeva, fra l'altro questa frase: "Considerano un insulto alla Patria e ai suoi Caduti la cosiddetta obiezione di coscienza che, estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà". Così lo racconta Lorenzo nella Lettera ai giudici: "Eravamo come sempre insieme quando un amico ci portò il ritaglio di un giornale. Si presentava come un comunicato dei cappellani militari in congedo della regione Toscana. [...] Ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella mia duplice veste di maestro e di sacerdote e loro mi guardavano sdegnati e appassionati. Un sacerdote che ingiuria un carcerato ha sempre torto. Tanto più se ingiuria chi è in carcere per un ideale. Non avevo bisogno di far notare queste cose ai miei ragazzi, le avevano già intuite. E avevano anche intuito che ero ormai impegnato a dar loro una lezione di vita. [...] Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote, e perfino al vescovo che sbaglia. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande I care. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. E il contrario del motto fascista Me ne frego"» (cfr. Lorenzo Milani. Gli ultimi e i primi, a cura di G. Ceccatelli, Edizioni Clichy, Firenze 2015, pp. 64-65).
Fiction, non realtà
I libri con i quali mi sono avvicinato alla sua figura sono stati Lettera a una professoressa prima ed Esperienze pastorali poi. Avevo appena iniziato la Facoltà di Filosofia. Lettera a una professoressa come prima reazione alla negativa esperienza scolastica liceale appena conclusa, Esperienze pastorali per capire cosa mi aveva allontanato dal catechismo e dalla parrocchia poco dopo essere passato a comunione. Non ne ho parlato per molto tempo con nessuno, forse tutto non avevo compreso, ma quelle letture hanno lavorato nella mia mente, ispirando il modo di rapportarmi con le altre persone e la realtà nel suo complesso. Spesso le sue frasi sono diventate degli slogan o si è pensato di riprodurre nelle scuole di oggi la Scuola di Barbiana. Nel 1997, su Raidue, è stata trasmessa la miniserie in due puntate Don Milani. Il Priore di Barbiana, di Andrea e Antonio Frazzi, con Sergio Castellitto e Ilaria Occhini. Film che, in modo semplice e coinvolgente, rendeva bene la figura di don Milani e la sua esperienza a Barbiana. A volte eccedendo un po' nel cliché del sacerdote controcorrente, al di là dagli schemi tradizionali e contestatario, ma senza mai discostarsi troppo dalla storicità dei fatti accaduti.
Nell'ottima interpretazione di un giovane Castelletto traspariva tutta l'ammirazione sua e dei due registi per una vita donata completamente a servizio dei suoi ragazzi. La novità di una pedagogia capace di valorizzare il singolo alunno rispettandone tempi e modi di apprendimento. Senza la fretta di giudicare, valutare, selezionare. Uno studio mai disgiunto dalla concretezza della vita, dal mondo del lavoro, da uno sguardo ampio, cosmopolita: l'apprendimento delle lingue e i viaggi di studio e lavoro all'estero, la lettura dei giornali, l'attualità, la conoscenza del presente e di cosa stava accadendo intorno a loro. il coraggio di stare sempre dalla parte della verità. Ed è una storia che incanta, che rende partecipe il pubblico mettendone in gioco i migliori sentimenti. I rapporti tra Milani e la sua famiglia sono delineati con grande sensibilità. Molto bella e toccante la scena della morte di don Milani con cui si conclude il film. A settembre, l'ho fatto vedere ai miei alunni in preparazione alla gita di inizio anno della nostra scuola a Barbiana, e ho avuto nuovamente conferma della bontà dell'opera dei fratelli Frazzi. Il problema è come fare esperienza di questa bellezza, come calarla nella vita dei giovani che oggi popolano le nostre scuole quando il mondo è completamente cambiato rispetto a quell'Italia di ormai cinquanta anni fa'. Quí la fiction non aiuta in quanto, per sua natura, tende a semplificare le cose, a renderle leggere, a eliminare il peso della storia, della realtà.
Un nume tutelare
«Nei racconti dei ragazzi riferiti dal loro compagno Edoardo Martinelli, [...] si può cogliere direttamente dalla voce degli allievi della scuola di don Milani l'impronta che quell'esperienza ha lasciato nella loro vita. L'impegno a riuscire, contraddicendo un destino già segnato; un po' di quella superbia, che secondo il priore andava coltivata negli umili; ma anche la memoria grata dello stupore per le scoperte, del senso di responsabilità dei più grandi per i progressi dei più piccoli, delle coraggiose e meravigliose avventure dei viaggi all'estero per imparare le lingue, inimmaginabili nelle loro famiglie, perfino della fatica e dei sacrifici necessari per frequentare la scuola, e magari anche dei rimproveri per un momento di pigrizia o di distrazione. Insomma una crescita personale evidente, riconosciuta e probabilmente mai sperata, come racconta Nevio, poi diventato autista di pullman e militante comunista: "della sua lezione mi sono rimasti oggi i ricordi più belli ed emozionanti. Mi è rimasta dentro una carica esplosiva che uso ogni qualvolta c'è bisogno, sperando di farlo nel modo più corretto e incisivo, mi è rimasta dentro la volontà di sentirmi una persona utile ai bisogni dei più deboli; la consapevolezza di non dover esser pecora e di andare anche controcorrente senza tradire quello che dice la mia coscienza, di dire sempre la verità, anche se questo può essere in contrasto con la mia fede politica, con le mie convinzioni sindacali e sociali e con gli interessi della Chiesa della quale mi sento di far parte". O come dice Edoardo, con le parole forse più belle: "L'orgoglio di comprendere il proprio stato, la propria condizione umana, l'ambiente in cui si cresce e in cui si vive, si lavora, si lotta. La consapevolezza di essere uno e inimitabile". Verità, fede, politica, convinzioni, orgoglio, consapevolezza, chi nella vita di ragazzi come questi, si era mai impegnato a fare simili doni?» (Lorenzo Milani. Gli ultimi e i primi, pp. 58-60).
Ripeto le ultime parole scritte da Giovanna Ceccatelli, «verità, fede, politica, convinzioni, orgoglio, consapevolezza» perché sono quelle cose che cerco di trasmettere ai ragazzi da quando, tredici anni fa, mi sono ritrovato a insegnare a dei liceali. Riuscire a fare questo credo sia il sogno di ogni professore che voglia essere anche educatore. Umili, vite segnate, poveri, sono le altre parole da cogliere, che probabilmente vanno in netto contrasto con la realtà di oggi, dove i ragazzi sperimentano sempre una forma di abbandono, ma insieme ad abbondanza, disillusione, scetticismo, narcisismo. Allora diventa difficile realizzare le altre parole. Ed è forte il rischio di scivolare nel moralismo colpevolizzando i giovani come se la povertà fosse l'unica strada per accettare la necessità di avere dei maestri. Come se il dialogo potesse crearsi solo tra persone umili, che cercano qualcosa, che prima di ottenere prestazioni desiderano conoscere. Solamente realizzare una scuola senza voti, cattedre e registri, sarebbe un problema, ma bisogna trovare il modo di raggiungere gli stessi obiettivi educativi anche oggi. I giovani attendono sempre qualcuno che li liberi. E, tuttavia, non basta leggere in classe Lettera a una professoressa, perché quell'esperienza torni magicamente a vivere. Così, dopo i primi anni di insegnamento, ho smesso di ricorrere a strane bacchette magiche, ma ho semplicemente preso una foto di don Milani da ragazzo, l'ho incorniciata e appesa in aula come un nume tutelare che ti protegge le spalle, che con il suo esempio indica lo scopo ultimo di fare scuola, un percorso particolare da cui prendere ispirazione.
La voce del maestro
Slogan, sogno, esempio, realtà, essere, sono le cinque tappe del percorso del mio avvicinamento a don Lorenzo Milani. Così, lo scorso 22 novembre, sono andato a vedere Barbiana '65. La lezione di don Lorenzo Milani, il documentario di Alessandro G.A. D'Alessandro (Italia 2017) prodotto da Laura e Silvia Pettini per Felix Film in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e Fondazione Don Milani. Al Nuovo Cinema di Figline Valdarno, dove ha avuto luogo la proiezione, era presente una delle produttrici, Laura Pettini, che, presentando il documentario, ha ripercorso brevemente la lunga storia della sua genesi partendo dall'occasione che cinquantadue anni fa aveva portato il padre di D'Alessandro a salire a Barbiana. Il regista Angelo D'Alessandro, autore di sceneggiati importanti per la Rai come Zanna Bianca e Ciuffettino, si era recato da don Milani per un'inchiesta sull'obiezione di coscienza. Si era, poi, proposto di fare una lezione di cinema a quei giovani come ne faceva tante ai suoi studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia. In particolare, mostrare ai ragazzi un film di Georg Wilhelm Pabst, La tragedia nella miniera, considerato uno dei principali film pacifisti del tempo. In effetti, appena a Barbiana arrivò la corrente elettrica, una delle prime cose che fece don Milani fu quella di procurarsi un proiettore da 16 millimetri con cui studiare con i ragazzi film d'autore, analizzandone linguaggio e montaggio, fotogramma per fotogramma. Ed effettivamente, come ha ricordato il figlio di D'Alessandro nel comunicato stampa a cura di Laura Pettini per la Felix Film, il film «venne visionato varie volte dal priore e dai ragazzi che alla fine dimostrarono come sí trattasse in realtà di un film mediocre. Mio padre raccontava di come avessero perfettamente ragione: era salito per fare lezione ai ragazzi ma la lezione l'avevano fatta a lui». Nacque, così, un dialogo profondo sui temi della fede, del Vangelo, dei diritti umani, della guerra e della pace, tra il regista e i giovani di don Milani, che lo porterà a tornare più volte a Barbiana. Fino a quando, comprendendo la sua sincera partecipazione all'esperienza della Scuola, sarà lo stesso don Milani a offrirgli la possibilità di riprendere e di girare un documentario sul metodo di Barbiana.
I filmati originali – circa 40 minuti in pellicola bianco e nero, mentre la colonna sonora era stata registrata a parte su nastro magnetico, come si usava in quegli anni – mostrano alcuni momenti fondamentali della Scuola di Barbiana: la scrittura collettiva, la lettura dei giornali, i ragazzi píù grandi che insegnano ai più piccoli, il lavoro manuale svolto dai ragazzi e la partecipazione alla Messa, in cui vediamo don Milani celebrare, ma solo "per finta", per la macchina da presa. Spezzoni di pellicola e riflessioni personali del regista rimasti per lunghi anni separati, fino a quando il figlio, dopo la morte del padre, dopo un lungo lavoro di riflessione e preparazione, non ha trovato l'ispirazione per unirli in una narrazione. Nel tentativo di farsi guidare dalla viva voce di don Milani, che al momento delle riprese stava scrivendo con i suoi ragazzi Lettera ai giudici, per difendersi dalle accuse di apologia di reato nel processo che lo attendeva a Roma, per cogliere il senso ultimo, lo scopo del suo fare scuola. Che, nell'interpretazione di D'Alessandro, è: far diventare i suoi allievi dei cittadini veri, uomini capaci di andare in fondo alle cose, ragionare con la propria testa ed essere "sovrani di se stessi". Attraverso uno studio approfondito, la Costituzione italiana e il Vangelo. Come nei loro interventi durante il documentario hanno cercato di chiarire i tre testimoni chiamati a rappresentare i tre pilastri della Scuola di Barbiana: metodo didattico, Adele Corradi, l'insegnante che ha vissuto l'esperienza di Barbiana con don Lorenzo; Costituzione italiana, Beniamino Deidda, ex Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e docente volontario fin dalla scuola a Calenzano; Vangelo, don Luigi Ciotti.
Non saprei dire quanto il documentario possa essere efficace per avvicinare, chi ancora non conosce don Milani, alla Scuola di Barbiana, ma è sicuramente un importante punto di partenza per continuare a studiare e ad approfondirne la figura. Sono rimasto colpito dalle immagini iniziali dove i ragazzi, prima in lambretta, poi a piedi, sotto la pioggia, per strade fangose, raggiungevano contenti la loro scuola. Come partecipavano alle lezioni di don Milani e sapevano interloquire con chi andava a trovarli. Mi ha colpito il suono della sua voce, il suo sguardo, il suo modo di essere, ed è stato come rincontrare un vecchio amico. Ed è bello che il documentario si sia concluso con le immagini di papa Francesco che prega sulla tomba di don Milani, perché quella visita del 20 giugno 2017 ha posto fine a un lungo esilio di sofferenza e solitudine, dando al sacerdote fiorentino il posto che merita nella Chiesa del nuovo millennio. Una Chiesa chiamata a ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani. «Non c'è da parlare della eroica storia di don Lorenzo Milani, ma della eroica storia dei poveri, della nobiltà della classe operaia e contadina che mi ha accolto e aperto gli occhi. In questi anni vi ho educato a sentirvi classe, a non dimenticarvi dell'umanità bisognosa e a tenere a bada il vostro egoismo, perché non si tratta di produrre una nuova classe dirigente, ma una massa cosciente. Il buon cristiano, oggi, non si limita a fare l'elemosina, ma s'impegna a
lottare per rimuovere le cause che tengono i poveri in condizione di sottomissione e miseria» (L. Milani, in M. Gesualdi, Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana, cit., p. 208). «Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con una fede consapevole. Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, in cui solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti spesso confusi messaggi che ci piovono addosso, e di dare espressione alle istanze profonde del proprio cuore, come pure alle attese di giustizia di tanti fratelli e sorelle che aspettano giustizia. Di quella umanizzazione che rivendichiamo per ogni persona su questa terra [...] fa parte anche il possesso della parola come strumento di libertà e di fraternità» (dal discorso di papa Francesco, in occasione del pellegrinaggio a Barbiana, 20 giugno 2017).
(FEERIA 17/1 n. 51, pp.50-55)

Trasparente e duro come il diamante
«Trasparente e duro come il diamante, doveva subito ferirsi e ferire». Delle definizioni di don Lorenzo Milani è forse questa la più sintetica ed efficace, non per caso appartiene a don Raffaele Bensi, padre spirituale di Lorenzo Milani dalla conversione alla morte, unico custode del segreto della sua fede. Ma a cinquant’anni dalla morte, ora che anche un Papa ha detto una parola definitiva su di lui, ancora dobbiamo chiederci – rubando il titolo al suo amico Giorgio Pecorini -: Don Milani, chi era costui? Proviamo a rispondere, poco più che in pillole, tenendo conto degli ultimi sviluppi.
UNA FAMIGLIA COLTA, AGNOSTICA E FACOLTOSA
Lorenzo Milani nasce, secondo di tre fratelli, a Firenze nel 1923 da Albano Milani Compretti e Alice Weiss, triestina. La famiglia è colta, facoltosa e agnostica, ma i figli Milani vengono battezzati quando si profila il rischio delle leggi razziali, dato che la mamma è di origine ebraica. Il bisnonno è il filologo Domenico Milani Comparetti. Tra i compagni di giochi nell’infanzia di Lorenzo ci sono i rampolli delle famiglie della borghesia fiorentina e, negli anni della scuola secondaria, milanese, tra loro Oreste Del Buono.
Da ragazzo Lorenzo è uno studente intelligente e incostante, che si applica con passione alle cose che gli interessano e trascura le altre, sapendo però di poter vivere della rendita della cultura respirata in famiglia, e, se del caso, di poter contare sul soccorso degli intellettuali pregiati, cui viene affidato nei momenti di difficoltà. Per un periodo va a lezione da Giorgio Pasquali, uno dei padri della filologia moderna.
Nel 1930 la famiglia si trasferisce a Milano dove Lorenzo completa gli studi fino alla maturità classica. Dopo, rifiuta di iscriversi all’Università e manifesta il desiderio di frequentare l’Accademia delle belle arti, cosa che il padre qualifica, come una “bambinata”. Però non lo ostacola forse nella convinzione che sia una passione transitoria: Lorenzo studia a Brera e va a lezione dal maestro Staube: il talento artistico è quello che è, modesto, ma il maestro coglie nell’allievo una sorta di “veemenza” nell’apprendere, che s’applicherà più tardi ad altre più concrete scelte di vita.
MISTERO DELLA FEDE E INDIGESTIONE DI CRISTO
È il 1941, Lorenzo sta studiando pittura e progetta di affrescare una cappella nella tenuta di famiglia a Monterspertoli. La sta esplorando quando, a un certo punto, scrive una lettera all’amico Oreste Del Buono: «Ho letto la Messa. Sai che è più interessante dei Sei personaggi in cerca d’autore?».
Potrebbe essere il primo segno di quello che sta cambiando dentro di lui. Anche se della genesi della sua fede si sa pochissimo, il poco che ha testimoniato don Raffaele Bensi, allora parroco di San Michelino a Firenze. Le lettere pubbliche del loro carteggio sono poche, alcune in Perché mi hai chiamato? (San Paolo). Per molto tempo si è ritenuto che fossero state tutte distrutte, ma gli storici non disperano ancora di poterle ritrovare.
Dell’innesco della fede del futuro don Milani non esistono racconti di eclatanti folgorazioni: c’è solo la testimonianza di un colloquio con don Bensi. Il padre spirituale ricorda il giovane Lorenzo, nel giugno 1943, che, per non interrompere un dialogo avviato, lo accompagna a celebrare il funerale di un giovane sacerdote e in quell’occasione promette: «Io prenderò il suo posto». Comincia lì quella che don Raffaele Bensi chiama «l’indigestione di Cristo», lo studio matto e disperatissimo in cui Lorenzo si immerge per recuperare le conoscenze mancanti.
GLI ANNI DEL SEMINARIO
L’ingresso in seminario, nel 1943, segue di poco la conversione: pur ligissimo alle regole, anche lì Lorenzo si rivela uno studente impegnativo che non dà pace a docenti e superiori: fa domande complicate e scomode, obbedisce sempre ma non rinuncia mai ad esercitare il senso critico e non si accontenta di risposte che non siano anche profonde.
Per la famiglia la scelta di Lorenzo è un mistero: non la comprendono ma la rispettano perché capiscono che questa volta non è una bambinata. È anzi, nella sua radicalità, una scelta adulta e matura che nel modo di esprimersi già manifesta, in nuce, la fedeltà scabra all’essenza del Vangelo, che sarà la cifra del sacerdote don Milani: d’una coerenza e di una franchezza destinate a rivelarsi scomode per molti.
Nelle lettere alla madre Lorenzo racconta con ironia ed entusiasmo la vita del seminario: una vita, negli anni di guerra, di freddo e cibo scarso. Lorenzo minimizza le sofferenze, sapendo bene di dover contenere le preoccupazioni della madre per la salute del figlio da sempre cagionevole e soggetto a bronchiti continue, per non dire delle altre preoccupazioni legate alla sua non compresa scelta di vita: è un’incomprensione che, però, si nutre di affetto e di rispetto reciproci, tanto che Lorenzo invita i genitori alle cerimonie che segnano le tappe della sua formazione religiosa. Ma rispetta le volte in cui decidono di non partecipare. Il 13 luglio 1947 Lorenzo Milani diventa don Milani e celebra la prima Messa a San Michelino.
SAN DONATO E LA SCUOLA POPOLARE
Dopo pochi mesi a Montespertoli, cappellano di don Bonanni, la prima “vera” destinazione del sacerdote don Milani è San Donato a Calenzano, un comune operaio in provincia di Firenze, a larghissima maggioranza comunista, dove viene mandato come cappellano dell’anziano don Pugi. È in quel contesto che nasce la scuola popolare: don Milani la fonda laica, perché nessuno se ne senta escluso a priori: capisce al volo che dal punto di vista pastorale costringere i giovani a scegliere tra il padre comunista e la scuola, sarebbe il modo di perderli senza neanche provare ad avvicinarli.
Sono gli anni delle grandi lacerazioni politiche attorno alle elezioni del 1948, della scomunica ai comunisti. Don Milani fa campagna elettorale per la Democrazia cristiana, anche se invita a tener conto nelle preferenze dei più attenti alla causa dei poveri. Ma, a contatto con la povertà e con lo sfruttamento, comincia a percepire nell’anima lo scarto tra le opportunità in cui è cresciuto e la miseria materiale e intellettuale in cui versa il popolo che gli è stato affidato e a maturare una profonda coscienza sociale. Fa scuola perché capisce che chi non ha la cultura minima per leggere un giornale o un contratto di lavoro non è in grado di difendersi dallo sfruttamento né di elaborare un pensiero critico. Si rende conto che senza la comprensione delle parole l’orizzonte della vita umana si riduce alla conquista di un piatto di minestra la sera e che anche l’ascolto della Parola rischia di diventare mera prosecuzione di riti, di cui non si comprende il significato.
Sono anche gli anni delle prime prese di posizioni pubbliche come la lettera aperta “Franco, perdonaci tutti, comunisti, industriali, preti”. Pubblicata su Adesso il quindicinale fondato da don Primo Mazzolari, con cui scambia alcune lettere: parole essenziali e molto dirette che mettono a nudo – senza perifrasi - le contraddizioni di una Chiesa non sempre schierata con i poveri nei gesti quanto vorrebbe esserlo predicando.
Cominciano a maturare le convinzioni che sfoceranno in Esperienze pastorali. Cominciano qui le incomprensioni con la gerarchia che vede nelle idee di quel cappellano più un pericolo che un invito accorato al ritorno all’essenza spoglia del Vangelo di Cristo, così efficacemente sintetizzata pare nel 1950, ma la data è controversa, nella lettera al giovane comunista Pipetta: «Quando tu non avrai più fame né sete, ricordatene Pipetta, quel giorno io ti tradirò. Quel giorno finalmente potrò cantare l'unico grido di vittoria degno d'un sacerdote di Cristo: “Beati i... fame e sete”».
L'ESILIO SUL MONTE DEI GIOVI
ll Concilio Vaticano II è lontano, la Curia fiorentina “soffre” il pensiero sociale avanzato da quello che gli storici della Chiesa chiameranno “il chiostro di folli di Dio”, formatosi attorno al cardinale Elia Dalla Costa con La Pira, Balducci, Rosadoni, Barsotti, Fabbretti, Turoldo, Bensi.
La voce del giovane cappellano Milani tuona con una franchezza sconosciuta ai toni felpati della curia del tempo e il suo dialogo “con i lontani”, come si diceva allora, viene percepito come troppo aperto.
Pesano i simboli: la scuola laica che non esclude e il funerale di un giovane operaio, durante il quale in chiesa sono apparse bandiere rosse. Dalle lettere si capirà che don Milani non le condivideva e non le avrebbe volute, ma che in quella circostanza non osò buttarle fuori perché in quel contesto avrebbe significato perdere tutte in blocco le pecorelle che stava faticosamente cercando di riportare all’ovile, distruggere con un gesto tutto il lavoro fatto per sminare il clima di reciproca diffidenza tra il suo popolo e la sua Chiesa. Ma sapeva anche che all’esterno avrebbero frainteso e ne soffriva.
Quando il 12 settembre del 1954 muore il parroco di San Donato don Pugi non accade quello che le pecorelle di San Donato si attendono e cioè che don Milani venga confermato parroco al suo posto. Gli assegnano, invece, un’altra parrocchia, ma non è una delle tante. È Sant’Andrea di Barbiana, una pieve isolatissima sul monte dei Giovi in Mugello.
Barbiana non è un paesello: è una chiesetta, una povera canonica, qualche cipresso e un piccolo cimitero, sul cocuzzolo di una montagna a cinquecento metri d’altitudine. Quaranta anime sparse per le case lontane. La parrocchia già destinata alla chiusura resta aperta per don Milani.
LA SCUOLA DI BARBIANA
Quando don Lorenzo Milani ci arriva, accompagnato dalla governante di San Donato Eda Pelagatti e dall’anziana madre di lei Giulia, il 6 dicembre del 1954, a Barbiana si sale a piedi, per una mulattiera. Quel giorno piove a dirotto: non c’è acqua corrente, né gas, né luce. Quando don Lorenzo ci arriva, Barbiana è la fine del mondo, ma scrive alla madre che non provino a distoglierlo da lì, a parlargli di un altro sradicamento dopo quello appena subito.
Il giorno dopo va in Comune a Vicchio e si compra una tomba al cimitero di Barbiana: don Milani ha 31 anni. Quello che trova è un popolo di pastori e contadini che pascola pecore e faticosamente strappa, al bosco che tutto mangia, una terra avara di frutti da dividere a metà col padrone in regime di mezzadria. Anche il parroco ha due poderi e don Milani decide subito che non chiederà ai due mezzadri che lo coltivano la metà del raccolto che gli spetterebbe.
E capisce subito che i figli di quel popolo sparso, se il pomeriggio vanno nei campi o a badar pecore, son destinati a uscire prematuramente dalla scuola di Stato senza saper né leggere né scrivere, defraudati, se non nella forma nella sostanza, del loro diritto all’istruzione e dei loro diritti successivi: scartati già da piccoli, come direbbe oggi papa Francesco, costretti a delegare in tutto, incapaci di aver voce in capitolo come persone, come cittadini, come cristiani.
La scuola di Barbiana in casa del priore o sotto il pergolato comincia con un doposcuola, che prestissimo diventa avviamento professionale e, quando sarà il momento, nel 1963, corso di recupero per la media unificata, per cui sarà preziosissimo negli ultimi anni l’aiuto di Adele Corradi, una professoressa che si farà trasferire in una scuola pubblica della zona, per dare una mano a don Milani con continuità.
La scuola di Barbiana è aderente alla vita e a tempo pienissimo: tutto è occasione di apprendimento, la fanno da padrone le parole in tante lingue, grimaldello per capire il mondo e il Vangelo. Don Milani accoglie i diseredati, quelli senza un’alternativa, rifiutati dalle scuole ufficiali, provenienti dalle case della zona o portati dagli amici, tra loro due fratelli orfani Michele e Francuccio Gesualdi, che gli crescono in casa come figli. L’esperimento educativo di Barbiana, che arriva a mandare i ragazzi da soli all’estero a studiare le lingue, Francuccio addirittura in Algeria, mantenendosi lavorando, attira l’interesse e la curiosità di molte persone che vanno lassù a vedere e vengono messe da don Milani a insegnare ciò che sanno ai suoi ragazzi invitati a far domande, a togliersi la timidezza contadina.
IL CASO "ESPERIENZE PASTORALI"
Sono gli anni in cui maturano gli scritti di don Milani, Esperienze pastorali esce nel 1958, ha l’imprimatur, ma fa rumore: non è un trattato di scienze pastorali, è la sintesi dell’esperienza vissuta da don Milani. Una riflessione sociologica, razionale e senza eufemismi – statistiche alla mano – sulle condizioni delle comunità a lui affidate, sul ruolo del parroco in contesti di povertà materiale e intellettuale.
In quelle pagine don Milani prende le distanze dalle forme di intrattenimento in uso negli oratori e nelle parrocchie, indicando lo studio e non lo svago come strada maestra dell’apostolato. Lo fa con un modo di esprimersi diretto, insolito tra i sacerdoti, che risulta urticante a molti e in primis alla Curia fiorentina dell’epoca. Il libro viene ritirato, pochi mesi dopo, dal Sant’Uffizio (per ragioni di opportunità, ma non con un decreto che ne metta in questione l’ortodossia).
Una recensione, firmata da padre Angelo Perego su La Civiltà cattolica, stronca pensantissimamente il libro e, per l’autorevolezza della fonte, segna in modo determinante la storia dell’incomprensione di don Lorenzo da parte della Chiesa, incluso il patriarca Angelo Roncalli futuro Giovanni XXIII. Un motivo di sofferenza senza tregua nella vita di don Milani, che esprime le sue idee con parole che riflettono insieme la sua toscanità e la radicalità del convertito, obbedendo però sempre a ogni minimo ordine dei superiori.
L'OBBEDIENZA NON E' PIU' UNA VIRTU'
Al di fuori della Chiesa, più che Esperienze pastorali, è – nel 1965 - la Lettera ai Cappellani militari a porre don Milani al centro del dibattito pubblico: è il testo noto come L’obbedienza non è più una virtù. Si tratta di una risposta a una presa di posizione pubblica di alcuni Cappellani militari che tacciano di “viltà” gli obiettori di coscienza.
Don Milani e i suoi ragazzi, che sulla porta della loro scuola hanno il motto “I care”, “mi importa”, “mi faccio carico”, e che stanno riflettendo insieme sul primato della coscienza, sulla necessità dell’assunzione della responsabilità del singolo nella società, rispondono con la lettera aperta che sortisce grande clamore: pongono - con rigore logico - il problema morale del cristiano davanti alle armi e alla guerra e, in particolare, all’ordine di sparare sui civili inermi.
L’obiezione di coscienza e il pacifismo non sono ancora un fatto acquisito per la Chiesa e nemmeno lo Stato ha ancora accettato come legale l’obiezione di coscienza al servizio militare: chi si sottrae alla leva obbligatoria finisce in carcere. A complicare a don Milani le cose con la Chiesa c’è il fatto che la lettera, spedita a tutti i giornali anche cattolici, viene pubblicata soltanto da Rinascita. Ma non tutti nel mondo cattolico hanno chiaro che non è stata una scelta del priore pubblicare su un giornale comunista. A complicargliele con lo Stato c’è la legge: Don Milani e Luca Pavolini, direttore di Rinascita, subiscono insieme un processo per istigazione a delinquere. Mentre il dibattito sull’obiezione di coscienza esplode e divide.
Don Milani al processo non partecipa, non nomina un avvocato ma si lascia difendere dall’avvocato d’ufficio Alfonso Gatti. E’ già molto malato, un linfoma di Hodgkin gli ha già decretato vita breve, si difende al processo con una memoria difensiva: nota come Lettera ai giudici. Il primo grado si conclude con l’assoluzione di entrambi.
LETTERA A UNA PROFESSORESSA
Un altro episodio, la bocciatura di due ragazzi di Barbiana all’esame d’ammissione alle scuole magistrali, innesca l’ultimo scritto: Lettera a una professoressa, una spietata, provocatoria, disamina sulla scuola pubblica dell’obbligo di quegli anni, incapace di colmare, secondo Costituzione, gli svantaggi iniziali di chi nasce in una casa povera di cultura e di denari.
Possibile, si chiede don Milani, che il Padreterno faccia nascere gli asini e gli svogliati solo nelle case dei poveri? La lettera è scritta con l’innovativo metodo della scrittura collettiva insieme ai ragazzi e va alle stampe, con una corsa contro il tempo, nell’aprile del 1967: don Milani è alle ultime settimane di vita, continua a soffrire anche per l’incomprensione della Chiesa, che il suo vescovo non smette di manifestargli.
Il testo di Lettera a una professoressa avrà vita propria dopo la morte del Priore: molto citato, poco letto, il più delle volte misconosciuto, diverrà ne mesi successivi icona della contestazione studentesca. Accanto agli entusiasmi non mancano strumentalizzazioni e fraintendimenti che, insieme ad altri successivi, spiegano l’accusa postuma a don Milani, ripetutamente tacciato, fino all’oggi, di essere stato – tramite la Lettera avulsa dal suo contesto - l’ispiratore dei guasti (veri o presunti) dell’istruzione contemporanea.
IL TESTAMENTO
Don Lorenzo Milani muore a 44 anni il 26 giugno del 1967 in via Masaccio a casa della madre dove ha trascorso gli ultimi mesi di vita, senza ricevere l’abbraccio del suo vescovo Ermenegildo Florit che non ha mai compreso l’urgenza evangelica sottesa ai suoi comportamenti. Il processo di appello condannerà Pavolini, mentre per don Milani la morte ha estinto il reato. Ai suoi ragazzi lascia un testamento che si conclude così: «Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non ho debiti verso di voi. L’ho scritto per dar forza al discorso! Ho voluto più bene a voi che a Dio. Ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. Un abbraccio, vostro Lorenzo». Nel 2014 Papa Francesco rimuove il provvedimento emesso nel 1958 dal Sant’uffizio su Esperienze pastorali. Il 20 giugno 2017 Francesco è il primo papa della storia a pregare a Barbiana sulla tomba di don Lorenzo Milani e nelle parole pronunciate quel giorno accoglie, definitivamente, come «un bravo prete da cui prendere esempio», il Priore di Barbiana nell’alveo della Chiesa. Ora possiamo dire che don Milani aveva ragione, quando diceva: «Fra cinquant’anni mi capiranno». E’ andata così, alla lettera.
Pino Puglisi..rendeva sacre le vite
"Abbiamo bisogno di persone che si mettano a servizio delle vocazioni, di persone cioè che siano a servizio dei fratelli, ponendosi accanto a ciascuno per un cammino graduale di discernimento. Persone che a tal fine diano indicazioni, alla luce della Parola di Dio, perché ciascuno capisca qual è la sua vocazione e qual è il servizio che deve rendere".
"Il maggior bene che ciascuno di noi può fare al fratello è aiutarlo a scoprire e poi a seguire la sua vocazione. Cioè a comprendere qual è il progetto che Dio ha su di lui e a realizzarlo".

Ognuno di noi sente dentro di sé una inclinazione, un carisma.
Un progetto che rende ogni uomo unico e irripetibile.
Questa chiamata, questa vocazione è il segno dello Spirito Santo in noi.
Solo ascoltare questa voce può dare senso alla nostra vita.
"Bisogna cercare di seguire la nostra vocazione, il nostro progetto d'amore.
Ma non possiamo mai considerarci seduti al capolinea, già arrivati. Si riparte ogni volta. Dobbiamo avere umiltà, coscienza di avere accolto l'invito del Signore, camminare, poi presentare quanto è stato costruito per poter dire: sì, ho fatto del mio meglio".
Padre Pino Puglisi
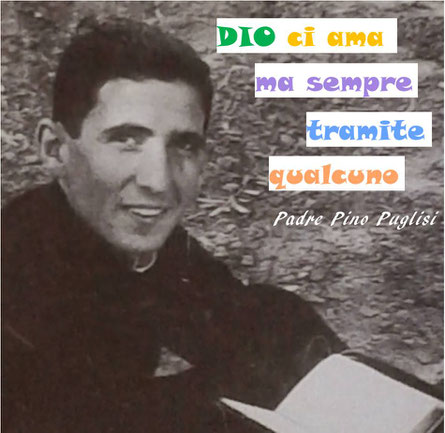
A testa alta
di Alessandro D'Avenia
«Perché lo avete ucciso?», chiede il magistrato. «Perché si portava i picciriddi (i bambini) cu iddu (con lui)», risponde il sicario che ha sparato il colpo alla nuca. Si tratta del Cacciatore, questo il suo soprannome a Brancaccio. Aveva sparato a padre Pino Puglisi, 3P, come lo chiamavamo noi a scuola, il 15 settembre 1993, 25 anni fa. Stavo per cominciare il quarto anno e lui, uno dei professori della mia scuola, il Liceo Vittorio Emanuele II di Palermo, non sarebbe più entrato in classe. Capo d’accusa: far giocare e studiare, con l’aiuto volontario dei ragazzi di cui era professore di religione, bambini che altrimenti erano preda della strada e di chi su quella strada comandava. Troppo poco?
3P sapeva infatti mescolare i quadrati della scacchiera di Palermo, facendo muovere chi conosceva solo la città di luce verso quella più tenebrosa, e viceversa. I ragazzi di un rinomato liceo classico aprivano gli occhi su strade nuove, perché l’inferno poteva essere girato l’angolo. A cosa serviva la cultura che ricevevamo se restavamo ciechi su ciò che avevamo accanto? Don Pino sapeva che per far rifiorire il quartiere in cui era nato e cresciuto, bisognava ripartire da bambini e ragazzi, anche se, per stare fermi e in silenzio, gli alibi non mancavano. La sua battaglia era tanto semplice quanto pericolosa: ridare dignità ai giovanissimi attraverso il gioco, lo studio, la catechesi, prospettando loro una vita diversa da quella del «picciotto mafioso». La mafia alleva il suo esercito tenendo la gente nella miseria culturale e assicurando il sufficiente benessere materiale, condizioni che riescono a garantire un consenso indiscusso nei contesti da cui attinge. Don Pino ne inceppava dall’interno il meccanismo, ripetendo a bambini e ragazzi di andare «a testa alta», perché la dignità non è un privilegio concesso da qualcuno, ma dono connaturato al nostro essere qui, voluti dal Padre Nostro e non dal Padrino di Cosa Nostra. Per questi motivi lottò per aprire un centro che chiamò «Padre Nostro», dove i ragazzi potevano stare anziché lasciarsi ghermire dalla strada, e si batté per avere la scuola media nel quartiere. Il giorno del suo omicidio era andato per l’ennesima volta nei sordi uffici del Comune a sollecitare i permessi per la scuola, inaugurata solo 7 anni dopo la sua morte.
Nonostante i molti impegni pastorali non smise mai di insegnare religione. Proprio quell’estate, forse temendo qualcosa, aveva chiesto una diminuzione d’orario, ma il preside che teneva a lui quanto i ragazzi, lo aveva convinto a non farlo. Ho conosciuto il suo volto, sempre sorridente anche se provato, da cui non traspariva la lotta impari che stava combattendo silenziosamente. La sua pace veniva dall’unione con Cristo, di cui offriva lo sguardo ad ogni persona, perché riteneva ogni vita unica e necessaria alla multiforme armonia del mondo, e infatti paragonava le singole vite alle tessere dei meravigliosi mosaici del duomo di Monreale. Per questo decisero di ucciderlo, perché scardinava il sistema mafioso da dentro, non con slogan o bei pensieri, ma lavorando accanto alle persone, calpestando le loro strade e dando loro nutrimento per il corpo e lo spirito, così che percepissero la possibilità di un’altra «strada». Per questo lo fecero fuori, erano gli anni di Riina, al quale i Graviano, capi mandamento del quartiere, erano affiliati. 3P era, a suo modo, dal basso, tanto pericoloso quanto Falcone e Borsellino, uccisi un anno prima. «Si portava i picciriddi cu iddu»: portava i bambini, non a lui, ma con lui verso una vita nuova, più piena, più bella, sicuramente meno facile, ma costruttiva, libera, vera. Padre Puglisi era «pericoloso» perché era un vero maestro, apriva la strada, ti prestava il coraggio che non avevi, come i veri padri. E proprio come i veri padri pagò di persona.
Avevo solo 16 anni. Ho provato a raccontare questa storia di tenebra e luce nel romanzo «Ciò che inferno non è», perché ha determinato il mio sguardo su me stesso e sul mondo. Ho sentito entrare dentro di me una vita molto più ampia e non volevo che quel fatto diventasse, con il tempo, l’ennesima, archeologica, commemorazione di una delle tante ferite della mia città, recuperata per l’occasione nelle soffitte della retorica. In molti sentimmo che quel sangue mite e coraggioso raggiungeva cuore e membra come una trasfusione. E così se il professore di lettere mi aveva fatto vedere «che cosa» sarei voluto diventare, un altro, 3P, mi fece vedere «come»: impegnarsi per ogni vita, anche quando c’è poco da sperare o attorno hai un sistema che ti scoraggia, ostacola, deride. Quel giorno ho capito che dovevo bandire dalla mia vita gli alibi: il pessimismo diventò per me una scusa per starsene comodi e la speranza la principale attività della testa, del cuore e delle mani. Grazie a 3P ho imparato che la vita può essere felice solo quando è impegnata per gli altri, il suo umanesimo era integrale, non solo mentale o verbale: affermare la vita altrui, costi quel che costi, perché raggiunga la vera altezza: «a testa alta, dovete andare a testa alta!». Per questo portava i bambini a guardare il cielo stellato, per trasformare il loro desiderio di vita attraverso la morte, come mostrava la mafia, in desiderio di vita attraverso la vita, come mostrava lui.
A lui mi ispiro per il mio lavoro. L’uomo che sono diventato lo devo alla ferita di quel sedicenne inconsapevole, ingenuo, egoista, che aprì gli occhi su un modo di impegnarsi nella vita che non poteva essere fatto solo di sogni e parole, ma doveva farsi carne. 25 anni dopo voglio ricordare quell’uomo minuto, sembrava che il vento potesse farlo volar via, ma gigantesco nella fede in Dio e quindi nella fede nell’uomo. L’ho constatato incontrando i ragazzi che operano oggi al Centro Padre Nostro, di fronte alla chiesa di San Gaetano. Studenti delle superiori o universitari si impegnano per i bambini come faceva don Pino, come è chiamato a fare ogni maestro, «portarsi i picciriddi cu iddu», non a lui, ma con lui: perché educare è dare a un giovane uomo coraggio verso se stesso e il mondo, ma tale forza educativa si sprigiona solo se io stesso sono impegnato, come posso, a crescere con quell’uomo. Abbiamo bisogno di maestri, il messaggio arriva forte e chiaro da una delle tante lettere sul tema, ricevuta pochi giorni fa: «Mi son sempre sentita sbagliata in classe. Ho avuto paura di occupare un posto nel mio banco e nel mondo, mi sono convinta di non essere abbastanza: abbastanza intelligente, abbastanza creativa, abbastanza bella… Non ho trovato insegnanti innamorati del proprio mestiere e capaci quindi di scovare il tesoro che ogni persona nasconde, ma insoddisfatti della propria condizione e convinti dell’inferiorità delle nuove generazioni. Ho avuto insegnanti che non leggevano una poesia “perché tanto non capireste”. Così mi sono ritrovata, da sola, a cercare parole che mi avrebbero salvato. Ho divorato libri, anche il manuale di letteratura. Cercavo chi mi avrebbe abbracciato anche da epoche lontane, chi mi avrebbe dato la mano e accompagnato nei tempi più bui. Ho trovato chi mi facesse conoscere il mondo, gli altri e me stessa. Da sola. Sto studiando per diventare maestra e ho fatto la mia prima esperienza in quarta elementare. È stata una delle cose più belle che mi siano successe. Ho scoperto con i bambini mondi così profondi che non scorderò mai». Essere maestri è aprire strade e aiutare le persone a sentirsi «abbastanza», scoprendo che in realtà lo sono già: «a testa alta, dovete andare a testa alta!». 3P da vero maestro non ha mai accampato alibi (in latino «alibi» vuol dire letteralmente essere «altrove») in un quartiere difficilissimo, né a scuola, ma ha creduto in quei giovani contro ogni speranza. Ha amato lì dov’era, con lui nessuno era «sbagliato».
La più bella definizione di maestro che io conosca si trova nell’incontro tra Dante e Brunetto Latini. Il poeta dice al defunto maestro che nella sua mente «è fitta, e or m’accora,/la cara e buona imagine paterna/di voi quando nel mondo ad ora ad ora/m’insegnavate come l’uom s’etterna». Ricorda con affetto la figura «paterna», maestro è chi dà la vita, uomo o donna che sia, e gli è grato perché «ad ora a ora», che mi piace pensare in termini di quotidiano orario scolastico, gli insegnava «come l’uom s’etterna», parole che indicano l’immortalità dell’anima, ma in senso più ampio, la ricerca radicale di ogni uomo: attingere a una vita che non si rovina, ma sempre si rinnova, all’altezza del desiderio umano. Brunetto si rammarica: «figliuolo mio… s’io non fossi sì per tempo morto… dato t’avrei a l’opera conforto». Egli avrebbe voluto continuare a prestare servizio, come si dice con lampante verità anche in burocratese scolastico, alla vita dell’allievo. Maestro è chi riconosce «l’opera» che l’altro deve fare e la serve, con la sua vita. Così è stato 3P, padre che ha dato la vita perché altri ne avessero una più degna, vera, felice. L’uomo che sono oggi lo devo a ciò che vidi a 16 anni, una lezione che non dimenticherò, ed è la lezione che ha reso la mia vita bellissima, perché solo i maestri ci liberano dalla paura della vita, ci prestano il coraggio di andare a testa alta lì dove siamo, spazzando via gli alibi, e ci fanno essere «abbastanza», anche se pensiamo di non esserlo mai. Grazie, 3P, il letto oggi lo rifai tu per me

Il segreto di un sorriso: Padre Pino Puglisi
Rideva, don Pino Puglisi, se lo chiamavano prete antimafia. Il parroco di Brancaccio, una delle borgate di Palermo a più alta densità mafiosa, non amava i proclami, si sforzava semplicemente di essere un sacerdote coerente con il Vangelo. Quella coerenza che non cede di fronte ai compromessisu cui spesso si basa la potenza prevaricatrice degli "uomini d’onore".
«Quel prete rompeva le scatole», dirà di lui uno dei componenti del commando di fuoco che lo uccise come un agnello, una sera di settembre, la sera del suo compleanno, di fronte alla porta di casa, mentre dalle finestre aperte entrava l’aria avvolgente dello scirocco.
La sua pastorale dentro la borgata, come ha scritto don Luigi Ciotti nella prefazione della biografia di Mario Lancisi del sacerdote che viene proclamato beato, era considerata "un’interferenza".
Per svolgere appieno la sua missione la Chiesa spesso "interferisce", si frappone tra vittime e carnefici, si inserisce nei disegni dei mafiosi, nei soprusi della politica complice, getta luce nei verminai nascosti nelle zone d’ombra. Don Puglisi, martire in odium fidei, è stato la dimostrazione vivente di quanta paura a Cosa nostra possa fare un’azione sacerdotale svolta fino in fondo: l’educazione, la catechesi dei ragazzi, l’apostolato in parrocchia, l’esempio e il richiamo all’autenticità dei valori del Vangelo.
Il parroco di Brancaccio, costretto a celebrare Messa in un garage perché la chiesa di San Gaetano era rimasta danneggiata dal terremoto, strappava centinaia di bambini alla strada, tradizionale vivaio mafioso.
Promuoveva comitati civici per rendere più vivibile una borgata che non aveva nemmeno un albero e una scuola media. Ricordava ai politici locali il senso autentico del loro mandato. Smontava e irrideva la cultura dell’indifferenza e dell’omertà (con Agostina Ajello aveva creato un "Padre nostro dei mafiosi" per tenere lontano bambini e ragazzi dalla mentalità criminale).
Portava a fare volontariato in un quartiere periferico i ragazzi della buona borghesia del liceo classico Vittorio Emanuele che, come avviene spesso nelle metropoli del Sud, in certe zone non ci avevano mai messo piede. Aveva fondato un centro, intitolato alla preghiera che tanto amava, per fare ripetizione ai bambini poveri, destinati a un futuro di disagio o di asservimentoalla potenza dei boss.
Non a caso il suo assassino, che era della sua stessa borgata, aveva la quinta elementare. E quando gli arrivavano minacce, intimidazioni, avvertimenti, invitava i mafiosi dal pulpito a redimersi.
Non è possibile comprendere fino in fondo la sua santità se non si comprende il suo modello autentico di sacerdozio. La sua luce di santità ora splende su una città difficile come Palermo, e ci ricordache anche nei momenti più cupi,come è stata l’epoca delle stragi, cui il martirio di Puglisi appartiene storicamente, la luce del Vangelo e l’esempio di un modo di vivere autentico non ci abbandonano mai.
«La morte di don Puglisi, così tragica e dolorosa, è la chiave di volta nell'atteggiamento della gente rispetto alla mafia. La verità squarcia il velo dell’ipocrisia: non esistono mafiosi buoni e mafiosi cattivi, ma un cancro da combattere civilmente ed ecclesialmente con la Parola, l’esempio, la testimonianza. Preti che umilmente, ma con fede certa si facciano compagni di viaggio degli uomini, col Vangelo in mano e nel cuore. Proprio come don Puglisi, che è annoverabile tra i profeti. La sua testimonianza, infatti, non dà quiete ed è coraggiosa, ferma, intransigente. Non accetta baratti né compromessi. Puglisi ha detto e fatto contro la mafia parole e azioni pesanti da imitare, proponendosi quale esempio di una vita più degna d’essere vissuta. La sua morte ci sprona a essere cristiani con la testa alta e la schiena dritta. Essa è un seme insuperabile di vitalità, la sfida del futuro della Chiesa siciliana e non solo: la morte di don Puglisi si pone come luminoso esempio di vita sacerdotale. Il suo sangue innocente è stato e dev’essere come una trasfusione nelle coscienze indifferenti, richiamando tutti a un nuovo approccio con il fenomeno mafioso e, quindi, a una decisa ricerca degli strumenti ecclesiali e pastorali più idonei a formare coscienze veramente cristiane (confraternite, comitati per le feste, consigli pastorali e affari economici) che operino evangelicamente: dopo Puglisi nulla può essere più come prima nella valutazione storica e sociologica del fenomeno mafioso dentro e fuori la Chiesa» (mons. Vincenzo Bertolone, postulatore della causa di beatificazione).
Qualche riferimento
- Vincenzo Bertolone, Padre Pino Puglisi beato. Profeta e martire, San Paolo 2013
- Augusto Cavadi, Francesco Palazzo, Rosaria Cascio, Beato fra i mafiosi. Don Puglisi: storia, metodo, teologia, Edizioni Di Girolamo, 2013
- Mario Lancisi, Don Puglisi. Il Vangelo contro la mafia, Piemme, 2013
- Alla luce del sole, film diretto da Roberto Faenza, 2005
- Brancaccio, un film di Gianfranco Albano, 2001

Rendeva sacre le vite che incontrava: Don Pino Puglisi
Intervista a Alessandro D'Avenia
Domanda. Dopo Bianca come il latte (2010), e Cose che nessuno sa (2011), è uscita la sua ultima fatica: Ciò che inferno non è, romanzo per cui ci sono voluti tre anni. C’è stato qualche incontro, qualche vicenda, che ha acceso in lei l’urgenza per questo libro?
Risposta. Non avevo in programma di scriverlo, stavo già lavorando ad altri progetti, ma ad un certo punto la storia ha avuto il sopravvento, come uno di quegli incontri per strada che ti obbligano a cambiare i tuoi programmi. Leggevo la confessione dell’assassino di don Pino, divenuto collaboratore di giustizia. Puglisi gli ha sorriso nell’attimo in cui stava per sparargli. Uno dei killer più efferati della mafia dice che per quel sorriso “non ci ha dormito la notte”. Quella frase è esplosa dentro di me come dinamite. Volevo capire come si fa ad essere così liberi da sorridere alla morte e ai suoi scherani. Quel sorriso liberava persino l’assassino dal suo gesto, lo costringeva a rivedere tutta la sua vita.
D. Che significato poteva avere?
R. Quel sorriso diceva: tu sei molto di più di quello che stai facendo a me. Riecheggiava il “perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Volevo scandagliare, da uomo e da narratore, il mistero di quel sorriso. Chi sa morire così sa anche vivere e insegna a vivere a chi resta. Volevo liberare l’agiografia e la cronaca dalla loro retorica o appiattimento e cogliere in che modo un capitolo della storia della salvezza si compiva in quel momento. Poi ci sono state la beatificazione per martirio di Puglisi e l’assegnazione del premio a lui intitolato. Altri incontri, altri volti, altre persone. È come se quell’uomo che avevo conosciuto nei corridoi della mia scuola mi desse la caccia. Il suo romanzo sulla mia carne lo aveva già scritto, ma era come se quella carne dovesse diventare di molti, attraverso la carta. Col senno di poi credo sia stato un tocco della grazia.
D. I due libri precedenti sono stati anche successi internazionali. Ma entrambi erano ambientati in città che potevano essere una qualsiasi metropoli europea. Qui invece sceglie Palermo. Perché questa decisione? Non teme che possa non essere compresa dai suoi lettori?
R. Al contrario. Lo comprenderanno ancora meglio. Più una storia è incarnata più può essere universale. È una città paradossale: di luce e lutto, di paradiso in una via e inferno girato l’angolo. È uno dei personaggi del romanzo e determina tutti gli altri come un fato incombente. Come nel cinema noir della metà del secolo scorso si tratta di un paesaggio reale e simbolico, nel cinema l’uso del campo lungo sugli ambienti determinava i sentimenti del personaggio, che ne diveniva una tessera, venivano messi a fuoco sia il personaggio sia l’ambiente come se fossero tutt’uno: luce e tenebra erano parte del personaggio.
D. Dunque il romanzo è anche è un atto d’amore verso Palermo.
R. Sì, ma di quell’amore che Borsellino definiva così: “Non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare”. Metto a fuoco Palermo nei dettagli, perché è Palermo che ha messo a fuoco la mia anima e i miei personaggi. In questo romanzo le due città, quella di Dio e quella degli uomini, intuite da Agostino, si intersecano nella luce e nelle tenebre, e Palermo ha di certo i connotati, i profumi, i colori reali, ma allo stesso tempo è la città degli uomini di tutti i tempi, quella in cui nelle tenebre la grazia si fa strada. Chi leggerà con attenzione coglierà un sottotesto continuo nella storia, quello che lega il dramma della storia a Dio.
D. Padre Pino Puglisi (3P, come viene soprannominato nel libro) è stato beatificato da Papa Francesco ed è stato suo insegnante a scuola. Credo che Ciò che inferno non è sia il primo romanzo laico, a grandissima tiratura, che corre il rischio di avere tra i suoi protagonisti un santo. Come è riuscito a non cadere nell’agiografia di don Pino?
R. Era la sfida principale. Volevo io per primo capire se la cronaca era già agiografica, o se invece la cronaca fosse la manifestazione di un tratto di storia della salvezza, della storia sacra del chinarsi di Dio sull’uomo. Romano Guardini scrive così: «Nessuno prende la realtà sul serio come il santo perché in verità ogni fantasticheria, sulla sua strada irta di pericoli, inesorabilmente si vendicherebbe. Divenire santo significa per l’uomo reale staccarsi da sé, per entrare nel Dio reale». Raccontare la santità è raccontare il massimo realismo e l’uomo Puglisi entrerà nel cuore anche dei non credenti, perché il santo è la pienezza dell’uomo e di fronte ad un uomo tutto d’un pezzo non si può che rimanere affascinati, come è accaduto a me. Mi sono documentato meticolosamente, seguendo anche le tracce del processo di beatificazione, per cogliere questo realismo del santo. E ho trovato gli ingredienti di un’epica quotidiana che ci riguarda tutti. Come trasformare la prosa di ogni giorno nella poesia di una vita bella? La storia racconta questo, ciò che inferno non è in mezzo all’inferno.
D. Cosa nostra sarà sconfitta quando non ci vorranno più gli eroi per sconfiggerla ma sarà diffusa la normale “eroicità” di chi è onesto e lavora per il bene. Da quello che si è potuto desumere finora dal suo romanzo pare essere questo un insegnamento importante che è contenuto lì. Mi sbaglio?
R. No, è proprio così. Il mio non è un romanzo antimafia, non è un romanzo sulla mafia, non è un romanzo di cronaca. È una storia che entra nel mistero del sacrificio: che non è il fatto in sé di morire, ma quello che significa alla lettera (sacrum facere: rendere sacro). 3P rendeva sacre le vite che incontrava perché erano rese sacre da Dio e lui non era altro che al servizio di quelle vite. Riecheggiano le parole di qualcuno: non siete voi che mi togliete la vita, sono io che la dono. Sacrificarsi è donare il proprio tempo, amore, cure, anche quando è difficile riuscire. Lui riusciva perché lasciava che Dio facesse questo con lui. Era innamorato pazzo di Cristo e questo amore traboccava. Credo che chiunque gli si accostasse vedeva un uomo qualunque capace di amare divinamente, sentiva la tenerezza di Dio su di lui, come accadde persino all’assassino. L’eroismo è questo: giorno per giorno non privarsi mai della possibilità di amare ed essere amati. Per questo ho scelto la frase di Dostoevskij in esergo: “l’inferno è la sofferenza di non poter più amare”. Chi trova il segreto per amare sempre nel quotidiano, trova il segreto della vita: fallimenti, sconfitte, cadute non possono distruggere la speranza, perché quella speranza si colloca altrove. In un altrove intoccabile, come un mare in tempesta in superficie e calmo pochi metri sotto.
(Da: ilsussidiario.net)
Il romanzo
Romanzo struggente e profondo, che attraversa l’animo di un adolescente, animato da passione civile e tormentata sensibilità religiosa al tempo stesso. Il protagonista, Federico, fa parte di quella generazione degli anni ’90 che visse come una sorta di perdita dell’innocenza gli attentati a Falcone e Borsellino. “Prima noi non sapevamo cos’era la mafia. O meglio, ce ne tenevamo fuori, era una cosa che non ci riguardava. Con gli attentati di Capaci e via D’Amelio è cambiato tutto. E Puglisi è stato il protagonista di questo nuovo, rinnovato impegno”. D’Avenia non ha scritto un santino, e nemmeno un romanzo antimafia. “La retorica dell’antimafia", dice, "non mi interessa. Quello che mi interessa è capire e far capire come il parroco della borgata più dimenticata della città ha cambiato le cose”.
Lo scrittore, rivivendo la cronaca di quei giorni terribili, ne legge i segni evangelici, a cominciare da come don Puglisi si comportava nel liceo classico Vittorio Emanuele. “Me lo ricordo a scuola: durante l’intervallo passeggiava nei corridoi e rispondeva alle domande dei ragazzi. Non gli piaceva la sala professori: diceva che era piena di professori”. Quel suo modo di deambulare lungo i corridoi era un modo per evangelizzare anche durante l’intervallo. Puglisi invitava gli studenti della Palermo bene ad andare a Brancaccio, quartiere di cui spesso non conoscevano nemmeno l’esistenza. Dovevano giocare a pallone, fare catechismo, aiutare il “parrino” nel Centro Padre Nostro, da lui fondato e finanziato con i soldi dello stipendio di insegnante di religione. “Don Pino sa che l’inferno opera più efficacemente sulla carne tenera: i bambini. Bisogna difendere la loro anima prima che qualcuno gliela sfratti. Custodire ciò che hanno di più sacro”.
D’Avenia nel costruire il romanzo interiore e civile di questo giovane Holden siciliano segue Puglisi attraverso quei fatti, negli anni bui di Palermo, li scruta a fondo e riconosce i segni evangelici di un calvario, fino allo spasimo finale, quel 15 settembre 1993.
“Il libro”, conclude lo scrittore, “è stata anche l’occasione per riconciliarmi con la mia città, Palermo, di cui non avevo capito nulla". Una città, potremmo dire, anch'essa bianca come il latte e rossa come il sangue, dove convivono inferno e paradiso, rappresentata da un dipinto di Raffaello sottratto come se le avessero sottratto l'anima e da una chiesa sconsacrata a cielo aperto, la chiesa dello Spasimo.
Divo Barsotti..il maestro solitario
Abbiamo bisogno di una fede sempre più grande, certo. La Chiesa vive un momento sempre più tragico di ieri e deve crescere in te la fede perché se non cresce in te la fede non ti basta più la fede che avevi ieri
Divo Barsotti

Sentirsi cristiani vuol dire sentirci fratelli con coloro che non hanno raggiunto la rivelazione di Cristo, vuol dire sentirci fratelli con coloro che hanno ascoltato la parola di Dio ma non hanno ancora intraveduto Gesù vuol dire sentirci fratelli con tutti, capaci di sentire e apprezzare tutto quello che è buono e santo e bello nella creazione, nella vita umana e nel mondo.
Divo Barsotti

Amando l'altro
La presenza di Dio nei santi è fonte di sicurezza anche per noi. Se non ci fossero i santi, noi potremmo certo credere, ma la nostra fede sarebbe come un appello a un Dio che rimane in silenzio, a un Dio che ci può promettere tutto, ma che non pare abbia mantenuto la sua parola. Di qui il senso di angoscia che potrebbe prenderci, se la nostra vita di amore ci legasse unicamente a Dio e non ci legasse anche a tutta un’umanità glorificata in Lui e per Lui.
(Divo Barsotti – Nella comunione dei santi - Milano 1970)
Divo Barsotti
E amando l’altro amerò anche il Signore. Quanti racconti nella letteratura monastica (ma anche nella letteratura tout court, come nello splendido racconto di Tolstoj dal titolo Dove c’è l’amore, c’è Dio) in cui facendo il bene in maniera semplice e quotidiana a un misero, dando da bere a una persona assetata, dando riparo a una persona smarrita, portando sulle spalle un anziano, si scopre di aver fatto questo a Cristo stesso. Non perché quella persona non fosse un vecchio o un assetato o uno che ha perso la strada, ma perché Dio è in quell’amore, in quella uscita da sé in totale gratuità. “L'amore per Dio, scrive Gustavo Gutierrez, non può far altro che esprimersi nell'amore per il prossimo”.
Negli esempi di aiuto e prossimità enumerati nel testo evangelico vi è un aspetto spesso trascurato nella riflessione: l’attitudine di lasciarsi aiutare, di lasciarsi avvicinare, toccare, curare, servire. La capacità e l’umiltà di lasciarsi amare fattivamente. Una capacità che rivela una dimensione di povertà più radicale della malattia o della fame o della nudità e che si chiama umiltà. L’umiltà che può nascere dalle umiliazioni operate dalla vita o procurate dagli uomini. E lasciarsi amare fattivamente significa lasciarsi toccare, affidare il proprio corpo malato o affamato o nudo alle cure di un altro. Del resto, la carità è attenzione e sollecitudine per il corpo dell’altro. E poiché il corpo è la realtà umana più spirituale, è attraverso il contatto con il corpo ferito, mancante, sofferente, bisognoso, che noi ricreiamo le condizioni di dignità dell’uomo ferito, offeso e ingiuriato dalla vita. Nello stesso tempo, noi affermiamo la nostra personale dignità umana prendendoci cura di lui. Ma anche chi si lascia avvicinare così intimamente da esporsi nel proprio bisogno all’attiva carità delle mani e del cuore di altri, osando la propria povertà, attua un’apertura essenziale all’altro e all’essere amato. E così avviene uno scambio di doni, un incontro tra due povertà, la reciprocità di un movimento di amore che, questo sì, è effettivamente un miracolo. Un miracolo che può accadere quotidianamente.

Divo Barsotti
La vita cristiana consiste nell’acquistare
lo Spirito Santo. Per noi si tratta dunque di vivere
nella ricerca, nell’implorazione e poi finalmente
nel possesso e abbandono allo Spirito di Dio.
Quello che importa, quello che è primordiale
per tutti, senza di cui tutte le preghiere non
valgono nulla, è la nostra dipendenza dall’azione
dello Spirito. Ma non
basta acquistarlo, bisogna che lo Spirito Santo viva
in noi e ci porti, ci muova. La nostra vita tanto più
è profonda ed è viva, quanto più lo Spirito di Dio ci
anima. Perciò
la vita cristiana impone prima di tutto questa
preghiera allo Spirito, poi l’obbedienza alla volontà
divina compiuta nello Spirito Santo, poi la docilità
allo Spirito Santo, poi finalmente l’abbandono
perfetto. Tutto il progresso dell’anima è in questo
procedere dell’anima in un lasciarsi possedere
dallo Spirito; se lo Spirito Santo veramente ci
possiede, come possedeva l’umanità di Gesù,
allora noi vivremo la vita stessa di Gesù.
Si tratta dunque di vivere questo abbandono
allo Spirito. E com’è possibile? Perché san Serafino
di Sarov diceva che la vita cristiana consiste prima
di tutto nell’acquisto dello Spirito Santo? Perché
è impossibile abbandonarci fintanto che noi non
siamo consapevoli che lo Spirito Santo vive in
noi. Lo Spirito Santo agisce molto spesso in noi
indipendentemente da noi.
La legge del cristiano è questo abbandono allo
Spirito. Certamente l’abbandono allo Spirito
non vuol dire andar contro i comandamenti, ma
nemmeno soltanto obbedire ai comandamenti,
perché vorrebbe dire obbedire alle tavole di pietra.
La legge di Dio rimane estranea a noi, al di fuori di
noi, mentre Dio si è fatto intimo a noi, e il vivere
la volontà divina consiste soltanto nel lasciarsi
possedere da questo Spirito che in noi vive.
Che tutta l’anima nostra bruci, che tutto l’essere
nostro non sia più che una fiamma, come diceva
un padre del deserto: «“Chi è il monaco? È una
torcia che brucia”. Alzò le mani e tutti videro che
egli era una torcia che bruciava». Anche voi siate una fiamma

Don Divo Barsotti e il Concilio Vaticano II
Il servo di Dio don Divo Barsotti (1914-2006) studiò attentamente il Concilio Vaticano II, i suoi documenti, e ne rimase turbato — pur non mettendone mai in discussione la legittimità –, come scrisse nei suoi diari.
Se c’è qualcuno che non può essere accusato di “turpe” tradizionalismo o di “becero” conservatorismo è il servo di Dio don Divo Barsotti (1914-2006), fondatore della Comunità dei figli di Dio. Anch’egli si fece travolgere dal “folle vento delle novità” fin dagli anni ’40-’50, quando cominciò ad avere vari incontri e rapporti epistolari con illustri personalità della nouvelle theologie (Henri de Lubac, Jean Danielou, Hans Urs von Balthasar, Louis Bouyer), nonché con esponenti del “cattolicesimo democratico” (Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti) e con quelli del “cattolicesimo del dissenso” (David Maria Turoldo e Ernesto Balducci), pur rimanendo indipendente da essi.
Don Divo fu infatti duramente “bastonato” dall’ex Sant’Uffizio quando fu bocciato un suo libro degli anni ’50. A differenza di molti dei nomi citati poc’anzi, egli non si mise mai contro la Chiesa, né pensò ad una ribellione “interna” e “nascosta” in attesa di tempi migliori, così – se pur con amarezza, perché riteneva che le sue ragioni e il suo pensiero non fossero stati sufficientemente esaminati – prese la penna in mano e riconobbe «[…] che alcune espressioni del libro possono indurre in errore… […] In ragione di questi errori o di quelle espressioni che possono indurre in errore, ho creduto mio dovere far ritirare dal commercio il libro»[1]. Chinando dolcemente il capo e accettando l’umiliazione, don Divo capì – dirà in seguito – «che amavo la Chiesa più di me stesso»[2]. Fu proprio per il suo sincero amore alla Chiesa che, secondo noi, il Signore lo mise al riparo da quel “folle vento delle novità” che prese il sopravvento nel mondo cattolico negli anni ’60.
Lettera e spirito del Concilio
Come fu riconosciuto dallo stesso papa Paolo VI, dopo il Vaticano II, non arrivò la “primavera” che egli e il suo predecessore, Giovanni XXIII, avevano sperato, ma un rigidissimo “inverno”[3]. Come fu possibile tutto ciò? Per molti è dovuto al fatto che ha trionfato, nel mondo cattolico, non il vero e proprio insegnamento del Vaticano II (cioè i documenti, la “lettera del Concilio”), ma il “folle vento delle novità” (ovvero il celeberrimo e nefasto “spirito del Concilio”)[4].
È davvero una “diagnosi” giusta? Lettera e spirito non sono forse le due facce della stessa medaglia?
Certamente, col Vaticano II, i novatores non ottennero tutto quello che volevano, ma il fatto che adesso occupino la Gerarchia dalla più alta cattedra significa che, da allora in poi, hanno trovato più porte aperte che chiuse.
Don Divo Barsotti
Don Divo Barsotti studiò attentamente il Vaticano II e i suoi documenti e ne rimase turbato – pur non mettendone mai in discussione la legittimità[5] –, come scrisse nei suoi diari. «Sono perplesso nei riguardi del Concilio medesimo: la pletora dei documenti, la loro lunghezza, spesso il loro linguaggio, mi fanno paura. […]»[6]. Riguardo i documenti del Concilio aggiungerà che «[…] non sono stati impediti gli equivoci, l’ambiguità e soprattutto non è stata impedita la presunzione, non l’ambizione e il risentimento, non la superficialità e la volontà di un rinnovamento che voleva essere uno scardinamento, uno sradicamento della tradizione dogmatica, una diminuzione della tradizione spirituale»[7]. Per don Divo, il Vaticano II, «forse perché ha voluto dir troppo, non ha detto molto»[8].
Questo significa che, per il sacerdote toscano, il Vaticano II è stato un errore? «No di certo», rispose. «La Chiesa aveva bisogno di confrontarsi con la cultura del mondo, e lo Spirito Santo ha impedito che nei documenti si insinuasse l’errore; ma anche se tutto è giusto, nel Vaticano II, non è detto che tutto sia stato opportuno»[9].
Infatti, il documento che più lo allibiva era la costituzione pastorale Gaudium et Spes in quanto «l’ambiguità si manifesta evidente, ed è estremamente grave, nel fatto che il rapporto Chiesa-Mondo non si risolve nel martirio. La Croce non è al centro della teologia del Concilio, non è la soluzione e il compimento della missione della Chiesa»[10]. Da questo non può che derivarne che il Vaticano II «[…] È ben povera cosa nei confronti dei concili che l’hanno preceduto. Il numero stesso dei documenti più che dire la sua grandezza, dice la presunzione dei vescovi, dice la povertà del suo insegnamento»[11].
La presunzione dei padri e dei periti conciliari
Don Divo non ha mancato di rimproverare duramente i padri e i periti conciliari. Li mise “a nudo” affermando che «la difesa ad oltranza del Concilio dice la cattiva coscienza di chi lo difende… Se è opera di Dio, non ha bisogno di essere difeso. […]»[12].
Ai padri conciliari e ai vescovi del post-concilio rinfacciava: «Non hanno voluto condannare l’errore e hanno preteso di “rinnovare” la Chiesa, quasi che il “loro” Concilio potesse essere il nuovo fondamento di tutto»[13]. Per questo il sacerdote toscano dichiarò: «[…] Io non so che farmene di una Chiesa che nasca oggi. Se si rompe l’unità la Chiesa è già morta. La Chiesa è viva soltanto se, senza soluzione di continuità, io sono nella Chiesa uno con gli Apostoli per essere uno con Cristo»[14]. Perciò non esitò a richiamare severamente i successori degli Apostoli al loro compito più importante: confermare nella Fede. I vescovi «[…] mi dicano quello in cui devo credere e quello che devo rigettare»[15].
Il gesuita Teilhard de Chardin è stato, secondo don Divo, il “cattivo maestro” di molti periti conciliari.
Con i periti conciliari e i teologi loro discepoli non fu meno tenero: «[…] Ma soprattutto mi indigna il comportamento dei teologi. Crederò loro quando li vedrò veramente bruciati, consumati dallo zelo per la salvezza del mondo. […] Tutto il resto è retorica. Soltanto la santità salva la Chiesa. E i santi dove sono? Nessuno sembra crederci più»[16]. Difatti «la novità di una teologia – ha scritto don Divo – che rinnega la teologia del passato, non è più una novità cristiana»[17].
Don Divo in particolare mise in guardia dai teologi “discepoli” del gesuita Pierre Teilhard de Chardin († 1955), poiché questi è «il pensatore che sta dietro a molti degli errori che inquinano la teologia (e la mentalità) moderna. È stato il maestro di certi periti ed esperti conciliari»[18]. Proprio verso di essi sentiva un «senso di rivolta che mi agita e mi solleva fin dal profondo contro la facile ubriacatura dei teologi acclamanti al Concilio. Si trasferisce all’avvenimento la propria vittoria personale, un’orgogliosa soddisfazione che non ha nulla di evangelico»[19].
Inoltre non riusciva a capire «come si potesse essere così duri con Lefevbre (che sbagliava, ma pur sempre sul piano disciplinare) e lasciar correre chi, come Kung, Curran, Schillebeeckx, metteva in discussione il Dogma»[20].
I responsabili e la causa della crisi della Chiesa
Per don Divo Barsotti i veri responsabili della crisi della e nella Chiesa sono i teologi[21] (oggi molti dei quali siedono in molte cattedre episcopali). Egli individuava infatti la causa di questa terribile crisi nella superba «leggerezza di aver voluto provocare e tentare il Signore»[22].
Poiché «tutti gli insegnamenti del Concilio, tutta l’azione della Chiesa, tutto è sospeso nel vuoto – ha spiegato il sacerdote toscano – se la Chiesa non ha più il coraggio di rendere testimonianza della divinità del Cristo»[23].
BIBLIOGRAFIA
Divo Barsotti. Il sacerdote, il mistico, il padre (P. Serafino Tognetti, Ed. San Paolo, 2012).
Sentinelle nel post-Concilio. Dieci testimoni controcorrente (Francesco Agnoli e Lorenzo Bertocchi, Cantagalli, 2011).
NOTE
[1] Divo Barsotti. Il sacerdote, il mistico, il padre (P. Serafino Tognetti, Ed. San Paolo, 2012, pagg. 187-191).
[2] Ibidem.
[3] «Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, d’incertezza» (Paolo VI, omelia della solennità dei Santi Pietro e Paolo del 29 giugno 1972).
[4] Posizione sostenuta da papa Benedetto XVI quando, durante il discorso alla Curia romana del 22 dicembre del 2005, parlò di due ermeneutiche conciliari: la prima è quella corretta (riforma nella continuità), la seconda è quella erronea (rottura e discontinuità).
[5] «Il Concilio era certamente legittimo, ma non aveva messo che solo delle virgole al discorso continuo della Tradizione. Ed ero incapace di capire perché si citasse quasi esclusivamente questo Concilio ultimo» (Don Divo Barsotti, Nel Figlio al Padre, pag. 257)
[6] Don Divo Barsotti, Battesimo di fuoco, pag. 58.
[7] Don Divo Barsotti, La Presenza donata, pag. 103.
[8] Don Divo Barsotti, Nel cuore di Dio. Diario 11 febbraio 1984 – 12 marzo 1985, pag. 284.
[9] Un filosofo, un mistico, un teologo suonano l’allarme alla Chiesa (Sandro Magister, 07-02-2005).
[10] Don Divo Barsotti, L’Attesa. Diario 1973-1975, pag. 213-214
[11] Don Divo Barsotti, Nel Figlio al Padre, pag. 257.
[12] Don Divo Barsotti, Battesimo di fuoco, op. cit., 272.
[13] Don Divo Barsotti, Fissi gli occhi nel sole, pag. 117.
[14] Don Divo Barsotti, Le responsabilità dei Preti. Prediche al Papa, 2010, pagg. 105-106
[15] Don Divo Barsotti, I cristiani vogliano essere cristiani, a cura di P. Canal, pag. 272.
[16] Don Divo Barsotti, Battesimo di fuoco, pag. 58.
[17] Don Divo Barsotti, Dopo il Concilio, 1970, pag. 90.
[18] Don Divo Barsotti, I cristiani vogliano essere cristiani, a cura di P. Canal, pag. 164.
[19] Don Divo Barsotti, Battesimo di Fuoco, pag. 58.
[20] Don Divo Barsotti, I cristiani vogliano essere cristiani, a cura di P. Canal, pag. 183-184.
[21] Citato in S. Albertazzi, Sull’orlo di un duplice abisso, Edizioni San Paolo, Milano 2009, pag. 37.
[22] Don Divo Barsotti, Battesimo di fuoco, pag. 27.
[23] Citato in S. Albertazzi, Sull’orlo di un duplice abisso, Edizioni San Paolo, Milano 2009, pag. 37.
Cliccare qui per scaricare l’articolo in PDF
Don Divo Barsotti lo aveva compreso bene: “La Chiesa da decenni parla di pace e non la può assicurare, non parla più dell’inferno e l’umanità vi affonda senza gorgoglio. Non si parla del peccato, non si denuncia l’errore. A che cosa si riduce il magistero? Mai la Chiesa ha parlato tanto come in questi ultimi anni, mai la sua parola è stata così priva di efficacia. “Nel mio nome scacceranno i demoni …”. Com’è possibile scacciarli se non si crede più alla loro presenza? E i demoni hanno invaso la terra. La televisione, la droga, l’aborto, la menzogna e soprattutto la negazione di Dio: le tenebre sono discese sopra la terra. […]. Forse la crisi non sarà superata finché, in vera umiltà, i vescovi non vorranno riconoscere la presunzione che li ha ispirati e guidati in questi ultimi decenni e soprattutto nel Concilio e nel dopo-Concilio. Essi, certo, rimangono i “doctores fidei”, ma proprio questo è il loro peccato: non hanno voluto definire la verità, non hanno voluto condannare l’errore e hanno preteso di “rinnovare” la Chiesa quasi che il “loro”

Il miracolo di ogni giorno
Divo Barsotti
E amando l’altro amerò anche il Signore. Quanti racconti nella letteratura monastica (ma anche nella letteratura tout court, come nello splendido racconto di Tolstoj dal titolo Dove c’è l’amore, c’è Dio) in cui facendo il bene in maniera semplice e quotidiana a un misero, dando da bere a una persona assetata, dando riparo a una persona smarrita, portando sulle spalle un anziano, si scopre di aver fatto questo a Cristo stesso. Non perché quella persona non fosse un vecchio o un assetato o uno che ha perso la strada, ma perché Dio è in quell’amore, in quella uscita da sé in totale gratuità. “L'amore per Dio, scrive Gustavo Gutierrez, non può far altro che esprimersi nell'amore per il prossimo”.
Negli esempi di aiuto e prossimità enumerati nel testo evangelico vi è un aspetto spesso trascurato nella riflessione: l’attitudine di lasciarsi aiutare, di lasciarsi avvicinare, toccare, curare, servire. La capacità e l’umiltà di lasciarsi amare fattivamente. Una capacità che rivela una dimensione di povertà più radicale della malattia o della fame o della nudità e che si chiama umiltà. L’umiltà che può nascere dalle umiliazioni operate dalla vita o procurate dagli uomini. E lasciarsi amare fattivamente significa lasciarsi toccare, affidare il proprio corpo malato o affamato o nudo alle cure di un altro. Del resto, la carità è attenzione e sollecitudine per il corpo dell’altro. E poiché il corpo è la realtà umana più spirituale, è attraverso il contatto con il corpo ferito, mancante, sofferente, bisognoso, che noi ricreiamo le condizioni di dignità dell’uomo ferito, offeso e ingiuriato dalla vita. Nello stesso tempo, noi affermiamo la nostra personale dignità umana prendendoci cura di lui. Ma anche chi si lascia avvicinare così intimamente da esporsi nel proprio bisogno all’attiva carità delle mani e del cuore di altri, osando la propria povertà, attua un’apertura essenziale all’altro e all’essere amato. E così avviene uno scambio di doni, un incontro tra due povertà, la reciprocità di un movimento di amore che, questo sì, è effettivamente un miracolo. Un miracolo che può accadere quotidianamente.

Divo Barsotti
Esegeta di Leopardi e di Dostoevskij
Ferdinando Castelli
Riportiamo una accurata analisi del Padre Ferdinando Castelli S.I, sul pensiero di don Divo Barsotti, fondatore della Comunità dei Figli di Dio, recentemente scomparso, circa la spiritualità di Leopardi e Dostoevskij.” In Leopardi il dolore non nasce solo dalla fine delle illusioni. Il dolore ha una radice religiosa: l'uomo cerca disperatamente un suo partner che non può che essere fuori dal mondo mutevole.” «S'avessi io l'ale»
“La visione dell'uomo come epifania di Dio, in senso sia positivo sia negativo, viene descritta da Dostoevskij nei suoi personaggi: una galleria che offre una rappresentazione metafisica e religiosa del dramma umano che è la nostra vita. Tutti sono alla ricerca di verità, di vita, di felicità, di libertà; tutti danno l'idea di idee incarnate; tutti sono portatori di un messaggio. Dostoevskij li insegue, li scova nei segreti del loro animo, non di rado si immedesima in essi, rivivendo esperienze personali. Pochi scrittori «hanno saputo discendere negli abissi del cuore umano come Dostoevskij, e proprio per questo ben pochi hanno saputo dirci più di lui come l'uomo sia al centro di tutto, come sia senza fondo e senza confine la sua vita».
I due testi che seguono sono tratti dalla Civiltà Cattolica, 3 febbraio 2007, quaderno 3759, pp. 231-243. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza di questi testi sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto.
Divo Barsotti è nato a Palaia (PI) nel 1914.
Pochi anni dopo l'ordinazione sacerdotale per interessamento di Giorgio La Pira si è trasferito a Firenze, dove ha iniziato la sua attività di predicatore e di scrittore. Oggi è unanimemente riconosciuto come mistico e come uno degli scrittori di spiritualità più importanti del secolo. La sua produzione letteraria è notevolissima: più di 150 libri, molti dei quali tradotti in lingue straniere, tra cui il russo e il giapponese, più centinaia di articoli presso quotidiani e riviste di spiritualità. Ha scritto commenti alla Sacra Scrittura, studi su vite di santi, opere di spiritualità, Diari e poesie. Tra i sui testi di più importanti: Il Mistero cristiano nell'anno liturgico; Il Signore è uno; Meditazioni sull'Esodo; La teologia spirituale di San Giovanni della Croce; La legge è l'amore; Cristianesimo russo; La religione di Giacomo Leopardi; La fuga immobile.
Ha fondato la "Comunità dei figli di Dio", famiglia religiosa di monaci formata da laici consacrati che vivono nel mondo e religiosi che vivono in case di vita comune; in tutto circa duemila persone. La Comunità è presente in Italia e nel mondo (Africa, Australia, Sri Lanka, Colombia) e si impegna a vivere la radicalità battesimale con i mezzi che sono propri della grande tradizione monastica.
Vicino per anni alla sensibilità del cristianesimo orientale, Divo Barsotti ha fatto conoscere in Italia le figure dei santi russi Sergio, Serafino, Silvano. Nel 1972 è stato chiamato a predicare gli Esercizi spirituali in Vaticano al Papa.
Ha insegnato teologia presso la Facoltà teologica di Firenze e ha vinto diversi premi letterari come scrittore religioso. Ha predicato in tutti i continenti e ultimamente è stato inserito tra le dieci personalità religiose più eminenti del '900, in Storia della spiritualità italiana, curato da P. Zovatto (Edizioni Città Nuova).
Don Divo è ritornato alla casa del Padre il 15 febbraio 2006
26/08/2007
________________________________________
Dostoevskji mi ha svegliato dal sonno
Due testi di Barsotti ci introducono alla comprensione del suo Dostoevskij. Il primo è nella premessa al volume: «Io debbo molto a Dostoevskij e per onestà, oltre che per gratitudine, io dovevo scrivere. Non importa il giudizio che si vorrà dare oggettivamente del lavoro. Il lavoro comunque, se non rivelerà cose nuove, potrà sempre rivelare qualcosa di me e prima di tutto a me stesso [...]. L'opera di Dostoevskij è stata per me un messaggio e mi ha svegliato dal sonno». Sonno? Un altro testo chiarisce: «Io devo la mia "conversione" a Dostoevskij [...]. Ci fu un momento della mia vita in cui io sognavo di diventare un grande poeta, ed ero perciò sul punto di lasciare il seminario. Poi cominciai a leggere Dostoevskij, che mi aprì gli occhi».
Per Barsotti, Dostoevskij è certamente un grande scrittore, ma è anche un profeta nel senso che svela l'uomo a se stesso, ne scandaglia le pieghe nascoste, ne rivela la grandezza e la miseria, ne proclama la missione, ne narra la drammaticità delle scelte. Profeta soprattutto perché, appassionato com'è del Cristo, lo addita come amore che redime e verità che salva. «Forse è la sua passione per Cristo che mi svegliò dal sonno come non mi aveva svegliato né la visione della Provvidenza in Manzoni, né la teologia di Dante». Attraverso Cristo don Divo avverte la presenza di Dio che gli parla e fuga i fantasmi che abitavano la sua crisi.
«Per lui mi ha parlato Dio. L'ho riconosciuto nel tormento di Raskòlnikov dopo il delitto, nella pietà e nella forza di Sonja [...]; l'ho amato nell'umiltà e nella dolcezza di Sonia de L'adolescente, nella luminosa bellezza di Macario, l'ho sentito presente nell'umiltà di Tichon ma anche nell'orrore della morte di Kirillov e nel la condanna di Stavrògin, finalmente l'ho veduto nello staretz Zosima e in Aljòsa. Sempre Dio era presente. La sua presenza dava un senso agli avvenimenti, dava un nome a ogni uomo. Il silenzio non era vuoto, era il silenzio di Dio che riempiva di sé ogni luogo, ogni avvenimento, era la vita nella comunione con lui, era la morte nella volontà di rifiutarlo, di volerlo negare» (p. 6 s). Il volume si sviluppa sostanzialmente su questi convincimenti, esami nati nelle loro varie sfaccettature lungo l'arco delle quattro parti: L'uomo e lo scrittore, I personaggi dei cinque maggiori romanzi, Il messaggio di Dostoevskij, La teologia di Dostoevskij.
L'uomo come epifania di Dio
Il concetto di Dostoevskij sulla religione si fonda sulla sua visione dell'uomo: «L'uomo supera la natura e annuncia un'altra realtà» (p. 20). Quale altra realtà? La realtà di Dio come realizzazione delle aspirazioni umane che superano il puro ambito naturale e riempiono il vuoto di Dio, che comporta malessere ontologico e morte. Dio non è un accessorio della natura umana, ne è il respiro vitale, è la presenza senza la quale essa si smarrisce e si frantuma. « È Dio che non cessa di torturare chi ha compiuto il delitto, finché nel pentimento non trova la pace del perdono, è Dio che vive nella pietà di Sonia per Raskòlnikov, nel suo amore senza limiti per i fratelli, è Dio che vive nella pietà e semplicità del principe Myskin, nella pace di Macario, il pellegrino che ormai ha finito di camminare e attende sereno la morte» (p. 21).
Contro Dio c'è il maligno, che è «la realtà del male in una vita di menzogna, in una volontà di distruzione e di morte». Così la vi ta umana è una lotta tra Dio e il maligno, che si contendono il suo dominio. Per descriverla Dostoevskij scende negli abissi del cuo re dove abitano il peccato e la Grazia, e vede il peccato che cor rode l'uomo, e Dio impegnato a conservare nella sua creatura la propria immagine nella quale risplende soprattutto l'amore.
Da queste considerazioni lo scrittore deduce che l'inferno e il paradiso non sono realtà estranee all'uomo. Sono nel suo cuore: le accoglie nella sua vita come parte di sé, e con esse si avvia all'eternità. Deduce anche che «l'uomo non è senza Dio» (p. 22). E’ in rap porto con Dio «non soltanto nella misura in cui lo ama; egli è in un suo rapporto con Dio, sia che questo sia odio o sia amore. Anche nella trasgressione alla legge egli vive un suo rapporto con Dio. Non può chiudersi in sé, rifiutare un suo rapporto con lui; nel pec cato stesso l'uomo, che vorrebbe sganciarsi da Dio per affermarsi e acquistare una sua "libertà", non vive nell'opposizione al suo Creatore che la sua distruzione e la sua morte. Al contrario, vive già un suo rapporto d'amore con Dio nel suo rapporto con la creazione, e più ancora nel suo rapporto di amore con l'uomo, perché la crea zione è il primo segno di Dio, e l'uomo, immagine di Dio, è il segno più alto della sua presenza. Così nell'amore del prossimo l'uomo vive la sua più alta esperienza di Dio» (p. 152).
Personaggi come testimoni
La visione dell'uomo come epifania di Dio, in senso sia positivo sia negativo, viene descritta da Dostoevskij nei suoi personaggi: una galleria che offre una rappresentazione metafisica e religiosa del dramma umano che è la nostra vita. Tutti sono alla ricerca di verità, di vita, di felicità, di libertà; tutti danno l'idea di idee incarnate; tutti sono portatori di un messaggio. Dostoevskij li insegue, li scova nei segreti del loro animo, non di rado si immedesima in essi, rivivendo esperienze personali. Pochi scrittori «hanno saputo discendere negli abissi del cuore umano come Dostoevskij, e proprio per questo ben pochi hanno saputo dirci più di lui come l'uomo sia al centro di tutto, come sia senza fondo e senza confine la sua vita» (p. 23).
Nella galleria dei personaggi che testimoniano in negativo la presenza di Dio, Barsotti fa incontrare gli eroi del romanzo I de moni: Nikolaj Stavrògin, Pètr Verkovenskij, Aleksej Kirillov. Qui lo scrittore narra il tentativo di un gruppo di «indemoniati» di sganciare il popolo dalle miserie del vivere quotidiano e di liberarlo da ogni alienazione, sostituendo la fede in Dio con la religione del popolo, non importa se ciò debba realizzarsi con la for za e il massacro. Kirillov vuole la divinizzazione dell'uomo, nega Dio, ne desidera la morte, e per realizzare tutto ciò si suicida; Stavrògin dissipa ogni sua possibilità nel vizio e nella volontà di sfidare la legge e la pubblica opinione: incapace di amare, «non vive che il vuoto». Pètr « è l'incarnazione del maligno, tutto in lui è menzogna, il suo impegno è quello di contraffare la verità, la sua opera è la distruzione e la morte» (p. 72).
Dalla lettura de I demoni si esce come da un incubo perché, re spinto Dio, che è vita, fa irruzione la morte. «La ribellione verso Dio, l'ateismo, il peccato non sembrano dare alcun frutto. La morte è la conseguenza irreparabile del peccato. Verso questa morte, che è il suicidio di Stavrògin, converge tutto il romanzo, ne è il compimento e il cuore» (p. 61). Ne I fratelli Karamazov la morte si configura con la follia. Ivàn nega Dio per orgoglio e lo sostituisce con la propria ragione; conseguentemente diviene pre da di pensieri e desideri malsani, incontra Satana e precipita nel la follia. Morte, follia, disperazione, solitudine, vuoto ínteriore: sono l'eredità di quanti rifiutano Dio.
Tra i personaggi che testimoniano in positivo la presenza di Dio, Barsotti ne predilige due: Sonia in Delitto e castigo e lo staretz Zosima ne I fratelli Karamazov. Sonia è «la figura cristianamente più pura di tutta l'opera di Dostoevskij: è una prostituta, ma vive incontaminata in un mondo di peccato» (p. 129). Per salvare la fa miglia dalla miseria, vende il suo corpo, ma il peccato non tocca la sua anima. «La sua bellezza è tutta spirituale. La sua apparizione, la sua presenza non turba, non eccita i sensi. Può discendere e può vivere nell'ambiente di peccato e di depravazione e non contaminarsi; anzi è lei che purifica [...]. Il suo sembra l'atteggiamento stesso di Dio nei confronti dei peccatori» (p. 40 s). Sa che la sua condizione non le consente di vivere una vita sacramentale e non osa partecipare alla vita della Chiesa, ma legge il Vangelo, che la fortifica e le dà la forza di accettare la sua abiezione.
Nello staretz Zosima, Dostoevskij ha inteso offrire un'icona del cristianesimo: un'icona che fosse la negazione di quanto, sullo stesso argomento, aveva sostenuto Ivàn Karamazov. Nel cristiane simo, personificato nello staretz, c'è un'invasione di pace, di gioia, di forza, di amore. Nella luce della fede tutta la realtà si trasfigura.
La teologia di Dostoevskij
La figura dello staretz ci introduce nell'ambito di quanto Barsotti chiama, un po' enfaticamente, La teologia di Dostoevskij. In realtà, lo scrittore non è un teologo né ha inteso fare teologia. E, un analista dell'animo umano; indagandone la natura, le esigenze e le leggi, intuisce che l'uomo è immagine di Dio e che, se distrugge questa immagine, distrugge se stesso e diventa immagine del maligno. Al centro del mondo dostoevskiano dunque c'è «l'uomo, e nell'uomo si fa presente il mistero stesso di Dio. La vita dell'uomo è lo scontro del male e del bene; il problema del ma le e la concezione del bene dominano tutti i romanzi, e il bene e il male suppongono la libertà, postulano Dio» (p. 143). In Dio c'è la vita e la pace, senza Dio c'è la disgregazione e la rovina.
Il problema dell'esistenza e della natura di Dio ha tormentato lo scrittore. È approdato alla fede non per via di ragionamento, ma attraverso la conoscenza di Gesù, incarnazione dell'amore che salva. Una fede, la sua, conquistata metro per metro, giorno do po giorno, durante un'esistenza trascorsa all'insegna dell'insicurezza, della sofferenza e della macerazione interiore. Una volta incontrato, Cristo non ha mai cessato di presentarglisi come salvezza dell'uomo, sorgente e salvaguardia della libertà, ideale di ogni grandezza, fondamento della civiltà e della convivenza.
Barsotti difende l'ortodossia della fede cristiana dello scrittore contro quanti sostengono che la sua, più che religione cristiana, è religione del popolo e della terra. «E certo che la tentazione di una religione del popolo e della terra non è stata mai assente dal la sua vita», ma «quando scriveva I demoni [in cui si ipotizza questa concezione] aveva ben chiaro che Dio non si identificava con l'anima di un popolo, e che la fede in Dio trascendeva una fede nel destino della nazione» (p. 142).
E la tentazione del «Dio russo»? Questa tentazione «rimase [in lui] fino alla fine, ma non provocò il suo allontanamento da Cristo. Il Cristo ha rotto l'incantesimo di una natura chiusa, nella quale l'uomo è prigioniero. Quel Dio che si è incarnato nel Cri sto non è, come nel paganesimo, una personificazione o un elemento della natura, ma è un Dio che trascende la natura. Nel rapporto con lui, l'uomo è salvo precisamente perché rompe l'incantesimo di una natura che lo tiene prigioniero. Nel suo rapporto con Cristo ogni uomo è salvo, perché Dio lo ama, e non è inghiottito e digerito dal processo del tempo e della storia: l'uomo supera la natura e supera il tempo» (p. 144).
Il Dio della religione di Dostoevskij pertanto «non si confonde col divino della natura e non è il Dio della metafisica, ma non è neppure il Dio della storia: è il Dio che si è rivelato all'uomo nel la vita e nella morte del Cristo, è, in ultima istanza, il Dio che vive nel cuore dell'uomo» (p. 1.45). E vero che questo Dio «non è mai esplicitamente il Dio Trinità della rivelazione cristiana», ma «non si può chiedere a un romanziere un trattato di teologia». E anche vero che lo scrittore «esplicitamente non parla dell'incarnazione», tuttavia la centralità del suo Cristo e l'amore che gli porta «suppongono una sua trascendenza». A questo proposito vorremmo ricordare la splendida affermazione cristologica - Gesù Cristo è il Verbo fatto carne - che si trova nei Taccuini per «I demoni». Dopo aver respinto la concezione, in quel tempo ricorrente, di un Cristo soltanto uomo, filosofo benefico e maestro di vita, afferma: «Ma io e voi, Satov, sappiamo che sono tutte sciocchezze, che Cristo-uomo non è il Salvatore e fonte di vita e che la sola scienza non completerà mai ogni ideale umano e che la pace per gli uomini, la fonte della vita e la salvezza dalla disperazione per tutti gli uomini, la condizione sine qua non e la garanzia per l'intero universo si racchiudono nelle parole: Il Verbo si è fatto carne e la fede in queste parole» [8].
Conclusione
Come definire i due volumi di Barsotti? Non sono opera criti ca: nessuna nota, nessun riscontro con altri studiosi, nessun confronto interpretativo. Don Divo va avanti per conto suo, solitario e tranquillo, in ascolto soltanto di se stesso. Li definiremmo per tanto una conversazione con due eccellenti compagni di strada, Leopardi e Dostoevskij, fatta con intelligenza d'amore e suggerita da comuni esperienze di vita e da approfondimenti spirituali. Volumi ricchi d'interesse, vivi, solcati da squarci di luce, per vari aspetti simpatetici. Non privi di limiti: ripetizioni, talune forzature interpretative, qualche carenza d'informazione. -
Se volessimo sintetizzarli in poche battute, trascriveremmo un pensiero del loro autore: «Tutto è ombra; ogni creatura, ogni avvenimento è segno. L'unica realtà sei Tu - e solo l'amore ti scopre» [9].
________________________________________
8 8 F. DOST0EVSKJI, I demoni. I taccuini per «I demoni», Firenze, Sansoni, 1958,1.012.
9 9 D. BARSOTTI, Nel cuore di Dio, Bologna, Edb, 1991, 68.

Don Divo Barsotti
Gianni Gennari
Divo Barsotti: prete, maestro, mistico, solitario, schivo e insieme trascinatore. Parlava poco, ha scritto moltissimo, vivendo in un eremo: amato da tanti, seguito dai semplici e stimato dai sapienti, libero con tutti, nella Chiesa, ma solo per Dio, unico centro della sua vita. Divo: forse mai un nome è stato così smentito dalla vita, 92 anni, trascorsa quasi nascosta: apparentemente pochi fatti, tanto silenzio, tanta preghiera, tantissimi scritti: più di 160 libri tradotti in moltissime lingue. Nasce a Palaia, in Toscana nel 1914 e vive tra Firenze e Settignano, nell'eremo di San Sergio dove ha fondato la Comunità dei Figli di Dio, e dove è morto il 15 febbraio 2006. Ha riflettuto, pregato, meditato, taciuto e scritto, don Divo, e i suoi libri sono stati una fonte cui si sono abbeverate innumerevoli schiere di alunni, discepoli, anche senza frequentarlo. Ha vissuto nella Chiesa cattolica, apertamente, ma si potrebbe dire non primariamente per essa nella sua dimensione visibile e terrena: tutto rivolto a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, don Divo. La sua Messa era una esperienza forte per i presenti e durava ore. Maestro: la sua parola tranquilla, semplice, scarna, approfondiva i passi della Scrittura aprendo sentieri sempre nuovi. Teologo: capace di tradurre in parole umane e comprensibili a tutti gli oggetti della fede, senza indulgenze alle mode, attento soprattutto a non svendere mai la verità divina per correre dietro alle opinioni diffuse. Non gli interessava il successo, o la notorietà: pochissime interviste, per decenni nessuna. Quasi mai visto in Tv, salvo circostanze pubbliche e solenni, e con altri. Mistico, nel senso di uno che si fa così profondamente invadere dallo Spirito del Padre e del Figlio da diventare per chi lo accosta come un incontro con la realtà stessa divina… Lui in apparenza forse scorbutico, perché rifuggiva dal chiasso e dalla pubblicità, ma era un libro aperto per chi si accostava a lui per trovare qualcosa che veniva dall'alto. Ha meditato e scritto soprattutto sulla Bibbia, libro per libro, capitolo per capitolo, con riflessioni che erano e sono lampi di luce che spingono a leggere ancora, a pregare, ad ascoltare e a vivere. È stato in relazione continua con i più grandi teologi, ricambiato e stimato, e anche con uomini ai vertici della Chiesa istituzione, fino ai Papi, e il suo percorso di pensiero e dottrina è tra quelli che hanno davvero anticipato di decenni alcune grandi novità del Concilio Vaticano II, e insieme quello che ne ha indicato con chiarezza franca e tenace i possibili itinerari che invece di tradurre la fede di sempre la tradivano con esiti che potevano essere disastrosi… Profondo conoscitore della spiritualità orientale, ha vissuto l'ecumenismo degli spiriti anche quando quello degli scritti e degli incontri era difficile, lontano e guardato con sospetto. Ha approfondito a lungo lo studio della santità vissuta nei secoli da figure grandi che hanno impreziosito la vita delle comunità cristiane. Quando dominava ancora, e da decenni, la teologia dei manuali astratti fatti di logica e citazioni autorevoli, lui indicava con forza la necessità di tornare alle fonti, la Bibbia innanzitutto, i grandi Padri della Chiesa, i santi, i testi liturgici che guidavano da 2000 anni la vita concreta della Chiesa di Cristo. Anche per questo qualche sua opera, come Commento all'Esodo, nel 1960 ebbe difficoltà in Italia con la Santa Sede, fu pubblicato solo in Francia ed ebbe il lasciapassare del Sant'Offizio solo dopo il Concilio, Nel 1975 – come per una rivincita non certo voluta da lui – Paolo VI gli chiese di predicare gli esercizi al Papa, e alla Curia Romana. Per molti aspetti è stato anche un uomo solo: solo alla ricerca ed al cospetto di Dio, Uno e Trino, mistero e parola, silenzio e fuoco, pace e rinnovamento. La sua Comunità dei Figli di Dio, fatta di uomini e donne, sposati e celibi, che lavorano e vivono in silenzio, ne continua la missione. E lui? Da lassù continua come sempre: preghiera e silenzio, solitudine con Dio e amore ai fratelli, figli di Dio…e lassù sono veramente tutti.



