Messaggeri di Dio ogni giorno.. nel sociale

"Se smarrite la fiducia, cercate i «meravigliatori», coloro che fanno miracoli e vi rigenerano perché vi fanno sentire voluti come figli, appartenenti. Chi sono? Quelli che per amore fanno e quelli che fanno per amore."
Alessandro D'Avenia
San Charles de Foucauld...

Ci vorrebbero molti buoni preti e anche buoni cristiani non per predicare, ma per prendere contatto, farsi amare, ispirare stima, fiducia, amicizia, rendere possibile un avvicinamento, dissodare la terra prima di seminare.
San Charles de Foucauld

Charles de Foucauld: un nuovo modo di vivere il Vangelo
Gabriele Ferrari
La vita di fr. Carlo de Foucauld è stata relativamente breve, solo 58 anni, di cui ventotto di vita mondana e anche dissoluta (1858-1886) e trent’anni vissuti al seguito del suo «beneamato fratello Gesù» (1886-2016), conclusisi violentemente, ucciso da banditi locali il 1° dicembre 1916.
Dopo la conversione culminata nell’incontro con l’abbé Huvelin il 28 ottobre 1886 nel confessionale della chiesa di Sant’Agostino a Parigi, egli intraprende un singolare percorso spirituale che lo porterà a una forma inedita di santità e di vita consacrata.
Egli ha tentato diversi cammini spirituali, dalla Trappa alla vita solitaria a servizio di un convento a Nazareth e a Gerusalemme, alla formazione sacerdotale alla vita nel deserto nordafricano di Beni Abbés e di Tamanrasset, sempre alla ricerca di una vita che gli permettesse di rivivere la vita umile, povera e nascosta di Gesù negli anni di Nazareth.
Innamorato di Gesù e del mistero dell’incarnazione, egli è convinto che, una volta conosciuto Gesù, non può far altro che mettersi a imitarlo. Per questo fr. Carlo cerca di incarnarsi, a sua volta, nell’umano più semplice e più feriale, nel lavoro umile e nella comunione di vita con gli altri, riempiendo la sua giornata di ascolto della Parola e di lunghe adorazioni davanti al ss.mo Sacramento. Egli si è così avvicinato alle persone più semplici e povere senza fare distinzioni di razza o religione, modello di quella fraternità universale che papa Francesco ha proposto nell’enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale Fratelli tutti: «Voleva essere “il fratello universale”. Ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi» (n. 287).
La vita e la morte di fr. Carlo sono diventati «un parametro su cui misurare un modo nuovo di essere testimoni di Cristo e del suo Vangelo e un modo nuovo di essere “martiri”» (Fratel MichaelDavide, Charles de Foucauld, San Paolo 2016, p. 151).
Non è possibile presentare qui il cammino umano e spirituale di Charles de Foucauld il quale, partendo da un’educazione religiosa e borghese e dal normale rifiuto di essa al momento dell’adolescenza, passando per la vita militare, giunge ad una crisi esistenziale che lo conduce a ritrovare la sua radice cristiana. Da essa è venuta la vita ascetica e mistica di fr. Carlo di Gesù, monaco atipico che vive nel deserto, in mezzo ai non cristiani, seguendo un progetto di vita che affascina ancora coloro che lo conoscono.
Qui si possono mostrare solo alcuni degli aspetti più significativi della sua spiritualità ai quali anche noi possiamo ispirarci nell’intento di vivere la parola di Gesù: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete riposo per la vostra vita» (Mt 11,29), tre atteggiamenti che sono molto attuali in questo momento della storia del mondo e della Chiesa, in particolare della missione ad gentes.
Un uomo innamorato di Gesù e del Vangelo
Dal 28 ottobre 1886 Carlo de Foucauld si sente, come Paolo (Fil 3,12) catturato da Gesù e comprende che ormai non può fare altro che vivere per Dio. La sua vita diventa allora una continua adorazione del suo Mistero.
Innamorato di Dio e, specificamente, di Gesù, il Dio che si è fatto uomo, Carlo dedicherà tutto sé stesso alla conoscenza e all’imitazione del suo «beneamato Fratello e Signore Gesù».
Passa lunghe ore in adorazione del ss.mo Sacramento, legge il Vangelo, lo medita, lo trascrive e, soprattutto, cerca di viverlo. Desidera crescere nella conoscenza di Gesù per amarlo, imitarlo, obbedirgli, lasciandosi incontrare e toccare da Gesù nella certezza di poter vedere e toccare in lui il «Verbo della vita» (1Gv 1,1). Scrive infatti al suo amico Gabriel Tourdes: «Ecco il segreto della mia vita: ho perduto il mio cuore per questo Gesù di Nazareth crocifisso 1900 anni fa e passo la mia vita a cercare di imitarlo per quanto possa la mia debolezza» (7 marzo 1902).
Lo stile di vivere, di preghiera e di adorazione, è una scelta personale di fr. Carlo, che tuttavia non gli impedisce – anzi – lo porta a entrare in profondità nel cuore, nella cultura e nella storia delle persone in mezzo alle quali, come il Verbo di Dio, ha messo la sua abitazione (cf. Gv 1,14). Non per un interesse solo etnografico, ma per poter conoscere la ricchezza dei doni riversativi da Dio come preparazione evangelica.
L’adorazione del mistero di Gesù e l’amore per il popolo diventano il contenuto della sua preghiera e della contemplazione.
Leggere oggi le sue meditazioni sul Vangelo, frutto delle sue lunghe ore di preghiera e di adorazione davanti al ss.mo Sacramento nel silenzio dell’eremo, è una esperienza affascinante e coinvolgente. Sono parole semplici ma profonde che invitano a rifare un personale cammino di accostamento della sacra Scrittura per fare della Parola di Dio il nutrimento della propria vita spirituale e il criterio per le scelte della vita e della missione di ogni discepolo anche e, soprattutto, oggi. Papa Francesco non invita forse la nostra Chiesa a ritornare al Vangelo?
Come a Nazareth: trovare Dio nella vita nascosta e feriale
Un secondo aspetto caratteristico di fr. Carlo di Gesù è vivere la vita di Nazareth. Egli sceglie di vivere nel deserto in mezzo ai poveri a servizio di una piccola tribù nomade: i Tuareg. Lo fa per assomigliare a Gesù che ha vissuto i primi trent’anni della sua vita nell’oscura borgata di Nazareth, facendo il falegname per guadagnarsi il pane di tutti i giorni.
La vita di fr. Carlo, come quella di Gesù, normale nella sua ordinarietà, è fatta di cose semplici, di accoglienza di chi incontra, di lavoro compiuto con cura e precisione, di relazioni fraterne con i compaesani nell’ascolto, nell’aiuto e nella condivisione della vita. Una vita povera, semplice, ordinaria, che non lo allontana da quella dei suoi Tuareg.
Ma fr. Carlo è convinto che essa, come quella vissuta da Gesù nei suoi trent’anni a Nazareth, è una vita che, vissuta davanti a Dio, ha un valore salvifico come i tre anni di vita pubblica.
Questa sua intuizione aiuta anche noi, cristiani di oggi, a riscoprire il valore nascosto tra le pieghe della quotidianità e delle normali relazioni della vita di tutti i giorni, mentre troppo spesso consideriamo valida solo quella vita che è fatta di attività e di presenza visibile e volta all’efficienza immediata.
Fr. Carlo sa, invece, che proprio nei gesti semplici e ordinari della vita di ogni giorno possono germogliare l’amore, la cura, il senso profondo che Gesù vi ha immesso vivendo per trent’anni come un uomo qualsiasi.
Ogni gesto vissuto alla presenza di Dio diventa, per fr. Carlo, un gesto d’amore e d’incontro con Dio, carico quindi di eternità! Scrive infatti all’abbé Huvelin, suo padre spirituale: «Questa piccola vita di Nazareth che sono venuto a cercare… una vita di lavoro e di preghiere… [è quella che] faceva nostro Signore» (22 settembre 1893).
Conseguentemente, lo stile di vita di fr. Carlo vuole essere quello della bontà, della vicinanza, della prossimità all’altro. Si propone di imitare Gesù e, come lui, desidera testimoniare il volto buono di Dio: «Il mio apostolato dev’essere l’apostolato della bontà», scrive alla cugina Marie il 12 maggio 1902.
Anche la nostra vita, comunque e ovunque essa si svolga, può perseguire questa finalità: cercare che ogni evento e ogni incontro faccia trasparire un briciolo della bellezza dell’amore di Dio apparso in Gesù: solo questa, infatti, è «la bellezza che salverà il mondo» (F. Dostoevskij in L’idiota).
Essere un «fratello universale»
La scelta di fr. Carlo di vivere con i Tuareg per offrire loro la sua amicizia in modo gratuito sull’esempio di Gesù, che amava tutti e tutti accostava, soprattutto chi aveva bisogno della sua presenza, ha dilatato il suo cuore così che volentieri egli dichiarava di sentirsi e di voler essere «fratello universale». Alla cugina Marie de Bondy scriveva: «Voglio abituare tutti gli abitanti, cristiani, mussulmani, ebrei e non credenti a guardarmi come loro fratello, il fratello universale… Cominciano a chiamare la mia casa “la fraternità” (la Khaoua, in arabo), e questo mi è caro» (7 gennaio 1902).
Il primo passo per essere fratello di tutti, per Carlo, era quello di incarnarsi profondamente (per quanto possibile…) nel mondo culturale dei suoi fratelli, condividere lo stile della loro vita, le loro attese e le loro sofferenze.
Nel tempo passato in Algeria durante il suo servizio militare, egli aveva avuto occasione di osservare e studiare la cultura dei popoli berberi fino ad acquisire una vera competenza in questo campo. Questo gli ha dato la possibilità e gli strumenti per accostare con intelligenza la cultura delle popolazioni in mezzo alle quali viveva, in un tempo in cui non si dava molta importanza alle culture non occidentali, pensando che solo l’Europa potesse vantare una cultura!
A partire dalla carità di Cristo, attinta quotidianamente nell’adorazione e nella lettura orante del Vangelo, fr. Carlo di Gesù sentiva crescere in sé il desiderio di dedicarsi sempre più a Dio e ai fratelli.
Nell’adorazione la presenza di Dio si fa reale, e in quel momento di intima preghiera egli porta alla presenza di Dio quanti incontrava ogni giorno e le tante persone con le quali mantiene relazioni epistolari. Egli non solo lavora per assomigliare a Gesù e guadagnarsi il pane, ma apre la sua abitazione per accogliere le persone che, sempre più numerose, si presentano sulla soglia della sua casa, a partire dai Tuareg, tutti rigorosamente musulmani, ai militari francesi presenti nella colonia fino ai turisti che già allora viaggiavano nel deserto. A tutti offre una parola e, se richiesto, un aiuto.
È straordinario il numero di lettere che egli ha scritto in quei pochi anni dal suo eremo, tutte intrise della sua fede. A tutti, infatti, offre la presenza di Dio che ha scoperto nella preghiera e nella meditazione del Vangelo: un Dio buono, che non giudica e non condanna, che non vuol conquistare nessuno alla fede, che spinge alla promozione e al bene dell’altro, un Dio che si fa fratello e ci chiede di fare altrettanto.
«È impossibile amare Dio, voler amare Dio senza amare, voler amare gli uomini: più si ama Dio, più si amano gli uomini. L’amore di Dio, l’amore degli uomini è tutta la mia vita, sarà tutta la mia vita, lo spero», scrive al suo amico Henry Duveyrier, il 24 aprile 1890.
Fr. Carlo si impegna con rigore e dedizione nell’aiuto materiale e spirituale di quanti incontra: accoglie, ascolta, dialoga, offre cibo e medicine… si fa amico e fratello di tutti, perché vuole farsi fratello di tutti, a imitazione del suo (e nostro) Signore e Fratello, Gesù di Nazareth… fino al giorno in cui, per la sua fedeltà a rimanere in mezzo ai fratelli musulmani, giunge al dono di sé nel sacrificio della vita, il 1° dicembre 1916.
La sua maniera di essere cristiano in mezzo a coloro che non sono e non intendono diventare cristiani è diventato un nuovo paradigma della missione ad gentes, per questo tempo segnato dalla cultura del sospetto e della diffidenza, mentre si cerca di liberarla dalle incrostazioni colonialiste che l’hanno deturpata e resa ostica alle generazioni attuali.

Fratel Charles: icona del dialogo
Lorenzo Prezzi (a cura)
Il teologo Brunetto Salvarani, nel suo libro (Fino a farsi fratello di tutti. Charles de Foucauld e papa Francesco), oltre al profilo biografico, ne evidenzia soprattutto la modernità del desiderio di diventare «fratello di tutti», tanto che Francesco nella sua enciclica «Fratelli tutti» lo indica come icona del dialogo.
La sua è una biografia sicuramente inquieta, quella di un uomo ansioso che non ha mai smesso di cercare: il sale della vita, se stesso, Dio, e alla fine soprattutto, e sopra ogni altra cosa, Gesù.
Un uomo che non sopportò le mezze misure, le mediazioni, gli equilibrismi, e tanto meno i compromessi, transitando spesso da un estremo all’altro, dagli abissi della dissipazione alla gloria mondana fino alla perfezione evangelica.
Ecco perché, imbattendosi in lui e nella sua storia da moderno padre del deserto, è impossibile rimanere indifferenti: o ci si innamora ingegnandosi a conoscere tutto di lui, o ci si rifiuta di farsi coinvolgere, di fronte a quello che potrebbe anche apparirci un idealista un po’ folle, incapace di fare i conti con la dura realtà. Tutto e subito, come quando Charles, il cristianesimo, lo ri-scopre (letteralmente, nel senso che riesce a togliere il velo che ne faceva la depositaria religione di famiglia, alla quale era costretto ad adeguarsi). Tanto da ammettere, nel 1886, già ventottenne: «Appena ho creduto che Dio esiste ho capito che non avrei potuto fare altro che vivere solo per lui».
Eppure, il nome di de Foucauld è divenuto, nel corso dei decenni, un punto di riferimento sicuro e imprescindibile per orientarsi in molteplici ambiti: ad esempio, per quanti vogliano accostarsi a una radicalità evangelica a imitazione di Gesù povero, per il sempre difficile (ma anche indilazionabile) dialogo fra cristiani e musulmani, per chi accetti di lasciarsi affascinare da una spiritualità del deserto accessibile sia ai credenti sia ai (cosiddetti) non credenti.
«Nella sua immagine – scrive Franca Giansoldati – forse possono riconoscersi tutti i falliti della storia». Ma già il suo primo biografo, René Bazin, aveva colto tale aspetto, presentandolo così: «È stato il monaco senza monastero, il maestro senza discepoli, il penitente che sosteneva, nella solitudine, la speranza di un’età che non doveva vedere…».
Fraternità
Qual è il ruolo di de Foucauld nell’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti?
La presenza di frère Charles nella Fratelli tutti mi sembra più strategica rispetto alle citazioni a lui riservate nell’occasione. L’intera enciclica, infatti, è racchiusa fra due icone del dialogo: i paragrafi iniziali sono incentrati su Francesco d’Assisi, quelli conclusivi su de Foucauld.
Non è una forzatura scorgere in tale architettura una precisa indicazione del papa: il monaco francese ha raccolto il testimone dal primo, ne ha attualizzato l’eredità nel cuore della modernità, ha saputo similmente attrezzarsi con una visione lunga, incarnando lo spirito originario del Vangelo, quello – per ricorrere a un’espressione cara all’Assisiate – letto sine glossa.
L’uno e l’altro hanno trascorso la prima parte della loro esistenza fra esperienze militari, sognate o vissute, e nel silenzio di Dio, prima di cambiare strada e mentalità, letteralmente convertendosi pur essendo cresciuti con un’iniziazione cristiana.
Entrambi, infine, hanno saputo concretizzare il loro rispettivo sogno non a parole ma con gesti di una radicalità che aveva in sé germi di espansione universale. Fino a spingerci a sostenere che la spiritualità dell’eremita alsaziano non emerge solamente nei capoversi finali del documento papale, ma pervade l’intera enciclica.
Al n. 286 dell’enciclica papa Francesco lo cita – a parte – in un elenco di uomini e donne che l’hanno ispirato nella riflessione sulla fraternità universale. Ne ricorda la «profonda fede» e la «sua intensa esperienza di Dio», che l’ha condotto a compiere «un cammino di trasformazione fino a sentirsi fratello di tutti».
Questo è lo scenario in cui de Foucauld si risolse a vivere in terra straniera, affrontando la solitudine, con la sola certezza di voler trasformarsi nel prossimo di chiunque, testimone della possibilità reale di una fraternità priva di confini.
Ed è in tale chiave che non è difficile comprendere il motivo per cui il secondo capitolo della Fratelli tutti, intitolato Un estraneo sulla strada, va letto come il cuore pulsante di tutto il testo. Vi si commenta il racconto del cosiddetto Buon Samaritano (Lc 10,25-37), in cui Gesù risponde alla domanda “Chi è il mio prossimo?” (10, 29), alla maniera rabbinica, tramite un’ulteriore domanda: “Chi è stato il prossimo per quel poveraccio caduto nelle mani dei briganti?”. Si può dire che è dall’icona del Buon Samaritano, con i suoi gesti tutti umani e non motivati religiosamente, che ha inizio l’enciclica.
E, simmetricamente, essa si chiude con la spiritualità nazarena di de Foucauld, che contrae con l’umanità che incrocia un rapporto d’amore non esibito, ma vissuto come dialogo e donazione che precedono lo stesso annuncio kerygmatico. Al modo in cui, nella vita nascosta di Gesù nei trent’anni di Nazaret, egli non ha predicato né declinato generalità religiose o identitarie, ma è vissuto da fratello e concittadino tra uomini.
Ecco poi il n. 287 dell’enciclica, in cui compare una fulminea, felicissima sintesi dell’esperienza spirituale di frère Charles, con un auspicio finale: «Egli andò orientando il suo ideale di una dedizione totale a Dio verso un’identificazione con gli ultimi, abbandonati nel profondo del deserto africano. In quel contesto esprimeva la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello, e chiedeva a un amico: “Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese”. Voleva essere, in definitiva, “il fratello universale”. Ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi. Amen».
In questa chiave, de Foucauld si avvia a diventare, di fatto, con la sua prossima canonizzazione, il santo del dialogo interreligioso. Che fu ricondotto alla fede cristiana dell’infanzia dall’incontro, durante un viaggio in Marocco, con musulmani ed ebrei che scandivano i propri giorni nella preghiera e l’abbandono a Dio. Perché gli incontri con l’alterità, a un orecchio capace di ascolto, non lasciano mai indifferenti.
Missione
Cos’ha da dire oggi de Foucauld rispetto al tema, così delicato, della missione cristiana?
È noto come negli ultimi decenni il concetto di missione sia stato sottoposto a un’amplissima revisione rispetto ai modelli finora adottati, revisione attuata non solo dai teorici della materia, i missiologi, ma anche dagli stessi operatori sul campo, missionarie e missionari, chierici e laici.
Le risposte alla crisi di tale nozione sono assai diversificate, così come i vissuti concreti degli attori diretti: dal recupero dei modelli più tradizionali che puntano a riproporre antichi schemi ritenuti solidi e inscalfibili, fino a tentare vie inedite che, nel corso della loro messa in opera, sperimentano – certo, a caro prezzo – l’arduo cammino di inculturazione dell’annuncio evangelico, nella consapevolezza che occorre sempre prendere le mosse ascoltando la realtà, prima ancora di sbandierare dottrine e idee da portare sul luogo sic et simpliciter.
Molte le cause della trasformazione in atto: dagli effetti della decolonizzazione nei Paesi che abbiamo chiamato fino a qualche anno fa del Terzo mondo agli sviluppi nelle scienze sociali, soprattutto in sociologia e antropologia, finalmente accolti come necessari per capire i cambiamenti in corso; dai drastici mutamenti di mentalità legati al decreto conciliare Ad gentes, che ha scelto di fondare biblicamente e teologicamente la missione e nel contempo di allargare a tutta la Chiesa il compito di fare missione, fino all’emergere di una cultura cosiddetta postmoderna.
Caratterizzata, quest’ultima, da un sistema di valori e credenze ben più profondi di quanto una prima superficiale osservazione possa far pensare: fra gli altri, alla rinfusa, un forte senso dello sviluppo storico delle idee e dei punti di vista; un’accettazione indiscussa della costruzione sociale della conoscenza e dell’influenza delle culture sulla comprensione; una chiara consapevolezza dell’immensità, diversità e misteriosità del mondo fisico e sociale; l’esaurimento delle metanarrazioni, le ideologie che sinora ci hanno descritto la realtà a tutto tondo.
In questo panorama, gli istituti missionari, e più complessivamente la missione della Chiesa, stano facendo i conti con la loro debolezza, con la loro crescente fragilità; e, contestualmente, con la necessità di annunciare e testimoniare il Vangelo non nella potenza dei mezzi o dei sostegni di vario tipo, ma nell’estrema precarietà di una situazione di crisi sistemica costantemente in progress.
Insuperabile, al riguardo, la considerazione di due decenni or sono del vescovo di Poitiers, il francese Albert Rouet, autore del bestseller La chance di un cristianesimo fragile, riferita a un giornalista che lo sollecitava a esprimersi su cosa la Chiesa avrebbe dovuto fare per poter essere meglio accolta nell’attuale congiuntura culturale, con cui indicava con parrhesia il proprio sogno: «Rispondo alla domanda con un’utopia. Vorrei una Chiesa che osa mostrare la sua fragilità. A volte la Chiesa dà l’impressione di non aver bisogno di nulla e che gli uomini non abbiano nulla da darle. Desidererei una Chiesa che si metta al livello dell’uomo senza nascondere che è fragile, che non sa tutto e che anch’essa si pone degli interrogativi».
Rileggere oggi la vicenda di Charles de Foucauld può aiutarci a entrare in sintonia con questo clima e a rimetterci in marcia, a dispetto di ogni oggettiva difficoltà. Sì, la fede cristiana, sulla scia del carisma del fratello universale, ci dovrebbe spingere oggi a prendere il largo, ad apprezzare il dono dell’incertezza e del mistero della creazione, nella consapevolezza che la missione è di Dio, sia pure limitata dai nostri umili tentativi di comprenderla e di viverla.
Perché, se si dà un punto fermo in questa stagione liquida, è che nulla nella missione e nell’annuncio evangelico sarà come prima, per cui i credenti sono sin d’ora chiamati a disporsi alla rottura e alla reinvenzione del messaggio cristiano, fino ad abbandonare definitivamente l’idea di un Dio onnipotente per abbracciare quella di un Dio che sta alla soglia dell’esistenza.
In altri termini, occorre dialogare per credere: risignificare il pluralismo, accettare il caos pur nella ricerca di un senso, nella convinzione che la verità non è un possesso; e che Dio – nel tempo segnato dall’incertezza, appunto – si dice nel movimento di impregnarsi, mescolarsi, donarsi, per ritrovare nell’altro le ragioni perdute dell’essere comunità e del tessere legami. Fratelli (e sorelle) tutti.
Ecco perché, a conti fatti, e a dispetto degli ancora troppi profeti di sventura (compagni ideali di quelli deprecati da Giovanni XXIII mentre introduceva, sessant’anni or sono, il concilio Vaticano II con la Gaudet Mater Ecclesia), questo cambiamento d’epoca non solo non dovrebbe mettere paura, ma potrà fare del bene al Vangelo e alla sua credibilità. Perché «se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24).
BRUNETTO SALVARANI, Fino a farsi fratello di tutti, Charles de Foucauld e papa Francesco, Cittadella, Assisi 2022
Padre Pino Puglisi...vivere con coerenza il Vangelo

"Don Pino Puglisi non voleva essere definito prete anti-mafia."
Alessandro D’Avenia
Il 15 settembre del 1993, nel giorno del suo 56° compleanno padre Pino Puglisi fu ucciso dalla mafia con un colpo di pistola alla nuca.
Era il professore di religione del mio liceo, il Vittorio Emanuele II di Palermo, e stava per noi cominciando il quarto anno. Quel mercoledì 3P, questo il suo soprannome tra i ragazzi, si era recato per l’ennesima volta in Comune per chiedere la bonifica dei sotterranei dei palazzoni di via Hazon, nel quartiere di Brancaccio, di cui era parroco. Quei locali erano teatro di duelli mortali tra cani su cui scommettere, spaccio e prostituzione minorile gestiti dalla mafia. 3P insisteva perché i locali venissero liberati e destinati alla grande assente del quartiere: la scuola media. Ho sempre visto nel gesto di bussare alle porte dell’amministrazione pubblica uno dei punti fondamentali del suo testamento. La mia vita e quella di tanti coetanei, ha uno spartiacque, prima e dopo la morte di 3P e se ho deciso di fare l’insegnante lo devo in gran parte a lui, come ho cercato di narrare nel romanzo «Ciò che inferno non è». Oltre ad andare in Comune, quel giorno si dedicò in vari modi alle persone della parrocchia e del quartiere. Verso sera, rincasando, in attesa di festeggiare il compleanno con amici e parenti, gli spararono. Perché un sacerdote era così pericoloso per la mafia che l’anno prima aveva eliminato Falcone e Borsellino?
Quando hanno chiesto al suo sicario, divenuto collaboratore di giustizia, il motivo dell’assassinio la risposta è stata: «Si portava i picciriddi cu iddu». Infatti don Pino aveva fatto aprire un centro accanto alla parrocchia di san Gaetano per permettere ai bambini e agli adolescenti del quartiere di giocare, studiare, stare insieme. Aveva chiamato il centro «Padre nostro» per scardinare dalle teste e dalle strade l’idea del padre come «padrino». Nel dialetto della mia città «u parrinu» è sia il padrino sia il sacerdote: un piccolo padre. Lui era proprio piccolo, aveva solo cuore e orecchie molto grandi, per ascoltare tutti, e un sorriso disarmante che incrociavo nei corridoi della mia scuola, un sorriso che accordava sempre, anche quando era stanco e preoccupato, alle nostre vite, che per lui, per quanto acerbe, erano vite su cui valeva la pena gioire, sempre. Al centro «Padre nostro», dove 3P portava gli studenti del suo liceo a dare una mano, i ragazzini del quartiere trovavano un’alternativa alla scuola della strada, che a Brancaccio aveva come maestri i picciotti mafiosi, eroi brillanti e da emulare con le loro armi e i loro soldi. La strada era il vivaio dell’esercito mafioso. Per questo 3P era pericoloso quanto Falcone e Borsellino, perché, con mezzi diversi, erodeva ciò di cui la mafia ha bisogno: il consenso. Don Pino faceva sperimentare ai giovanissimi l’unica cosa che dà il coraggio della libertà: la bellezza. Dove non c’è bellezza non c’è speranza di cambiare la realtà, la bellezza, fosse anche solo quella di un campetto di calcio in terra con le linee ben tracciate, è ciò che permette di sentire la differenza e poi di fare la differenza. E il potere non sopporta di essere messo in discussione perché la mancanza di consenso lo fa crollare, quindi il controllo del territorio è tutto. E così 3P con la sua preghiera, la celebrazione dei sacramenti, le gite al mare, i tornei di calcio, il doposcuola... era pericoloso. Non voleva essere definito prete anti-mafia, perché diceva che il suo compito era essere come Cristo, essere pro, anti nessuno, permettere a tutti di cambiare, anche a costo di rimetterci in prima persona. E Cristo finì male, proprio perché osò mettere in discussione il potere, religioso e politico, che opprimeva la gente e che, temendo di perdere il consenso, lo fece fuori come un delinquente. Cristo aveva detto «lasciate che i bambini vengano a me», il programma che don Pino ha realizzato sino all’ultimo giorno della sua vita, andando a chiedere alla sorda burocrazia statale che quella vita più bella e libera venisse mostrata non solo in un piccolo centro parrocchiale, ma in una scuola per i ragazzini del quartiere. Sapeva bene che è con l’educazione che si cambiano le cose, persino un quartiere in cui quegli scantinati non venivano sgomberati e quella scuola non veniva costruita perché politici e mafiosi erano conniventi. Poco prima che cominciasse quell’anno scolastico di 30 anni fa don Pino, provato dalla situazione che stava sostenendo tra minacce, vandalismo e percosse, aveva chiesto una riduzione di orario. Il preside lo convinse a mantenere le classi che aveva: gli studenti ne avevano bisogno. Ma quell’anno non varcò mai le porte di quella scuola che potete vedere accanto alla bella cattedrale normanna della città, dove è custodito il suo corpo in un sarcofago a forma di spiga. Per questo quando all’inizio di ogni anno scolastico leggo sulle pagine dei giornali la solita nauseante storia dei precari, delle migliaia di cattedre scoperte, del sostegno per i fragili che o non c’è o cambia continuamente, dell’edilizia scolastica inadeguata e brutta, penso a 3P che quella mattina del 1993, prima di morire, aveva bussato invano per l’ennesima volta alle porte del Comune per chiedere di aprire una scuola e proteggere i bambini dalla legge della strada. I lavori di bonifica degli scantinati sono stati fatti nel 2005, mentre la scuola media di Brancaccio è stata inaugurata a gennaio del 2000 e intitolata a 3P. Molte cose nel quartiere sono cambiate grazie alla sua eredità: tanti di quei bambini, ora adulti, portano avanti la sua opera. Altrettante non sono cambiate, perché le cose cambiano quando cambiano le persone e le persone cambiano solo quando sono amate, come dice il poeta Ezra Pound: «Ciò che sai amare rimane/ il resto è scoria/ Ciò che tu sai amare non sarà strappato da te/ Ciò che tu sai amare è la tua vera eredità» (Cantos, LXXXI).

Rendeva sacre le vite che incontrava: Don Pino Puglisi
Intervista a Alessandro D'Avenia
Domanda. Dopo Bianca come il latte (2010), e Cose che nessuno sa (2011), è uscita la sua ultima fatica: Ciò che inferno non è, romanzo per cui ci sono voluti tre anni. C’è stato qualche incontro, qualche vicenda, che ha acceso in lei l’urgenza per questo libro?
Risposta. Non avevo in programma di scriverlo, stavo già lavorando ad altri progetti, ma ad un certo punto la storia ha avuto il sopravvento, come uno di quegli incontri per strada che ti obbligano a cambiare i tuoi programmi. Leggevo la confessione dell’assassino di don Pino, divenuto collaboratore di giustizia. Puglisi gli ha sorriso nell’attimo in cui stava per sparargli. Uno dei killer più efferati della mafia dice che per quel sorriso “non ci ha dormito la notte”. Quella frase è esplosa dentro di me come dinamite. Volevo capire come si fa ad essere così liberi da sorridere alla morte e ai suoi scherani. Quel sorriso liberava persino l’assassino dal suo gesto, lo costringeva a rivedere tutta la sua vita.
D. Che significato poteva avere?
R. Quel sorriso diceva: tu sei molto di più di quello che stai facendo a me. Riecheggiava il “perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Volevo scandagliare, da uomo e da narratore, il mistero di quel sorriso. Chi sa morire così sa anche vivere e insegna a vivere a chi resta. Volevo liberare l’agiografia e la cronaca dalla loro retorica o appiattimento e cogliere in che modo un capitolo della storia della salvezza si compiva in quel momento. Poi ci sono state la beatificazione per martirio di Puglisi e l’assegnazione del premio a lui intitolato. Altri incontri, altri volti, altre persone. È come se quell’uomo che avevo conosciuto nei corridoi della mia scuola mi desse la caccia. Il suo romanzo sulla mia carne lo aveva già scritto, ma era come se quella carne dovesse diventare di molti, attraverso la carta. Col senno di poi credo sia stato un tocco della grazia.
D. I due libri precedenti sono stati anche successi internazionali. Ma entrambi erano ambientati in città che potevano essere una qualsiasi metropoli europea. Qui invece sceglie Palermo. Perché questa decisione? Non teme che possa non essere compresa dai suoi lettori?
R. Al contrario. Lo comprenderanno ancora meglio. Più una storia è incarnata più può essere universale. È una città paradossale: di luce e lutto, di paradiso in una via e inferno girato l’angolo. È uno dei personaggi del romanzo e determina tutti gli altri come un fato incombente. Come nel cinema noir della metà del secolo scorso si tratta di un paesaggio reale e simbolico, nel cinema l’uso del campo lungo sugli ambienti determinava i sentimenti del personaggio, che ne diveniva una tessera, venivano messi a fuoco sia il personaggio sia l’ambiente come se fossero tutt’uno: luce e tenebra erano parte del personaggio.
D. Dunque il romanzo è anche è un atto d’amore verso Palermo.
R. Sì, ma di quell’amore che Borsellino definiva così: “Non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare”. Metto a fuoco Palermo nei dettagli, perché è Palermo che ha messo a fuoco la mia anima e i miei personaggi. In questo romanzo le due città, quella di Dio e quella degli uomini, intuite da Agostino, si intersecano nella luce e nelle tenebre, e Palermo ha di certo i connotati, i profumi, i colori reali, ma allo stesso tempo è la città degli uomini di tutti i tempi, quella in cui nelle tenebre la grazia si fa strada. Chi leggerà con attenzione coglierà un sottotesto continuo nella storia, quello che lega il dramma della storia a Dio.
D. Padre Pino Puglisi (3P, come viene soprannominato nel libro) è stato beatificato da Papa Francesco ed è stato suo insegnante a scuola. Credo che Ciò che inferno non è sia il primo romanzo laico, a grandissima tiratura, che corre il rischio di avere tra i suoi protagonisti un santo. Come è riuscito a non cadere nell’agiografia di don Pino?
R. Era la sfida principale. Volevo io per primo capire se la cronaca era già agiografica, o se invece la cronaca fosse la manifestazione di un tratto di storia della salvezza, della storia sacra del chinarsi di Dio sull’uomo. Romano Guardini scrive così: «Nessuno prende la realtà sul serio come il santo perché in verità ogni fantasticheria, sulla sua strada irta di pericoli, inesorabilmente si vendicherebbe. Divenire santo significa per l’uomo reale staccarsi da sé, per entrare nel Dio reale». Raccontare la santità è raccontare il massimo realismo e l’uomo Puglisi entrerà nel cuore anche dei non credenti, perché il santo è la pienezza dell’uomo e di fronte ad un uomo tutto d’un pezzo non si può che rimanere affascinati, come è accaduto a me. Mi sono documentato meticolosamente, seguendo anche le tracce del processo di beatificazione, per cogliere questo realismo del santo. E ho trovato gli ingredienti di un’epica quotidiana che ci riguarda tutti. Come trasformare la prosa di ogni giorno nella poesia di una vita bella? La storia racconta questo, ciò che inferno non è in mezzo all’inferno.
D. Cosa nostra sarà sconfitta quando non ci vorranno più gli eroi per sconfiggerla ma sarà diffusa la normale “eroicità” di chi è onesto e lavora per il bene. Da quello che si è potuto desumere finora dal suo romanzo pare essere questo un insegnamento importante che è contenuto lì. Mi sbaglio?
R. No, è proprio così. Il mio non è un romanzo antimafia, non è un romanzo sulla mafia, non è un romanzo di cronaca. È una storia che entra nel mistero del sacrificio: che non è il fatto in sé di morire, ma quello che significa alla lettera (sacrum facere: rendere sacro). 3P rendeva sacre le vite che incontrava perché erano rese sacre da Dio e lui non era altro che al servizio di quelle vite. Riecheggiano le parole di qualcuno: non siete voi che mi togliete la vita, sono io che la dono. Sacrificarsi è donare il proprio tempo, amore, cure, anche quando è difficile riuscire. Lui riusciva perché lasciava che Dio facesse questo con lui. Era innamorato pazzo di Cristo e questo amore traboccava. Credo che chiunque gli si accostasse vedeva un uomo qualunque capace di amare divinamente, sentiva la tenerezza di Dio su di lui, come accadde persino all’assassino. L’eroismo è questo: giorno per giorno non privarsi mai della possibilità di amare ed essere amati. Per questo ho scelto la frase di Dostoevskij in esergo: “l’inferno è la sofferenza di non poter più amare”. Chi trova il segreto per amare sempre nel quotidiano, trova il segreto della vita: fallimenti, sconfitte, cadute non possono distruggere la speranza, perché quella speranza si colloca altrove. In un altrove intoccabile, come un mare in tempesta in superficie e calmo pochi metri sotto.
(Da: ilsussidiario.net)
Il romanzo
Romanzo struggente e profondo, che attraversa l’animo di un adolescente, animato da passione civile e tormentata sensibilità religiosa al tempo stesso. Il protagonista, Federico, fa parte di quella generazione degli anni ’90 che visse come una sorta di perdita dell’innocenza gli attentati a Falcone e Borsellino. “Prima noi non sapevamo cos’era la mafia. O meglio, ce ne tenevamo fuori, era una cosa che non ci riguardava. Con gli attentati di Capaci e via D’Amelio è cambiato tutto. E Puglisi è stato il protagonista di questo nuovo, rinnovato impegno”. D’Avenia non ha scritto un santino, e nemmeno un romanzo antimafia. “La retorica dell’antimafia", dice, "non mi interessa. Quello che mi interessa è capire e far capire come il parroco della borgata più dimenticata della città ha cambiato le cose”.
Lo scrittore, rivivendo la cronaca di quei giorni terribili, ne legge i segni evangelici, a cominciare da come don Puglisi si comportava nel liceo classico Vittorio Emanuele. “Me lo ricordo a scuola: durante l’intervallo passeggiava nei corridoi e rispondeva alle domande dei ragazzi. Non gli piaceva la sala professori: diceva che era piena di professori”. Quel suo modo di deambulare lungo i corridoi era un modo per evangelizzare anche durante l’intervallo. Puglisi invitava gli studenti della Palermo bene ad andare a Brancaccio, quartiere di cui spesso non conoscevano nemmeno l’esistenza. Dovevano giocare a pallone, fare catechismo, aiutare il “parrino” nel Centro Padre Nostro, da lui fondato e finanziato con i soldi dello stipendio di insegnante di religione. “Don Pino sa che l’inferno opera più efficacemente sulla carne tenera: i bambini. Bisogna difendere la loro anima prima che qualcuno gliela sfratti. Custodire ciò che hanno di più sacro”.
D’Avenia nel costruire il romanzo interiore e civile di questo giovane Holden siciliano segue Puglisi attraverso quei fatti, negli anni bui di Palermo, li scruta a fondo e riconosce i segni evangelici di un calvario, fino allo spasimo finale, quel 15 settembre 1993.
“Il libro”, conclude lo scrittore, “è stata anche l’occasione per riconciliarmi con la mia città, Palermo, di cui non avevo capito nulla". Una città, potremmo dire, anch'essa bianca come il latte e rossa come il sangue, dove convivono inferno e paradiso, rappresentata da un dipinto di Raffaello sottratto come se le avessero sottratto l'anima e da una chiesa sconsacrata a cielo aperto, la chiesa dello Spasimo.
Don Luigi Ciotti..."Legalità è Speranza, la Speranza è: NOI!

Ciotti e una vita di impegno libero: «Sporchiamoci le mani per il bene»
Antonio Maria Mira e Costanza Oliva
Don Ciotti 80 anni il 10 settembre
Il sacerdote fondatore di Libera compie 80 anni il 10 settembre e ripercorre i grandi nodi affrontati in decenni di sfide: «Pace da edificare nel pensiero, nel linguaggio e nelle pratiche»
La tregua armata non basta, «la logica di deterrenza va scardinata». Semplicemente perché «una pace vera non può essere fondata sull’equilibrio delle forze». Don Luigi Ciotti va subito al cuore della questione, e come fa da sempre non rinuncia a mettere in discussione uno dei concetti “mainstream”. Il 10 settembre compirà 80 anni, e anche se non ama particolarmente festeggiarsi, dalla Certosa di Avigliana dove Libera ha radunato gli amici sacerdoti e vescovi come ogni anno a fine estate, si concede ad Avvenire in una lunga intervista, in cui ripercorre e mette insieme i grandi nodi che ha affrontato in una vita passata a costruire e al tempo stesso a scardinare.
A partire dalle guerre, naturalmente: Come diceva don Tonino Bello, la pace va costruita, non bastano parole e proclami. Come farlo, oggi, sui tanti fronti di guerra e sui nostri fronti sociali e personali?
La pace va costruita su tre fronti. Nel pensiero: dobbiamo pensarla possibile non come sospensione temporanea del conflitto, ma situazione di giustizia duratura. Nel linguaggio: disarmare le parole per disarmare i comportamenti, come ha detto Papa Francesco. Senza scordare che la pace ha bisogno anche di silenzio, preghiera, digiuno. Infine nelle pratiche: pacifista non è chi vuole “uscirne pulito” senza compromettersi col male, ma chi si sporca le mani tutti i giorni per il bene. Come chi soccorre i migranti in mare, cura le persone malate senza mezzi, educa i giovani a relazioni sane, rifiuta di caricare i container di armi nei porti, coltiva le terre sottratte alle mafie, respinge l’ordine di combattere per non uccidere persone innocenti. La pace si costruisce con gli strumenti della pace: la diplomazia, il dialogo, gli aiuti umanitari, le giuste garanzie di sicurezza per le persone, i popoli, le minoranze.
Siamo tutti molto preoccupati ma anche incapaci di uscire da schemi e parole tradizionali. Forse avremmo bisogno di litigare un po’ di più con la nostra coscienza?
Esatto. La pacificazione delle coscienze è la peggiore nemica della pace fra le persone e i popoli! Quel sentirsi sempre dalla parte giusta, intoccabili, “a posto”. Invece le coscienze inquiete, sempre piene di dubbi e domande, sono quelle capaci di suscitare cambiamenti.
Anche di perdonare? Ne parliamo molto, ma…
Per noi cristiani il perdono è o dovrebbe essere una meta, qualcosa verso cui tendere sull’esempio di Gesù in croce. Se parliamo della dimensione civile del perdono verso chi ha commesso un crimine, mi sembrano illuminanti le parole della “Misericordiae Vultus” di Papa Francesco: giustizia e misericordia “non sono due aspetti in contrasto fra di loro, ma due dimensioni di un’unica realtà”. “Chi sbaglia dovrà scontare la pena, solo che questo non è il fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono”. La misericordia non giudica, non respinge. Accompagna le persone ad affrontare le proprie fragilità, aiutandole a cambiare.
Ma è possibile perdonare tutti? Oggi ce lo chiediamo se guardiamo alle guerre, lei nella sua vita ha affrontato il dolore e la richiesta di verità e giustizia delle vittime della mafia..
La misericordia non esclude la fermezza, il diritto delle vittime e delle loro famiglie di essere riconosciute e tutelate nei loro diritti. Gli sconti di pena per i collaboratori di giustizia sono un discorso a parte che a volte suscita fraintendimenti. Non implicano l’idea di “perdono”: sono frutto dell’intuizione di magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che credevano nella possibilità di combattere le mafie dall’interno, offrendo ai loro esponenti di rimettersi in gioco e rinnegare il male commesso.
Lei sostiene di essersi sempre sentito parte della Chiesa anche quando parte della Chiesa non lo capiva, accettava, sosteneva. Perché “un irregolare” (come lo definisce monsignor Galantino) non ha mai “rotto” con la Chiesa?
La mia fedeltà alla Chiesa è semplice fedeltà al Vangelo. C’è chi guarda alla Chiesa come istituzione, ma la Chiesa è innanzitutto una comunità di persone che credono e si affidano alla Parola di Gesù. Se continuo a riconoscermi in quella Parola, e farne la mappa della mia vita, continuerò a sentirmi parte di quella comunità, cioè sentirmi a casa dentro la Chiesa, pur nelle differenti sensibilità su alcuni temi o alcune forme di espressione. Lo dico con molta umiltà e molta riconoscenza per ciò che la Chiesa, a partire da quella torinese, mi ha dato.
I giovani sono alla ricerca di senso, di impegni concreti e di adulti che “accompagnino”. Cosa è cambiato rispetto a 60 anni fa quando col Gruppo Abele avete cominciato proprio coi giovani?
Rilancio: cosa è cambiato da quando Don Bosco, in quella stessa Torino ma centovent’anni prima, ha avviato il suo incredibile cammino accanto ai giovani più emarginati? Tutto e niente. Sono cambiati i volti, le provenienze, le ragioni dell’emarginazione, ma non il bisogno di riferimenti educativi credibili, di opportunità di studio e lavoro, di riconoscimento e riscatto sociale. Col Gruppo Abele ci siamo inventati dei percorsi inediti per rispondere a problemi che si presentavano in forma nuova, ma avevano radici storiche.
Oggi c’è chi propone di abbassare l’età della punibilità dei giovani...
Ancora oggi basterebbe rileggere don Bosco per capire che la repressione da sola non serve, anzi peggiora le cose. Lui diceva che “un sistema repressivo può impedire un disordine, ma difficilmente può rendere migliori i giovani delinquenti”. E se non aiuti le persone a cambiare, non cambieranno mai le situazioni. Abbassare l’età della punibilità non ha senso, dobbiamo piuttosto investire nella prevenzione dei reati minorili, e potenziare gli interventi di sostegno che includano anche le loro famiglie.
Spesso vediamo i giovani protestare, ma di solito vengono spesso accusati di non farlo nel modo giusto. Cosa direbbe loro e quali strumenti di disobbedienza si possono usare?
C’è il rischio di guardare i percorsi esistenziali dei giovani con gli occhi del passato. Dobbiamo invece cogliere i loro percorsi inediti, dentro i problemi di oggi. Ovviamente si tratta di restare dentro l’argine della nonviolenza. Ma da adulto, so che devo mettermi in una posizione di ascolto attento e non giudicante. Chi se la prende con le forme di disobbedienza dei giovani spesso guarda il dito per ignorare la luna. Su temi come il cambiamento climatico, le guerre o le ingiustizie sociali sono i giovani a fare la differenza, a indicarci con forza la necessità di cambiare i nostri stili di vita, produzione e consumo. Sono sempre loro a dire dei “no” importanti: no a una eccessiva richiesta di protagonismo produttivo, efficientismo fisico e psichico, no a una prospettiva basata sul “di più è meglio”.
Davanti a tanti giovani che si sentono fuori posto - come si è sentito lei quando era giovane - è possibile ribaltare lo sguardo e vederlo in modo positivo? Come chiave empatica e una spinta che porta ad agire?
Non esiste una strada sola verso l’impegno. Alla base, come dicevo, serve conoscenza. Capire il presente, nelle sue molte storture, ti dà l’innesco per volerlo cambiare. Poi certo vivere alcune ingiustizie o fragilità sulla propria pelle può trasformarsi nello stimolo a fare qualcosa per altri che le subiscono. Ma ognuno ha i suoi percorsi. L’essenziale come dico sempre è che quei percorsi si intreccino e arricchiscano a vicenda, perché il cambiamento sociale non è per navigatori solitari. I giovani questo lo capiscono bene: un altro grande motore del loro impegno è infatti la relazione, il ritrovarsi insieme a vivere visceralmente certe esperienze. Abbiamo ancora negli occhi le immagini del Giubileo dei giovani a Tor Vergata, ma anche quelle dei giovani che vediamo arrivare a migliaia ai campi estivi di Libera, con loro voglia di partecipazione e di ascolto.
La corruzione è sempre più diffusa. Le stesse mafie ne hanno fatto loro strumento più della violenza, eppure appare tollerata. Tutti parlano di legalità ma lei ripete spesso che è solo uno strumento verso la giustizia. Ce lo spiega?
È sbagliato vedere nel rispetto delle regole un fine a sé stante. La legalità è il mezzo, ma la giustizia sempre lo scopo. Dove per giustizia intendiamo l’uguaglianza dei diritti, dei doveri, delle opportunità e dei servizi. Le leggi le fanno le persone, e le persone a volte sbagliano. Quindi possono esistere leggi sbagliate, che contrastano coi dettami della coscienza e, nel caso di un cristiano, con la Parola di Gesù. Le norme italiane ed europee sull’immigrazione, con la loro disumanità di fondo, per quanto mi riguarda sono un esempio. La cultura della legalità deve distinguersi dal semplice legalismo, e affondare le radici in un profondo senso etico. Per questo la responsabilità individuale resta l’architrave del sistema.
L’assenza dello Stato nei confronti dei migranti rende più facile per le mafie approfittarsi della loro vulnerabilità?
Magari potessimo parlare di assenza dello Stato! La verità è che oggi lo Stato contro le persone migranti spesso si accanisce, con leggi e procedure che tendono a sospingerle dentro un limbo d’invisibilità, povertà e illegalità, di cui approfittano appunto i poteri criminali. Abbiamo alcune buone leggi, ad esempio quelle per il contrasto alla tratta o la legge recente contro il caporalato. Ma servono risorse, investimenti, controlli. Serve che l’Italia - e anche l’Europa - imparino a proteggere le persone, per trasformarle in cittadini fedeli e responsabili, anziché disperati al soldo delle mafie.
La droga, della quale non si parla più, se non come questione criminale e non sociale. Così come delle altre dipendenze: alcol, azzardo, ecc.. Ci stiamo assuefacendo?
Mettiamo la testa sotto la sabbia, approfittando del fatto che le dipendenze di oggi ci sembrano più “compatibili” con la vita quotidiana. Ma è un’illusione! Le dipendenze continuano a essere un dramma per tante persone e famiglie, a produrre costi sanitari e tensioni sociali. Abbiamo depotenziato i servizi terapeutici e la prevenzione è quasi scomparsa.
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa...un faro di Giustizia!

La fede del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ci illumina e ci guida ancora oggi. Credente sulle orme di Cristo, Dalla Chiesa ci testimonia l’esempio di una vita di lavoro onesto e pulito e di lealtà verso lo Stato e le sue Istituzioni”
Omelia dell’Arcivescovo di Palermo
nato il 27 settembre 1920- morto il 3 settembre 1982
Ci siamo riuniti in questa Cattedrale – in questo spazio umano-divino, fecondato e contaminato da popoli e da culture diverse, dove da secoli si celebra l’amicizia di Dio con le donne e gli uomini di questa nostra diletta Città bella e straziante. Nelle pagine della Parola di Dio appena proclamate – soprattutto nel brano evangelico – anche noi abbiamo trovato un’eco di questa amicizia fedele, in un giorno per noi tutti carico di memoria e di gratitudine.
Il passo dell’evangelista Luca (Lc 6,1-5) si trova nel contesto di una serie di dispute con alcuni farisei che mettono in discussione e criticano l’operato di Gesù e dei suoi discepoli. Qui, in particolare, a motivo dei discepoli che raccolgono e mangiano le spighe in giorno di sabato, contravvenendo così alla norma del riposo sabatico. Quale autorevolezza può avere un Rabbi che non sa educare i suoi discepoli a rispettare la Torah, la Legge? E Gesù risponde alla maniera dei rabbini, rifacendosi a un testo della Scrittura (1Sam 21,1-7) allorché Davide con i suoi compagni mangiò per fame nella casa di Dio i pani dell’offerta.
Nell’interpretazione della Legge, Gesù non perde di vista l’intenzione ultima e profonda della volontà di Dio: la centralità della persona umana e la gioia della condivisione del pane quotidiano – del pane essenziale dell’amore – nella fatica e nella gioia della giornata umana. La Legge è al servizio dell’uomo, non è data per ostacolarlo. Il sabato è memoria e pregustazione del pane fragrante della convivialità eterna che deve orientare l’impegno quotidiano e ordinario, la responsabilità che ognuno di noi porta dentro l’arduo e meraviglioso spartito della vita. Gesù guarda al bisogno di un cibo e di un sostentamento che alimenta la vita. Egli viene da Dio, dal Dio che ha il volto del Padre amante degli uomini, del Padre provvidente attento a che nessuno dei suoi figli e delle sue figlie manchi del pane della vita e della libertà e della gioia della convivialità. Dio ha pensato e vuole gli uomini liberi da ogni forma di oppressione.
«Signore del sabato è il Figlio dell’uomo» (Lc 6,5). Oggi, come allora, Gesù ci aiuta ad allargare lo sguardo. A custodire ampi orizzonti. Specialmente perché questa Parola ci viene affidata nel quarantesimo anniversario dello spietato agguato in cui persero la vita il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, la consorte Emanuela Setti Carraro e l’Agente scelto Domenico Russo. Una donna e due uomini liberi che hanno scelto di amare.
In un interessante manoscritto del NT, il Codex Bezae, viene riportato, dopo il v.4 di questo VI capitolo, un detto sconosciuto di Gesù pronunciato «lo stesso giorno vedendo qualcuno lavorare di sabato […]: “Uomo, se sai ciò che fai, sei beato, se invece non lo sai, sei maledetto e trasgressore della Legge”». Gesù chiede sempre – cosa alquanto urgente ai nostri giorni – di guadagnare un orizzonte più ampio della vita, un ‘fare’ che non perda uno sguardo autenticamente umano. Egli riafferma il primato dell’amore e della cura del prossimo al di sopra di tutto, persino delle prescrizioni legali. È la novità e la forza insita nella fede, nell’adesione a Cristo l’Uomo compiuto, il Figlio dell’uomo Signore del sabato.
«Fede», «credo», sono termini che il Generale Carlo Alberto non sbandiera ma che menziona spesso nei suoi interventi, soprattutto quando si rivolge agli uomini dell’Arma o ai suoi Cari, o scrive all’amata Dora strappata improvvisamente e prematuramente al suo affetto. In data 31 marzo – 1 aprile 1978, annota nel suo diario: «Sono sempre stato un credente (…) Oggi voglio avere quella fede; voglio avere più fede!». E manifesta la ferma volontà di voler tornare «alla pienezza di un “Credo”, di quel Credo che è stata per me una cara, dolce costante». Una fede provata, spesso invocata con l’umiltà di un bambino: «Sì. Credo in Dio, nell’Immenso. Anche se, su questa terra, forse perché siamo piccini piccini, qualche volta diventa difficile» (Intervista per «Telemond», 7 marzo 1978). Una fede che si incarna nel credere fino in fondo alle scelte della vita, nel portare avanti il «credo inalterato» degli alti valori umani, civili e religiosi che motivano e guidano l’esistenza personale, familiare, professionale e civica.
La fede del Generale Carlo Albero Dalla Chiesa ci illumina e ci guida ancora oggi: la fede negli uomini e nelle donne che “sanno ciò che fanno”, e la fede in Dio che ci vuole consapevoli e liberi da ogni condizionamento; liberi da ogni potere che limita e opprime la dignità umana e che impedisce la convivenza giusta, solidale, inclusiva e pacifica delle nostre città; soprattutto una convivenza libera dalle organizzazioni mafiose e terroristiche, dall’illegalità a dalle connivenze subdole e pervasive.
Sentiamo l’urgenza di custodire la memoria del Prefetto Carlo Albero Dalla Chiesa, di attingere ancora al suo luminoso orizzonte di vita alimentato dalla fede «in Dio, nell’Immenso». Custodiamo la responsabilità di rimanere fedeli all’insegnamento indirizzato ai suoi Carabinieri dalla sua cattedra di testimone verace, il 5 giugno 1980 a Milano: «Voi rifiutate le violenze ed il loro mercato, i mimetismi ed i facili baratti, i giudizi costruiti sull’opportunismo; voi rifiutate da persone leali, il falso e l’insinuazione eretti a sistema; respingete – anche con il silenzio – ciò che di ottuso e di folle può travolgere il bene di ognuno e di tutti» (Discorso di commemorazione del 166° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri).
Uomo che «sa ciò che fa», professionista preparato e arguto, credente sulle orme di Cristo, Dalla Chiesa ci testimonia ancora «l’esempio di una vita pulita, fatta di entusiasmo», di «lavoro onesto e pulito», ci indica «la forza di resistere, la gioia del donare senza chiedere», l’impegno «di mantenere inalterato lo smalto della lealtà verso lo Stato e le sue Istituzioni», la disponibilità «alla macerazione della vita quotidiana, all’amore per un dovere che tutto pospone». Non ultimo, ci provoca ad optare sempre per «la difesa dell’inerme». Anche noi, come ci ricorda S. Paolo e ci testimoniano questi nostri Amici, «lavoriamo con le nostre mani. Insultati, benediciamo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo».
Arcidiocesi di Palermo, Arcivescovo Corrado Lorefice

DALLA CHIESA: UN ESEMPIO PER LE NUOVE GENERAZIONI
Alessandro Cucciolla
Dalla Chiesa: un esempio per le nuove generazioni
Per l’Arma dei Carabinieri, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è più di un’icona: è una sorgente continua di ispirazione. Il suo ricordo viene onorato non solo con cerimonie ufficiali, ma anche attraverso iniziative volte a trasmettere i suoi valori ai più giovani.
In occasione dell’anniversario della sua morte, i Comandi dei Carabinieri in tutta Italia affiggono locandine con una delle sue frasi più celebri: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”. Questa scelta rivela la volontà di sottolineare non solo l’eroismo, ma anche la profonda umanità e il senso del dovere verso il futuro del generale.
L’Arma organizza anche mostre, come quella presso il Museo Storico di Roma, inaugurata in occasione del 40° anniversario della sua morte, avvenuta il 3 settembre 1982. La mostra, intitolata Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'Uomo, il Generale (1982/2022), ha ripercorso la sua vita attraverso documenti, uniformi e cimeli, ricostruendo la sua straordinaria carriera al servizio dello Stato.
L’obiettivo è chiaro: mantenere viva la memoria di un comandante amato e rispettato, un “grande Carabiniere” la cui visione di uno Stato “fedele” al servizio dei cittadini rimane un pilastro della formazione di ogni militare.
E se l’Arma ne celebra l’eredità istituzionale, i figli Nando, Rita e Simona Dalla Chiesa hanno offerto al Paese un ritratto intimo e potente del loro padre, attraverso le pagine dei loro libri. In Un papà con gli alamari, scritto a più mani, emerge una figura lontana dall’immagine pubblica del generale integerrimo. È il racconto di un padre affettuoso, presente e persino giocherellone, un uomo che amava la bellezza e la semplicità delle piccole cose quotidiane.
Simona Dalla Chiesa, la figlia minore, ha spiegato il titolo del libro evocando il ricordo della divisa del padre, percepita con la tenerezza di un abbraccio. Il libro si apre con una toccante lettera-testamento che il generale scrisse ai figli mentre era in volo verso Palermo, un messaggio carico d’amore e di un presagio di solitudine. Accanto a questo ritratto privato, si staglia la denuncia forte e coraggiosa di Nando Dalla Chiesa nel suo saggio Delitto imperfetto. Pubblicato a soli due anni dall’omicidio, il libro è un’inchiesta lucida e spietata che non si limita a piangere un padre, ma punta il dito contro quelli che l’autore definisce i “responsabili morali” della sua morte. Nando Dalla Chiesa accusa apertamente esponenti della Democrazia Cristiana siciliana e vertici dell’Arma di aver isolato il padre al suo arrivo a Palermo come Prefetto, creando quel vuoto istituzionale che lo rese un bersaglio facile per la mafia. È un’opera che ha trasformato il dolore privato in un atto di impegno civile, diventando un testo fondamentale del movimento antimafia.
L’Italia intera ricorda il generale Dalla Chiesa in modo tangibile e diffuso. Il suo nome è impresso in centinaia di strade, piazze, scuole e caserme in tutto il Paese, a perenne testimonianza del suo sacrificio. Istituti come l’I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone (Viterbo) e l’Istituto Comprensivo di Trappeto (Palermo) educano le nuove generazioni all’ombra del suo esempio.
Ogni 3 settembre, anniversario della strage di via Carini, le città di Palermo, Milano e Parma, tra le altre, si fermano per commemorare lui, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Queste cerimonie vedono la partecipazione delle più alte cariche dello Stato, delle forze dell’ordine e di semplici cittadini, uniti nel rifiuto di ogni forma di criminalità organizzata. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in ogni anniversario, non manca mai di ricordare la figura del Generale Dalla Chiesa con parole di profondo rispetto e ammirazione. Nei suoi messaggi, il Capo dello Stato sottolinea costantemente come Dalla Chiesa sia stato un “esempio eccezionale di fedeltà ai valori della democrazia” e un “esemplare servitore della Repubblica”. Mattarella evidenzia la sua lucida visione strategica nel contrasto al terrorismo e alla mafia e come le sue intuizioni siano rimaste un “patrimonio comune” per chi ha continuato la sua battaglia. Il Presidente rimarca come il sacrificio di Dalla Chiesa abbia contribuito a scavare un solco incolmabile tra la società civile e la criminalità mafiosa, rafforzando la determinazione delle istituzioni nella difesa della legalità.
Oltre al ricordo commosso, cosa rimane oggi dell’eredità del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa? Rimane, innanzitutto, un metodo. La sua capacità di comprendere la complessità dei fenomeni criminali, di combatterli con strumenti investigativi innovativi e di cercare sempre un dialogo con i cittadini onesti, soprattutto i giovani, costituisce ancora un modello per chi opera per la giustizia. Rimane l’esempio di un uomo che non si è mai tirato indietro, che ha accettato l’incarico più difficile nel momento più buio, consapevole dei rischi ma spinto da un incrollabile senso del dovere. Rimane il coraggio di un figlio che ha saputo trasformare la rabbia in un’arma di denuncia, e l’amore di tre figli che hanno voluto condividere con il Paese l’umanità del loro “papà con gli alamari”.
Infine, rimane una speranza. La speranza, incarnata dalle tante scuole che portano il suo nome, che le future generazioni possano crescere con la stessa schiena dritta e lo stesso sguardo sereno con cui il generale Dalla Chiesa ha servito l’Italia, fino all’ultimo giorno.
(*) Dopo 43 anni dalla brutale uccisione per mano mafiosa, la memoria del generale Dalla Chiesa non sbiadisce.
Don Benzi...fratello di tutti

Il centenario. I 100 anni di don Benzi, lo «scarabocchio di Dio» che capovolse il mondo
Lucia Bellaspiga
A Rimini tre giorni di eventi per celebrare il fondatore della Papa Giovanni XXIII, nato il 7 settembre 1925. La rivoluzione dell'"apostolo della carita" opera oggi al fianco degli ultimi in 40 Paesi
Al cardinale Caffarra, allora arcivescovo di Bologna, che un giorno gli disse «don Oreste, tu sei un santo», rispose correggendolo con umile fermezza: «No, eminenza, io sono solo uno scarabocchio di Dio». Sono migliaia i fermo-immagine che possono raccontarci la straordinaria vita di don Oreste Benzi, il prete romagnolo nato cento anni fa, il 7 settembre 1925, alle porte di Rimini, da famiglia tanto povera materialmente quanto ricca in spirito e in amore. Aveva 7 anni il giorno in cui la maestra Olga in classe parlò di tre figure esemplari, lo scienziato, l’esploratore e il sacerdote, e quel mattino il piccolo Oreste tornò a casa con una decisione, «mamma, io farò il prete». Entrò in seminario che ne aveva 12 (era settimo di nove figli) e i suoi genitori per permettergli gli studi chiesero l’elemosina... Li incontrò in famiglia i primi poveri, li conobbe nella dignità del padre Achille e della madre Rosa, che seppero imprimere nel suo cuore la forza della fede e il rispetto per gli ultimi, e poi li ri/conobbe, per tutta la vita: negli scartati, negli indifesi, nei calpestati, quei “piccoli” che «guai a lasciarne indietro anche solo uno». I poveri non ci vengono a cercare, diceva sempre, «allora dobbiamo noi andare a cercare loro», e così spazzava via alibi e coscienze pulite.
Dal 5 settembre per tre giorni a Rimini decine di eventi di giorno e di notte stanno raccontando la vita e le opere di don Oreste attraverso le parole dei testimoni diretti, ma anche di personalità della cultura e dello spettacolo, concerti, filmati, funzioni religiose, giochi, intrattenimenti per le famiglie e i bambini. Ma contemporaneamente il centenario è festeggiato in tutto il mondo con grandi celebrazioni, a partire dallo Zambia dove nacque la prima delle sue missioni all’estero. «Quando vi chiedono dov’è il vostro domicilio, voi rispondete: il nostro domicilio è tra i più bisognosi! E tra i più bisognosi siate tra i più bisognosi ancora, laggiù in fondo», tra gli ultimi e ancora più giù: questo raccomandava ai suoi della “Papa Giovanni XXIII”, la comunità che fondò a Rimini nel 1968, l’anno delle contestazioni.
L’“infaticabile apostolo della carità”, come lo definirà molti anni dopo papa Benedetto XVI, dava così una solida struttura alla sua rivoluzione, contagiando da subito i primi giovani disposti a legare la propria vita agli oppressi e a cambiare la loro fetta di mondo. Con il tempo lo hanno seguito in migliaia (e ancora lo seguono, i più giovani senza averlo mai incontrato), aprendo le loro case a chi era per strada, accogliendo in famiglia chi una famiglia non l’aveva, instaurando con i “piccoli” una relazione di autentica reciprocità: è il concetto della “condivisione diretta”, ovvero non la solidarietà del “buono” verso il derelitto, ma la convivenza totale nella vita quotidiana, sotto lo stesso tetto, ricevendo l’uno dall’altro. È la visione capovolta su cui nasceranno le tante declinazioni della “Papa Giovanni XXIII” nel mondo, dall’Operazione Colomba (la forza di pace basata appunto sul concetto della presenza fisica nelle zone di conflitto, in mezzo alle popolazioni colpite, nei campi profughi, attualmente in Palestina, Ucraina e Colombia), alle Capanne di Betlemme (strutture di accoglienza, anzi di convivenza, con i senza tetto e senza nulla), alle numerose case-famiglia (un caleidoscopio di storie, dove giovani coppie di genitori aprono le loro vite agli “irrecuperabili” che nessuno vorrebbe, disabili gravissimi, bambini rifiutati, anziani soli, ragazzi piegati da alcol e droga, schiave della tratta strappate ai marciapiedi, stranieri, giovani madri salvate dall’aborto, detenuti con pena alternativa al carcere...) e tutti hanno un nuovo ruolo, chi è figlio, chi nonno, o zio, o fratello, in una vera famiglia che dura per sempre. Esperienze che l’ottica mondana direbbe “impossibili”, eppure la “Papa Giovanni XXIII” (anzi Xxiii, con il logo che stilizza una famiglia) oggi gestisce 652 strutture e progetti in 40 Paesi nel mondo, tra cui 247 case-famiglia, 13 comunità terapeutiche, 11 centri per carcerati, 15 cooperative sociali con 101 centri lavorativi e 51 centri educativi. Dietro il sorriso da buon prete di campagna, c’era in realtà l’energia inflessibile del sacerdote pronto a tutto per rimediare alle ingiustizie insopportabili: non si trattava di fare l’elemosina, ma di restituire ciò che il mondo aveva rubato a quelle vittime.
«L’uomo non è il suo errore», ripeteva don Benzi a chi aveva sbagliato, «tu non sei un ladro, sei un uomo che ha rubato», non un gioco di parole ma la prova che si può sempre risalire la china e tutti abbiamo una speranza. Altrimenti non ci sarebbe redenzione. «Ero spacciato, le sostanze stupefacenti le avevo prese tutte e avevo imparato bene a rimediare i soldi, tanti soldi. Ma ero deluso, decisi di farla finita... Quella notte a Capodanno ero seduto per terra in stazione contro il muro, quando è entrato quel cappottone nero col colbacco e lo spumante in mano», ci raccontò nel 2012 Oscar Baffoni, allora responsabile delle missioni in Asia per la “Papa Giovanni XXIII”: quella lontana notte disperata don Oreste lo aveva ascoltato e gli aveva fatto la consueta proposta, «vieni con me, vedrai che facciamo tutto nuovo».
Lo ha fatto con migliaia di “fratellini e sorelline”, come li chiamava lui, che incitava in romagnolo a rialzarsi, «dai, ci stai?». Convinto che i preti dovessero «strapazzarsi per le anime», dormiva tre ore per notte, come ricordano i volontari che hanno avuto la fortuna di accompagnarlo nelle sue “avventure” fino alla morte, arrivata improvvisa la notte del 2 novembre 2007, quando i Santi incontrano i Defunti. “Avventure” come le chiamava lui, in senso etimologico: «L’avventura è il Dio che viene. Adventus è qualcosa che viene e quindi non c’era. Mi piace andare incontro a ciò che viene e non restare fermo a ciò che c’era». E infatti fermo non stava mai, «io sono una dinamo – scherzava – se mi fermo mi spengo». Sulla lavagna dietro la sua scrivania c’erano scritti i suoi numeri di cellulare e un ordine: “Se mi chiamano avvertitemi a qualsiasi ora”, perché – raccomandava – chi mi ha cercato magari non troverà più il coraggio di farlo. Con questo spirito la notte si presentava davanti ai falò con mazzi di Rosari e benediceva le sorelle schiave che lo circondavano chiamandolo «father»: a migliaia hanno trovato il coraggio di comporre quel numero e salvarsi. La forza per una vita del genere la trovava nella preghiera («per stare in piedi bisogna imparare a stare in ginocchio»), sorretto da una fede che chiamava «il mio respiro».
Il suo fuoco incendiava o invece ustionava, affascinava o disturbava. «Lei è un santo, mica possiamo vivere come lei», si assolvevano in tv politici e giornalisti tra compassione e imbarazzo, e don Oreste, scarabocchio di Dio, allora perdeva la pazienza. Al suo funerale 18 anni fa a tenere alto il cartello “Santo subito”, ma con ben altro spirito, erano le ex prostitute che aveva liberato (e oggi la causa di beatificazione in corso si basa su 18mila pagine di documenti, rilegati in 56 volumi). Il Duomo di Rimini risultò troppo piccolo per i diecimila accorsi a salutarlo, si passò al Palacongressi, in prima fila le persone importanti (disabili, zingari, barboni, prostitute, immigrati, volontari), molto più indietro le autorità, com’è ovvio nel mondo capovolto. Un mese prima di morire don Oreste aveva lasciato la sua casa e si era trasferito alla Capanna di Betlemme, la struttura riminese per senzatetto, «eccomi, sono un barbone»: giù, e ancora più giù... Il sabato precedente, come faceva spesso, la notte era andato in discoteca, a parlare di Dio a 350 giovani. Al ritorno, sorridendo tra i suoi volontari, con Dio aveva patteggiato, «quando verrò su da Te dovrai farmi uno sconto: se non c’ero io quando te lo prendevi un applauso alle 3 di notte in una discoteca?».
Il programma degli eventi a Rimini
Tre giorni (e notti) per celebrare i 100 anni di don Oreste Benzi attraverso numerosi appuntamenti di preghiera, testimonianza, musica, sport e festa. È quanto organizzato a Rimini da Fondazione Don Oreste Benzi, dal Comune e dalla Diocesi di Rimini per ricordare lo sguardo rivoluzionario del sacerdote, che anche oggi genera una tensione innovatrice. Ieri sulla spiaggia libera il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato la “Messa sul Mare”, seguita fino a notte da eventi musicali e dalla voce dei “Testimoni di speranza”, giovani che oggi vivono la costruzione di un mondo più giusto sulle orme di don Oreste. Oggi, 6 settembre, in vari luoghi della città la mattina è dedicata a incontri sulla “Società del gratuito”, una delle intuizioni di don Oreste. Dalle 14.45 alle 17.30 al Teatro Galli l’evento clou del centenario, dal titolo “Come se tu fossi qui – don Oreste ha 100 anni ma non li dimostra”, kermesse di racconti e approfondimenti per mostrare quanto il pensiero di don Benzi sia ancora tra di noi. Alle 18 all’Arena Francesca da Rimini la Messa all’aperto presieduta dal vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi. Alle 21.15 il concerto alla Corte degli Agostiniani, con canti raccolti dall’esperienza missionaria della Papa Giovanni XXIII nel mondo. Domani, domenica 7 settembre, giorno natale di don Oreste, dalle 9,15 Festa per le famiglie ai Giardini della curia, mentre alle 9.30 in Sala Manzoni la postulatrice della causa di beatificazione, Elisabetta Casadei, presenta il suo libro La mistica della tonaca lisa, con il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, il vescovo emerito Francesco Lambiasi, i giornalisti Lucia Bellaspiga e Valerio Lessi, il responsabile di casa-famiglia Luca Russo. Alle 11 in Duomo la Messa presieduta dal vescovo Anselmi. Oltre a tutto ciò, gare sportive, mostre, attività: la mappa del programma completo su www.fondazionedonorestebenzi.org.

Don Oreste una vita per il riscattore della dignità del prossimo
ricorrenza nascita Don Benzi il 7 settembre
Marco Tassinari
Sorridente, sereno, sempre con la sua tonaca lisa e il rosario in tasca. Una vita interamente dedicata ai bimbi disabili e abbandonati, alle prostitute, ai tossicodipendenti, agli emarginati. Dieci anni fa, il 2 novembre 2007, moriva don Oreste Benzi. Per tutto il 2017 si sono susseguite in tutta Italia le iniziative in memoria del prete di strada riminese, ricordato da molti per la sua lunga tonaca nera, sempre lisa e consumata.
Gli “altri” nel cuore
Il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII era entrato a 12 anni in seminario a Rimini e venne ordinato sacerdote il 29 giugno 1949. Si impegnò da subito a favore dei giovani, a cui aveva iniziato a proporre Un incontro simpatico con Cristo: in centinaia da tutta Italia accorrevano ai suoi momenti di spiritualità.
In quegli anni maturò in don Oreste una fondamentale convinzione: «Nella pre-adolescenza si formano i valori che diventano pressoché definitivi; io vedevo che i ragazzi si incontravano con tanti disvalori e non si incontravano con l’unico valore: Cristo», ha raccontato in più occasioni.
Nel 1968 con un gruppetto di giovani e alcuni altri sacerdoti ha dato vita alla Comunità Papa Giovanni XXIII, pensata come comunità di fedeli riuniti dalla voglia di condividere la vita con gli ultimi. Nel 1972 guidò l’apertura della prima Casa Famiglia a Coriano, sulle colline riminesi; da allora l’Associazione di fedeli di diritto pontificio si è occupata di tutte le forme della marginalità sociale, sempre rimanendo fedele alla vocazione della condivisione diretta della vita con i poveri, e nella la lotta per la rimozione delle cause delle ingiustizie.
Un fiorire di opere
Negli anni sono fiorite comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri diurni per disabili, cooperative sociali, case per l’accoglienza dei senza fissa dimora, delle donne vittima di tratta.
Don Benzi ha sempre lottato contro l’aborto, pregando di fronte agli ospedali. Ha promosso missioni nei paesi poveri. Ha accompagnato i giovani nel servizio civile e i volontari per la pace nei paesi in guerra.
Negli ultimi anni lo si incontrava lungo le buie strade della prostituzione per chiedere alle donne che si prostituivano Do you love Jesus? Ami Gesù? Alle donne di strada proponeva sempre la liberazione immediata. Quella che ancora cercano i tanti poveri lungo le strade delle nostre città. Era sempre di corsa; per questo, alla fine della sua vita terrena, papa Benedetto XVI lo definì «infaticabile apostolo della carità».
La sua parola oggi è mantenuta vita nei commenti al Vangelo e alle letture del giorno che sono raccolti dal messalino di Pane Quotidiano: ogni giorno migliaia di persone rileggono don Oreste e il suo costante invito a vivere “come avrebbe fatto Gesù” la propria quotidianità.
Sin dal 2001 aveva cominciato ad occuparsene personalmente, scrivendo per ragioni di stampa le sue meditazioni con largo anticipo. Ma mai nessuno si sarebbe potuto aspettare quanto successe il giorno della sua salita al cielo. Grande fu lo stupore quando, il mattino di quel 2 novembre 2007, i suoi più stretti collaboratori, riuniti al suo capezzale, presero in mano il libretto di Pane Quotidiano e lessero il suo commento alla lettura del giorno. Ecco quello che vi era scritto: «Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra, la gente che sarà vicino dirà: è morto. In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio occhio non potrà più vedere, ma in realtà la morte non esiste, perché appena chiudo gli occhi a questa terra, mi apro all’infinito di Dio».
Contro la prostituzione
Don Benzi è stato il primo in Italia a lottare contro la cultura della prostituzione e a denunciare la tratta delle donne. È riuscito ad affrontare lo scabroso tema della prostituzione, senza moralismi, dal punto di vista delle vittime. Durante il Giubileo del 2000 andò da papa Wojtyla insieme ad una giovane prostituta nigeriana, Anna. «Papà – chiese la giovane a Giovanni Paolo II –, libera le ragazze come me: io mi sono ammalata di aids sulla strada. Lì la vita è schifosa, è brutta, è dura… Papà, sulla strada ci sono molte giovani, ma anche tante bambine. Papà, libera le bambine».
Quella foto fece il giro del mondo. Le sue parole commossero non solo l’anziano pontefice, ma tutta l’opinione pubblica. Anna morì pochi mesi dopo.
Don Benzi era riuscito a svelare l’orrore che si cela dietro i finti sorrisi delle donne costrette a prostituirsi. Durante la sua vita riuscì a liberare circa 6.000 donne vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale. Oggi il suo impegno per la liberazione delle vittime di tratta è raccolto dai volontari delle unità di strada che ogni settimana incontrano migliaia di donne in tutta Italia, e dalla campagna Questo è il mio corpo: sostiene le proposte di legge che intendono contrastare la prostituzione di strada agendo sul fronte della domanda e scoraggiando i clienti.

Testimonianze su Don Benzi
Il primo impatto
Il primo incontro ravvicinato con don Oreste avvenne il 13 marzo 1999 ad Anagni. Lo avevamo invitato a un Convegno che si teneva nel Seminario regionale, di cui ero stato rettore.
Il «Don» arrivò puntualmente… in ritardo e non sapeva che qualche giorno prima ero stato nominato vescovo. Appena glielo dissero, si buttò in ginocchio davanti alla tantissima gente venuta a sentirlo, e mi chiese la benedizione.
La sensazione a pelle fu quella di un prete divorato dalla carità, un uomo eccezionale per la sua umanità calda, avvolgente, un cristiano straordinario per la sua fede limpida e rocciosa.
Cosa «invidio» a don Oreste
A don Oreste invidio l’amore per Gesù. Questo è stato l’architrave della sua vita. Un amore «folle» che lo rendeva tenacemente attaccato alla preghiera, alla Messa che celebrava anche quando rientrava molto tardi da un pellegrinaggio. Si vedeva che nel fondo più profondo del cuore gli scorreva come un fiume carsico – il dialogo con Gesù – che di tanto in tanto affiorava in superficie. Si sentiva che era un uomo «carico» di Dio.
Come ha cambiato il mio essere prete…
Ha esercitato su di me un influsso considerevole, perché mi ha reso più sensibile alla «spina» dei poveri e più attento nel coltivare la relazione con il Signore, una relazione preziosissima e fragilissima. Se dovessi indicarlo tra i miei modelli ideali di prete, sarebbe certamente tra i primi tre, perché era un prete-prete, totalmente consegnato in una «resa» incondizionata alla chiamata, senza programmi riservati, senza sogni e progetti personali.
…e il mio essere cristiano
Ho visto in don Oreste l’identificazione tra l’essere «cristiano» e l’essere «prete». Ciò che per lui era fondamentale era l’essere un discepolo innamorato del suo dolce Gesù e della sua Chiesa. Provava forte il senso del battesimo, che non sentiva come un fattore decorativo, marginale, ma come un elemento centrale, fondante e portante.
Tante volte dico ai nostri seminaristi e anche ai nostri preti: «Il difficile – e il bello! – non è tanto l’essere prete, ma l’essere cristiano». Anche per me questo titolo di «eccellenza» mi appare davvero extra-large. La vera eccellenza è quella comune a tutti, quella del battesimo. Non ce n’è un’altra particolare.
Mi ha reso più «padre»
Ho sempre visto in lui un prete appagato, stracontento. Un prete felice come avviene quando il sentimento di paternità e di fraternità è vero, forte.
La ricetta che dava contro la tristezza era sempre quella di pensare agli altri e ai loro problemi, cioè di «decentrarsi», di «farsi abitare» dagli altri. Detto sinceramente: ogni volta che mi viene da pensare a lui e mi specchio nella sua santità, mi vedo molto distante dal suo modello. Però, colgo la bellezza e il fascino del suo stile di vita. Vorrei che nessuno mi leggesse in faccia una preoccupazione, magari assillante, che scivoli nella tristezza. La sofferenza sì, la si comprende nel prete, come pure la tensione o la stanchezza. La tristezza no, mai.
Don Oreste era capace anche di arrabbiarsi quando vedeva le molte ingiustizie nei confronti dei poveri, ma lo faceva in modo evangelico, come Gesù. In me invece riscontro tutt’altro: la mia collera è lo sfogo del mio orgoglio colpito e l’effetto di qualche ferita che mi brucia dentro.
… e mi ha aiutato a sentirmi «figlio» della Chiesa riminese
Avrei desiderato essere figlio spirituale di un prete come don Oreste. Di fatto lui mi ha aiutato a sentirmi «figlio» e «fratello» di questa bella Chiesa riminese. Quando ha saputo della mia nomina a vescovo di Rimini, mi ha telefonato e le parole che mi ha detto, quasi un patto reciproco, sono state: «Venga! Non abbia paura! Io l’aiuterò». Parole che poi – appena quaranta giorni dopo – mi hanno causato un’amarezza violenta quando quella mattina presto del 2 novembre 2007 mi sono trovato di fronte alla sua salma. Ma subito ho avvertito una grande pace che mi veniva da una sicurezza invincibile: che lui era e continua ad essere in grado di mantenere la promessa. In tanti passaggi della vita mi viene non solo da pensarlo vicino, ma da parlargli e dirgli: «Don Oreste, adesso mi devi aiutare, ma voglio vedere come te la cavi».
Dal Colloquio con la Postulazione,
30 settembre 2016
(tratto da Don Oreste Benzi fratello di tutti)
Mons. Santo Marcianò
Ordinario militare per l’Italia (2013) e già vescovo di Rossano-Cariati (2006-2013)
Un giovane che parlava ai giovani! È la prima immagine che ho di don Oreste Benzi e penso sia un’immagine che lo dipinge abbastanza fedelmente. L’ho infatti conosciuto quando, da rettore del Seminario e direttore dell’Ufficio diocesano vocazioni, l’avevo invitato a Reggio Calabria per una giornata diocesana dei giovani, per offrire loro, assieme alle riflessioni e alla festa, la testimonianza forte di una vita dedicata all’evangelizzazione e al servizio degli ultimi, dei poveri, dei piccoli.
Fu una testimonianza luminosa e illuminante, centrata particolarmente sul suo lavoro di recupero delle donne in strada, la cui sorte inquietava la vita, i giorni e le notti di don Oreste.
«Dormiresti tranquillo se fosse tua sorella?». Il suo grido dal palcoscenico, dinanzi a una piazza gremita di adolescenti e giovani, aveva squarciato il buio di quella sera e le luci di quella festa. Soprattutto, aveva scosso il cuore dei ragazzi – e non solo -, offrendo un lampo di quella che si è sempre più confermata la cifra della santità di don Benzi: credere con forza che, con l’aiuto di Dio, non esiste nulla di irrecuperabile, di impossibile, di troppo rischioso. E che, se qualche rischio ci fosse – e di rischi penso lui ne abbia corsi davvero tanti… – vale sempre la pena di rischiare: per salvare una sorella o un fratello, per dare una famiglia a un bambino abbandonato e solo, per non perdere l’occasione di dimostrare a Dio, con il coraggio e la fantasia della carità, la misura della propria fede e speranza.
La strada, le periferie, gli scartati… le parole con cui papa Francesco ci mette in discussione oggi sono stati i gesti con cui don Oreste ci ha messo in discussione ieri. Gesti fecondi, che rimangono nella straordinaria esperienza della Comunità Giovanni XXIII: nell’amore «più grande» di quelle persone, soprattutto dì quelle famiglie, che aprono le porte, il cuore e la vita alle vite più rifiutate, quelle che nessuno vuole, vivendo di sobrietà gioiosa, di comunione e preghiera, e facendosi carico di tante sofferenze umane, nella semplicità nascosta del quotidiano.
Un carisma stupendo, quello della «Papa Giovanni», che, già da vescovo di Rossano-Cariati, avevo accolto con gioia come ricchezza per la diocesi e ancora oggi continuo a condividere, accompagnando il cammino di tanti amici e fratelli.
Un carisma stupendo, quello di don Oreste Benzi, in grado di raggiungere tutti e provocare, oggi come ieri, una rivoluzione d’amore, l’unica risposta evangelica alla cultura della morte e alla globalizzazione dell’indifferenza.
Per innescare questa rivoluzione, Dio ha chiamato un rivoluzionario: un uomo dal passo da gigante, dal cuore immenso, dalla voce imponente… Un giovane che parlava ai giovani ma che è sempre staro, e sempre è rimasto, un bambino entusiasta, trasparente, temerario: un bambino fiducioso e gioioso tra le braccia di Dio.
† Santo Marciano Arcivescovo Ordinario militare per l’Italia
Lettera alla Postulazione,
11 marzo 2017
(tratto da Don Oreste Benzi fratello di tutti)
Mons. Vincenzo Paglia
Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e presidente della Federazione Biblica Cattolica internazionale. Già presidente del pontificio Consiglio per la Famiglia (2012-2016) e vescovo di Temi (2000-2013)
Ho conosciuto don Oreste in un convegno degli operatori della carità promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. La sua figura si imponeva per la semplicità per un verso, che andava dalla sua «famosa» tonaca lisa, alla passione più radicale per mettere al centro della Chiesa i poveri. Questo contrasto, o meglio questo legame, tra la semplicità nel presentarsi e il fuoco che sprigionava, colpiva chiunque lo incontrasse.
Il ricordo che ho di lui è quello di una figura che mostrava la forza e la bellezza della Chiesa del Concilio Vaticano II: in qualche modo lui esprimeva visivamente e operativamente, fuori di tanti orpelli, il cuore della misericordia. Con la sua persona don Benzi mostrava quell’incipit del Concilio (e quindi Giovanni XXIII), che mostrava una Chiesa che aveva scelto la medicina della misericordia come dimensione primaria della Chiesa. In questo senso, don Oreste era davvero un prete conciliare e trova un’assonanza straordinaria con papa Francesco, il quale continua quel «filo rosso» iniziato con papa Giovanni XXIII e che ha attraversato tanti testimoni, tra cui certamente don Oreste Benzi.
Ricordo che una delle cose più belle che ci dicemmo era la sua passione per la testimonianza. Mi diceva che la carità va vissuta prima che detta; va testimoniata, perché arrivi fino al cuore. E non è che gli mancassero le parole per dirla o per proporla sul piano pubblico. Mi diceva: «Noi la carità dobbiamo farla vedere: dobbiamo prenderci i bambini, dobbiamo andare dove stanno le ragazze sfruttate».
Una sottolineatura che più mi colpì era quella della comunità come la medicina più bella per guarire tutto; in particolare, la famiglia, intesa in maniera ampia, che poi era il senso della Chiesa come famiglia che accoglie. Questa fu una delle conversazioni che facemmo e che ci fece «scattare una simpatia».
Sono totalmente favorevole al fatto che si sia aperta la Causa di beatificazione, perché don Oreste nella sua figura raccoglie quella dimensione plurale dell’amore di cui oggi abbiamo estremo bisogno. Che figure come la sua possono essere mostrate anche ufficialmente, credo sia particolarmente necessario, perché c’è un quid, una dimensione di universalità dell’amore, che don Benzi mostra con la sua vita semplice e nello stesso tempo universale.
Un processo di beatificazione non è teso ad allontanare don Benzi da noi per metterlo più in alto, ma a far scendere il suo seme, a seminare la sua testimonianza il più largamente possibile.
Dall’Intervista rilasciata alla Postulazione,
5 gennaio 2017
Monsignor Cesare Nosiglia.. vescovo dei lavoratori
“Un pastore mite e saggio, sempre fedele al popolo e sollecito verso le persone più fragili".
Papa Leone XIV

Vescovo Cesare Nosiglia "vicino ai poveri senza timore, esempio di Chiesa che si espone"
morte 27 agosto 2025
"Chi ha conosciuto il vescovo Cesare sa che c'è molto di lui in queste semplici parole evangeliche. L'arcivescovo Cesare non tollerava i vuoti. La sua agenda non poteva prevedere delle pagine bianche. Riempiva i giorni, riempiva le ore, riempiva i minuti. Era sempre in movimento, sentiva l'urgenza dell'azione pastorale, sentiva l'impellenza del servizio del prete e del pastore. Ma dietro questa urgenza, dietro questa impellenza c'era l'attesa dell'ulteriorità e dell'altrove del Volto lucente di Cristo. Anche se forse non sempre appariva in modo netto, immediato, perché - lo sappiamo tutti, chi lo ha conosciuto lo sa - il suo carattere era schivo, riservato". Questo ha detto nella omelia delle esequie del' arcivescovo emerito di Torino Cesare Nosiglia, il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa.
Tra le riflessioni anche una dedicata all'incontro con i fragili: "Mi colpiva la spontaneità che monsignor Nosiglia aveva quando incontrava delle persone fragili. Una spontaneità, francamente, che forse non gli era così immediata in altre circostanze. Mi sono chiesto tante volte perché era così. Forse perché i più fragili, i più poveri sono senza difese. E quando tu li incontri sul serio, scopri che anche tu sei fragile e senza difese, non devi mascherarti, puoi essere quello che sei. Lo ha intuito sin dall'inizio del suo ministero, che ha posto all'insegna di un motto che richiama la Lettera ai Corinzi, che abbiamo sentito, «Caritas congaudet veritati»".
Una vita per la Chiesa
Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana dal 2010 al 2015, segretario della Commissione episcopale per l’educazione cattolica (1995-2000) di cui, dal 2000 al 2005 fu presidente”. Nel messaggio della Conferenza episcopale a firma del cardinale presidente Matteo Zuppi e del segretario generale monsignor Giuseppe Baturi, l’arcivescovo Nosiglia viene descritto come uomo di grande spiritualità, che “ha servito la Chiesa in Italia leggendo i segni dei tempi, ponendosi in ascolto delle istanze che andavano emergendo negli anni, con uno sguardo attento ai disoccupati e alle popolazioni Sinti e Rom. Impegnato in modo particolare nel settore della catechesi sin dagli anni Settanta, è stato tra i promotori del Documento di base “Il Rinnovamento della Catechesi” (1970) favorendo, successivamente, il progetto dei Catechismi della Chiesa italiana. Un impegno culminato con la direzione dell’Ufficio Catechistico nazionale dal 1986 al 1991, di cui già era vicedirettore. Di grande spessore anche il suo apporto alla Chiesa di Roma che ha servito in qualità di ausiliare e vicegerente, acuto collaboratore del cardinale Camillo Ruini".
Uomo di profonda fede
Abbiamo avuto testimonianza della sua profonda fede in occasione delle Ostensioni della Sacra Sindone, specialmente in quella del Sabato Santo 2020 (11 aprile) in piena pandemia da Covid. Le sue parole: 'La Sindone oltre che specchio del Vangelo ci offre non solo il corpo martoriato di Gesù nei segni della sua passione ricordati dai Vangeli ma è anche icona di questo giorno che prelude alla Pasqua di Risurrezione'. Di questo, la sua vita è stata testimonianza fino alla fine
La celebrazione dei funerali in una cattedrale di Torino gremita ha visto la partecipazione dei Vescovi – molti anche gli emeriti – del Piemonte. Presieduta dal Cardinale Repole e concelebrata con il card. Giuseppe Betori, mons. Vincenzo Paglia, e il vescovo di Vicenza mons. Giuliano Brugnotto, attuale vescovo di Vicenza Sempre da Vicenza presenti mons. Beniamino Pizziol, vescovo emerito di Vicenza, successore di mons. Nosiglia, mons. Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia, ordinato vescovo da Nosiglia, originario del vicentino che è tornato a vivere in diocesi, mons. Lodovico Furian, vicario generale di Nosiglia dal 2007 al 2010, e mons. Massimo Pozzer, segretario di Nosiglia a Vicenza.
Tra i tanti sacerdoti e diaconi torinesi e segusini anche il rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice, don Michele Viviano, e il padre Generale della Piccola Casa don Carmine Arice.
Il cardinale Repole ha ricordato i tanti messaggi di affetto e cordoglio giunti tra cui quello di Papa Leone XIV che lo ha definito “pastore mite e saggio, sempre fedele al popolo e sollecito verso le persone più fragili”. Altri messaggi dai cardinali Zuppi presidente della Cei con il segretario mons. Baturi, Marengo, Antonelli, Battaglia, Reina, Ruini. Cordoglio anche delle altre confessioni cristiane, della comunità islamica ed ebraica torinesi.
Santa Teresa di Calcutta...il coraggio di Amare senza limiti
L’intera vita e l’opera di Madre Teresa offrirono testimonianza della gioia di amare, della grandezza e della dignità di ogni essere umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente e con amore, e dell’incomparabile valore dell’amicizia con Dio. Ma vi fu un altro aspetto eroico di questa grande donna di cui si venne a conoscenza solo dopo la sua morte. Nascosta agli occhi di tutti, nascosta persino a coloro che le stettero più vicino, la sua vita interiore fu contrassegnata dall’esperienza di una profonda, dolorosa e permanente sensazione di essere separata da Dio, addirittura rifiutata da Lui, assieme a un crescente desiderio di Lui. Chiamò la sua prova interiore: “l’oscurità”. La “dolorosa notte” della sua anima, che ebbe inizio intorno al periodo in cui aveva cominciato il suo apostolato con i poveri e perdurò tutta la vita, condusse Madre Teresa a un’unione ancora più profonda con Dio. Attraverso l’oscurità partecipò misticamente alla sete di Gesù, al suo desiderio, doloroso e ardente, di amore, e condivise la desolazione interiore dei poveri.
Santa Teresa di Calcutta

Madre Teresa di Calcutta. Il coraggio e la profezia della fragilità universale che apre il cuore dell’infinito amore di Dio
Matteo Liut
ricorrenza nascita 26 agosto e morte 5 settembre
La nostra unica vera forza è la nostra fragilità, perché è attraverso le crepe della nostra finitudine che possiamo intuire l’enormità della vita che circonda e coglierla in tutti coloro che ci stanno vicino, a partire dagli ultimi, i sofferenti, gli emarginati. E fu proprio il coraggio di fare della prorpia fragilità un messaggio universale a rendere Madre Teresa di Calcutta un’icona agli occhi di tutto il mondo, una testimone di un’umanità capace delle più grandi cose accanto ai piccoli. Dietro a quella “piccola donna”, infatti, si nascondeva la forza dirompente dell’amore di Dio di Gesù Cristo, che ha scelto di condividere in tutto e per tutto, tranne il peccato, la nostra esperienza esistenziale con tutti i suoi limiti. Agnes Gonxha Bojaxiu era nata in Macedonia nel 1910 ed era entrata nella Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora di Loreto. A 19 anni si trovò in India dove emise i voti e cominciò a dedicarsi all’insegnamento. Nel 1946, mentre si trovava in treno, ebbe la sua “seconda chiamata”: avrebbe dovuto dare vita a una nuova congregazione che si dedicasse agli ultimi tra gli ultimi. Fu così che quella fragile donna portò tra le vie di Calcutta, con l’aiuto delle sue Missionarie della Carità, l’amore di Dio e la forza del Vangelo. Madre Teresa morì il 5 settembre 1997 ed è santa dal 2016.
Alcide De Gasperi..."raggiungere la giustizia sociale"

De Gasperi ( ricorrenza morte 19 agosto): il suo coraggio e la sua pazienza riportati alla luce dal Presidente di Mattarella
Domenico Rosati
Dunque, l’Italia è stata una Repubblica presidenziale, sia pure solo per due settimane; e il primo Capo provvisorio dello stato non è stato Enrico De Nicola ma Alcide De Gasperi. Il quale, peraltro, non ha fatto nulla per essere ricordato in tale veste nei libri di storia, ben altri e di più ampio respiro essendo i suoi meriti davanti al paese. E tuttavia non è privo di interesse il fatto che il richiamo ad un passaggio quasi del tutto oscurato della nostra vicenda politica sia stato riportato alla luce dal Presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella, e che ciò sia avvenuto in occasione della lectio svolta a Pieve Tesino, luogo natale dello statista democristiano.
Due fronti attuali
Perché la scelta di ingrandire questo fotogramma? Sarebbe già un merito se l’intenzione fosse quella di uscire dalla rete dei luoghi comuni di una letteratura degasperiana registrata sul modulo (andreottiano) del garante della continuità dello stato dopo la disgregazione del fascismo e sull’impianto (fanfaniano) del “ricostruttore” che favorisce l’avvento del vero “riformatore”.
Un discorso commemorativo è difficile da scrivere e da interpretare, perché deve contemperare il tema storico con le urgenze dell’attualità. D’altra parte, è opinione comune che «la storia è sempre contemporanea» e non è arbitrario ricercare nel testo quel che, oltre la cronaca, l’autore ha voluto comunicare.
Il tributo all’attualità politica è stato sobrio, con due riferimenti: l’Europa e le frontiere in rapporto alle migrazioni. Sul primo punto Mattarella ha scelto di marcare il carattere volontaristico delle scelte compiute nella costruzione dell’Unione. Che è frutto – ha detto – «non di banche e transazioni economiche» ma dell’azione «di uomini politici e di parlamenti lungimiranti». Per cui, «soltanto la nostra miopia nel riconoscere il bene comune» potrà distruggere l’edificio.
L’altro spunto è stato svolto con il riferimento all’accordo De Gasperi-Gruber che, nel 1946, consentì a Italia e Austria di regolare in modo stabile e lungimirante la condizione delle minoranze di lingua tedesca nella regione di confine, costituendo un modello valido per tante situazioni consimili. Era un riferimento d’obbligo dato che l’incontro si svolgeva in Trentino, ma non era obbligatoria la sottolineatura del significato della “sdrammatizzazione” della frontiera del Brennero, in un momento in cui la pressione migratoria offre esca ai cattivi pensieri di ripristino.
Le due virtù del politico
Della figura di De Gasperi, il proprium dell’intervento Mattarella ha messo a fuoco essenzialmente due caratteristiche, presentate come requisiti importanti dell’agire politico: il coraggio e la pazienza.
De Gasperi dette prova di coraggio quando, dopo il referendum del 1946, che aveva scelto la Repubblica, dovette fronteggiare, da Presidente del Consiglio, le contorsioni dell’establishment monarchico e dello stesso monarca Umberto II che contestavano, in sostanza, la validità del voto e miravano a riaprire la partita. E qui Mattarella riporta la testimonianza del ministro Bracci che assistette al colloquio decisivo tra il re e il presidente: «È quasi commovente – così si espresse – quest’uomo mite, che non ha origini repubblicane e che, da galantuomo, affronta deciso e sereno la lotta contro la corona per obbedire al popolo».
In quella circostanza de Gasperi aveva dalla sua soltanto l’esito del voto popolare stentatamente convalidato dalla Corte di Cassazione. Molti speravano (o temevano) che si sarebbe avventurato in un problematico tentativo di mediazione. Invece non ebbe esitazioni; e lo fece perché convinto che – come spiegò più tardi – «solo il popolo è l’artefice del proprio destino». Il popolo, non una dinastia fondata su un presunto diritto divino.
E questo coraggio lo confermò nella decisione, che fece adottare al Consiglio dei ministri, con cui detronizzò il re assumendo, come la legge gli consentiva, i poteri di Capo dello stato. Poteri che mantenne fino all’elezione di De Nicola, avvenuta a fine giugno. E che utilizzò, tra l’altro, per dichiarare estinto il Senato (di nomina regia) e per approvare la grande amnistia di pacificazione predisposta dal guardasigilli Togliatti.
Una storia di determinazione politica degna di figurare tra gli esempi contenuti ne I profili del coraggio di J.F. Kennedy. Una storia che sarebbe stata confermata nel 1953, dopo il mancato scatto della «legge truffa» quando – come è stato recentemente ricordato da Luigi Berlinguer – De Gasperi rifiutò il riconteggio dei voti accettando la sconfitta politica al di là di ogni certificazione numerica.
Il tema della pazienza è abbordato sempre in connessione con il trapasso dalla monarchia alla repubblica, anche qui sulla base di una testimonianza di un democristiano che chiede di affrettare i tempi e si sente rispondere che occorre evitare che… il treno si ribalti. De Gasperi non amava “i gesti gladiatori” anche se – come si è visto – sapeva decidere. Dire che «la principale virtù della democrazia è la pazienza» non era un elogio dell’inerzia o un esercizio di controllo degli impulsi, e neppure un tener conto delle «lentezze dell’uomo». Era semplicemente un «esercizio della speranza».
Il concetto è convalidato dalla bella citazione di un discorso del 1948: «Non abbiamo il diritto di disperare dell’uomo, né come individuo né come collettività; non abbiamo il diritto di disperare della storia». È il testo in cui respinge la tentazione di perseguire la giustizia sociale indipendentemente dalla libertà politica e dai tempi che essa richiede. Dove l’invito alla pazienza pare rivolto alle forze della sinistra; ma, simmetricamente, si dovrebbe ricordare che De Gasperi, sempre in nome della «pazienza democratica», si oppose all’idea di mettere fuori legge il Partito Comunista come pure gli era richiesto da diverse sponde. Nella sua visione tripolare (Mattarella la chiama “trialistica”) egli contrastava decisamente le spinte antisistema, ma non accettava di farlo al di fuori del contesto di democrazia che gli era caro.
Per quale disegno?
Elogio del coraggio, dunque, ed elogio della pazienza. A servizio di quale disegno? Anche qui Mattarella offre una citazione preziosa. Riguarda il programma dell’Assemblea Costituente ed è importante evocarla perché a De Gasperi si è spesso imputato di aver trascurato la preparazione della Carta. Dice De Gasperi che l’Assemblea «creerà nella Costituzione una repubblica di tutti, che si difende ma non perseguita, sarà equilibrata nei suoi poteri, fondata sul lavoro ma giusta verso tutte le classi sociali, riformatrice ma non sopraffattrice, rispettosa delle libertà delle persone, dei Comuni, delle Regioni». Soprattutto quel «fondata sul lavoro» merita attenzione. Fino ad ora ci si era accapigliati sulla paternità della formula dell’art. 1: se la Repubblica democratica fondata sul lavoro fosse un’idea di Fanfani o delle sinistre costituenti. Ora sappiamo che l’ispirazione veniva dal Capo dello stato, Alcide De Gasperi, nel primo e probabilmente ultimo discorso pronunciato in tale veste.
Chiosa finale. Mattarella giustamente ricorda che i governi di De Gasperi dal 1945al 1953 realizzarono importanti riforme e altre ne misero in cantiere. È esatto ma non basta. Occorrerebbe aggiungere, guardando a quel che è accaduto dopo, che la stagione degasperiana è stata la più ricca di interventi riformatori dell’intero settantennio repubblicano. Ma questo è l’argomento di un’altra narrazione.

De Gasperi: quando la fede dà forma alla politica
Cardinale Gualtiero Bassetti
Carissimi amici e amiche,
al di là di ogni retorica, sono veramente poche le occasioni in cui si riesce a coniugare «storia e futuro» in un unico evento. In questo convegno, invece, come avete ben sottolineato nel titolo, si fa giustamente riferimento a un passato e ad un futuro del Paese che possono essere riuniti simbolicamente «nei valori degasperiani». Alcide De Gasperi, infatti, non è stato soltanto un «politico di professione» che ha governato il Paese circa 70 anni fa, ma ha rappresentato una delle espressioni più alte di un popolo e di un gruppo dirigente – cristiano, democratico ed italiano – che ha ricostruito l’Italia dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale e ha tracciato la strada maestra per gli anni futuri, addirittura fino ai giorni nostri.
Per chi, come il sottoscritto, è cresciuto nella Firenze di La Pira e si è abbeverato dell’umanesimo fiorentino, formandosi in quell’eccezionale impasto di spiritualità e socialità – il pane e la grazia – che per decenni la città dei Medici è stata testimone nel mondo, parlare oggi di Alcide De Gasperi assume un significato molto importante. Penso, infatti, che le diverse sensibilità spirituali, culturali e politiche che hanno caratterizzato il mondo cattolico in questi 70 anni di storia repubblicana, necessitino di essere lette sotto una nuova luce e con un nuovo angolo visuale. Le differenti vedute che animarono il dibattito tra i «professorini» della DC, la leadership politica degasperiana e quella ecclesiastica montiniana, così come le differenti prospettive politiche dei cattolici durante la Seconda repubblica, esigono oggi un autorevole approfondimento culturale e soprattutto una nuova riflessione pubblica.
Ed in questa dinamica di approfondimento culturale e di riflessione pubblica, sono assolutamente convinto che la figura di De Gasperi occupi un posto rilevantissimo. Un posto di rilievo su cui è ancora opportuno riflettere. Non solo dal punto di vista storico – ambito nel quale è stato prodotto molto nell’ultimo decennio, anche per merito della Fondazione De Gasperi – ma soprattutto in un’ottica di piena consapevolezza pubblica della sua figura. Una figura che, infatti, si caratterizza per essere, ancora oggi, un modello esemplare di impegno sociale sia per il credente impegnato in politica, che per ogni persona di buona volontà che abbia veramente a cuore il bene comune del Paese.
A mio avviso, De Gasperi è stato indubbiamente un vero italiano, un autentico cristiano e uno straordinario statista, tra i più importanti – se non il più importante – dell’Italia unita. Queste tre dimensioni, tutte fortemente intrecciate tra loro, hanno però un’unica sorgente: la cifra spirituale e culturale della sua caratura umana.
La spiritualità
La dimensione spirituale rappresenta infatti il punto di partenza, doveroso, per ogni riflessione sulla sua personalità. Come ha giustamente sottolineato giustamente Maria Romana De Gasperi, la spiritualità e la politica non furono due aspetti divergenti ma, all’opposto, «due angoli visuali diversi e complementari» che delineavano la sua complessa e ricchissima figura. La ricerca di Dio, l’anelito verso il trascendente, le domande ultime sul senso della vita, così come l’amore verso Francesca – testimoniato in moltissimi documenti – fanno parte di un’unica cornice umana, da cui non si può scindere la teoria e la prassi, l’assunzione di responsabilità verso il Paese e la faticosa esperienza di governo. Come infatti ha scritto l’ex direttore de L’Osservatore romano Giuseppe Dalla Torre nelle sue memorie, De Gasperi visse in una sorta «di doppia solitudine»: quella «di lui, cattolico che si elevava verso quel Dio al quale chiedeva tranquillità e abbandono», e quella «di lui, politico» che si prodigava nel perseguire «fin che era possibile, la giustizia e la carità tra gli uomini». La fede era dunque riposta in Dio, la politica era invece una missione laica. L’una ispirava l’altra con passione, inquietudine e soprattutto senza compromessi.
Tra le tante testimonianze di fede che si possono rintracciare nella vita pubblica e privata di De Gasperi vorrei mettere in evidenza alcuni stupendi documenti che risalgono a due momenti molto diversi della sua vita: il primo momento, quello più duro, tra il 1927 e il 1928 quando fu una vittima innocente della persecuzione del regime fascista che lo condusse addirittura nel carcere di Regina Coeli; il secondo momento, dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando si trovò a guidare l’Italia nel momento più duro per il Paese: quella della ricostruzione dopo la sconfitta e la devastazione della guerra.
Nel 1927, quando ormai il fascismo è diventato un regime dittatoriale che ha compresso ogni libertà, De Gasperi redige una lettera all’amico trentino Giovanni Ciccolini in cui scrive:
No, non sono un martire, ma forse posso concederti d’essere un confessore delle nostre idee. (…) Non chiudo nel petto un animo d’eroe né mi illumina la luce interiore di un santo; tuttavia lodato sia il Signore il quale mi fa comprendere come fosse giusto che nella disgrazia di tutti, io che ero nei primi posti, per un equo compenso, debba ora trascinarmi sulla via più lacero e più malconcio degli altri. Non c’è nessun merito ad essere i primi, quando si marcia sotto un sole trionfante. C’è forse qualche merito nel trascinarsi avanti nel fango della via, dopo la rotta.
Si intravedono in queste parole il dolore dell’uomo, l’umiltà del peccatore e la sapienza di Giobbe. Una miscela di sentimenti e di riflessioni che trovano una chiave di volta solo nella lode di Dio. Sembra quasi di sentire il salmista quando canta “il Signore è il mio pastore (…) Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome”. De Gasperi si trova a vivere nella dolorosa e umiliante condizione di chi, non solo ha perso la battaglia politica, ma ha anche perso la libertà, le amicizie e gli affetti. Nonostante tutto, però, continua ad affidarsi al Signore e cerca ancora di rintracciare dei segni di speranza lungo questa strada segnata dalla sconfitta.
Non casualmente in un’altra lettera, scritta sempre nel 1927 all’amico Ciccolini, si chiede: «Quando sarà? Nel libro della Provvidenza è forse tutta scritta la pagina della nostra generazione?». È una «dura fatica» per De Gasperi accettare l’esito funesto dell’umiliazione politica, ma ha ancora la forza di affermare con vigore che, nonostante i tanti tradimenti umani, le violenze subite e l’ipocrisia dilagante «il cristianesimo applicato alla vita pubblica vuol dire lealtà, franchezza, coraggio, sacrificio». È evidente, in queste due lettere all’amico Ciccolini, il combattimento interiore dell’uomo De Gasperi che, drammaticamente, non può sapere che la strada della persecuzione e della sua marginalizzazione umana e politica è ancora molto lunga.
Nell’agosto del 1927, inoltre, mentre si trova alla clinica Ciancarelli di Roma, scrive alla moglie Francesca una delle lettere più note e più citate del suo epistolario. In quella missiva chiarisce stupendamente la sua visione della politica – una «missione» e non un’effimera ricerca del potere – e soprattutto la sorgente spirituale di questa «missione» da cui tutto discende e prende forma. Scrive De Gasperi:
Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come dilettanti, ed altri che la considerano, e tale è per loro, come un accessorio di secondarissima importanza. Ma per me, fin da ragazzo è stata la mia missione. (…) Rimanendo fedele alla mia stella, dovevo percorrere quella fino in fondo. Vi sono gli uomini di preda, gli uomini del piacere, gli uomini di buona fede. Anche tu, vero, mi vuoi bene, perché sono fra questi ultimi. E allora Dio mi abbandonerà? Addio miei cari, dormite in pace nelle case romite. Io sono presente!
Parole magnifiche ed eloquenti che riprenderò alla fine del mio intervento. Mi permetto di soffermarmi, adesso, su quella domanda che si pone De Gasperi: «Dio mi abbandonerà?». La politica è senza dubbio il campo della sua missione, ma la stella da cui tutto discende non si trova su questo mondo. La risposta a questo interrogativo impellente, la troviamo in una successiva lettera alla moglie, del 18 giugno 1928, in cui si può apprezzare pienamente la sua dimensione spirituale. In uno dei momenti più duri della sua esistenza, quando la rabbia e l’orgoglio avrebbero potuto prendere il sopravvento su ogni altra espressione dell’animo umano, si assiste invece ad un’ancora più intima e profonda conversione del cuore. Scrive De Gasperi:
Dapprincipio il centro ero io e tutto il resto si trovava sulla circonferenza: Dio, la famiglia, gli amici. Poi, lentamente, faticosamente, gemendo e sospirando sotto la pressura dell’esperienza, il centro si spostò: al centro stava ora Dio ed io mi trovavo sulla periferia, col resto del mondo; un pulviscolo in un vortice inesplorabile. Mi provai allora a spiegare gli avvenimenti dal Suo punto di vista.
Queste stupende parole di De Gasperi, in cui sembrano riecheggiare persino dei termini straordinariamente in sintonia con il pontificato di Francesco, sono il compimento di un autentico cammino di conversione. Non l’odio, non il rancore e non la vendetta trovano spazio nel cuore di una persona che – è bene ricordarlo – aveva pagato la sua libertà di pensiero con la galera e l’emarginazione: ma la centralità di Dio nella sua vita.
De Gasperi con queste parole testimonia quello che significa la libertà per un cristiano. Egli è infatti autenticamente una persona libera. Così libera che pur essendo incarcerato, perseguitato e ridotto ad una nullità politica da un regime violento e illiberale, non solo rimane fedele alle sue idee, ma riesce addirittura a riscoprire la fede in una dimensione ancor più matura e intima.
«Al centro stava ora Dio – scrive De Gasperi – ed io mi trovavo sulla periferia» come «un pulviscolo in un vortice inesplorabile». Parole magnifiche che assumono un significato profondo per la difficilissima situazione di vita in cui si trova: sconfitto, umiliato e isolato, si trova a camminare lungo un sentiero strettissimo e scosceso. Eppure riesce a vincere la paura e la solitudine umana riscoprendo quella fede che gli fornisce una spiegazione alle sue sofferenze e agli avvenimenti drammatici che sta vivendo.
Questa intima dimensione spirituale che lo accompagna da sempre ma che riscopre durante le persecuzioni della dittatura fascista non lo abbandonerà più. Sarà una costante della sua vita, che tornerà ad essere presente e visibile anche nei momenti pubblici più importanti. Pur senza farsene vanto e senza venature ipocrite, De Gasperi testimonierà la sua fede senza tentennamenti e con grande umiltà.
Per esempio nel discorso che tenne al I Congresso del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana nel 1945. In quell’occasione, dopo aver condannato i metodi «della forza» e «dell’intrigo» che da sempre inquinavano la vita politica, disse:
Quel poco di intelligenza che ho la metto al servizio della verità la quale si trova sepolta molte volte sotto strati difficilmente penetrabili, ma esiste. Io mi sento un cercatore, un uomo che va a scovare e cercare filoni della verità della quale abbiamo bisogno come dell’acqua sorgente e viva delle fonti. Non voglio essere altro.
«Io mi sento un cercatore (…) al servizio della verità (…). Non voglio essere altro». Parole che certificano una caratura morale di indiscutibile livello e che esprimono, ancora una volta, il senso profondo della sua «missione»: essere al servizio del Paese senza chiedere nulla per se stesso. A questo proposito, è doveroso citare una delle più efficaci sintesi della personalità di De Gasperi, scritta da un osservatore d’eccezione: don Luigi Sturzo. All’indomani dello storico viaggio negli Stati Uniti nel 1947, il prete di Caltagirone tratteggia una sintetica ma efficace descrizione del politico di Pieve Tesino. Scrive Sturzo:
Persona diritta, integra, senza posa, condotta rettilinea, bontà, austera complessità umana; egli, in momenti di smarrimento e di ansia, ha rappresentato la nuova Italia con le sue speranze. Quale l’avvenire dell’Italia? Hanno domandato politici ed economisti. De Gasperi non è profeta; le sue risposte sono state caute e misurate, ma la sua persona diceva più che le sue parole, perché assicurava quegli uomini di affari che l’Italia ha un leader e uno statista di senno e di equilibrio tali da poter superare crisi difficili ed evitare avventure pericolose.
In queste poche righe, don Sturzo ha sintetizzato alcuni tratti salienti della personalità degasperiana: il lato umano e spirituale di una persona «integra» e buona, assieme a quello più squisitamente politico di un «leader» e di uno «statista» che può «evitare avventure pericolose» all’Italia. Ritornano, dunque, quasi alla conclusione di questo mio intervento quelle tre caratteristiche salienti che avevo detto all’inizio della mia riflessione. Quando avevo definito De Gasperi come «un vero italiano, un autentico cristiano e uno straordinario statista, tra i più importanti – se non il più importante – dell’Italia unita».
L’eredità
La grande questione che oggi si pone dinanzi ai nostri occhi non è solo il riconoscimento degli indubbi meriti storici di De Gasperi, quanto la questione cruciale della sua eredità nel mondo attuale. Io ritengo che si tratti di un’eredità estremamente preziosa per l’Italia e l’Europa attuale. Così preziosa che necessita ancora di essere pienamente sviluppata. Mi permetto di evidenziare due suggestioni.
La prima riguarda l’identità nazionale. Ho definito De Gasperi come un «autentico italiano» e l’ho fatto perché sono ben consapevole della sua origine di «uomo di confine» e delle accuse ingiuste (di essere un austriacante) che gli sono state spesso rivolte. Egli è stato suddito dell’Impero Asburgico, parte integrante di una minoranza nazionale e ha saputo lottare per l’autonomia italiana. Ha poi conosciuto il carcere e la persecuzione del regime fascista che in nome di una visione autoritaria della nazione ha incarcerato altri italiani. E infine, nell’ultima parte della sua vita, è stato il leader di un gruppo dirigente che ha ricostruito l’Italia e che si è battuto con convinzione per costruire un’Europa unita e in pace. Da questo punto di vista, dunque, l’esperienza di De Gasperi ci viene a ricordare alcuni concetti preziosi per declinare l’identità nazionale: solidarietà, responsabilità, libertà ed Europa.
Il quadro concettuale su cui si muove De Gasperi è dunque straordinariamente attuale. Proprio oggi quando stanno sorgendo venti di guerra in Medio Oriente, quando il Mediterraneo è al centro di un conflitto silenzioso sui migranti, quando tante piccole Italie emergono nel dibattito pubblico e quando il processo europeo viene messo in discussione da troppe pulsioni particolaristiche e di chiusura verso l’esterno, ecco, in questo contesto, il messaggio di De Gasperi sull’Italia e sull’Europa è straordinariamente importante: un’Italia libera e responsabile in una nuova Europa più solidale.
La seconda suggestione riguarda la vocazione politica. Che per De Gasperi è indiscutibilmente segnata dal rapporto tra la dimensione spirituale e la dimensione politica. Un rapporto cruciale nella sua biografia. E tuttavia un rapporto laico. Senza cedere a tentazioni integriste, senza ricorrere a scorciatoie propagandistiche e senza mai strumentalizzare i simboli religiosi come amuleti identitari. De Gasperi ha il totale rispetto per la dimensione del sacro e trae la sua vocazione politica da una ispirazione spirituale che combina insieme l’esigenza di giustizia sociale con quella di carità. De Gasperi fa politica come «una missione» e con una sobrietà di cui oggi si sente una grande, grandissima, necessità in Italia, in Europa e in tutto il mondo occidentale.
Mai come oggi si avverte l’esigenza di questo slancio missionario, di questa carità politica, di questo autentico anelito verso il bene comune che è la condizione più importante affinché un semplice politico diventi poi un vero statista al servizio della propria comunità. L’Europa e l’Italia hanno urgente bisogno di un nuovo patto sociale tra tutti quegli uomini e quelle donne di buona volontà che hanno il coraggio, la passione, il talento e il desiderio autentico di costruire nuovi percorsi di impegno sociale e politico per il futuro del Paese e del Continente. L’ho detto più volte e lo ripeto ancora oggi: c’è un’Italia da ricucire per superare le divisioni ideologiche e territoriali; e per trovare una cura alle ingiustizie sociali verso i giovani, i disoccupati e le famiglie.
Cari amici e care amiche, e mi avvio alla conclusione, c’è un cammino ancora tutto da percorrere e una storia ancora tutta da scrivere. Anche se a volte abbiamo la sensazione di camminare in una valle oscura, non bisogna mai perdere la speranza. Ciò che è più importante, come scrisse De Gasperi, è che tutti gli «uomini di buona fede» distinguendosi da «gli uomini di preda» e da «gli uomini del piacere» si incamminino verso il futuro rimanendo fedeli «alla propria stella». Una stella il cui fulcro è contrassegnato, indiscutibilmente, dal valore incalpestabile della dignità umana, che va difeso sempre in ogni momento della vita.
Padre Dehon..."insieme trasformiamo il mondo"
"Cerca il bene dell'altro, e troverai anche il tuo bene!"
Padre Dehon

Dehon e il discernimento politico
Antonio Teixeira
"Nonostante il peccato, gli insuccessi e l'ingiustizia, la redenzione è possibile, è offerta e già presente"
Padre Dehon
Il 12 agosto 1925 moriva a Bruxelles p. Leone Giovanni Dehon, prete francese e fondatore della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù (dehoniani). Per farne memoria, la Congregazione ha organizzato una serie di eventi tra Saint Quentin (Francia), dove Dehon ha operato come vicario parrocchiale e ha fondato il suo istituto religioso, e Bruxelles, dove ha vissuto dopo l’espulsione dei religiosi da parte del Governo francese (1903) ed è morto. Per l’occasione, la Commissione teologica europea dei dehoniani ha tenuto un seminario di studio sulla eredità del pensiero e della azione sociale di padre Dehon a Clairefontaine, in Belgio. Il testo che riprendiamo di seguito è stato presentato durante i lavori di questo seminario.
La riflessione che propongo riguarda il modo in cui padre Leone Giovanni Dehon concepiva e accettava la Repubblica come forma di governo desiderata e scelta dal popolo francese. Il nostro fondatore faceva parte di un vasto gruppo di cristiani francesi che accettavano la Repubblica. Essere repubblicani e cristiani rappresentava a quel tempo una novità piuttosto difficile da comprendere, soprattutto se si considera che i massoni avevano svolto un ruolo importante nella fondazione della Repubblica. Vale la pena notare che all’assemblea massonica del 1865, Jérôme Bonaparte, fratello minore dell’imperatore Napoleone e maresciallo di Francia dal 1850, fu riconosciuto Gran Maestro della Loggia del Grande Oriente. Questo riconoscimento fu possibile perché il requisito di credere in Dio per l’adesione alla Loggia era stato eliminato dalla costituzione massonica.
Il ruolo dei massoni era attivo. L’ambiguità che circondava la Repubblica fece sì che la sua accettazione da parte dei cristiani non fosse né uniforme né omogenea. Il fenomeno dei cristiani che sostenevano la Repubblica coincise con la loro preoccupazione sociale per i lavoratori delle fabbriche, che vivevano in condizioni di diffuso impoverimento e degrado morale. Emersero così tre tendenze tra i cristiani sul modo di intendere la Repubblica.
Il primo approccio sottolineava il ruolo chiave dei datori di lavoro nella promozione del benessere dei lavoratori. Era essenziale proteggere i valori della famiglia, la libertà, la religione e i principi morali da qualsiasi minaccia. In questo contesto, il clero svolgeva un ruolo significativo come custode e precettore dei buoni costumi cristiani. La morale e la dottrina cristiana garantivano l’esistenza di una società sana.
La seconda tendenza era incentrata sul protagonismo dei lavoratori. I circoli di Reims, forse ispirati dalle pratiche socialiste, enfatizzavano la figura del lavoratore salariato come artefice e gestore del proprio benessere. I lavoratori non volevano che il loro destino dipendesse dalla misera beneficenza del datore di lavoro, ma dalla giustizia sociale per tutti. All’interno di questa tendenza, nel 1896 fu creato il Partito Democratico Cristiano.
La terza tendenza era costituita da coloro che cercavano di costruire ponti di dialogo tra le due posizioni precedenti.
Questo è, in linea di massima, il contesto del posizionamento cristiano nella Repubblica francese. Oltre alla diversità e al conflitto occasionale tra i cristiani repubblicani, esisteva anche un gruppo significativo di cristiani che desideravano un ritorno all’Ancien Régime.
È in questo contesto che Dehon riflette e discerne il suo ruolo di cristiano nel nuovo contesto politico e sociale francese. Certamente, una variabile da considerare nel discernimento del Fondatore dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù è il pontificato di Leone XIII. Il pontefice invitava i cristiani ad aprire nuove strade in una nuova società caratterizzata dallo sviluppo industriale, da nuovi fenomeni demografici urbani e da nuovi costumi culturali. A mio avviso, questo è proprio ciò che ha realizzato il nostro fondatore.
Dehon seguì infatti le linee guida di Leone XIII, ma non come semplice portavoce, bensì come pensatore che sviluppò le proprie idee e convinzioni personali, diventando un mediatore che sapeva dialogare con amici e avversari. Non a caso durante il Congresso di Lione, Dehon fu eletto come uno dei rappresentanti del clero nel Consiglio del Partito Democratico Cristiano.
Non credo si possa dire che Dehon è stato un innovatore politico; ma senza dubbio è stato un abile e prudente stratega .
Apprendistato repubblicano
I cambiamenti nei sistemi politici delle nazioni sono come uragani, capaci di distruggere in poco tempo ciò che aveva richiesto anni per essere costruito. Alcuni cambiamenti sono difficili da accettare a causa della complessità dell’interpretazioni e così Dehon dovette imparare a vivere nella Repubblica.
Il suo interesse e la sua azione politica non erano capricciosi, ma nascevano dalle circostanze e dall’esigenza evangelica di influenzare positivamente il regime repubblicano [1] .
La sua analisi della situazione lo portò a comprendere che l’autorità e la credibilità della Chiesa dipendevano da una profonda comprensione del dinamismo della Repubblica e dalla ricerca e creazione di spazi che consentissero ai cristiani di influenzare le decisioni politiche. Considerava la politica come un’opportunità per fare del bene, non solo come una piattaforma per proteggere gli interessi ecclesiali.
Non è infatti un caso che incoraggiasse i cattolici a non concentrarsi su sé stessi, ma ad ampliare la loro visione per abbracciare tutta la società: «Quando un giorno i cattolici francesi prenderanno la decisione di creare un blocco parlamentare, dovranno familiarizzarsi con l’idea che questo gruppo non potrà limitarsi a fare politica religiosa, ma dovrà essere molto attivo in tutti i settori della vita pubblica, se vorrà difendere con successo gli interessi legittimi della Chiesa. Questo partito dovrà avere un programma politico e in particolare un programma sociale concreto… Aiutati che il cielo ti aiuterà!» [2].
Una visione matura della politica
Considerare Dehon semplicemente come un repubblicano acritico, o come un repubblicano di convenienza che obbediva ciecamente alle direttive di papa Leone XIII, significa non prendere sul serio le scelte politiche del fondatore. Gli scritti di Dehon rivelano un processo in cui il fondatore acquisì acume politico e prudenza.
Egli non cercava di imporre i propri criteri, ma lavorava per raggiungere un equilibrio armonioso delle forze e mantenere il dialogo con pensatori di tutte le tendenze.
Non sorprende che Dehon, in qualità di organizzatore del Congresso di Lione del 1896, non abbia né squalificato né preso le distanze da padre Naudet, e abbia mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti di Leclercq, entrambi appartenenti agli ambienti di Reims. Allo stesso modo, ha mantenuto un dialogo con figure ecclesiastiche, politici e intellettuali di varie tendenze e leader sindacali. Apprezzava allo stesso modo La Tour du Pin, Albert de Mun, padre Naudet e il politico Étienne Lamy.
Chi conosce queste figure sa che avevano convinzioni diverse e opinioni politiche divergenti. Sebbene all’inizio del suo discernimento politico padre Dehon credesse che la democrazia cristiana dovesse essere integrata nelle strutture ecclesiastiche e governata dalla dottrina della Chiesa, gradualmente arrivò ad accettare e riconoscere la saggezza di negoziare con coloro che non condividevano le sue convinzioni iniziali.
Inizialmente considerava la democrazia cristiana come un quadro che sosteneva il rispetto della famiglia, della moralità e della Chiesa. È comprensibile che nelle sue prime opinioni politiche padre Dehon fosse più simpatizzante di Le Mun o La Tour du Pin e più scettico nei confronti di Lamy o Naudet.
Con la maturazione politica, Dehon iniziò a dialogare con nuovi interlocutori che non sempre erano in linea con i suoi ideali originali. Pur cercando costantemente di proteggere il ruolo della fede nella società, la sua comprensione di tale ruolo si evolse da un’attenzione all’apologetica ecclesiale a una fonte di ispirazione socio-politica. La dottrina passò dall’essere un contenuto da preservare a tutti i costi a uno strumento che facilitava il dialogo con la comunità più ampia, anche con chi aveva opinioni opposte, contribuendo in ultima analisi al bene comune. Gradualmente, padre Dehon passò da una visione sacralizzata della società a una visione politica e conciliatoria.
Parallelamente all’evoluzione del suo discernimento politico, maturarono anche le sue convinzioni teologiche. Dehon passò da una visione teologica caratterizzata dalla devozione al Sacro Cuore di Gesù, carica di affettività e intrisa di discorso morale, alla comprensione della devozione dal punto di vista della grazia.
Non è un caso che in Couronnes d’amour, padre Dehon ripensi la sua interpretazione della riparazione e della devozione alla luce dell’eredità spirituale di Santa Teresa del Bambino Gesù [3]. L’impegno sociale, il discernimento politico e l’interpretazione teologica sono aspetti che, in Dehon, vanno di pari passo.
La democrazia cristiana come spazio di sintesi
L’impegno sociale della Chiesa in tutte le sue forme – dai circoli vincenziani di Ozanam alla Gioventù Cattolica di Marc Sangnier – ha avuto un ruolo importante nel discernimento di Dehon. Le corporazioni, i congressi nazionali e regionali, le cooperative, i circoli operai, i circoli di studio, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le pubblicazioni costituivano una modalità democratica di partecipazione che aiutava i cristiani a integrarsi nella Repubblica con proposte, progetti e riflessioni serie.
La democrazia cristiana divenne un grande movimento che articolava le diverse convinzioni politiche dei cristiani di varie classi sociali. Dehon raggiunse un equilibrio tra le diverse visioni politiche, sociali ed economiche dei vari movimenti sociali. Il suo ruolo di fondatore della congregazione, padre generale, canonico, confidente di Leone XIII e i suoi rapporti di amicizia con influenti uomini d’affari e lavoratori dell’epoca lo resero una figura importante di riferimento, mediazione e influenza.
Ha consigliato e si è lasciato consigliare
In questa sezione esaminerò uno degli interlocutori di Dehon. Quello che cerco fare qui è tracciare il discernimento di Dehon in campo politico attraverso una corrispondenza specifica: le lettere scritte sul caso Étienne Lamy.
Il Dehon delle conferenze e dei libri, che trasmetteva convinzioni che dovevano servire da base per il discernimento, è diverso dal Dehon della corrispondenza: colui che discerne deve prendere decisioni, deve usare la sua influenza e capisce che non tutto funziona secondo un manuale. Nelle sue lettere appare un uomo che accoglie e difende chi la pensa diversamente in vista del bene superiore.
Il caso Étienne Lamy
Il 29 gennaio 1899, Étienne Lamy [4] scriveva a padre Dehon esprimendo il suo sconcerto per il cambiamento politico dei Padri Assunzionisti, che avevano deciso di tornare a sostenere L’Union de la France Chrétienne [5]. Ciò che più lo turbava era che La Croix, un giornale appartenente alla federazione che dalla fine del 1897 riuniva sette movimenti cattolici per coordinare gli sforzi politici sotto un’unica bandiera cattolica, appoggiava questo cambiamento.
Lamy attribuì questa sorprendente svolta a padre Picard, che da tempo si considerava il legittimo portavoce dei desideri di Leone XIII [6]. L’atteggiamento di Picard derivava dalla sconfitta dei candidati cristiani alle elezioni legislative del 1898. La disillusione era così profonda che i lavoratori cristiani militanti criticarono duramente la Federazione dei Movimenti Cattolici.
Il 14 gennaio 1898, Payan, un operaio cattolico, comunicò a Delevanne, responsabile dell’orientamento politico del movimento della Democrazia Cristiana, la sua delusione per il fallimento elettorale e li accusò di non aver tenuto conto del movimento operaio nell’organizzazione delle proposte politiche elettorali: «A noi, che siamo l’unica forza, non si propone di allearci con nuove forze sacrificando alcune idee per nulla, per alcuni politici» [7].
Lamy, a differenza di padre Picard, non aveva sfruttato la fiducia che il papa aveva riposto in lui. La sua azione discreta contrastava con la pretesa arrogante di Picard e della stessa La Croix, che, sventolando la bandiera di Leone XIII, serravano i ranghi attorno a un regime chiuso al dialogo. Lamy era un politico di carriera, repubblicano e cattolico. La sua presenza nell’opera sociale e nella collaborazione politica all’interno della democrazia cristiana era ben accolta negli ambienti politici francesi.
La manovra politica degli Assunzionisti mirava a rimuovere Lamy. La proposta di Picard rappresentava una battuta d’arresto politica e un errore strategico nella leadership politica della Democrazia Cristiana [8]. Sebbene Dehon non condividesse pienamente le convinzioni di Lamy, non si lasciò influenzare dai pregiudizi e cercò l’opportunità politica del momento.
Il 10 febbraio 1899, dopo aver ricevuto due lettere da Lamy, Dehon scrisse al cardinale Rampolla avvertendolo del pericolo di perdere Lamy. Secondo questa corrispondenza, Lemire, Lorin e i principali politici del partito cattolico francese ritenevano «assolutamente necessario mantenere M. [Étienne] Lamy alla guida dell’organizzazione cattolica. Perderlo significa tornare all’antica Unione conservatrice che ci ha perseguitato per vent’anni. Se in Francia si venisse a sapere che M. [Étienne] Lamy non è più il capo della federazione, tutti concluderebbero che il papa ha cambiato politica, che rinuncia alla sincera adesione al regime costituzionale e che cede a coloro che sognano una prossima restaurazione monarchica» [9] La lettera mostra un Dehon che ascolta, valuta le conseguenze e prende decisioni.
Dallo scambio epistolare di Dehon sul caso Lamy emerge un carattere prudente, che non fa pendere la bilancia verso l’Ancien Régime, che vede con favore la vicinanza alla Repubblica e accetta la presenza di politici repubblicani nel Partito Democratico Cristiano.
Dehon ascolta Lamy, ascolta i membri del partito e infine consiglia il cardinale Rampolla. La sua prudenza ci permette di tracciare i tratti di un Dehon sensibile, cristiano e pratico. Come cristiano, non si limitava a difendere le dottrine, ma si preoccupava di discernere il momento politico e sociale alla luce della fede.
Dehon cercava il consenso e proponeva ciò che avrebbe giovato a tutti e avrebbe portato ad accordi tra i legislatori. Il suo atteggiamento politico non era quello di rivaleggiare o opporsi agli avversari, ma di cercare soluzioni.
È illuminante leggere la lettera che scrisse a Paul Six il 26 novembre 1894 riguardo alla partecipazione dei lavoratori ai profitti industriali [10]. In questa lettera, padre Dehon sottolineava come questa idea fosse accolta con favore dai democratici cristiani, dai socialisti e persino dai conservatori come il conte di Hausonville [11]. Il fatto che la proposta cristiana godesse di un così ampio consenso rifletteva una politica di ispirazione cristiana in grado di influenzare sia i datori di lavoro che i lavoratori cristiani e non cristiani [12] .
C’è molto da dire su padre Dehon. Lo scopo di questo breve studio non era quello di affrontare un aspetto specifico della sua personalità, ma di individuare alcune riflessioni e discernimenti in cui è possibile delineare le caratteristiche delle scelte politiche del nostro fondatore.
[1] «Sì, ha fatto tutto. Ha chiesto ai cattolici di sacrificare i loro affetti e le loro preferenze per unirsi sul terreno costituzionale accettando il governo della Repubblica. Lo ha fatto perché era suo dovere accettare il governo costituito; era nel loro interesse entrare nella Repubblica per migliorarne la legislazione» (https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/ART/REV/ART-REV-1901-0100-8031085?ch=0).
[2] https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/ART/REV/ART-REV-1903-0500-8031118?ch=0
[3] Ciò non significa che Dehon dimentichi Santa Margherita Maria Alacoque, ma semplicemente che la legge dal punto di vista della grazia piuttosto che dell’affetto.
[4] Étienne Lamy era un importante politico francese che incarnava il complesso rapporto tra repubblicanesimo e cristianesimo nella Francia della fine del XIX secolo. Dopo la creazione del Partito Democratico Cristiano nel 1896 e la sua successiva riorganizzazione al Congresso di Lione dello stesso anno, Lamy emerse come figura chiave nell’organizzazione politica cattolica. In preparazione alle elezioni legislative del 1897, fu nominato presidente di una coalizione federata che riuniva varie associazioni cattoliche per coordinare i loro sforzi in vista delle campagne legislative del 1898. Questa federazione rappresentò un significativo tentativo di unità politica cattolica, che comprendeva movimenti diversi con approcci diversi all’impegno sociale e politico. La coalizione includeva il movimento della Democrazia Cristiana, l’Unione Nazionale di Padre Garnier, l’ACJF (Association catholique de la jeunesse française) e l’influente giornale cattolico La Croix. Questa ampia alleanza rifletteva la crescente consapevolezza tra i cattolici francesi che un’efficace partecipazione politica nella Terza Repubblica richiedeva un’azione coordinata tra diverse tendenze e classi sociali. La nomina di Lamy alla guida di questa federazione dimostrò la sua posizione unica di mediatore tra le diverse correnti politiche cattoliche. In quanto repubblicano convinto e cattolico praticante, rappresentava la possibilità di conciliare il governo democratico con i valori cristiani, una sintesi che molti dei suoi contemporanei trovavano difficile da realizzare (Cf. Histoire de la Démocratie Chrétienne 61/333).
[5] Gruppo cattolico fondato nel 1892 dall’arcivescovo cardinale di Parigi con l’unico scopo di difendere il cattolicesimo.
[6] Cf. https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/COR/COR-LC1-1899-0129-0006001?ch=2
[7] Histoire de la Démocratie Chrétienne 62/333
[8] Nella sua seconda lettera a padre Dehon, datata 6 febbraio 1899, Lamy descrive in modo più dettagliato la difficile situazione che sta affrontando: «Et pour mon compte je suis résolu à ne pas continuer en ce cas l’épreuve, parce que je ne veux avoir aucune responsabilité dans les résultats. M. Harmel est sous l’influence des pères. La preuve est que, sur leur appel, il a tenté de faire désavouer les délégués des « Démocrates chrétiens » qui dans la fédération sont d’accord avec moi. (…) Se questa politica sembra dover essere, dopo tanti fallimenti, tentata nuovamente, non resta che lasciare ai padri la direzione che hanno ripreso» (https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/COR/COR-LC1-1899-0206-0006002?ch=2).
[9] https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/COR/COR-1LD-1899-0210-0093909?ch=1
[10] https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/COR/COR-1LD-1894-1126-0030102?ch=1
[11] “M. le comte d’Haussonville, un retrogrado, che in questi giorni rimproverava allo stesso tempo i socialisti e i democratici cattolici, ammetteva che forse c’è qualcosa da aspettarsi dalla partecipazione ai profitti” (https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/COR/COR-1LD-1894-1126-0030102?ch=1).
[12] “Questa idea della partecipazione dei lavoratori alla prosperità dell’officina si sta facendo strada anche al di fuori del mondo padronale cristiano, sotto l’ispirazione di un sentimento naturale di equità e solidarietà. Nel suo libro sul Familistère di Guise, Bernardot fornisce un elenco degli stabilimenti industriali e commerciali in cui esiste la partecipazione del personale agli utili, sia in Francia che all’estero. Ne cita 321, di cui 116 in Francia” (https://www.dehondocsoriginals.org/pubblicati/ART/REV/ART-REV-1894-1100-8031014?ch=0).
San Massimiliano Kolbe..."Ave Maria"

Le ultime parole di san Massimiliano Maria Kolbe, «Ave Maria», annunciano una verità che nessun cristiano dovrebbe dimenticare: Dio si è offerto al mondo e ha vinto la morte invitandoci a vivere la nostra esistenza come un unico grande dono. E le nostre ferite, i nostri momenti bui, le sofferenze, sono spazi dove Dio sceglie di stare assieme a noi: ecco la radice della speranza.

San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire
ricorrenza morte 14 agosto
I primi anni di vita
Massimiliano Kolbe nasce il 7 gennaio 1894 a Zduńska-Wola, in una regione polacca controllata dalla Russia. Il padre, un tessitore, e la madre, una levatrice, sono ferventi cristiani: nel Battesimo scelgono per lui il nome di Raimondo. Frequenta la scuola dei francescani a Leopoli. Nel 1910 entra nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali assumendo il nome di Massimiliano. Inviato prima a Cracovia e poi a Roma, qui resta sei anni, laureandosi in filosofia all’Università Gregoriana e in teologia al Collegio Serafico. Viene ordinato sacerdote il 28 aprile 1918.
La Milizia dell'Immacolata
A Roma, mentre gioca a palla in aperta campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca: è tubercolosi. La malattia l’accompagnerà per tutta la vita. Fonda con il permesso dei superiori la “Milizia dell’Immacolata”, associazione religiosa per la conversione di tutti gli uomini per mezzo di Maria. Ritornato in Polonia, a Cracovia, pur essendo laureato a pieni voti, a causa della malferma salute non può insegnare né predicare, non potendo parlare a lungo. Sempre col permesso dei superiori, si dedica alla promozione della “Milizia dell’Immacolata”, raccogliendo numerose adesioni fra i religiosi del suo Ordine, professori e studenti dell’Università, professionisti e contadini.
Il successo della rivista "Il Cavaliere dell'Immacolata"
Durante il Natale del 1921, padre Kolbe fonda a Cracovia un giornale di poche pagine, “Il Cavaliere dell’Immacolata”, per diffondere lo spirito della “Milizia”. Trasferito a Grodno, a 600 chilometri da Cracovia, crea una piccola tipografia per la stampa del giornale, con vecchi macchinari: con questa iniziativa riesce ad attirare molti giovani, desiderosi di condividere uno stile di vita francescano ispirato a Maria. Il giornale si diffonde sempre di più. A Varsavia, grazie alla donazione di un terreno da parte del conte Lubecki, fonda “Niepokalanów”, la ‘Città di Maria’. Il centro si sviluppa rapidamente: dalle prime capanne si passa a edifici veri e propri, la vecchia stampatrice viene sostituita dalle nuove tecniche di composizione e stampa. Il “Cavaliere dell’Immacolata” raggiunge in breve una tiratura di milioni di copie, mentre vengono creati altri sette periodici.
La Città di Maria in Polonia e in Giappone
Con l’ardente desiderio di espandere il suo Movimento mariano oltre i confini polacchi, Kolbe si reca in Giappone, dove fonda la “Città di Maria” a Nagasaki. Qui, dopo l’esplosione della prima bomba atomica, avrebbero trovato rifugio gli orfani di Nagasaki. Collabora con ebrei, protestanti e buddisti, certo che Dio sparge semi di verità in ogni religione. Apre una Casa anche ad Ernakulam, sulla costa occidentale dell’India. Per curare la tubercolosi, torna in Polonia a Niepokalanów.
Niepokalanów, rifugio per profughi ed ebrei
Dopo l’invasione della Polonia, il 1° settembre 1939, i nazisti ordinano lo scioglimento di Niepokalanów. Ai religiosi costretti a lasciare il centro, padre Kolbe raccomanda una sola cosa: “Non dimenticate l’amore”. Restano circa 40 frati, che trasformano la cittadina in un luogo di accoglienza per feriti, ammalati e profughi. Il 19 settembre 1939, i tedeschi prelevano padre Kolbe e gli altri frati, portandoli in un campo di concentramento, da dove vengono inaspettatamente liberati l’8 dicembre. ritornati a Niepokalanów, riprendono la loro attività di assistenza per circa 3500 rifugiati, di cui 1500 ebrei. Dopo qualche mese, però, i rifugiati vengono cacciati o catturati e lo stesso Kolbe, dopo il rifiuto di prendere la cittadinanza tedesca per salvarsi, è imprigionato il 17 febbraio 1941 insieme a quattro frati. Dopo aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, è costretto a indossare un abito civile, perché il saio francescano “disturbava” i nazisti. Il 28 maggio viene trasferito nel campo di sterminio ad Auschwitz. Con il numero 16670, viene messo insieme agli ebrei perché sacerdote e addetto ai lavori più duri, come il trasporto dei cadaveri al crematorio.
La vita ad Auschwitz e la testimonianza nel bunker
La sua dignità di sacerdote incoraggia gli altri prigionieri. Un testimone ricorda: “Kolbe era un principe in mezzo a noi”. Alla fine di luglio è trasferito al Blocco 14, dove i prigionieri sono addetti alla mietitura nei campi. Uno di loro riesce a fuggire: per questo dieci prigionieri vennero destinati dai nazisti al bunker della morte. Padre Kolbe si offre in cambio di uno dei “prescelti”, un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. La disperazione dei condannati viene trasformata nella preghiera comune guidata da padre Kolbe. Dopo 14 giorni rimangono in vita solo in quattro, fra cui padre Massimiliano. Allora le guardie decidono di abbreviare la loro agonia con una iniezione di acido fenico. Padre Kolbe porge il braccio, dicendo “Ave Maria”: sono le sue ultime parole. E’ il 14 agosto 1941.
Nadia Toffa...Voce degli Ultimi nella Verità

Nadia Toffa e la fede: così imparò a vivere per saper morire
Maurizio Patriciello
ricorrenza morte 13 agosto
«Voglio imparare. Il tempo stringe e io debbo imparare. Imparare a vivere per saper poi morire». Nella vita non sempre ci rendiamo conto dell’importanza del dover imparare a vivere. Si vive e basta. Un fatto scontato, istintivo, naturale. E questo è grande errore. Sono passati pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice tv bresciana, che ha scosso l’Italia. In tanti ci siamo chiesti il perché. Qualcuno, grossolanamente, ha liquidato la faccenda parlando di una sorta di reazione emotiva. Le emozioni hanno la loro importanza, non c’è dubbio, ma da sole dicono ben poco.
La parabola di Nadia Toffa – discendente secondo una logica solo umana; ascendente secondo la logica di Dio – inizia da lontano, da quando per le prime volte la vedemmo affacciarsi sullo schermo. Una ragazza bella, slanciata, cocciuta, intraprendente. Schietta, brava, coraggiosa. I più giovani si specchiavano in lei, magari con un pizzico di benevola invidia. I più anziani la consideravano alla stregua di una figlia da proteggere. Una giovane destinata al successo, Nadia. Simpatica, brava, coinvolgente. Sarebbe arrivata lontano. Una mattina, come un fulmine a ciel sereno, in un albergo di Trieste, perse i sensi. Sarebbe stata lei stessa, mesi dopo, a confessare di avere il cancro. I telespettatori rimasero sconcertati.
Cancro, parrucca, chemio, sono parole da esorcizzare, lei invece ne parlava con serenità. Era finta, calcolata, per chissà quali scopi quella serenità, o faceva sul serio quella giovane giornalista? No, Nadia, non stava barando, non era capace di barare. In lei si specchiarono migliaia di ammalati di cancro, i loro parenti, i loro amici. E ancora una volta, Nadia accettò di diventare la portavoce dei malati. Un popolo al quale non sempre i cosiddetti sani assicurano la giusta comprensione e i diritti cui hanno diritto.
Nadia capì che le veniva chiesto molto perché molto le era stato dato. Accolse come una sorta di "vocazione" il male che l’affliggeva e dal quale fece di tutto per guarire. Intanto, però, da quel male si lasciava ammaestrare. Nulla doveva andare perduto. Dalla sofferenza imparava. E le giornate, quando il dolore le dava tregua, le sembrarono più lunghe, le sere più dolci, il cielo più azzurro, gli amici più cari. Imparò che tutto viene da Dio. E gridò al mondo la sua fede. «Dio non è cattivo, credetemi, Dio non è cattivo». Nadia, inchiodata in un letto di dolore, stava evangelizzando il dolore.
Con Dio iniziò a dialogare e litigare, come sapeva fare lei, cocciuta, ma mai cattiva. E comprese che la preghiera, da noi cristiani tante volte trascurata quando la vita ci sorride, era un "abbraccio". L’abbraccio caldo e rassicurante di Dio alla sua creatura. E volle comunicare ai fratelli in umanità la scoperta fatta. Imparava a vivere, Nadia. O, meglio, andava perfezionando la lezione iniziata tanti anni prima. Imparò ad amare la vita anche nei giorni del dolore. Capì che la Nadia di un tempo andava sfiorendo, non sarebbe tornata più. Ma non ne fece un dramma.
Con lei ho avuto un rapporto limpido, onesto, discreto, che si è andato intensificando negli ultimi mesi. «Continuo la chemio e non mollo. Sorrido e accetto tutto quello che Dio ha disegnato per me. Porto nostro Signore nel cuore e vedremo cosa deciderà per me. Porgo la mia anima vicino al suo immenso cuore. Grazie di esistere, padre. Le voglio bene».
Per gli auguri di Natale, le scrissi: «Nasconditi, Nadia sempre cara, come un uccellino, nelle fenditure della Roccia. La tempesta, il freddo, la neve, il gelo, le raffiche di vento, nulla potranno contro la Roccia che ti ripara. Lasciati cullare come un bambino sul seno della mamma. Non opporre resistenza. Dio è più grande del nostro povero cuore. Ti ama. Sei sua. Gli appartieni. Ti brama. In questa certezza, riposa». Poche ore dopo, la brillante giornalista, chiamandomi per la prima volta col solo nome di battesimo, rispondeva: «Grazie, Maurizio. Mi metterò al riparo tra le sue braccia. Io non ho paura per me ma per la mia cara mamma».
Papa Paolo VI, bresciano come lei, ci disse che «il mondo, oggi, non ha bisogno di maestri ma di testimoni». Nadia Toffa lo è stata. Per questo l’Italia intera ha pianto la sua morte e continua a volerle bene.

Margherita Rebuffoni: «Con la sua fede Nadia mi ha dato la forza di dirle addio»
La mamma di Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice de Le Iene morta di cancro, apre il suo cuore: «In certi momenti sento solo il peso della croce. Ma vado avanti perché mia figlia mi ha detto: “Ama la vita, è un dono prezioso di Dio”»
Il silenzio. Prima nella stanza e poi, come una voragine, nel cuore. Il lutto si presenta così: ci zittisce. Ci spoglia. Talvolta ci arriva perfino a strappare la carne di dosso. Ne sanno qualcosa quei genitori che, come Margherita Rebuffoni Toffa, hanno visto morire prematuramente i propri figli. Il dolore è talmente acuto, folle e viscerale che l’eco della sofferenza si imprime nei loro sguardi, accompagnandoli per il resto dell’esistenza. «Chiunque perde un figlio è un genitore mutilato», conferma Margherita. Di quella mutilazione è dffcile parlare. Probabilmente non dovremmo nemmeno farlo, ma a insistere è lei stessa: una madre che non edulcora nemmeno un centesimo del suo dolore. Una madre che ammette come «a volte la solitudine diventa disperazione» e che non si capacita del «destino infame» toccato in sorte alla figlia. Ma che sa che, da qualche parte, c’è un senso più grande: nemmeno il dolore più cocente può travolgere quel dono meraviglioso che è la vita...
Il suo è un vero e proprio atto di fede…
«La vita è dura: non lo nego. Ho perso mia sorella Marilena quando aveva solo 21 anni, mia figlia Nadia è morta a 40 anni, mio marito ha avuto un aneurisma celebrale e mio padre è stato per circa sei anni sulla sedia a rotelle. La vita sa essere molto dura, ma va accettata: ognuno ha il proprio percorso. Io ho avuto la fortuna immensa di avere la fede, che mi ha aiutato e mi aiuta moltissimo». È sufficiente per resistere? «Ci sono dei momenti, anche molto lunghi, dove senti solo il peso della croce che ti porti addosso: non c’è altro che quel peso. Nient’altro. Bisogna però continuare a credere che la luce arriverà. Magari sarà piccola, ma arriverà e ti aiuterà ad andare avanti. Ai genitori che sono mutilati come me, consiglio di farsi aiutare, di pregare tanto, di cercare di trasformare questo dolore enorme in bene e di invocare la protezione proprio dei nostri cari che sono nell’Aldilà».
Anche Nadia condivideva la sua stessa fede?
«È sempre stata credente. Da bambina frequentava la parrocchia e ha studiato dalle Canossiane di Vitorchiano. Già prima che si ammalasse parlavamo spesso del senso della vita, del Paradiso, di Dio. La fede è un grandissimo dono ed è stata fondamentale durante la sua malattia. Nadia si confrontava molto con don Maurizio Patriciello: lui ha celebrato il suo funerale e siamo ancora in contatto. Inoltre ricordo che, quando i dolori si facevano così forti da mozzarle il fiato, mi diceva: “Mamma, aiutami a far scendere Gesù nel cuore e a far scendere nel cuore la zia Marilena che è il mio angelo custode”. Così, pregavamo insieme e piano piano il dolore passava. Magari la preghiera l’aiutava semplicemente a rilassarsi, sta di fatto che il dolore andava via».
La fede è sicuramente un sostegno, ma non toglie il dolore della perdita: crede che si possa, in qualche modo, arrivare preparati alla morte o è un mistero che bisogna semplicemente guardare?
«Non si arriva mai preparati. A un certo punto, però, capisci che devi lasciare andare la persona amata. Nell’ultimo periodo Nadia era molto peggiorata: purtroppo aveva avuto una nuova recidiva e non potevano più operarla (aveva già subito 5 operazioni, ndr). Le settimane passavano e io la vedevo cambiare: era sempre più stanca e sofferente. Un giorno mi resi conto che Nadia stava lottando perché non voleva lasciarmi nel dolore più atroce che esista al mondo (perché perdere un figlio è un dolore atroce!). Non so come io abbia fatto, né da dove mi sia arrivata la forza: è un momento di comunione profondissima tra madre e figlia, impossibile da descrivere. So solo che la vedevo stare male, spiritualmente ancora prima che fisicamente, e così le ho detto: “Non ti preoccupare, vola via”. E l’ho lasciata andare».
Nadia è sempre stata combattiva e ha accettato la malattia. Ma lei? L’ha accettata?
«È durissima, lo ripeto: è durissima. Però Nadia mi ha preparata a questo momento, “costringendomi” piano piano ad accettarlo: negli ultimi due anni mi continuava a ripetere di pensare alla Madonna, di affidarmi a lei che, così giovane, aveva provato il dolore più grande al mondo, ossia vedere suo Figlio crocifisso. “Mamma, quando non ci sarò più, tu devi continuare a fare quello che hai sempre fatto e amare la vita perché è un dono immenso di Dio”, aggiungeva sempre. “Non sprecare nemmeno un minuto di quello che ti è dato da vivere! Ricordati che sarò sempre lì vicina a proteggerti”. Si parlava di questo: lei per consolare me e io per aiutare lei…».
Da qui è nata dunque l’idea della Fondazione?
«Sì, volevo rendere concreto il desiderio di Nadia di aiutare l’istituto neurologico Besta di Milano, dove è stata curata dal dottor Finocchiaro. Nadia mi ha anche lasciato tantissimi scritti, poesie, appunti, dipinti: insieme alla casa editrice Chiarelettere stiamo valutando cosa pubblicare, oltre al libro Non fate i bravi».
Secondo lei qual è insegnamento più bello lasciato da sua figlia?
«La raccomandazione che abbiamo scelto come titolo del libro: Non fate i bravi. Nadia me lo diceva spesso: è troppo semplice fare i bravi, stare nel proprio piccolo, non pensare male di nessuno, fare piccole offerte. Non fare i bravi vuole invece dire metterci la faccia, litigare per le proprie idee, anche a muso duro. Solo così possiamo aiutare gli altri: se non facciamo i bravi».
Chi è. La Iena dei reportage coraggiosi
Nadia Toffa era nata a Brescia nel 1979. Giornalista e conduttrice della trasmissione Le Iene, con i suoi reportage aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica su gravi problemi quali la ludopatia, lo smaltimento illegale di rifiuti in Campania da parte della camorra e l’alto tasso di tumori nella “Terra dei fuochi”. L’anno scorso il cancro ha messo fine alla sua vita: si è spenta il 13 agosto 2019, dopo una lunga terapia e cinque operazioni. La sua è stata una battaglia lunga e coraggiosa, che ha raccontato sui social e nel libro Fiorire d’inverno – La mia storia (Mondadori). Recentemente è uscito un suo libro postumo: Non fate i bravi (Chiarelettere).
Gino Strada...abolire la guerra è possibile!


Ha fondato Emergency, Gino Strada, è stato sempre dalla parte delle vittime dei conflitti
ricorrenza morte 13 agosto
Nello Scavo
Se n’è andato mentre la Storia gli dava ragione. “Chi allora si opponeva alla partecipazione dell’Italia alla missione militare, contraria alla Costituzione oltre che a qualunque logica, veniva accusato pubblicamente di essere un traditore dell’Occidente, un amico dei terroristi, un’anima bella nel migliore dei casi”. Gino Strada
Era quel tipo d’uomo, impastato di quella tempra che i potenti mal sopportano, che puoi far parlare solo con parole sue. Chi lo conosceva sapeva d’imbattersi prima o poi in un della sue riflessioni asciutte, dirette e taglienti, disperate eppure mai scoraggianti, come gli strumenti da chirurgo che gli hanno permesso di salvare vite in Oriente come in Africa, nel Mediterraneo come a Milano contro il Covid. Quegli stessi ferri da sala operatoria che gli hanno fornito un metodo per guardarsi intorno. “Come medico - diceva -, potrei paragonare la guerra al cancro. Il cancro opprime l’umanità e miete molte vittime: significa forse che tutti gli sforzi compiuti dalla medicina sono inutili? Al contrario, è proprio il persistere di questa devastante malattia che ci spinge a moltiplicare gli sforzi per prevenirla e sconfiggerla. Concepire un mondo senza guerra è il problema più stimolante al quale il genere umano debba far fronte. È anche il più urgente”.
L’1 dicembre 2015 concesse ad “Avvenire” un testo. Non un testamento, a rileggerlo oggi, ma un “mandato” per quelli di buona volontà. Scriveva: “Io sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Europa. Ho operato migliaia di persone, ferite da proiettili, frammenti di bombe o missili. A Quetta, la città pakistana vicina al confine afgano, ho incontrato per la prima volta le vittime delle mine antiuomo. Ho operato molti bambini feriti dalle cosiddette 'mine giocattolo', piccoli pappagalli verdi di plastica grandi come un pacchetto di sigarette. Sparse nei campi, queste armi aspettano solo che un bambino curioso le prenda e ci giochi per un po’, fino a quando esplodono: una o due mani perse, ustioni su petto, viso e occhi. Bambini senza braccia e ciechi. Conservo ancora un vivido ricordo di quelle vittime e l’aver visto tali atrocità mi ha cambiato la vita”.
Ma era quando il fondatore di Emergency provava a spiegare il perché di quei conflitti, che la sua figura diventava scomoda. “Dobbiamo convincere milioni di persone - scriveva ancora - del fatto che abolire la guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile. Questo concetto deve penetrare in profondità nelle nostre coscienze, fino a che l’idea della guerra divenga un tabù e sia eliminata dalla storia dell’umanità”.
A lungo accanto a lui c’è stata Teresa Sarti, la moglie che sapeva dare forma e struttura alle appassionate intuizioni di Gino. Se n’è andata nel 2009, per colpa di un tumore. Una guerra nella guerra che hanno combattuto insieme senza arretrare di un solo anelito nel loro impegno.
Mentre le agenzie rilanciavano la notizia del lutto Cecilia, la loro unica figlia, raccoglieva a bordo 85 desaparecidos del Mediterraneo. E’ in mare con la nave di soccorso “Resq” che offre l’ultimo appiglio ai dimenticati di guerre e soprusi che, come in Afghanistan, non ci vedono estranei. Come se la notizia delle morte non fosse riuscita a interrompere la concretezza di una vocazione familiare che dal 1994 a oggi ha messo radici in 19 Paesi curando oltre 11 milioni di persone. “Se l'uomo non butterà fuori dalla storia la guerra - ripeteva Gino Strada -, sarà la guerra che butterà fuori dalla storia l'uomo".

Gino medico eccellente perché uomo eccellente
Guido Oldani
Gino Strada e io per qualche anno ci siamo visti ogni giorno. Eravamo, ufficialmente, quelli che si definivano studenti lavoratori. Studiavamo con grande passione l’anatomia, fino alla maniacalità, con il nostro insuperabile maestro Sergio Milanesi. Sapevamo di avere due strade diverse ma, forse, analoga muscolatura per il pugilato della vita. Lui mirava a diventare chirurgo di guerra, deciso com’era ad avversarla e a salvare gli uomini che, in qualche modo volenti o nolenti, ci finivano dentro. Io desideravo conoscere nei dettagli il corpo umano, per capire un po’ di più della mente che dà la parola poetica e può cambiare il mondo, togliendolo dai suoi provincialismi abituali. Gino, come me era un ex sessantottino, sposato con Teresa, dai bellissimi capelli rossi, aveva già una bimba, che lo avrebbe seguito.
L’erede di Schweitzer, lasciatemelo chiamare così, aveva avuto contrasti, ad esempio con il professor Staudacher, che lo citò in giudizio, credo per interruzione di pubblico servizio. Divennero grandi amici. Succede spesso fra galantuomini che si affrontano. Ogni notte che a chirurgia d’urgenza al Policlinico di Milano, arrivavano feriti dai disastri stradali o malavitosi, sapevano di poter telefonare a Gino Strada che sarebbe corso dalla sua Sesto San Giovanni, allora conosciuta come 'Stalingrado d’Italia', per via dell’altissima presenza di operai comunisti e che era, però anche la città del pensatore aclista Giovanni Bianchi. Gino tentava nuove vie di aggressione operatoria anche lavorando in condizioni inventive di chirurgia sperimentale. Ho in mente inoltre quando affrontò il viaggio in macchina con qualcuno, per andare al funerale di un esponente delle rivolte iugoslave, e mentre viaggiava, studiava in vista di un esame universitario imminente.
Quando mi è capitato di vederlo intervistare in televisione, mi sembrava sempre che il giornalista di turno si rapportasse a lui come un cammello a un orso bianco del Polo Nord. Il suo gesto tipico, mentre parlava nelle pubbliche assemblee o a lezione, era di far ruotare, come le lancette di un orologio impazzito, una catenella che inanellava le chiavi del suo mazzo personale. Era alto, vigoroso e di bell’aspetto, con un ciuffo di lato al quale ometteva di dare pubblicità con qualche gesto calcolato. Poi ci perdiamo di vista, lui crea il percorso di Emergency e va a soccorrere e portare salute là dove è troppo rischioso e i topi scappano. La mano chirurgica di Gino salva le vite a prescindere dalle appartenenze politiche o religiose: salva chiunque e ovunque, Italia compresa. Su una figura come la sua sarebbe facile la retorica o addirittura l’impostura. Alcuni teologi parlerebbero di stile cristiano. La sua fatica umanitaria è culminata in un infarto, dal quale lo ha salvato il blitz di un elicottero.
L’ho incontrato al funerale della moglie Teresa: ci siamo abbracciati e compresi per le nostre diverse strade. Poi qualche attore non ha saputo resistere alla tentazione di farsi notare con un inutile sproloquio. Il suo viso televisivo si era progressivamente segnato ed era incominciato qualche doloroso tic alla bocca, non certo alla bussola del pensiero. Il suo nome è tornato all’evidenza alle ultime elezioni per il presidente della Repubblica e, poi, per la scelta del Commissario anti-Covid in una della situazioni più delicate. Naturalmente non se ne è fatto nulla. Gli uomini eccellenti servono giusto per poterli citare da lontano e poi si torna a sfrucugliare nelle tarantelle dei compromessi. Gino ha realizzato la solidarietà tra i continenti, lontano da ogni trionfo nella propria regionalità.
Chiara Corbello Petrillo...l'Amore che si dona


Mostraci il tuo volto. La vita nuova di Chiara Corbella continua nel volto degli altri
ricorrenza 13 giugno
Roberto I. Zanini
A dieci anni dalla morte la serva di Dio continua a tonificare la fede di tanti che si rivolgono al suo esempio. I genitori: «Ha saputo trasmettere il senso sorridente della sofferenza trasfigurata»
Entri al cimitero del Verano, a Roma, domandi della tomba di Chiara e tutti te la sanno indicare. Dal giorno della sua morte, 10 anni fa, non solo è di gran lunga la più visitata, ma è anche la più adornata e colorata di oggetti, di rosari ed ex voto, fotografie, lettere e bigliettini in un flusso costante di devozione e d’amore. Quella tomba offre la percezione della vita che non muore. In qualche modo sorride ai suoi visitatori con la stessa capacità rigeneratrice del sorriso di Chiara, del volto di Chiara. Qualunque giorno tu vada troverai certamente giovani donne che chiedono la grazia di un figlio, che ringraziano per averlo avuto. Lì dove riposano le spoglie di questa grande donna dei nostri giorni la vita sorge sempre nuova. Poche persone ricevono come lei così tanta corrispondenza. Poche riescono, come lei, a rispondere con tanta sensibile e amorosa assiduità. «Sul sito ufficiale di Chiara ogni giorno arrivano messaggi e lettere di riconoscenza "per grazia ricevuta". Qualcuno in Brasile ha fatto un sito social a lei dedicato e ci sono decine di migliaia di follower. Accanto alla sua tomba una grande cassetta postale accoglie le paure, le confidenze, i bigliettini, le lettere, i disegni, le fotografie che le persone desiderano condividere con lei. Scrivono come a un’amica perché lei allarga i cuori, li accoglie nel suo. Tante volte ho parlato con queste persone delle ragioni di tanta speranza... Molti sono giovani religiosi e religiose che sottolineano l’importanza di Chiara per la loro vocazione. Questo è davvero il Volto di Dio. Il volto sorridente della sofferenza trasformata, trasfigurata come solo Dio sa fare».
A parlare sono i genitori di Chiara Corbella, Maria Anselma e Roberto, seduti l’uno accanto all’altra nel giardino della loro casa romana, quella in cui Chiara è cresciuta insieme a Elisa, la sorella maggiore e che ancora ospita la nonna, 101 anni, a cui era particolarmente legata: «Anche negli ultimi giorni di vita, la prima domanda alla mattina era: "la nonna come sta"». A guardare i volti così sorridenti e voltivi di questa mamma e questo papà, seppure di tanto in tanto velati dalla naturale commozione che segue il flusso dei ricordi, si intuisce quanto possa essere stata straordinaria l’esperienza con quella figlia traboccante di gioia pur nelle aspre esperienze della sua giovane vita.
Anselma. «Le ultime settimane a pensarle ora sono state incredibili. C’era un’atmosfera positiva, quasi di allegria. Capisco che possa sembrare strano. Uno sconosciuto che ci fosse venuto a trovare sapendo di tanta tragica sofferenza avrebbe potuto tranquillamente pensare di essere entrato in una casa di matti. Si scherzava e si rideva insieme e lei partecipava alla scherzo».
Roberto. «Oggi le persone che ci incontrano ci ringraziano, ci dicono "voi non sapete quanto Chiara ci sia vicina". Perché da quando è morta Chiara non è più semplicemente "nostra figlia", Chiara è di tutti e noi siamo diventati: "I genitori di Chiara". Qualche settimana fa mi ha chiamato un amico che vive a Dublino per dirmi che una sua nipote, novizia delle suore di Madre Teresa, gli aveva parlato di due novizie a Roma che avrebbero preso i voti a giorni e avevano scelto di chiamarsi Chiara in onore di mia figlia. Sono andato alla cerimonia: una Chiara Luz e l’altra Chiara Amata... avevano un bel sorriso...
Dicevate della straordinarietà di quelle ultime settimane.
Anselma. Subito prima di Pasqua 2012 i dottori ci avevano comunicato che il tumore, manifestatosi l’anno precedente, si era diffuso e non c’era più speranza. Dopo Pasqua ci siamo trasferiti nella casa di campagna, vicino a Roma. Gli amici di Chiara venivano a visitarla e una volta a settimana si trovavano tutti insieme per il rosario. Ogni volta si aggiungeva qualcuno e dopo il rosario si stava insieme, si condivideva come in una grande festa.
Effettivamente quando nelle fotografie o nei filmati si incontra il volto sorridente di Chiara in quegli ultimi mesi è davvero difficile privarsene, non desiderare di vederlo ancora.
Anselma. Era allegra, positiva. Non si lamentava. Non era mai rassegnata. Se mi vedeva triste diceva: «Non ti preoccupare mamma... vuol dire che è la cosa migliore per me e per tutti quelli che ci stanno vicino». Era convinta che Dio voleva per lei e per noi la cosa migliore. A un certo punto ha capito chiaramente il senso di tanta sofferenza, si è sentita chiamata a essere parte dell’opera redentrice di Gesù.
E voi? non è facile per dei genitori?
Roberto. Cosa posso dire... Io mi ritengo fortunato. Anche qui si sono invertite le parti: non siamo stati noi ad accompagnarla, ma lei ci ha accompagnato fino in fondo. Ci ha detto a tutti, uno per uno: «Vi voglio bene. State sereni». Sì, se n’è andata ma ci ha fatto vivere e capire che era per qualcosa di più grande, che valeva la pena. Per il suo funerale ha chiesto a Enrico (il marito Enrico Petrillo, ndr) di comprare una piantina da donare a coloro che sarebbero venuti. Lui ne ha comprate a centinaia e tutte sono state accolte dai presenti come vita che continua.
Anselma. Lei è associata un po’ alla lavanda. Per il matrimonio ne aveva fatti tanti mazzetti da regalare. A ogni messa per l’anniversario della morte, che quest’anno faremo ad Assisi, mettiamo centinaia di piantine di lavanda intorno all’altare e poi le distribuiamo ai presenti.
Perché ad Assisi?
Era molto legata ad Assisi, ai francescani di Santa Maria degli Angeli. Lì si è rafforzato il legame con Enrico, lì vive il direttore spirituale. E poi la postulazione passa dalla diocesi di Roma nelle mani dei frati Minori francescani.
Torniamo alle piantine del funerale...
Roberto. Sì, amava molto la vita. Ha dato la vita per la vita. E poi aveva particolare attenzione per la bellezza, per la famiglia, per la serenità delle relazioni umane. Fin da bambina non tollerava che avessimo discussioni. Quando capitava, come in ogni coppia, lei arrivava e ci congiungeva fisicamente, pretendeva che ci dessimo un bacio. Era molto attenta al prossimo, desiderava sanare, anche prevenire, ogni discordia.
Anselma. Era tutta per gli altri. Notava ogni sfumatura sui volti delle persone. Si accorgeva della minima sofferenza. A scuola, ma anche quando seguiva la preghiera dei più piccoli nella comunità del Rinnovamento che frequentavamo, aveva molte attenzioni per i figli di genitori in crisi. Aveva maturato capacità di ascolto, di pazienza misericordiosa. Gli amici si appoggiavano a lei. Non imponeva punti di vista, ma era coerente nella fede e nella vita. Sempre accogliente. Questo ne faceva un riferimento anche al liceo Visconti.
E a casa?
Roberto. Una sua caratteristica era la naturalezza. Mai nulla in lei era ostentato. Amava scherzare e ci divertivamo con le battute, i giochi di parole. Si interessava a tutto quello che succedeva intorno a lei e nel mondo. Era un’ottima interlocutrice, pacata, eppure determinata.
Anselma. Era concreta, con i piedi per terra, ma con lo sguardo rivolto al cielo.
Aveva un particolare dialogo con Dio?
Anselma. Era nella sua indole. E a me sembrava naturale: in fondo con lei e con Elisa abbiamo sempre frequentato lo stesso gruppo di preghiera, facevamo ritiri, pellegrinaggi, andavamo a Medjugorje. Abbiamo cercato di fare una strada di fede. Lei non saltava mai la preghiera personale. Faceva preghiera del cuore. E la Madonna per lei era una mamma, ne ascoltava gli insegnamenti che le salivano dal cuore. Poi appuntava ogni ispirazione, la arricchiva con dei disegni... Era il suo modo per mettere Dio al primo posto e il resto della giornata veniva di conseguenza, nella normalità.
Roberto. Sì, in famiglia l’unico fuori linea ero io. Vivevo queste cose di riflesso, ma tutto era normale, vissuto con semplicità. Per Chiara il Signore era un amico, si rivolgeva a lui in romanaccio.
Medjiugorje era un riferimento...
Roberto. Ci è andata più volte. Aveva 19 anni quando a Medjugorje ha conosciuto Enrico. È sempre stata bella ma sembrava disinteressata alle relazioni affettive. Vedendola molto coinvolta, ho provato a dire: «È il primo, Chiara, non ti preoccupare troppo» e lei mi ha detto: «Guarda che questo me lo sposo». Tutti e due andavano ad Assisi dove facevano corsi vocazionali. Hanno cominciato a frequentare don Fabio Rosini. Sono diventati amici di un frate di Santa Maria degli Angeli. Un giorno ci hanno invitati a cena e ci hanno comunicato data e ora del matrimonio in una chiesa di Assisi. Era il 2008.
Poi i due figli con malformazioni congenite e subito morti. Nel 2011 arriva il concepimento del terzo.
Anselma. Finalmente andava tutto bene. Poi si manifesta quella che sembrava un’afta alla lingua. Al quarto mese di gravidanza la situazione è esplosa. A tutti i costi lei vuole proteggere il bambino così la operano in anestesia locale: tolgono un pezzo della lingua, poi niente morfina. La notte è durissima, i dolori lancinanti. Una vera notte oscura. La assalgono i dubbi: «Se Dio ci fosse non mi tratterebbe in questo modo, non mi lascerebbe in questo stato». La fede e la speranza tornano limpide alla mattina quando arriva Enrico e insieme fanno le Lodi.
Viene in mente santa Bakhita che sul letto di morte, alle consorelle che chiedevano se si sentisse sul Calvario, rispondeva: «No, sul Tabor».
Anselma. Eppure la sofferenza è stata tanta. Dopo l’operazione c’era la necessità di fare subito dopo un intervento di pulizia dei linfonodi del collo che però non si poteva fare in anestesia locale. E lei trattava con i medici per far passare il tempo. Il giorno del parto trova nella stanza una mamma che aveva perso il bambino e la consola. Dopo quattro giorni la operano. Il cancro si era già diffuso. Tutta l’estate fa chemio e radio. Non riusciva a deglutire e viene alimentata con un sondino. A Natale 2011 si pensava che il peggio fosse passato.
Eppure quello che più si ricorda di Chiara è ciò che accade dopo. A cominciare dalla foto del suo volto sorridente con la benda sull’occhio.
Anselma. È stata fatta a Medjugorje, ad aprile 2012, quando la malattia aveva già intaccato l’occhio.
Ci è voluta andare dopo che ha saputo che le restava poco tempo?
Roberto. Lo desiderava tanto. Voleva portare noi e i suoi amici. All’inizio si pensa a quaranta persone. Io mi sono sempre occupato di turismo e attivo i miei contatti per organizzare. Intanto aumenta il numero di chi vuole venire. Alla fine riempiamo un aereo da 160 posti e a tanti dobbiamo dire di no. Siamo partiti il 17 aprile con un tempo pessimo e lei la sera prima stava malissimo, non stava in piedi.
Anselma. Quella sera gli dicevo: «Non andare. Come fai? La Madonna ti ascolta anche da casa...». «Non ti preoccupare mamma - fu la sua risposta - quello che il Signore vuole che io faccia me lo lascia fare». Il giorno dopo a Medjugorje, in un incontro con tutto il gruppo, seduta accanto a Enrico parla per due ore rispondendo alle domande sorridente e spigliatissima, la battuta pronta. Lì viene scattata quella fotografia. Alla mattina seguente sale anche lei a piedi al luogo delle apparizioni con un sole splendido. Tornati giù il tempo è pessimo e il giorno dopo uguale. Al rientro a Roma non reggeva più il dolore e ha dovuto cominciare la morfina.
Fede incrollabile e spontaneità...
Anselma. Era davvero spontanea in tutto. Salda in Dio e spontanea, felicemente spontanea. Un giorno Gigi (Gigi De Palo) le organizza un incontro col cardinale vicario Vallini. Lei stava già male. Abituata a jeans e maglietta, spigliata come sempre mi chiede: «Come ci si veste per incontrare un cardinale?». Ma quel giorno è il cardinale a incontrare Chiara. Si appartano. Parlano a lungo. In occasione del funerale, Vallini quasi non può fare a meno di sottolineare: «Abbiamo una nuova Gianna Beretta Molla». Lei era così. È così. La guardi a arriva al cuore. Io la chiamo la freccia di Dio perché arriva senza intermediazioni.

Chiara Corbella, “sorella che intercede presso Dio”: primo passo verso la beatificazione
Nella Basilica di San Giovanni in Laterano si è chiusa l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità della giovane mamma romana, scomparsa nel 2012 a 28 anni per un tumore apparso quando aspettava il figlio Francesco.
Gli occhi di Chiara Corbella si rivedono in quelli scuri di Francesco in prima fila con il papà Enrico, i nonni Roberto e Maria Anselma, la zia Elisa ed i suoi cugini. Ha 13 anni, il guizzo dell’adolescenza, un viso che ispira dolcezza e ha la gentilezza, non scontata a quell’età, di dispensare sorrisi a chi gli si avvicina per parlargli di Chiara, scomparsa nel 2012 a 28 anni per un tumore alla lingua. Allora Francesco cresceva nel suo grembo e lei decise di curarsi tutelando quella vita nascente che, già nelle precedenti gravidanze di Maria Grazia Letizia e di Davide Giovanni, aveva protetto scegliendo di accoglierle pur essendo “imperfette” agli occhi del mondo ma comunque doni preziosi di Dio.
Nella Basilica di San Giovanni in Laterano Francesco ha assistito insieme a molti amici, a persone arrivate dalla Sicilia, alcune di nazionalità polacca, alla chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù, la fama di santità e dei segni della Serva di Dio Chiara Corbella. I sigilli apposti con la ceralacca sulle carte dell’inchiesta, avviata il 21 settembre 2018, sanciscono un ulteriore passaggio verso la sua beatificazione. I documenti giungeranno in Vaticano per l’esame del Dicastero delle Cause dei Santi.
“I fedeli avvertono che Chiara è l’amica di Dio, testimone eloquente della fede, compagna di viaggio nell’itinerario della vita, una sorella che intercede presso Dio per tante necessità. Questo sensus fidei non è altro che una manifestazione dello Spirito Santo che agisce nel cuore di ogni battezzato”, ha detto monsignor Baldassare Reina, vicegerente della diocesi di Roma, illustrando la fama di santità di Chiara Corbella, “figlia della Chiesa di Roma”, e sottolineando le tante testimonianze di fede e di grazie giunte. Ha ricordato poi la frase dell’Apocalisse che nel 2007 cambiò il cammino di Chiara: “Quando egli (ndr. Dio) apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre”. È l’inizio del suo abbandono, del suo lasciarsi plasmare. “Se leggiamo la vita di Chiara con una logica umana – ha spiegato monsignor Reina - sarebbe assimilabile ad una tragedia, sostenuta invece dalla fede e dall’amore sponsale l’esperienza della sofferenza si muta in Chiara in esperienza di vita eterna, dai toni decisamente pasquali. La sua malattia accettata in obbedienza alla volontà di Dio diventa condizione possibile per andare in Paradiso. È la vittoria definitiva che smaschera l’inganno della morte”.
Chiara, l’albero sotto cui ripararsi
A prendere la parola durante la cerimonia anche fra Francesco Piloni, provinciale dei Frati Minori di Assisi, che ha ricordato Enrico e Chiara quando erano giovani fidanzati in cammino verso il matrimonio e quando, soprattutto Chiara, scoprì che “il contrario dell’amore è il possesso”. Una frase che lei stessa ha scritto in una lettera al piccolo Francesco in occasione del suo primo compleanno. Da allora “la Serva di Dio – ha aggiunto fra Piloni - ha iniziato a germogliare, diventando un grande albero dove molti di noi trovano riparo e consolazione”. Il marito Enrico Petrillo, nel suo intervento, ha voluto invece ringraziare i presenti “per tutto l’amore donato": "Avete amato Chiara e avete amato me. La bellezza di Chiara è che lei ci ha rivelato una caratteristica di Dio, Dio è un Dio felice anche nella morte e un Dio dolce”.
Le risate di Chiara
“C’è tanta felicità, è una cosa inaspettata – spiega il papà Roberto Corbella - e sono convinto che Chiara si starà facendo tante risate dall’altra parte. Vedere una figlia che fa felici tante persone ci fa accettare meglio il fatto di non averla con noi”. Per Roberto i 12 anni passati dalla morte di Chiara non sono un tempo di mancanza, “non è che non c’è più, in situazioni come questa c’è ancora, la rivediamo in tante testimonianze, in tanti giovani che ci dicono che Chiara gli ha cambiato la vita”. Nel cuore di un papà una figlia futura beata resta “la bimba che avevo sulle ginocchia, una ragazza molto solare che amava la vita in tutte le sue forme, si batteva per la pace, non sopportava se io e mia moglie discutevamo. E poi amava tutti gli animali che lei e la sorella ci portavano a casa. Ci hanno portato uno zoo praticamente, voleva curarli tutti”.
Pepe Mujica... il Presidente dei Poveri

Un ricordo di Pepe Mujica a due mesi dalla morte
Francesco Bottacin religioso dehoniano, è stato a lungo missionario in Uruguay
(Montevideo, 20 maggio 1935 − Montevideo, 13 maggio 2025),
«Pepe» (come comunemente veniva chiamato) è stato un vero promotore di democrazia popolare, sostanziale, dove tutti i cittadini erano chiamati a riflettere sui grandi temi di fondo e su quelli all’ordine del giorno. I 10 anni che lo hanno visto al Governo (prima come ministro dell’Agricoltura e poi come Presidente della Repubblica), dal 2005 al 2014, sono stati un periodo di vera educazione politica grazie soprattutto alla sua vicinanza alla gente e ai suoi discorsi, con un linguaggio accessibile ai piú, uniti alle scelte del Frente Amplio (alla cui estrema sinistra c’era il suo Movimiento de Participación Popular, erede del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros): scelte che se non vedevano il Paese in accordo suscitavano però discussioni animate non solo nelle sedi istituzionali, ma anche nelle strade, nei circoli nelle chiese.
Le opzioni fondamentali
Era di dominio pubblico che la sua origine (e quella di sua moglie, Lucia Topolansky) era tra i guerriglieri Tupamaros di Raúl Sendic, un gruppo sorto negli anni Sessanta da una marcia in difesa dei diritti dei lavoratori della canna da zucchero che da Artigas arrivò a Montevideo e che si caratterizzò soprattutto per azioni dimostrative non violente (la marcia appunto, l’occupazione della Città di Pando…).
Un gruppo comunque armato, con le sue vittime, le cui azioni hanno portato al carcere (e alla tortura) molti dei suoi membri tra cui lo stesso Mujica (che in carcere aveva trascorso più di 10 anni), ma che ha saputo evolvere, dopo la fine della dittatura nel 1984, in un movimento politico le cui istanze sono state sempre a favore dei lavoratori, dei poveri, dei senza casa che vivevano nelle baraccopoli (gli «asentamientos»).
Mujica era fedele e carismatico interprete del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros e molte delle sue opzioni erano in realtà quelle del Movimento. Una su tutte: la proposta di legge, all’inizio di ogni legislatura, che ciascun parlamentare avesse uno stipendio corrispondente a quello di un operaio specializzato e, dal momento che la proposta non veniva mai approvata, la conseguente autotassazione per donare l’eccedente in favore di un fondo per la costruzione di case negli asentamientos.
Riconciliazione
José Mujica: un uomo che ha pagato per le sue scelte con il carcere, con uno stipendio normale, con una vita sobria o povera, rimedio secondo lui anche contro la violenza dei malviventi, che poco gli potevano rubare; non ha abbandonato la sua cascina in campagna alle porte di Montevideo neppure quando era Presidente, continuando a coltivare fiori con sua moglie.
«Io e Lucia», diceva, «abbiamo una piccola casa, che mettiamo a posto in 10 minuti alla mattina, così poi ci dedichiamo alle cose piú importanti e che più ci piacciono: la coltivazione dei fiori, la lettura…». E, al di là delle politiche contingenti, questo consigliava ai giovani e ai meno giovani: aprire la mente con la lettura, non perdere il vincolo con la terra da cui veniamo, vivere del proprio lavoro anche manuale. Solo così ci si può avvicinare a una progettualità politica che ricerchi il bene di tutti a iniziare dai più bisognosi.
Un tema ha però segnato particolarmente la sua traiettoria politica dopo la fine della dittatura: la riconciliazione. Il Paese era diviso tra coloro che avevano appoggiato l’esercito e coloro che ne avevano subito le violenze; lui stesso e sua moglie erano stati in carcere come la gran parte dei membri del loro Movimento. La riconciliazione e la giustizia erano un’urgenza per tutti i Governi che si sono succeduti.
Mujica ha contribuito alla riconciliazione con le parole, ma soprattutto con i gesti. Sono rimasti nella memoria collettiva le sue parole di richiesta di perdono la sera dell’elezione a Presidente verso coloro che avesse potuto offendere nella campagna elettorale; la trepidazione (nel ricordo di sua moglie Lucia, Presidente del Senato) mentre passava in rassegna l’Esercito, tra i cui alti gradi ancora erano presenti coloro che lo avevano imprigionato; la risoluzione rapidissima della crisi diplomatica causata dalle sue offensive parole, a microfoni non spenti, verso la Presidente Argentina Cristina Fernández de Kirchner e il suo defunto marito.
Quando fu eletto papa Francesco non si recò a Roma per la Messa Inaugurale del Pontificato, perché dichiaratamente non credente: volle vi andasse Astori, suo vice, perché cattolico; e quando dovette affrontare la legge sull’interruzione della gravidanza (che il suo predecessore Tabaré-Vásquez non volle firmare, perché medico) espresse il desiderio, non realizzabile, che si potesse arrivare a una conclusione senza offendere nessuno.

Il riposo del presidente povero
«Anche il guerriero ha diritto al suo riposo». Già a inizio anno l'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, morto questa notte all'età di 89 anni a Montevideo, aveva salutato la vita pubblica. «Il mio tempo è finito», aveva detto il 10 gennaio, rendendo pubblica la sua malattia - cancro all'esofago, che ha descritto con schiettezza - mentre chiedeva di «non rilasciare più interviste» ma di poter salutare affettuosamente i suoi connazionale. Verrà ricordato come il «presidente povero, e amico dei poveri» al quale neppure il potere ha tolto la capacità di sognare. L'ultimo sospiro di "Pepe" è stato annunciato su X dal suo delfino, il presidente uruguaiano Yamandú Orsi, che ha scritto: «Ci mancherai molto, caro vecchio. Grazie per tutto ciò che ci hai dato e per l'amore donato al tuo popolo».
Nato il 20 maggio 1935, Mujica ha militato nel Movimento di liberazione nazionale "Tupamaros" ed è stato detenuto per in quattro occasione, trascorrendo almeno 15 anni di prigionia. La sua ultima detenzione è avvenuta tra il 1972 e 1985, venendo preso in ostaggio dalla dittatura militare che governò il Paese nello stesso periodo. Con il ritorno della democrazia è stato parlamentare e ministro dell'Agricoltura e infine presidente della Repubblica oriental dell'Uruguay dal 2010 al 2015. Durante il suo governo è stato definito «il capo di Stato più umile del mondo» dalla testata londinese Bbc a causa del suo stile di vita semplice e della donazione del 90% del suo stipendio mensile, 12mila dollari, a poveri, Ong e piccoli imprenditori.
Ora l'America Latina piange un uomo entrato in politica per predicare con l'esempio. Lo stesso papa Francesco lo aveva definito un «esempio per la politica latinoamericana e del mondo» descrivendolo come «un politico di razza», tra quelli che sono a rischio estinzione. Fino a domani il suo "Paisito", piccolo Paese, come lo chiamava lui stesso, potrà dargli un ultimo saluto. Gli sarà dedicato un corteo funebre che partirà dal Palazzo di governo ("Torre Ejecutiva") facendo tappa in diversi punti di Montevideo, che ricordano alcuni passaggi della sua vita: dalla sede del "Frente Amplio", passando per il Movimento di Partecipazione popolare e il Palazzo legislativo.
Il Prof Giovanni Scambia...una Vita per i suoi pazienti

In ricordo del Prof Giovanni Scambia a 5 mesi dalla sua morte.
La sua passione educativa, la sua eredità
Monsignor Claudio Giuliodori
Un ritratto vivo e toccante del grande medico specialista in ginecologia oncologica di levatura mondiale, protagonista clinico e scientifico del Policlinico Gemelli, nell'omelia alle sue esequie.
Quello che proponiamo è il testo dell’omelia pronunciata dal vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, sabato 22 febbraio durante le esequie nella chiesa centrale dell'Università Cattolica di Roma del professor Giovanni Scambia, ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica e direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, a capo della Unità operativa complessa di Ginecologia oncologica, ma soprattutto figura di medico e di uomo di levatura eccezionale, come attestato dalle innumerevoli testimonianze nei giorni successivi alla sua repentina scomparsa. Al termine del testo, monsignor Giuliodori cita parole indimenticabili di Scambia, già affidate a un video realizzato dall’Università Cattolica pochi mesi prima.
Caro Giovanni,
mi permetto di rivolgermi a te come ho sempre fatto in questi anni in modo semplice e diretto, profittando di quella familiarità e amicizia che hai saputo offrire a tutti coloro che ti hanno conosciuto. E sono davvero tanti! Lo abbiamo visto anche in queste giornate, dal flusso ininterrotto di persone, autorità e semplici pazienti, che sono corse a darti l’ultimo saluto. Tutti profondamente addolorati, ma soprattutto grati e riconoscenti per aver potuto godere della tua presenza, dai familiari al mondo accademico, dai ricercatori al personale sanitario e amministrativo, dagli studenti ai pazienti che hai curato, soprattutto le tante donne affette da patologie oncologiche che hai seguito con grande competenza scientifica e premurosa sensibilità umana.
Vorremmo non essere qui per darti l’estremo saluto. Siamo tutti sconvolti e increduli per la rapidità con cui un male, da te ben conosciuto e tante volte curato, ti ha rubato alla vita e sottratto al nostro affetto. Una vita, la tua, davvero straordinaria che tutti abbiamo ammirato per quanto hai saputo realizzare e di cui siamo grati a te e al Signore.
Ti ringraziamo, in primo luogo, per l’instancabile e appassionata ricerca scientifica che ha caratterizzato i tuoi studi e il tuo impegno accademico e che ti ha visto raggiungere i più alti riconoscimenti internazionali fino a contribuire in modo determinante a trasformare anche il Policlinico Gemelli in uno dei più importanti Istituti di Ricerca a livello nazionale di cui sei stato dinamico e illuminato direttore. Una ricerca però mai finalizzata a se stessa, ma sempre orientata ad offrire le migliore e più innovative cure ai pazienti che hanno potuto trovare in te, e nella squadra che hai saputo creare, un riferimento sicuro per affrontare malattie e situazioni considerate fino a poco tempo fa inguaribili.
Così il secondo elemento che abbiamo potuto ammirare nella tua vita professionale, e di cui ti ringraziamo, è stata l’instancabile dedizione alle pazienti che sempre più numerose si sono rivolte a te e a questa istituzione sanitaria per trovare risposte alle loro complesse problematiche. Non ti sei mai sottratto alle urgenze e alle richieste, lavorando giorno e notte, e facendo tua le paure e le aspettative delle pazienti che confidavano nelle tua capacità di trovare soluzioni e di dare risposte, anche nei casi più difficili. Ogni caso una sfida a cui non ti sei mai sottratto, sviluppando una medicina personalizzata quanto mai mirata ed efficace. Il tuo prenderti cura di tutti e di ciascuno, nella ricerca delle soluzioni più innovative e appropriate, ha fatto nascere tante reti solidali che si sono tradotte anche in molteplici e straordinarie iniziative di fundraising e di sensibilizzazione culturale. “Note di Luce”, il tradizionale evento da te programmato per lunedì prossimo al all’Auditorium Parco della Musica, non è stata annullato perché questo è certamente il tuo desiderio.
Infine, ma non perché sia stato l’ultimo dei tuoi interessi ma piuttosto, penso di poter dire, il primo e più importante, la dedizione alla formazione degli studenti, degli specializzandi e dei ricercatori. In una parola la passione educativa che ha fatto fiorire attorno a te una scuola formidabile di giovani e di professionisti capaci di fare tesoro della tua sapienza e di seguirti riconoscendo in te un vero maestro di scienza e di vita. Ci lasci mentre è in corso a Roma Esgo un Congresso Mondiale sulla ginecologia oncologica con miglia di medici provenienti da tutto il mondo di cui tu e la tua scuola siete protagonisti indiscussi a livello internazionale.
Guardando a queste tue caratteristiche, richiamate in modo essenziale e certamente incompleto - chiunque dei presenti potrebbe aggiungere molto altro e in modo certamente migliore - ho immaginato quale Parola della Scrittura ti avesse ispirato e meglio potesse interpretare la tua sensibilità spirituale, dimensione non ostentata o appariscente, ma profondamente radicata in te e nel tuo animo inquieto sempre sinceramente alla ricerca della verità.
Dal libro della Sapienza ho tratto un brano che certamente avresti apprezzato e in cui probabilmente ti saresti riconosciuto perché - abbiamo letto -: «La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano». Ma soprattutto penso che la tua vita sia stata illuminata e plasmata da queste parole dell’autore sacro: principio della sapienza è «il desiderio di istruzione, l’anelito per l’istruzione è amore, l’amore per lei è osservanza delle sue leggi, il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità e l’incorruttibilità rende vicini a Dio».
E ora sei vicino a Dio e puoi presentarti a lui con tutto il bagaglio di sapienza che hai saputo coltivare in questi anni della tua vita terrena, certamente troppo brevi per noi, ma assolutamente preziosi davanti a Dio perché hai servito Lui nel volto di ogni malato. Come Buon samaritano ti sei preso cura, con sapienza e intelligenza, di tanti fratelli e sorelle provati dalla malattia.
Nella tua opera si è come incarnata la pagina del Vangelo di Marco che ho voluto riproporre perché seguendo la tua vocazione ti sei fatto interprete, con la tua peculiarità e originalità, di Gesù stesso vero medico dell’anima e del corpo. Tu non hai mai speculato sulle speranze o sulla disperazione delle persone malate, ma hai sempre saputo dare risposte concrete ed efficaci. Quante donne hanno cercato rifugio e conforto sotto il mantello della tua alta professionalità e hanno trovato speranza grazie al tuo sguardo scientifico e alla tua perizia chirurgica? Gesù si è servito anche di te per dire a tante donne ancora oggi; «Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
Il Signore ora ti attende in Cielo e certamente saprà ricompensarti per tutto il bene fatto. Ma oltre al Signore penso che ad attenderti ci saranno anche i nostri fondatori. Padre Agostino Gemelli che riconoscerà in te un interprete geniale del “sogno della vita sua”, e cioè di aver una Facoltà di Medicina e chirurgia dove scienza e fede si incontrano ai più alti livelli. Di questo incontro, fecondo e generativo, sei stato un interprete unico e straordinario, di cui tutti siamo ammirati e orgogliosi. Ma ad accoglierti ci sarà anche la Beata Armida Barelli, perché nel tuo cuore abbiamo tutti potuto vedere e sperimentare un riflesso di quel Sacro Cuore di fronte al quale la “grande anima” dell’Ateneo amava dire: «È impossibile? Allora si farà. Sacro Cuore mi fidi di te!». Oso pensare che anche tu la mattina presto quando ti fermavi a pregare nella cappella al terzo piano non mancavi di provocare il Signore affinché ti donasse coraggio e lungimiranza per trovare nuove e più efficaci cure per le tue pazienti o per spingere il Policlinico verso nuove e inedite sfide nel campo sanitario e della ricerca scientifica.
Ti salutiamo con un grande, immenso abbraccio da parte della tua famiglia e della grande famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Policlinico Gemelli. Ci lasci una formidabile eredità che speriamo di saper custodire e sviluppare. La tua passione e la tua opera l’hai sintetizzata a novembre nel bellissimo video in cui alla fine, e ora lo comprendiamo, ci consegnavi anche il tuo testamento che non possiamo non riascoltare ancora una volta dalla tua voce:
«C’è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani che dovranno costruire il futuro della nostra scuola e della nostra clinica, ed è quello di meravigliarsi dei progressi e delle conquiste, così come mi meraviglio ancora io oggi di dove siamo arrivati.
Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire ad una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino, o che l’intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure, eppure oggi è così.
Per chi scriverà la nostra storia il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie, magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme, di prendersi cura delle donne, e per questo ringrazio tutti, le nostre ostetriche, gli infermieri e tutto il personale paramedico, i neonatologi, i radiologi e radioterapisti, gli anestesisti, gli psicologi, gli anatomopatologi, gli studenti e gli specializzandi, e il personale che si prende cura del reparto, e tutti coloro che migliorano il nostro lavoro e tracciano la strada verso un domani, che voglio davvero immaginare luminoso ed emozionante, per tutti noi e per tutti voi».
Grazie Giovanni. Il Signore ti dia pace.
San Giuseppe Moscati...il medico di tutti

San Giuseppe Moscati, medico di Napoli
ricorrenza della nascita 25 luglio
Giuseppe Moscati, che da Santo gode di una grande devozione a Napoli, in realtà è nato a Benevento nel 1880 e aveva addirittura origini avellinesi. Figlio e nipote di magistrati, la sua vita professionale sembrava segnata, ma nessuno aveva fatto i conti con la sua grande fede che lo ha portato ben presto su una strada diversa…
“Il mio posto è accanto agli ammalati!”
Nel 1892, quando Giuseppe è un adolescente, suo fratello si fa molto male cadendo da cavallo e come conseguenza dell’incidente inizia a soffrire di epilessia. Sarà stato questo accorgersi precocemente della brevità della vita umana, l’essere colpito dalla sofferenza, o forse la visione continua dei malati dalla finestra della casa paterna che si affaccia sull’Ospedale degli Incurabili, che porta Giuseppe a preferire la facoltà di Medicina a quella di Giurisprudenza. Allora la medicina e la scienza in generale erano terreno fertile per il materialismo, ma Giuseppe riesce a tenerlo a distanza, alimentando la sua fede con l’Eucaristia quotidiana.
Il medico di tutti
Giuseppe si laurea brillantemente ed è un medico promettente: a nemmeno 30 anni diventa famoso per le sue diagnosi immediate e precise, che hanno del miracoloso considerando gli scarsi mezzi dell’epoca. A chi glielo fa notare lui risponde che è merito della preghiera, perché è Dio l’artefice della vita, mentre i medici non possono che essere indegni collaboratori. È con questa consapevolezza che va al lavoro ogni giorno, sia all’Ospedale degli Incurabili dove sarà nominato primario nel 1925, sia nel suo studio privato dove sono accolti tutti e dove non fa pagare i poveri, ma, anzi, li paga lui per essere andati a curarsi, sia nelle frequenti visite a domicilio in cui porta oltre all’assistenza medica anche il conforto spirituale. Si narra che una volta, dopo aver guarito un operaio da ascesso polmonare che tutti avevano scambiato per tisi, questi voleva pagarlo con tutti i suoi risparmi, ma Giuseppe gli chiese come onorario che andasse a confessarsi: “Perché è Dio che ti ha salvato”.
Scienza e fede
Oltre a dedicarsi alla cura dei malati, Giuseppe è anche un ottimo ricercatore che sperimenta le nuove tecniche e i nuovi farmaci, come l’insulina che dal 1922 inizia a essere utilizzata nella cura del diabete. É talmente abile nelle autopsie che nel 1925 gli viene affidata la direzione dell’Istituto di anatomia patologica. Non è inusuale vederlo farsi il segno della croce prima di operare su un cadavere, per il rispetto che si deve a un corpo che è stato un uomo amato da Dio. Per lui scienza e fede non sono due mondi lontani, separati e inconciliabili, ma due elementi che convivono nella sua quotidianità, fatta di una grande devozione per la Vergine Maria, di sobrietà e povertà personale alla sequela di San Francesco, e della scelta del celibato per avere più tempo per i suoi sempre più numerosi pazienti.
L’eruzione del Vesuvio e il colera
Ci sono due episodi importanti nella vita di Giuseppe Moscati che fanno meglio comprendere la grandezza di questa figura: l’8 aprile del 1906 il Vesuvio inizia a eruttare. Giuseppe capisce immediatamente la situazione e si reca a Torre del Greco, dove l’Ospedale degli Incurabili ha una piccola succursale, per mettere in salvo i malati. Quando anche l’ultimo paziente sarà al sicuro, la struttura, in effetti, crolla. Nel 1911, invece, a Napoli si diffonde un’epidemia di colera e anche stavolta Giuseppe sarà non soltanto accanto ai malati senza paura del contagio, ma anche in prima linea con le sue attività di ricerca che contribuiranno molto a contenere la malattia.
Medico e apostolo fino alla fine
Nello studio di Giuseppe Moscati si recano tutti, anche personaggi famosi quali il tenore Enrico Caruso e il Beato Bartolo Longo. A tutti riservava la stessa attenzione e la stessa scrupolosità, perché in ogni volto vede quello di Gesù sofferente. Nella sala d’attesa c’è una scritta per regolare gli onorari: “Chi può metta qualcosa, chi ha bisogno prenda”. È lì, al suo posto, sulla sua poltrona – quella diventata poi una reliquia da venerare – quel 12 aprile 1927 quando un infarto lo stronca all’età di 47 anni. Sarà canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1987 al termine del sinodo dei vescovi sulla vocazione e la missione dei laici all’interno della Chiesa.
Chiara Amirante..."si può risorgere da ogni disagio"
"Dio dell’impossibile, se mi metti nel cuore questa spinta io ti dico sì, ma tu mettimi nella condizione"
Chiara Amirante


Chiara Amirante sorride anche nei momenti difficili
nascita 20 giugno 1966
Lucia Bellaspiga
La risposta alla disperazione con un percorso di riscatto: «Dico il mio grazie a Dio per tutti coloro che sono stati nella morte e sono risorti spiritualmente». Parla la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti.
«Sono stata una bambina vivace e impegnativa, di quelle che bombardano i genitori di “perché?” e non si accontentano di risposte preconfezionate... Ma ho avuto la grazia di nascere da due genitori che si erano convertiti da poco, quindi nel momento della massima scoperta di questa grande notizia che troppo spesso si dà per scontata. Mi è andata bene». Ed è tuttora impegnativa, Chiara Amirante, 52 anni, ogni definizione le va stretta: laureata in scienze politiche alla Sapienza di Roma, autrice di bestseller e personaggio televisivo, soprattutto fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, nata 25 anni fa nei meandri della Stazione Termini per salvare 27 ragazzi dai loro inferni personali e oggi divenuta la casa spirituale di 700mila testimoni di luce nei cinque continenti. Lei sarà anche premiata alla Festa di Avvenire a Lerici, il 31 luglio.
Chiara, un quarto di secolo di Nuovi Orizzonti è un giro di boa non indifferente. Come lo sta vivendo?
Venticinque anni ti portano a riguardare indietro e contemplare con stupore quello che Dio ha operato. In realtà ogni giorno faccio questo esercizio di ringraziare il Padre, ma certamente farlo tutto insieme per i 25 anni mi ha colmato il cuore di commozione. Ho ripensato a quei primi giorni in cui, da ragazza, mi sono immersa nell’inferno della strada, tra tanti fratelli sofferenti, nella droga, nella disperazione, nell’abbandono dopo il carcere, nella prostituzione, e poi a quanti di loro sono passati dalla morte alla vita. Nel 1994 cominciavamo con la prima piccola comunità, in una villetta familiare mandata senza preavviso dalla Provvidenza, i materassi sparsi ovunque. Da quei 27 su cui nessuno avrebbe scommesso, vero popolo della notte, è poi fiorito questo popolo di “cavalieri della luce”, testimoni della risurrezione nelle stesse strade in cui prima vivevano di espedienti. Il giorno di Pentecoste a Frosinone eravamo in tremila a festeggiare questo anniversario, una folla di persone, ciascuno un miracolo. Ho visto le lacrime di tanti mentre a 82 ragazzi consegnavo quella piccola croce simbolo dell’essere consacrati come “Piccoli della gioia”, sapevo che quasi tutti i presenti erano stati nella morte ed erano risorti spiritualmente, e da lì è salito il nostro grazie a Dio di questa grande famiglia che sempre più ci chiama a essere testimoni di gioia per chi ha perso la speranza.
Lei è una consacrata, ma Nuovi Orizzonti è una realtà che ha molti volti ed esperienze diverse. Che cosa vi accomuna?
Per lo più noi abbiamo una consacrazione laicale, ci sono anche “Piccoli della gioia” sposati, sposi chiamati al servizio del Padre anche nel lavoro quotidiano, oppure nelle missioni, ovunque, le “Famiglie di Nazareth” che vivono una dedizione totale a Dio, aperte all’accoglienza. È questa la nostra caratteristica specifica, anche se poi abbiamo pure sacerdoti, religiosi e religiose: la consacrazione come “Piccoli della gioia” è per tutti gli stati di vita. Credo che sia un segno dei tempi se lo Spirito Santo sta mandando tanti carismi e chiama i laici là dove sono. Riflette ciò che già il Concilio chiariva, e cioè che la santità è una chiamata per tutti, non è qualcosa che possiamo delegare a sacerdoti e religiosi. Oggi soprattutto, in un mondo spesso radicato in «strutture di peccato », come le chiamava Giovanni Paolo II, c’è un’urgenza assoluta di sposi santi, di santi immersi nel mondo del lavoro, di professionisti santi, capaci di rinnovare la società da dentro. Va detto però che come Chiesa siamo un po’ indietro nel riconoscere il contributo che ciascun laico può portare: colpa di quel clericalismo duro a morire di cui parla papa Francesco. Il sacerdozio è un dono immenso, ma poi siamo tutti corpo di Cristo.
Quei genitori che lei da bambina bombardava di domande hanno fatto in tempo a vedere il suo cammino?
Poverini, sì. Sentirsi dire da una figlia che va a vivere in strada non è facile. Avevo sentito la chiamata a lasciare tutto per andare a vivere in strada con la mia nuova famiglia, ero anche guarita all’improvviso da una malattia incurabile... In una giornata di spiritualità, quando erano sotto l’azione dello Spirito Santo, ho detto loro che avrei lasciato la casa e il lavoro per seguire Gesù nei bassifondi della città... Per la grande stima che avevano di me mi hanno dato la loro benedizione, sapevano che se facevo delle pazzie era perché Dio me le metteva nel cuore, essendo io molto razionale. Ma poi papà ha cercato di farmi ragionare, diceva che per una ragazza era troppo pericoloso. Mamma ha capito subito che era una chiamata e niente mi avrebbe distolto, ma lui ha vacillato, «Se vuoi diventare santa fallo lontano da me, perché non posso morire di crepacuore », mi ha detto. Ma Dio non si lascia mai vincere in generosità e proprio il giorno in cui dovevo trasferirmi in strada con la mia nuova famiglia di disperati è arrivata dalla Provvidenza la prima struttura per iniziare l’accoglienza residenziale. Mamma e papà sono poi venuti a vivere nove giorni di ritiro spirituale con i 27 arrivati tutti da esperienze estreme...
Che cosa proponeva a questi ragazzi?
Di fare un’esperienza di risurrezione. «Non importa se credete che Gesù è figlio di Dio – dicevo loro –meditate almeno le parole di questo grande uomo che mi hanno portato a rischiare la vita per voi». Meditavamo la promessa di Gesù, che se chiediamo al Padre lo Spirito Santo egli ce lo dona: avevano i cuori tanto spezzati che nessun percorso umano avrebbe potuto trasformare i loro cuori di pietra in cuori di carne. Il nono giorno era la festa del Battesimo di Gesù. La maggior parte di loro non aveva mai pregato, ognuno ha chiesto lo Spirito in modo molto semplice, balbettando qualche parola. Non piangevano da quando erano bambini, ci siamo trovati tutti in lacrime e in quella cappellina siamo rimasti fino a sera, nessuno riusciva ad allontanarsi. Mio papà, vedendo questi lupi trasformarsi in angeli, si è tranquillizzato, innamorato di ciò che Dio stava operando non ci ha più lasciati.
Tra tanti salvati, è andata incontro a sconfitte?
Non credo nelle sconfitte. Quando Gesù ha vissuto il più grande fallimento, ha ottenuto la più grande vittoria per l’umanità. Dio è morto, ma da quella morte è avvenuto il miracolo dei miracoli. C’è nella nostra vita la terribile possibilità di dire “no” all’amore di Dio, il che è la tragedia della nostra esistenza ma anche la forza del libero arbitrio. La cosa bella è che ogni “no” può sempre ritornare a essere un “sì”. Poi è vero che quando perdi per strada qualcuno lì per lì ti arriva la spada nel cuore, ma per la mia lunga esperienza so che, se Dio ha seminato il suo amore in un cuore, quel cuore resta segnato e il più delle volte prima o poi ritorna. Certo, c’è sempre un Pietro che rinnega o un Giuda che tradisce, ma se un tempo mi scoraggiavo e soffrivo, ora è più forte la certezza che le tenebre non prevarranno.
A volte si sente sola?
Da 25 anni porto la croce terribile di raccogliere il grido lancinante dei fratelli, e non si arriva a tutti. Nonostante il Papa chieda di uscire nelle periferie esistenziali, l’indifferenza è ancora un grave peccato di omissione da parte di troppi. Ci sono poi tanti che attaccano il Papa: come si può avere la presunzione, da cattolici, di saperne più del Pontefice? Il Divisore è abile...
Come si spiega la presenza di tanti attori, cantanti, vip, attratti da Nuovi Orizzonti, da Nek a Bocelli a molti altri?
Me lo chiedo spesso. Certo nel mondo dello spettacolo c’è grande sete di spiritualità, di uscire dalle apparenze per trovare rapporti veri. Vedere in Nuovi Orizzonti le realtà di ragazzi rinnovati dal Vangelo, toccare con mano i miracoli di tante risurrezioni interiori, riaccende in loro una nostalgia. Il mondo ci propone una gioia patinata. Quando vedono la luce negli occhi dei nostri ragazzi, dicono: «La voglio anch’io questa luce, se ce l’ha fatta lui allora posso anch’io ». E da personaggi tornano a sentirsi persone.
Don Antonio Coluccia...la forza del Vangelo contro la criminalità

Don Coluccia fa rumore sulla piaga della droga. Quando ci svegliamo?
Maurizio Patriciello
Ben vengano la solidarietà, le strette di mano, le polemiche e le prese di posizioni politiche. Ben vengano i consigli dei superiori preoccupati per l’incolumità di questo prete affidato alle loro paterne cure. A don Antonio Coluccia, però, non interessa tanto la propria sicurezza – anche quella, ci mancherebbe – ma portare a galla un fenomeno malavitoso talmente incancrenito da essere diventato “normale”. Il dramma è questo, al Quarticciolo come a Caivano, a Tor Bella Monaca come a Scampia e in tante altre periferie. Don Antonio sa bene che non sarà una passeggiata della legalità a risolvere il problema, eppure insiste. E i fatti gli danno ragione se un semplice corteo riesce a far saltare i nervi ai malavitosi. Non è tanto il mancato introito di una sera, proveniente dalla droga, a preoccuparli, ma il fatto che una persona – un prete, addirittura - si sia permesso di accendere i riflettori su un mondo che – pur stando sotto gli occhi di tutti – avrebbe dovuto godere, secondo loro, di uno “statuto speciale”. Legge non scritta ma attuata.
«Qui comandiamo noi. Lasciateci in pace. Dobbiamo mangiare tutti. A ognuno il suo. Badate ai veri problemi del Paese…». Tutti sanno. E quando dico “tutti” intendo la Roma dei professionisti, degli imprenditori, degli industriali, delle forze dell’ordine, della gente comune, dei preti, ma, soprattutto, della politica. È a questo punto che l’operato di don Antonio diventa insopportabile. Con la sua impeccabile talare nera dalla quale non si separa mai – ammettiamolo, tanti lo avrebbero preferito in jeans e maglietta malandata, un cosiddetto “prete antimafia” - don Antonio ci richiama alle nostre responsabilità. Qual è, dunque, la vera intenzione di questo giovane religioso salentino? Attirare l’attenzione su di sé? Certo non manca chi ha la faccia tosta di affermarlo. La solita tiritera: vuole apparire, vuole andare in televisione, ama la ribalta, non sono fatti suoi, chi crede di essere, e scemenze del genere. In genere chi le inventa ha tutto l’interesse a farlo. La prima arma di difesa di chi naviga nel fango è il fango stesso. Messo in un’apposita macchina, serve a occultare, a sporcare, a insozzare, a fare perdere credibilità. Molto più dei colpi di pistola valgono le calunnie. Generano dubbi, acquietano le coscienze intorpidite, dividono, devastano.
A don Antonio, la capitale d’Italia deve molto. Credo che abbia tanto da insegnare a tutti, a cominciare da noi preti, continuamente invitati e trascinati, da papa Francesco a uscire dalle sacrestie, a sporcarci le mani, a sentire gli odori delle pecore e il puzzo di coloro che ne farebbero un boccone. I lupi non dormono, sempre alla ricerca dell’agnellino da sgozzare. I lupi sono scaltri, occorre – parola di Gesù – essere scaltri almeno al pari di essi. Scaltrezza come metodo, il fine è il bene comune. Un bene, cioè, che appartiene a tutti ma che alcuni vogliono accaparrarsi. Se c’è una cosa che preoccupa don Coluccia non è tanto la propria incolumità. Lui ha già messo in conto tutto. Quando mise mano all’aratro sapeva bene il rischio che correva. No, non è questo a rendere insonni le sue notti, a mettergli le ali ai piedi, a distrarlo durante la Messa. A turbarlo sono gli uomini della sua scorta, per i quali sente una grande responsabilità. Tra loro è nata un’amicizia bella. Si sorvegliano a vicenda. Ognuno teme e trema per la vita dell’altro.
Don Antonio non è un ingenuo ma un prete a tutto tondo. Non sta esagerando. Sta solo – come gli ha raccomandato il Papa – facendo rumore. Tant’ è che i nomi di questi quartieri della periferia romana, fino a ieri sconosciuti alla maggior parte degli italiani, oggi non lo sono più. Don Antonio ci sta tirando giù dal letto dove pigramente avremmo continuato a dormicchiare facendo finta che, in fondo, il problema non esiste. Non sto dicendo che eravamo all’anno zero, tutt’altro, voglio affermare, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che questa guerra alla criminalità la vinceremo solo stando insieme. Un esercito preparato dove anche l’ultimo dei soldati e dei volontari è necessario per conquistare la vittoria. Un giovane professionista, una volta, ebbe a criticare una mia affermazione. Avevo detto che, a ben guardare, il problema della droga sono anche gli stessi drogati. Non ne era convinto. Per questo lo ripeto qui. Se non ci fosse la domanda la risposta cadrebbe da sola. Occorre chiarire una volta per tutte che i consumatori di droghe – persone oneste, giovani, padri di famiglia – oltre a rovinare se stessi alimentano la stessa malavita che li angaria. Scendiamo in campo, tutti insieme.
A don Coluccia il nostro ringraziamento e le nostre raccomandazioni. Sii prudente, caro confratello. Di eroi morti ne abbiamo già troppi. Sono un vero pugno nell’occhio. Falcone e Borsellino, don Diana e don Puglisi, insieme alla numerosa schiera di martiri che li accompagnano, ci fanno male. Stanno a dirci che hanno dovuto rinunciare alla loro vita anche perché non sempre gli altri hanno fatto il proprio dovere. Ci rimproverano per la nostra negligenza, la nostra pigrizia, la nostra ottusità. Don Antonio, continua – come già in modo mirabile stai facendo – a darci calci negli stinchi. Da vivo, però. Con perseveranza, forza, prudenza e quella virtù desueta che tanto piace al nostro Dio, l’umiltà. E tutti noi, che leggiamo le gesta di questo povero prete, cerchiamo di apprenderne la lezione. Non lo lasciamo solo. Soli si muore. Lo ripeto per i duri di orecchi: soli si muore. Scendiamo in campo, facciamogli scudo, moltiplichiamo a dismisura non solo le passeggiate della legalità, ma tutto ciò che serve a riportare lo Stato nelle nostre periferie.

La lunga lotta di Don Antonio contro la criminalità di strada
data di nascita 2 giugno 1975
Da ex operaio in una fabbrica salentina, a sacerdote fondatore dell’opera “don Giustino” per gli emarginati. Una vita rivoluzionata nel giro di pochi anni e dedicata ai poveri e ai bisognosi. Ma allo stesso tempo molto «scomoda», addirittura un prete «da eliminare».
Don Antonio Coluccia lotta da anni per restituire dignità agli uomini della sua comunità e non solo, ma gli ostacoli incontrati lungo il percorso non sono stati pochi. Nel 2012 ha trasformato una villa confiscata a un boss della banda della Magliana, in una casa di accoglienza. Don Antonio in questi anni è stato oggetto di minacce di morte a seguito del suo impegno nella pastorale di strada.
A Roma e non solo, è un simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità, dalle cui mani cerca ogni giorno di strappare i giovani con le sue iniziative, con i valori dello sport – a San Basilio ha aperto una palestra della legalità con le fiamme oro della polizia di Stato – e con il suo coraggioso impegno.
È segno di testimonianza della fede con opere di carità e di vera azione pastorale.
Don Franco Monterubbianesi...un rivoluzionario concreto

Il testamento spirituale di don Franco Monterubbianesi: «Io sono colpevole»
Pino Ciociola
Questo “Io sono colpevole” l’ha dettato a Luca prima d’andarsene, martedì scorso, tre giorni prima di compiere 94 anni. Il testamento spirituale di don Franco Monterubbianesi, fondatore della Comunità di Capodarco ( nella foto)
“Io sono colpevole – si legge -, colpevole di aver amato il prossimo, colpevole di aver pregato per tutti, colpevole di essere stato progressista o anche di più (e ride, ndr), sì sono colpevole del bene che ho voluto al mondo e agli ultimi, d’aver aiutato chi era considerato immeritevole o scansafatiche, colpevole di aver preso la parola, di non averla lasciata a quegli uomini che si credevano innocenti in una società in cui gli esclusi erano colpevoli solo di essere nati”.
Non era da mezze parole o mezze verità, don Franco. Va avanti: “Chi si ricorda delle mele marce? Così vi chiamavano, invece voi avete fatto la Storia... Perché Capodarco è la Storia! Ma da colpevoli siete tornati a essere abbandonati, poveri, umili, piccoli innocenti e non siete più solo italiani, perché il Signore ci dice sempre di aprirci al Mondo”.
“Non esistono colpevoli, non esistono innocenti”, ripete don Franco, come ha fatto per l’intera vita: “Ci sono gli Uomini, come genere umano, e hanno bisogno di progetti per essere vivi, hanno bisogno di creare e non di distruggere”. Al contrario, i colpevoli “sono gli ‘ignavi’, gli indifferenti e anche se a volte sono molto arrabbiato con chi non mi risponde al telefono, oggi devo perdonarlo”. Capodarco “è nata non giudicando, così deve continuare”. Continua: “Qui non abbiamo mai giudicato... Come potevo giudicare io, che ero più pazzo dei matti?”
È anche a tratti amaro, don Franco, nel suo testamento spirituale: “Questa non è la prima volta che muoio, siamo morti un po' a ogni fine, ogni volta che un pezzo se ne andava”, eppure “per poi risorgere sempre, perché noi siamo i Giovani di Capodarco e allora voglio che questa sia una festa per voi e un nuovo inizio”.
Detta le sue volontà, prima di salutare: “Non dovete disunirvi e non dovete star qui a litigare – fa scrivere chiaro -. Quando una mano è tesa, afferratela sempre anche voi che oggi vi sentite ultimi, che vi sentite esclusi, tenete strette le relazioni in famiglia, con i figli, con gli amici, con la Fede e alimentate sempre la Speranza. Pensate a un Noi e sarete più sereni perché costruirete qualcosa di bello”.
Sorride, don Franco. “Noi tutti siamo qui e il mio amico Luca, l'Americano e amico dell'Africa, che cura il progetto con il Catholic Land Movement negli Usa a cui teniamo tanto, che mi dice che è meglio non dilungarmi (sorride ancora, ndr)”. Invece va avanti: “Fate che il vostro cuore di pietra si trasformi in un cuore di carne, guardate i poveri, i giovani, l'Africa, guardate il mondo e pensate che esistano solo uomini la cui unica colpa sarà quella di non stare insieme, di distruggere e non costruire”.
La sua volontà, ancora: “Dovete lasciare una traccia di voi su questa vita, non ci abbandonate, state vicini a tutti gli uomini bravi, alle famiglie che abbiamo formato e solo così a ogni caduta risorgeremo. Gesù e Maria ci vogliono bene sempre”. Del resto, anche “io vi voglio bene, a tutti, anche quando mi avete causato molta sofferenza e ho tanti ricordi belli dalla mia famiglia”.
“Alla fine, qui, in un letto, è stata durissima, però ora è tempo di andare”, dice, avvicinandosi al commiato: “Quattro anni fa avevo ho chiesto al signore altri cinque anni, ma a voi ne spettano mille e più, se sarete uniti, sinceri e come dicono i miei giovani, non vi disunite!”. Allora, “guardate tutti questi ragazzi, giovani e vecchi amici, che mi hanno fatto compagnia e pensate che sono stato arrabbiato a volte, ma sempre felice, perché questo bene è di tutti”.
Ed ecco l’addio o l’arrivederci: “Ho detto abbastanza – chiude don Franco -. Però dovete chiedere ed essere degli "scocciatori" come me, capito? E bisogna partire sempre da voi giovani e raccontare tutto questo fermento. Ciao. Ciao. Ciao”.

Capodarco, così don Franco ha reso concrete le parole dignità e diritti
Don Franco Monterubbianesi è scomparso a 94 anni lo scorso 27 maggio. Nelle parole del direttore generale della Comunità di Capodarco dell'Umbria il ricordo del fondatore. «Non era un santo», sottolinea «era un uomo, con i suoi difetti, ma anche con una forza e una visione che hanno ispirato e cambiato la vita di molti». Non un visionario teorico, ma un rivoluzionario concreto
Riccardo Sollini
Il 27 maggio 2025, all’età di 94 anni, è venuto a mancare Don Franco Monterubbianesi, fondatore della Comunità di Capodarco. I racconti epici di quel Natale del 1966 fanno ormai parte della storia di trasformazione del nostro Paese.
L’intuizione di Don Franco, condivisa con altri compagni di strada, ha saputo trasformare le parole “dignità” e “diritti” in azione concreta per conquistarli.
Lo spartiacque alla fine degli anni ’60
Fu un passaggio epocale, che si inseriva nel contesto della nascita del nostro Welfare State. La fine degli anni ’60 rappresentò uno spartiacque culturale: i diritti non erano più vissuti come concessioni esterne, ma come responsabilità collettive e individuali.
La nascita della Comunità di Capodarco, come di altre esperienze simili, ruppe uno schema profondamente radicato nella società: quello dell’assistenzialismo caritatevole. Al suo posto, si affermava l’idea rivoluzionaria che vivere la propria vita in pienezza fosse un diritto.
Don Franco Monterubbianesi
La vita di Don Franco è stata segnata da un sogno inseguito con ostinazione quasi ossessiva, diventato la priorità quotidiana del suo impegno.
Aveva la straordinaria capacità di percepire ciò che nella nostra società non funzionava, e il bisogno incessante di raccontarlo, narrarlo, diffonderlo con ogni mezzo possibile.
Non conosceva stanchezza lui, ma metteva alla prova la pazienza di chi lo circondava, insistendo, incalzando, tornando sullo stesso punto fino allo sfinimento – degli altri, non suo.
Lo sguardo mondialista e l’agricoltura sociale
Aveva compreso l’urgenza di uno sguardo mondialista: chi si fa carico degli ultimi non può ignorare le ingiustizie che attraversano ogni angolo del pianeta. È stato tra i primi a legare l’accesso ai diritti con la necessità di proteggere il creato. In un periodo della sua vita, si lasciò ispirare profondamente dal concetto di Pachamama, che inseriva in ogni riflessione come chiave di connessione tra giustizia sociale e giustizia ambientale.
Fu anche tra i primi a intuire il potenziale dell’agricoltura sociale come strumento di riscatto, e coltivò con tenacia il sogno del “dopo di noi” – o, come diceva lui, del “dopo di noi durante il noi” – pensato come orizzonte concreto per garantire un futuro alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Le sue intuizioni erano immersioni visionarie, spesso premonitrici dei tempi che sarebbero venuti.
La capacità di generare trasformazioni
Era un visionario, sì, con una dose di quella follia che caratterizza chi ha il coraggio di aprire porte nuove. Una follia difficile da gestire per chi, intorno a lui, ragionava secondo schemi più lineari, o si doveva fare carico delle difficoltà economiche e gestionali che i sogni messi nelle mani sbagliate hanno generato. Ma una follia necessaria, capace di generare trasformazioni. A volte diventava ossessione, e poteva suscitare rabbia, specie alla decima telefonata sullo stesso tema.
Don Franco non era un santo, come è stato forse descritto in modo un po’ troppo agiografico nei giorni successivi alla sua morte. Era un uomo, con i suoi difetti, ma anche con una forza e una visione che hanno ispirato e cambiato la vita di molti. Due articoli letti in questi giorni mi hanno colpito profondamente e mi hanno aiutato a comprendere la portata della rivoluzione che ha saputo mettere in atto. Due persone con disabilità, in modo diverso, lo hanno ringraziato per aver donato loro una seconda vita. Sono persone che oggi rappresentano un esempio di lotta e trasformazione, attivisti che si battono per migliorare le condizioni di vita degli altri.
Sono cambiati gli occhi con cui guardare la realtà
L’intuizione della Comunità di Capodarco ha permesso di affermare, con serietà e concretezza: si può fare. Sì, una persona con disabilità ha il diritto di sposarsi, di inseguire i propri sogni, di creare spazi di cura, di farsi carico delle fragilità altrui. Le fragilità non spariscono, ma possono essere trasformate in risorsa. Non si guarisce dalla propria condizione, ma quella condizione non è più il centro della vita.
Si aprono altre opportunità, si sviluppano altre competenze, si attivano altre intelligenze. Con questi nuovi “occhiali”, mi sento di dire che da quel momento in poi il mondo non è stato più lo stesso. Perché sono cambiati proprio gli occhi con cui guardiamo la realtà, e la consapevolezza che ciascuno ha il diritto di trasformare lo sguardo su di sé.
Forse questa è la rivoluzione più grande: tendere la mano non per accudire, ma per stare accanto e dire: «La tua vita può essere diversa. Si può fare. Guarda oltre, pretendi di essere altro». Una nota personale. Ho ancora almeno dieci messaggi in segreteria di Don Franco. Ripensandoci, mi rendo conto che la sua necessità costante di lanciare intuizioni, di spostare continuamente l’obiettivo, andava spesso in contrasto con il mio modo di essere. Più volte mi sono innervosito, molte più di quante gli abbia detto grazie. Forse è stato un errore.
Per questo, voglio ringraziare Nunzia Coppedè della Comunità Progetto Sud e Francesca Bondì della Comunità di Capodarco di Perugia. Sono loro che mi hanno aiutato oggi a comprendere davvero il messaggio e, soprattutto, l’azione concreta che Don Franco è riuscito a introdurre.
Da visionario teorico quale era ritenuto, è stato in realtà un rivoluzionario concreto.
Paolo Dall'Oglio...esser Chiesa del dialogo

“Per ragioni che hanno a che vedere con l’impegno della mia vita, questa è una guerra civile che lacera la mia anima. Vorrei fare qualcosa per fermarla… Ma non voglio vivere una vita che sia altro da un dono radicale”
Paolo Dall'Oglio

Paolo Dall'Oglio, maestro di umanità
«Prendersi cura di una persona di qualsiasi classe sociale, simpatia o pesantezza, aveva la precedenza su tutto, perfino sull’appuntamento della preghiera. Paolo aveva davvero a cuore le persone, che considerava sacre perché espressione diretta di Dio». Padre Jihad Youssef, 47 anni, è il superiore della comunità monastica di Deir Mar Musa al-Habashi (monastero di San Mosè l’Abissino) in Siria, fondata nel 1991 da padre Paolo Dall’Oglio.
Al gesuita, di cui non si hanno notizie dal 29 luglio 2013, quando venne rapito da un gruppo di estremisti islamici vicino ad al-Qāida, è legato in maniera indissolubile: «In me, Paolo, tu vivi», scrive nella toccante prefazione al libro Paolo Dall’Oglio. Il mio testamento, appena pubblicato dal Centro Ambrosiano. «In noi, tua comunità, tuoi amici, sei vivo. Uno come te, Paolo, non può morire. Anche se fossi morto nel corpo, rimani vivo in Dio».
L’INCONTRO CON DIO
La vita di padre Youssef è stata del tutto trasformata dall’incontro con la comunità di Mar Musa. Siriano, originario della Chiesa maronita, da ragazzo Jihad fa parte dei giovani del gruppo di preghiera Equipes Notre Dame.
«A 19 anni siamo stati a Mar Musa trascorrendo lì una notte in un ambiente primitivo, non c’era nemmeno l’elettricità. Abbiamo celebrato Messa e il Signore mi ha pescato: il mio cuore non è più tornato a casa», ricorda. «Dopo qualche mese sono stato nuovamente a Mar Musa e ho confidato a padre Paolo il desiderio di diventare monaco.
Siamo rimasti d’accordo che prima avrei portato a termine gli studi». Il tempo di concludere il corso di laurea in Scienze motorie e Jihad, violino e zaino in spalla, è di nuovo a Mar Musa: «Volevo fare il ragazzo di mondo, tutto muscoli e musica, ma a casa non ero più in pace: sono tornato al monastero il giorno dopo la laurea». Accolto a Mar Musa nel 1999, nel 2008 diventa sacerdote. Studia poi Sacra Scrittura al Pontificio istituto biblico di Roma e consegue il dottorato in Teologia biblica alla Gregoriana.
LA VITA COMUNITARIA
Gli anni con padre Paolo lo formano come uomo e come cristiano. E se la comunità di Mar Musa è consacrata al dialogo islamo-cristiano, padre Youssef non ha remore nell’ammettere che «la vita comunitaria è in sé la sfida più grande, più grande anche del dialogo interreligioso»:
«La comunità è la fornace che ci purifica dai nostri limiti e iniquità, è il posto dove nascono le difficoltà e in cui germoglia l’armonia. Paolo non desiderava l’obbedienza cieca quanto il confronto, non aveva segreti e capitava che ci riprendesse davanti a tutti. La trasparenza nelle relazioni era per lui la via per non accumulare nel cuore amarezza e rammarico. Credeva poi fermamente nell’uguaglianza fra tutti: uomini e donne, grandi e piccoli, forti e deboli, intellettuali e no, superiori e novizi».
L’esperienza comunitaria – prosegue il monaco – è scuola di vita: «Essere superiore costa fatica e chiede tanta disponibilità, d’altra parte non siamo stati battezzati per riposare ma per servire. Il nostro desiderio è rimanere a Mar Musa fino alla seconda venuta di Cristo, portando avanti ciò che il Signore ha seminato nei nostri cuori, lavorando sulla nostra vita spirituale in comunità. Il combustibile è la grazia del Battesimo, che ci dà la forza di sopportare una vita gomito a gomito con persone diverse da noi».
PADRE PAOLO, UNO SPIRITO LIBERO E PROFONDO
Nato a Roma nel 1954, padre Paolo Dall’Oglio entra nella Compagnia di Gesù a 21 anni. Dopo trent’anni in Siria al lavoro per il dialogo interreligioso, nel 2012 è espulso dal Paese per le sue posizioni contro il regime. L’anno successivo rientra due volte in Siria impegnandosi nelle trattative per la liberazione di alcuni ostaggi fra cui due vescovi, uno siro-ortodosso, l’altro greco-ortodosso. Di lui non si hanno più notizie dal rapimento, il 29 luglio 2013 a Raqqa. Lo scorso ottobre la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sul sequestro per l’impossibilità di accertarne la sorte dal punto di vista giudiziario. «Uno sguardo non fondamentalista, ma lieve, pieno di quella speranza che non delude perché riposa in Dio. Sempre aperto al sorriso»: così papa Francesco parla di lui nella prefazione a Paolo Dall’Oglio. Il mio testamento (Centro Ambrosiano), ricordandolo come uno «spirito libero» con «grande profondità di visione».
IL LASCITO DI PADRE PAOLO
Oggi la comunità di Mar Musa, che si trova a circa 80 chilometri a nord di Damasco, è composta da otto monaci, «nove con Paolo»: «Quattro monache, tre monaci e un novizio. Siamo cinque siriani, una libanese, una tedesca e uno svizzero». Fino allo scorso marzo ne faceva parte anche padre Jacques Mourad, co-fondatore della comunità, da marzo arcivescovo di Homs, Hama e Nebek.
«Noi monaci e monache abbiamo lasciato tutto per seguire Dio, ogni giorno ci chiediamo come fare per camminare verso un discepolato vero. Non bisogna aggrapparsi a piani immodificabili ma, data la velocità dei cambiamenti, rimodulabili ogni anno», spiega Youssef. «Andiamo avanti cercando di essere aperti alla grazia dello Spirito, cercando di capire che forma prenderà la fratellanza islamo-cristiana e cercando di innescarla, ad esempio, con progetti per i giovani e l’ambiente».
A Mar Musa la giornata comincia con il caffè delle 7. «Prima ciascuno prega, legge o medita. Poi alle 7.30 recitiamo le Lodi e ci intratteniamo per un’ora di catechismo», racconta ancora Youssef. Ed è proprio in questi momenti di catechesi che, fra il novembre 2011 e il giugno 2012, padre Paolo commentò la Regola di Mar Musa.
Le riflessioni di allora oggi sono raccolte nel già citato Il mio testamento. «In quelle conferenze Paolo desiderava consegnare a noi, e alla Chiesa, l’essenza del suo pensiero. Ci intrattenevamo per un paio d’ore: gli argomenti erano tanti, legati ai tre voti di povertà, castità e obbedienza, e al nostro carisma. A riprendere in mano Il mio testamento, emerge come al centro di tutto ci sia la relazione con Dio e come l’uomo avanzi nella maturazione dell’amore per Dio e per il prossimo.
Si riflette sul dialogo islamo-cristiano, la sacralità dell’ospite, e si affronta anche la questione antropologica: dalla sessualità alla relazione uomo-donna, dall’omosessualità alle questioni di genere, che in tante società non si vivono in modo sereno e sono un tabù anche per la Chiesa».
LA SPERANZA OLTRE LA GUERRA
Sono passati dieci anni da quando di padre Paolo si sono perse le tracce. Da allora la situazione in Siria non è certo migliorata, anzi. Nel Paese, squassato da più di dieci anni di guerra civile e dalla violenza cieca del regime di Bashar al-Assad, nonché dall’ultima disgrazia del terremoto dello scorso febbraio, le Nazioni unite stimano in oltre 15 milioni le persone che necessitano di aiuti umanitari, su un totale di 22 milioni abitanti.
«Il popolo è angosciato e depresso» commenta Youssef. «Non puoi pensare ad altro se non al pane e alla scuola dei ragazzi. Nel cuore umano la speranza c’è ancora, resiste perché siamo un popolo vivo e creativo, ma l’incertezza rende la vita un sopravvivere». Nonostante tutto, padre Youssef è un uomo sereno: «Paolo mi ha insegnato che il Signore viene prima di tutto e non c’è che un solo Signore. A tenere alta la speranza è Dio, l’immagine di Dio in noi. Non trovo altra giustificazione a questa nostra resistenza».
di Laura Bellomi
DUE LIBRI L’ATTUALITÀ DI PADRE DALL’OGLIO
Nel decimo anniversario del rapimento di padre Paolo Dall’Oglio sono stati pubblicati due libri utili per conoscere meglio la sua figura e la sua storia. Il libro Il mio testamento, a cui accenniamo nell’intervista con padre Jihad Youssef, è pubblicato dal Centro Ambrosiano con la prefazione di papa Francesco. Si tratta di un vero e proprio testamento spirituale, da cui emergono chiari i temi più cari a Dall’Oglio.Verrà presentato il 29 luglio alla chiesa di Sant’Ignazio a Roma alla presenza, tra gli altri, proprio di padre Youssef. Una mano sola non applaude di Riccardo Cristiano è invece il testo pubblicato da Àncora. Come da sottotitolo, ripercorre la storia di padre Paolo Dall’Oglio letta nell’oggi. Viene presentato il 24 luglio alle 18.30 alla Biblioteca europea di Roma alla presenza – tra gli altri – di Francesca e Immacolata Dall’Oglio, sorelle di padre Paolo, e di Jacques Mourad, arcivescovo di Homs e cofondatore della comunità di Mar Musa.
Don Gallo..il prete degli ultimi


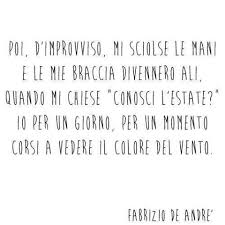
“Chi riconosce l’appartenenza alla famiglia umana, come fa a non aprire le porte?
Poi io, come cristiano, come faccio a non essere accogliente?
E io ti accolgo come sei"
Don Gallo

Don Gallo a dieci anni dalla morte: «Continuiamo le sue battaglie»
Il prete di strada scomparso nel 2013 non è stato dimenticato. I suoi valori di accoglienza e solidarietà vivono nonostante il vento politico contrario nella Comunità di San Benedetto da lui fondata. E che continua a essere meta del pellegrinaggio di politici e intellettuali
di Massimiliano Salvo
Nella trattoria A’ Lanterna, a Genova, è ancora tutto identico: il chiasso, l’odore di fritto, le foto di vip alle pareti. E le citazioni: Don Gallo di qua, Don Gallo di là. Perché fu proprio il prete di strada, all’inizio degli anni ’80, a immaginarsi in queste tre stanze qualcosa di impensabile per l’epoca: un ristorante gestito da persone con problemi di dipendenza. «E oggi eccoci qui», dicono gli eredi del progetto, una ciurma un po’ incasinata tra i fornelli e la sala. Maura, capello bianco, da dietro al bancone allunga il dito: «Don Gallo si sedeva lì, in quel tavolo ovale».
Il 22 maggio saranno dieci anni dalla morte del prete di strada, educatore, attivista, saggista e fondatore della Comunità di San Benedetto al Porto. «Non una comunità di recupero, ma una comunità di accoglienza», ripete Domenico Chionetti detto “Megu”, che di Don Gallo è stato portavoce ed è da sempre in prima linea nel portare avanti le sue battaglie.
Non è stato semplice: subito dopo la morte del “Gallo” nella stessa Comunità c’era il timore che fosse difficile continuare con lo stesso slancio. E invece l’associazione ha resistito ed è ancora protagonista della vita sociale e politica di Genova, dove il 22 maggio doveva tenersi una giornata di eventi per ricordare il sacerdote, rinviata a luglio dopo la tragedia dell’Emilia Romagna. Hanno aderito Moni Ovadia, Dori Ghezzi, Africa Unite e Walter Massa (presidente nazionale di Arci). A volere la giornata è stata la Comunità, non le istituzioni locali: anche perché rispetto agli ultimi anni della vita di Don Gallo il contesto politico è completamente cambiato.
Dieci anni dopo: la destra dilaga, gli amici rimangono
Quando Don Gallo morì, a 84 anni, Genova e la Liguria erano in mano al centrosinistra mentre oggi il centrodestra del sindaco Marco Bucci e del presidente Giovanni Toti non hanno rivali; a livello nazionale Fratelli d’Italia aveva il 2% e la Lega il 4%, ora governano. La Comunità però è ancora in prima linea nelle lotte per diritti civili e sociali, ed è una tappa simbolica nelle visite genovesi per una certa sinistra politica e culturale. Tanto per dire: il comizio di Elly Schlein, il venerdì sera prima delle primarie del Pd, è stato in piazza Don Gallo, nel “ghetto” di Genova, zona dimenticata popolata da spacciatori e prostitute.
A metà aprile, come tradizione, il segretario della Cgil Maurizio Landini è stato a Campoligure nell’entroterra di Genova, paese natale della famiglia di Don Andrea, dove il prete è sepolto e dove ogni anno la Comunità ricorda la Liberazione. «Don Gallo era cattolico, ma anche partigiano e militante comunista: e non ci vedeva nessuna contraddizione», lo ricorda il suo caro amico Moni Ovadia, attore e scrittore. «Dal punto di vista cristiano era un santo, dal punto di vista ebraico un “giusto”. Si batteva per l’uguaglianza e la giustizia sociale e lo faceva con una passione vibrante». Tra battute e sbuffi di sigaro Don Gallo era un uomo di relazioni, ed è infatti lunga la lista di amici e sostenitori della Comunità: da Vasco Rossi e Ilaria Cucchi a Nicola Fratoianni e Vauro, passando per Vito Mancuso, Dario Vergassola, Fiorella Mannoia, Però Pelù, i Subsonica, Caparezza, Erri De Luca, Dori Ghezzi.
Per rendersi conto degli intrecci del sacerdote basta fare un salto nel suo archivio: tra le decine di agende spicca quella del 2001, anno del G8 di Genova. In quei giorni di manifestazioni gli appuntamenti del Don erano senza sosta: “intervista con Mario Monicelli”, “cena con Manu Chao”, “marcia con Franca Rame”, “intervista a Porta a Porta”. «Don Gallo andò al concerto di Manu Chao, il giorno dopo Manu Chao venne nella nostra sede», ricorda la storica aiutante del sacerdote, Liliana “Lilly” Zaccarelli. «Aveva un assegno per noi. “Serve per dar da mangiare alla gente”, ci disse».
La Comunità oggi
Oggi la Comunità ha una trentina di dipendenti ma non ama dare numeri, memore di quando in passato tutti chiedevano a Don Gallo: «Quanti ne salvate?». E lui piccato rispondeva: «Che importa? Degli altri cosa facciamo, li ammazziamo?», per sottolineare una visione non salvifica, ma di rispetto anche per chi non riusciva a liberarsi dalla dipendenza. L’impegno della Comunità in questo campo è intanto diventato meno rilevante, tanto che delle cinque comunità di un tempo oggi ne sopravvivono tre: dal dilagare dell’eroina negli anni ’70 il mondo delle dipendenze è cambiato: «Ma la vocazione è identica», spiega Marco Malfatto, presidente della Comunità. «Ci occupiamo di persone e di bisogni, di essere umani, luoghi, quartieri».
I bisogni cui risponde la Comunità si sono quindi ampliati: verso le vittime della tratta, delle nuove povertà e del gioco d’azzardo, oppure con l’aiuto ai migranti; ma anche con l’offerta di servizi in zone problematiche, e con la solidarietà in ottica di economia circolare grazie alla raccolta di abiti usati e la lotta agli sprechi del cibo. «La persona resta al centro: ma davvero, non per modo di dire», spiegano Malfatto e “Megu” Chionetti. «La grande eredità di Don Gallo è la sua pedagogia: è importante la scelta, la motivazione di ognuno».
Il fulcro di questo mondo continua a essere la trattoria di fronte al porto, in via Milano 134r, luogo di emancipazione e incontro, laboratorio politico e di riflessione. Dove il cuoco o il cameriere possono essere un richiedente asilo un ex carcerato, e a tutti i commensali è data la stessa importanza: che si tratti di un magistrato, un cantante, un politico, un portuale. «Qui non c’è una classe sociale, non si fanno distinzioni», ripete chi ci lavora, con orgoglio. «Perché questa è A’ Lanterna di Don Gallo. E a tavola, come diceva Don Andrea, siamo tutti uguali».

Don Andrea Gallo
“Un prete che si è scoperto uomo”
Andrea nasce a Genova il 18 Luglio 1928 e viene immediatamente richiamato, fin dall’adolescenza, da Don Bosco e dalla sua dedizione a vivere a tempo pieno “con” gli ultimi, i poveri , gli emarginati, per sviluppare un metodo educativo che ritroveremo simile all’esperienza di Don Milani, lontano da ogni forma di coercizione.
Attratto dalla vita salesiana inizia il noviziato nel 1948 a Varazze, proseguendo poi a Roma il Liceo e gli studi filosofici.
Nel 1953 chiede di partire per le missioni e viene mandato in Brasile a San Paulo dove compie studi teologici: la dittatura che vigeva in Brasile, lo costringe, in un clima per lui insopportabile, a ritornare in Italia l’anno dopo.
Prosegue gli studi ad Ivrea e viene ordinato sacerdote il 1 luglio 1959.
Un anno dopo viene nominato cappellano alla nave scuola della Garaventa, noto riformatorio per minori: in questa esperienza cerca di introdurre una impostazione educativa diversa, dove fiducia e libertà tentavano di prendere il posto di metodi unicamente repressivi; i ragazzi parlavano con entusiasmo di questo prete che permetteva loro di uscire, poter andare al cinema e vivere momenti comuni di piccola autogestione, lontani dall’unico concetto fino allora costruito, cioè quello dell’espiazione della pena.
Tuttavia, i superiori salesiani, dopo tre anni lo rimuovono dall’incarico senza fornirgli spiegazioni e nel ’64 Andrea decide di lasciare la congregazione salesiana chiedendo di entrare nella diocesi genovese: “la congregazione salesiana, dice Andrea, si era istituzionalizzata e mi impediva di vivere pienamente la vocazione sacerdotale”.
Viene inviato a Capraia e nominato cappellano del carcere: due mesi dopo viene destinato in qualità di vice parroco alla chiesa del quartiere Carmine dove rimarrà fino al 1970, anno in cui verrà “trasferito” per ordine del Cardinale Siri.
Nel linguaggio “trasparente” della Curia era un normale avvicendamento di sacerdoti, ma non vi furono dubbi per nessuno: rievocare quel conflitto è molto importante, perché esso proietta molta luce sul significato della predicazione e dell’impegno di Andrea in quegli anni, sulla coerenza comunicativa con cui egli vive le sue scelte di campo “con” gli emarginati e sulle contraddizioni che questa scelta apre nella chiesa locale.
La predicazione di Andrea irritava una parte di fedeli e preoccupava i teologi della Curia, a cominciare dallo stesso Cardinale perché, si diceva, i suoi contenuti “non erano religiosi ma politici, non cristiani ma comunisti”.
Un’aggravante, per la Curia è che Andrea non si limita a predicare dal pulpito, ma pretende di praticare ciò che dice e invita i fedeli a fare altrettanto: la parrocchia diventa un punto di aggregazione di giovani e adulti, di ogni parte della città, in cerca di amicizia e solidarietà per i più poveri, per gli emarginati che trovano un fondamentale punto di ascolto.
Per la sua chiara collocazione politica, la parrocchia diventa un punto di riferimento per molti militanti della nuova sinistra, cristiani e non.
L’episodio che scatena il provvedimento di espulsione è un incidente verificatosi nel corso di una predica domenicale: lo descrive il settimanale “Sette Giorni” del 12 Luglio 1970, con un articolo intitolato “Per non disturbare la quiete”.
Nel quartiere era stata scoperta una fumeria di hashish e l’episodio aveva suscitato indignazione nell’alta borghesia del quartiere: Andrea, prendendo spunto dal fatto, ricordò nella propria predica che rimanevano diffuse altre droghe, per esempio quelle del linguaggio, grazie alle quali un ragazzo può diventare “inadatto agli studi” se figlio di povera gente, oppure un bombardamento di popolazioni inermi può diventare “azione a difesa della libertà”.
Qualcuno disse che Andrea era oramai sfacciatamente comunista e le accuse si moltiplicarono affermando di aver passato ogni limite: la Curia decide per il suo allontanamento dal Carmine.
Questo provvedimento provoca nella parrocchia e nella città un vigoroso movimento di protesta ma, la Curia, non torna indietro e il “prete scomodo” deve obbedire: rinuncia al posto “offertogli” all’isola di Capraia che lo avrebbe totalmente e definitivamente isolato.
Lasciare materialmente la parrocchia non significa per lui abbandonare l’impegno che ha provocato l’atteggiamento repressivo nei suoi confronti: i suoi ultimi incontri con la popolazione, scesa in piazza per esprimergli solidarietà, sono una decisa riaffermazione di fedeltà ai suoi ideali ed alla sua battaglia “La cosa più importante, diceva, che tutti noi dobbiamo sempre fare nostra è che si continui ad agire perché i poveri contino, abbiano la parola: i poveri, cioè la gente che non conta mai, quella che si può bistrattare e non ascoltare mai.
Ecco, per questo dobbiamo continuare a lavorare!”
Qualche tempo dopo, viene accolto dal parroco della chiesa di San Benedetto, Don Federico Rebora, ed insieme ad un piccolo gruppo nasce la comunità di base, la Comunità di San Benedetto al Porto.
Dopo tanti anni, la nostra porta è sempre aperta!
Don Lorenzo Milani..il prete che scuoteva la Chiesa


Il testimone
Lorenzo Milani
Una fede scomoda
Dalla testimonianza di don Renzo Rossi, amico di don Lorenzo Milani fin dagli anni del seminario e per tutta la vita, conosciamo il primo atto della sua vita da priore nell'esilio di Barbiana. La possiamo leggere nel volume Lorenzo Milani, «Perché mi hai chiamato?». Lettere ai sacerdoti, appunti giovanili e ultime parole (San Paolo, Cinisello Balsamo 2013), curato da Michele Gesualdi, uno dei primi ragazzi della scuola di Barbiana e attuale Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. Il libro presenta testi inediti (con lettere a don Bensi, don Renzo Rossi, mons. Loris Capovilla, Primo Mazzolari, Barsotti e altri ancora), a cui sono opportunamente affiancati brani già noti ai lettori per favorire la lettura e la comprensione degli inediti. Scrive don Renzo Rossi: «Il giorno dopo il suo arrivo a Barbiana, Lorenzo venne a trovarmi nella canonica di Vicchio e mi chiese di accompagnarlo in Comune perché voleva comprarsi subito la tomba nel piccolo cimitero di Barbiana. Io gli feci in faccia una bella risata! "Quanto sei bischero!". Ma lui mi disse che con quel segno (la tomba) voleva sentirsi legato totalmente, nella vita e nella morte, alla sua nuova gente! La sua scelta "per tutta la vita fu immediata" !» (p. 94). Davanti alla miseria di quella minuscola parrocchia sperduta sul monte Giovi, quasi irraggiungibile all'epoca (6 dicembre 1954), non pochi amici protestarono auspicando un suo rapido trasferimento altrove. Tra questi, oltre alla madre, il giudice Gian Paolo Meucci e don Raffaele Bensi, suo confessore. Proprio dal carteggio con il parroco di San Michelino Visdomini veniamo a sapere la sua reazione, davanti alla proposta di considerare Barbiana come un posto da abbondare al più presto: «La prego dí non parlare più né con me né con altri di questa parrocchia come se fosse un banco di prova provvisorio in attesa di qualcos'altro. La sua lettera mi ha talmente turbato che son stato due o tre giorni a pensare al suicidio. Poi per fortuna le ho dato del bischero e poi l'ho anche perdonato» (p. 21). La lettera è del 29 dicembre, venti giorni dopo il suo arrivo a Barbiana, e ci dà subito l'idea della radicalità e della libertà interiore di don Lorenzo, del suo coraggio nel difenderla dicendo, senza mezze misure, al suo amato amico e confidente don Bensi, che gli è di scandalo, distogliendolo dalla sua missione, dalla sua vocazione. Comprando la tomba nel piccolo camposanto antistante la chiesa, don Lorenzo si confrontava col senso ultimo della sua esistenza dí credente e di sacerdote, agendo coerentemente con quanto aveva scritto, un anno prima, nella traccia della sua omelia per la festa dei morti: «questa vita non è tutto, ma solo un passaggio o un esame» (p. 191). La vita di don Lorenzo si è svolta sotto questo esame, sotto lo sguardo di Dio, e da qui derivano il suo coraggio, la sua radicalità per certi aspetti violenta, la percezione in lui chiara e inequivocabile della abissale differenza che corre tra lo stare sotto lo sguardo degli uomini oppure sotto lo sguardo di Dio. In questo senso, parla di sé come di un «eserciziante perpetuo» o anche come di un «rigido rabbino tradizionalista». Tanto rigoroso con se stesso, quanto capace di dedicarsi instancabilmente agli altri, facendo sua l'espressione di Gesù citata da Paolo e ripresa da Francesco di Assisi, «c'è più gioia nel dare che nel ricevere». Tanto esigente con i suoi allievi e nel rapporto dialettico con i suoi interlocutori o avversari, quanto capace di ammirare la generosità della sua perpetua, Eda, e dei suoi ragazzi nell'assisterlo fino alla fine.
Nella lettera a don Bensi che abbiamo citato, emerge anche con forza il senso, che via via prenderà un contorno sempre più definito, del suo modo di intendere il sacerdozio e la sua missione nella nuova situazione in cui si è venuto a trovare. Si tratta della sua ben nota opposizione contro l'ideologia della ricreazione, su cui tornerà più volte nel tempo con argomentazioni molto stringenti. «Voglio scrivere un libro contro la ricreazione. Lo intitolerò: L'Eresia del secolo. E sarà diretto in parti uguali contro i preti e i comunisti». Vorrebbe predicare gli esercizi spirituali ai diaconi proprio su questo argomento: «Do loro ospitalità quassù per tutta la settimana e li rimando in giù riformati» (p. 20). Circa un anno dopo, vorrebbe parlarne ai teologi, come scrive sempre al suo confessore: «Da anni covo in cuore il segreto desiderio di parlare ai teologi. Naturalmente parlerei della ricreazione e della scuola. Non chiedo di farmi dei seguaci, ma solo di poter turbare per mezz'ora le loro coscienze, seminare un dubbio, una necessità di revisione degli slogans» (p. 25). L'unica ricreazione buona, che don Milani ammette, è quella che ha un carattere educativo e che di fatto ha accolto con entusiasmo nella sua scuola. Vorrebbe, dunque, parlare ai diaconi in formazione e ai teologi professionisti, e mentre rivendica questa attenzione esprime, al contempo, pieno distacco da se stesso e dalle sue prese di posizione. Prenderà sempre le distanze, a più riprese, da chi si fa difensore delle sue idee («qualcuno – scrive – si è buttato accanitamente per difendere le mie affermazioni cui io stesso non credo più da mesi o da anni»), perché non cerca seguaci né tanto-meno di affermare un "metodo don Milani", per così dire, da applicare altrove. Scrive, nel 1956, a don Renzo Rossi: «Sarebbe bello che io potessi assolvere la funzione di serbatoio di pensiero per tutti gli indaffaratissimi preti che non han tempo per pensare a quel che fanno, ma vedo questa cosa assolutamente impossibile e del resto anche immorale per parte loro. Ognuno deve pensare quello che fa e siccome ognuno fa cose diverse e incontra persone diverse, nessuno può valersi, sull'apostolato, del pensiero d'un altro. Così son giunto alla conclusione che sia mia specifica missione non il distribuire pensieri prefabbricati ai preti, ma solo turbarli e farli pensare» (p. 108). Nella dedizione instancabile alla sua missione di "conturbatore di coscienze", non cerca le luci della ribalta o il conforto di un ampio consenso, ma lascia trasparire la verità irresistibile del Vangelo, quella buona notizia che facendosi lievito nella cultura cresce, inevitabilmente, generando una controcultura rispetto agli slogan e alla mentalità più diffusa e accolta acriticamente. Del resto, secondo don Lorenzo, un parroco non deve avere la preoccupazione di "piacere". «Ecco dunque l'unica cosa decente che ci resta da fare: stare in alto (cioè in grazia di Dio), mirare in alto (per noi e per gli altri) e sfottere crudelmente non chi è in basso, ma chi mira basso. Riceffargli ogni giorno la sua vuotezza. La sua miseria, la sua inutilità, la sua incoerenza» (Lettera a don Ezio Palombo, del 25 marzo 1955, cit. da N. Fallaci, Vita del prete Lorenzo Milani, Bur, Milano 1993, p. 231).
La sua lotta per una vita coerente e fedele è an- che il suo dramma umano e di sacerdote: come fare un cammino non solitario né eccentrico e arbitrario, se ci si trova isolati e in esilio, di fatto quasi extra ecclesiam? Le sue parole sulla curia fiorentina, e sul crudele esilio in cui è stato relegato, sono durissime e non solo perché espresse senza accomodamenti e con il suo linguaggio diretto e molto toscano (che ancora forse scandalizza qualcuno e che è stato un facile bersaglio dei suoi detrattori, che non sono mai mancati nell'ambiente dei cristiani di facciata). Per don Lorenzo non era possibile una via mediana: aderire alla fede senza aderire alla Chiesa, senza un'obbedienza piena, equivale per lui a farsi una fede su misura, una fede fai-da-te. Ne scrive in proposito con grande chiarezza già nel 1953: «Quelli che scelgono e preferiscono e alla fine si creano la verità da credere si fanno la religione in casa a conto proprio. Sì, vedete, il mondo moderno che ci ha educati alla democrazia e alla fiducia nelle opinioni degli uomini ci ha dato anche questa tendenza di volerci fare su misura anche la fede. [...] Fede è entrare in casa d'altri, non costruirsi la casa. Entrare in una casa che non abbiamo costruita, che non è nostra, che non ci viene donata in proprietà ma in cui è già troppo alto onore di poter entrare. Ospiti del gran re. Non per mutar di posto a qualche mobile che non ci piace, ma per piegarci, accettare di umiliarci e accettare di soffrire qualcosa per amor di lui che tanto ci ha amato. Tutto dunque crederemo o nulla» (pp. 184-185). Al di fuori di questa prospettiva radicale e senza sconti, le parole di don Milani possono sembrare prese di posizione eccentriche o ideologiche o, per qualcuno, opinioni personali. Il priore di Barbiana, invece, sa bene di non aver aderito ad alcun partito, ad alcuna "ditta", ed è disposto a pagare fino in fondo il prezzo della solitudine per la sua coerenza. La fede professata deve, dunque, avere la sua verifica in un'etica vissuta, altrimenti è falsa.
Del resto, scrivendo a don Bensi nel 1965, rivendica di essere una «persona estremamente matura di cui ogni parola è misurata e frutto di anni di meditazione e di silenzio» (p. 65). In quel silenzio, la sua fede è cresciuta, fino a esprimere in poesia la forma della sua sequela senza sconti, del suo paradossale amore per Gesù: «Gesù ti odio / tu non mi dovevi chiamare. / [...] Gesù ti adoro / mi sei restato tu solo / Gesù m'aggrappo / alla tua unica mano / Gesù m'aggrappo / perché non voglio sparire / Ahi! // la tua mano è cosparsa di spine / Accidenti alle spine / della tua corona / Gesù ti odio / maledetta la tua croce / Gesù ti odio / ma non mi lasciare solo / Gesù ti odio / ma tu sai se è amore» (p. 209).
Bernardo Artusi

I CARE!
“L’arte dello scrivere è la religione. Il desiderio di esprimere il nostro pensiero e di capire il pensiero altrui è l’amore. E il tentativo di esprimere le verità che solo si intuiscono e le fa trovare a noi e agli altri. Per cui essere maestro, essere sacerdote, essere cristiano, essere artista e essere amante e essere amato sono in pratica la stessa cosa.”
Don Lorenzo Milani

Gianfranco Ravasi "Don Milani, una voce profetica nel deserto"
Don Milani. Il prete che scuoteva la Chiesa mostra tutta la sua attualità grazie all’amore per la persona umana, soprattutto se emarginata
All’anagrafe fiorentina era stato registrato come Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti, nato il 27 maggio 1923 da una famiglia borghese e intellettuale di matrice ebraica. Negli archivi parrocchiali apparirà come battezzato solo dieci anni dopo, successivamente a una lunga parentesi milanese dei genitori, che si erano trasferiti nel capoluogo lombardo nel 1930, ove il figlio avrebbe seguito tutto il cursus scolastico fino all’Accademia di Brera. Lorenzo ritornerà con loro a Firenze nel 1943 e fu là che si aprì il suo percorso spirituale che lo condusse al sacerdozio il 13 luglio 1947.
A questo punto sciogliamo del tutto l’enigma: stiamo parlando di don Lorenzo Milani, relegato dall’incomprensione ecclesiastica nel Mugello, a Barbiana, modesta frazione del comune di Vicchio che diverrà nota proprio per la genialità e la fede di questo prete. Là rimase fino alle soglie della morte, che avverrà a Firenze per grave malattia nel 1967.
La sua è stata una voce profetica che risuonava nel deserto, scuoteva le coscienze, anticipava i tempi collocandosi nei crocevia più roventi della società attraverso i suoi scritti, a partire dalle Esperienze pastorali del 1958, passando a L’obbedienza non è più una virtù per approdare all’indimenticabile dittico epistolare della Lettera a una professoressa (1967) su un originalissimo progetto educativo e della Lettera ai cappellani militari (1965) sull’obiezione di coscienza che gli costò una condanna per apologia di reato postuma, perché la sentenza fu pronunciata a un anno dalla sua morte avvenuta nel 1967. Sempre fermo e sereno, dichiarava ai suoi accusatori: «Dove è scritto che il prete debba farsi volere bene? A Gesù o non è riuscito o non è importato».
Ai ragazzi della scuola di Barbiana confessava nel suo testamento: «Ho voluto più bene a voi che a Dio; ma ho speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto sul suo conto».
Il suo amore per la persona umana, soprattutto se povera ed emarginata, era totale: «Il cuore dell’uomo è qualcosa che i libri non sanno leggere né catalogare. Un’anima non si muta con una parola», scriveva a quella “professoressa” così rigida nel suo ottuso sapere e inesorabile nel suo giudizio su un’esperienza didattica creativa. Lapidario era don Lorenzo anche nell’ammonire che il «massimo della diseguaglianza è fare parti uguali tra diseguali», convinto com’era che «un atto coerente isolato è la più grande incoerenza» e che «non dobbiamo avere paura di sporcarci le mani.
A che servirà averle pulite se le avremo tenute in tasca?».
La sua fede era appassionata: «Se dicessi che credo in Dio, direi troppo poco perché gli voglio bene.
E volere bene a uno è qualcosa di più che credere nella sua esistenza». Pur incompreso, come si diceva, dalle autorità ecclesiastiche, rimase sempre fedele alla Chiesa. Un suo compagno di seminario che sarebbe poi divenuto proprio arcivescovo di Firenze, il cardinale Silvano Piovanelli, anni fa mi confidava che, a quanti chiedevano a don Milani perché non lasciasse una Chiesa così dura verso di lui, rispondeva: «E dove mai troverò chi mi perdona i peccati?», rivelando anche un temperamento da asceta, consapevole della fragilità umana e della necessità del perdono divino.
La sua opera principale a livello di elaborazione della sua esperienza è stata certamente il volume citato Esperienze pastorali, le cui righe sono già stilisticamente di un’essenzialità assoluta e programmatica, come egli stesso affermava in una sua lettera: «Lo stare per mesi su una frase sola togliendo via tutto quello che si può togliere», spogliando la verità da ogni paludamento retorico e dal manto dorato dell’ipocrisia. Infatti, «siamo in un mondo in agonia che Dio forse sta accecando per castigarlo per aver troppo e troppo male usato l’intelletto, oppure di non averne fatto parte agli infelici».
E alla fine il bilancio del suo impegno di pastore e di educatore era stato sorprendente: «Devo tutto quello che so ai giovani operai e contadini cui ho fatto scuola. Quello che loro credevano di stare imparando da me, son io che l’ho imparato da loro. Io ho insegnato loro soltanto a esprimersi mentre loro mi hanno insegnato a vivere». Alla base, infatti, del suo insegnamento c’era soprattutto la ricerca condotta in comune tra insegnanti e discepoli. Il magister (da magis, più) si trasformava sempre in minister (da minus, meno) che procede spalla a spalla con l’altro. È ciò che avrebbe ribadito una figura lontana da don Lorenzo in tutti i sensi come Roland Barthes quando riconosceva che «vi è un’età in cui si insegna ciò che si sa; ma poi ne viene un’altra in cui si insegna ciò che non si sa, e questo si chiama cercare».
In questo che non è un ritratto ma solo un’evocazione simpatetica di un sacerdote e testimone dalla storia tormentata e gloriosa, nel centenario della sua nascita, è stato naturale lasciare soprattutto a lui la parola, come abbiamo fatto intarsiando il nostro testo con l’eco della sua voce. La conclusione, però, dovrebbe essere affidata a un’immagine del 20 giugno 2017: papa Francesco in piedi, a capo chino e in silenzio, davanti alla tomba di don Milani in quel piccolo e semplice camposanto di campagna. Enzo Biagi aveva scritto: «È sepolto nel cimitero di Barbiana, sperduto e vuoto paese abitato dagli spiriti. Ma don Lorenzo parla ancora».
di GIANFRANCO RAVASI

Sergio Mattarella "Don Milani, battistrada di una cultura nuova"
Rivolgo un saluto a tutti i presenti, che vorrei poter salutare singolarmente (...) Ricordiamo oggi, nel centenario della nascita, don Lorenzo Milani. È stato anzitutto un maestro. Un educatore. Guida per i giovani che sono cresciuti con lui nella scuola popolare di Calenzano prima, e di Barbiana poi.
Testimone coerente e scomodo per la comunità civile e per quella religiosa del suo tempo. Battistrada di una cultura che ha combattuto il privilegio e l’emarginazione, che ha inteso la conoscenza non soltanto come diritto di tutti ma anche come strumento per il pieno sviluppo della personalità umana. Essere stato un segno di contraddizione, anche urticante, significa che non è passato invano fra noi ma, al contrario, ha adempiuto alla funzione che più gli stava a cuore: fare crescere le persone, fare crescere il loro senso critico, dare davvero sbocco alle ansie che hanno accompagnato, dalla scelta repubblicana, la nuova Italia.
Don Lorenzo avrebbe sorriso di una sua rappresentazione come antimoderno se non medievale, della sua attività. O, all’opposto, di una sua raffigurazione come antesignano di successive contestazioni dirette allo smantellamento di un modello scolastico ritenuto autoritario. Nella sua inimitabile azione di educatore — e lo possono testimoniare i suoi “ragazzi” — pensava, piuttosto, alla scuola come luogo di promozione e non di selezione sociale. Una concezione piena di modernità, di gran lunga più avanti di quanti si attardavano in modelli difformi dal dettato costituzionale.
Era stato mandato qui, a Barbiana, in questo borgo tra i boschi del Mugello — con la chiesa, la canonica e poche case intorno — perché i suoi canoni, nella loro radicalità, spiazzavano l’inerzia. La sua fede esigente e rocciosa, il suo parlare poco curiale, i suoi modi, a volte impetuosi, lontani da quelli consueti, destavano apprensione in qualche autorità ecclesiastica.
In tempi lontani dalla globalizzazione e da internet, da qui, da Barbiana — allora senza luce elettrica e senza strade asfaltate — il messaggio di don Milani si è propagato con forza fino a raggiungere ogni angolo d’Italia; e non soltanto dell’Italia. Don Milani, aveva una acuta sensibilità circa il rapporto — che si pretendeva gerarchico — tra centri e periferie.
Come uscire da una condizione di emarginazione? Come sollecitare la curiosità, propulsore di maturità? Come contribuire, da cittadini, al progresso della Repubblica? Il motore primo delle sue idee di giustizia e uguaglianza era proprio la scuola.
La scuola come leva per contrastare le povertà. Non a caso oggi si usa l’espressione “povertà educativa” per affermare i rischi derivanti da una scuola che non riuscisse a essere veicolo di formazione del cittadino. La scuola per conoscere. Per imparare, anzitutto, la lingua, per poter usare la parola.
«Il mondo — diceva don Milani — si divide in due categorie: non è che uno sia più intelligente e l’altro meno intelligente, uno ricco e l’altro meno ricco. Un uomo ha mille parole e un uomo ha cento parole». Si parte con patrimoni diversi. Da questa ansia si coglie il suo grande rispetto per la cultura. La povertà nel linguaggio è veicolo di povertà completa, e genera ulteriori discriminazioni.
La scuola, in un Paese democratico, non può non avere come sua prima finalità e orizzonte l’eliminazione di ogni discrimine.
Lettera a una professoressa, scritta con i suoi ragazzi mentre avanzava la malattia — che lo avrebbe portato via a soli 44 anni — è un atto d’accusa, impietoso, di tutto questo. Lettera a una professoressa ha rappresentato una lezione impartita a fronte delle pigrizie del sistema educativo e ha spinto a cambiare, ha contribuito a migliorare la scuola nel mezzo di una profonda trasformazione sociale del Paese.
Ha aiutato a comprendere meglio i doveri delle istituzioni e sollecitato a considerare i doveri verso la comunità. Sempre più gli insegnanti, hanno lavorato con passione per attuare i nuovi principi costituzionali. Perché a questo occorre guardare.
La scuola è di tutti. La scuola deve essere per tutti. Spiegava don Milani, avendo davanti a sé figli di contadini che sembravano inesorabilmente destinati a essere estranei alla vita scolastica: «Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo di espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose». Impossibile non cogliere la saggezza di questi pensieri. Era la sua pedagogia della libertà.
Il merito non è l’amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e per non far perdere all’Italia talenti; preziosi se trovano la possibilità di esprimersi, come a tutti deve essere garantito. I suoi ragazzi non possedevano le parole. Per questo venivano esclusi. E se non le avessero conquistate, sarebbero rimasti esclusi per sempre.
Guadagnare le parole voleva dire incamminarsi su una strada di liberazione. Ma chiamava anche a far crescere la propria coscienza di cittadino; sentirsi, allo stesso tempo, titolare di diritti e responsabile della comunità in cui si vive. Aveva un senso fortissimo della politica don Lorenzo Milani. Se il Vangelo era il fuoco che lo spingeva ad amare, la Costituzione era il suo vangelo laico. «Ho imparato che il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia». Difficile trovare parole più efficaci. Difficile non riscontrare lo stretto legame del suo insegnamento con la fede che professava: prima di ogni altra cosa, il rispetto e la dignità di ogni persona. Qui si intrecciano il don Milani prete, l’educatore, l’esortatore all’impegno.
L’impegno — educativo, e di crescita — richiede sempre, per essere autentico, coerenza. Spesso sacrificio. Al pari di tanti curati di montagna che hanno badato alle comunità loro affidate, Don Milani non si è sottratto. Era giovane. Chiedeva ai suoi ragazzi di non farsi vincere dalla tentazione della rinuncia, dell’indifferenza.
La scuola di Barbiana durava tutto il giorno. Cercava di infondere la voglia di imparare, la disponibilità a lavorare insieme agli altri. Cercava di instaurare l’abitudine a osservare le cose del mondo con spirito critico.
Senza sottrarsi mai al confronto, senza pretendere di mettere a tacere qualcuno, tanto meno un libro o la sua presentazione. Insomma, invitava a saper discernere. Quel primato della coscienza responsabile, che spinse don Milani a rivolgere una lettera ai cappellani militari, alla quale venne dato il titolo L’obbedienza non è più una virtù e che contribuì ad aprire la strada a una lettura del testo costituzionale in materia di difesa della Patria per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
Padre David Maria Turoldo, amico di don Milani, disse di lui che «diventando disobbediente» in realtà obbediva a principi e regole ancora più profonde e vincolanti. Non certo a un capriccio o a una convenienza.
Non c’era integralismo nelle sue parole, piuttosto radicalità evangelica. Sapeva di avere in mano un testimone. Un testimone che doveva passare di mano, a cui poi i suoi ragazzi “aggiungessero” qualcosa.
Un grande italiano che, con la sua lezione, ha invitato all’esercizio di una responsabilità attiva. Il suo “I care” è divenuto un motto universale. Il motto di chi rifiuta l’egoismo e l’indifferenza. A quella espressione se ne accompagnava un’altra, meno conosciuta. Diceva: «Finché c’è fatica, c’è speranza». La società, senza la fatica dell’impegno, non migliora. Impegno accompagnato dalla fiducia che illumina il cammino di chi vuole davvero costruire. E a don Lorenzo ha percorso un vero cammino di costruzione. E gli siamo riconoscenti.
di SERGIO MATTARELLA

"Signore, io ho provato che costruire è più bello che distruggere, dare più bel che ricevere, lavorare più appassionante che giocare, sacrificarsi più divertente che divertirsi. Signore Gesù fa che non me ne scordi più"
Don Lorenzo Milani

Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio
Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo non è più tempo delle elemosine, ma delle scelte
Chi non sa amare il povero nei suoi errori non lo ama.
Voler bene al povero è proporsi di metterlo al posto che gli spetta
Don Lorenzo Milani

La lezione di don Lorenzo
Giovanni Meucci
In dialogo con il documentario Barbiana '65. La lezione di don Lorenzo Milani (Italia 2017), del regista Alessandro G.A. D'Alessandro, cinque verbi per raccontare un possibile incontro con don Milani: visitare, leggere, ascoltare, imitare, essere.
Salire a Barbiana
La prima volta che sono salito a Barbiana è stato, forse, più di venti anni fa, insieme ad alcuni membri della mia Comunità, l'amico don Bruno Forte, attuale arcivescovo di Chieti-Vasto e don Renzo Rossi. Ricordo l'accoglienza di Michele Gesualdi, il suo dialogo con don Bruno Forte, riguardo alla paura che don Lorenzo Milani potesse essere trasformato in un "santino" perdendo la propria umanità e quella severità di carattere con cui, in tante agiografie, difficilmente si presentano i santi. Mentre parlavano, osservavo le pareti della Scuola di Barbiana dove tutto era rimasto a quei giorni in cui don Milani, a causa dell'aggravarsi del tumore, aveva dovuto abbandonare i monti del Mugello per concludere la sua esistenza nella casa della madre, in via Masaccio a Firenze. Tutto molto semplice, povero, essenziale, ma pieno di vita, di profezia, di attualità. La piccola piscina, simbolo borghese di ricchezza trasformato in strumento per abbattere le paure dei suoi giovani alunni. Era una giornata di primavera o autunno, non ricordo, però si stava bene fuori e abbiamo potuto concludere la breve visita scendendo verso il piccolo cimitero dove Lorenzo Milani è sepolto. Tornando poi lungo la strada sterrata nel bosco verso la Pieve, in quanto la scorciatoia per risalire era alquanto difficoltosa, avevo incontrato un grosso cane fortunatamente seguito a poca distanza dalla sua padrona. Mi ero, comunque, leggermente spaventato perché ero solo. Ecco la sensazione più forte di quella prima visita: la solitudine, la sofferenza, la paura che la figura di don Milani potesse continuare a essere fraintesa nella sua unicità e irripetibilità anche dopo la morte. Non tanto dalla società civile, dal mondo intellettuale e della cultura, dalle scuole e da educatori e docenti, ma dalla Chiesa, dai cristiani stessi. Segno di una ferita ancora profondamente aperta, quella con una parte dell'ambiente ecclesiale fiorentino, per un sacerdote che aveva semplicemente deciso di attuare e vivere il Vangelo fino in fondo, fino alla passione nell'orto del Getsemani. Obbediente al suo Vescovo in cui vedeva adempiersi la volontà di Dio Padre.
Leggendo il libro di Michele Gesualdi Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana, si percepisce proprio una grande sofferenza non tanto per le incomprensioni tra don Milani e i suoi due Vescovi, ma per lo scandalo causato nei giovani del tempo. Anche se questo può sembrare assurdo, Gesualdi esprime la consapevolezza che quell'esilio sia stato un evento di grazia che ha permesso alla vocazione di don Lorenzo di manifestarsi nella sua pienezza. Come testimonia il ricordo di questo sacerdote: «Mi sembra di sentirla ancora la sua voce: "bisogna innamorarsi di tutti quelli che fanno parte della nostra famiglia, di tutto ciò che facciamo e l'amore deve essere un amore carnale. Non esiste un uomo migliore di un altro, non esiste posto al mondo che io possa amare di più. È Dio che mi ha messo qui. Questa certezza è il simbolo di una predilezione sconfinata di cui sono stato oggetto. [...] Non ci sono rimpianti nella mia vita, né nostalgie. I miei superiori io li amo: nessuno può dimostrarmi di essere stato punito o di non aver ubbidito. Della verità non si deve aver paura; un sacerdote non ha nulla da perdere; ovunque vada, troverà sempre qualcuno da amare, non a parole che sarebbe un mostruoso misfatto e una ignobile falsità, ma con i fatti. Amare non significa dare qualcosa, significa dare noi stessi, significa essere e i poveri sono quelli che Dio oggi in particolare, ha gettato sul nostro cammino; essi sono il segno di contraddizione; di fronte a loro bisogna scegliere. Non ci sono vie di mezzo, né possibili compromessi. Non si può vivere senza innamorarsi. La soluzione che io ho trovato è una nelle infinite. Vedi questi bambini io li amo. Essi hanno riempito il mio cuore"» (cfr. M. Gesualdi, Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2016, pp. 232-233).
Ritirato sul monte è diventato un faro che ha rischiarato la notte indicando la strada per un rinnovamento del modo di vivere il Vangelo e di essere cristiani nell'oggi. Se il seme gettato non muore, non dà frutto. E più veniva ufficialmente isolato, più salivano alla Scuola persone importanti per incontrarlo, giudici, politici, giornalisti, professori, uomini di spettacolo. Più cercavano di nasconderlo più il suo pensiero sí diffondeva tra le persone. La forza della sua azione stava nella scelta di amare i ragazzi di Barbiana, senza cercare visibilità per se stesso, riconoscimenti pubblici o spazi di carriera. Umiliato, offeso, calunniato, per le parole di verità contenute nelle sue lettere e nei suoi scritti, non rispondeva con oltraggi, ma spiegava e rispiegava il senso del suo pensiero. Ed era questo che certamente non piaceva a tanti delatori: la capacità di non cedere all'ira, di obbedire sempre alla Chiesa, di rimanere fedele alla verità nell'oggettività del suo rivelarsi. E quando si esponeva e decideva di scrivere le sue lettere, come Risposta ai Cappellani militari, era a scopo educativo, di esempio per i suoi ragazzi affinché imparassero a rimanere fedeli alla propria coscienza in ogni occasione della vita. A sviluppare il proprio senso critico conservando sempre la libertà interiore ed esteriore. In quei giorni, infatti, sul quotidiano «La Nazione» di Firenze era riportato un documento dei cappellani militari contro l'obiezione di coscienza «in cui si leggeva, fra l'altro questa frase: "Considerano un insulto alla Patria e ai suoi Caduti la cosiddetta obiezione di coscienza che, estranea al comandamento cristiano dell'amore, è espressione di viltà". Così lo racconta Lorenzo nella Lettera ai giudici: "Eravamo come sempre insieme quando un amico ci portò il ritaglio di un giornale. Si presentava come un comunicato dei cappellani militari in congedo della regione Toscana. [...] Ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella mia duplice veste di maestro e di sacerdote e loro mi guardavano sdegnati e appassionati. Un sacerdote che ingiuria un carcerato ha sempre torto. Tanto più se ingiuria chi è in carcere per un ideale. Non avevo bisogno di far notare queste cose ai miei ragazzi, le avevano già intuite. E avevano anche intuito che ero ormai impegnato a dar loro una lezione di vita. [...] Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. Come ha libertà di parola e di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote, e perfino al vescovo che sbaglia. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande I care. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. E il contrario del motto fascista Me ne frego"» (cfr. Lorenzo Milani. Gli ultimi e i primi, a cura di G. Ceccatelli, Edizioni Clichy, Firenze 2015, pp. 64-65).
Fiction, non realtà
I libri con i quali mi sono avvicinato alla sua figura sono stati Lettera a una professoressa prima ed Esperienze pastorali poi. Avevo appena iniziato la Facoltà di Filosofia. Lettera a una professoressa come prima reazione alla negativa esperienza scolastica liceale appena conclusa, Esperienze pastorali per capire cosa mi aveva allontanato dal catechismo e dalla parrocchia poco dopo essere passato a comunione. Non ne ho parlato per molto tempo con nessuno, forse tutto non avevo compreso, ma quelle letture hanno lavorato nella mia mente, ispirando il modo di rapportarmi con le altre persone e la realtà nel suo complesso. Spesso le sue frasi sono diventate degli slogan o si è pensato di riprodurre nelle scuole di oggi la Scuola di Barbiana. Nel 1997, su Raidue, è stata trasmessa la miniserie in due puntate Don Milani. Il Priore di Barbiana, di Andrea e Antonio Frazzi, con Sergio Castellitto e Ilaria Occhini. Film che, in modo semplice e coinvolgente, rendeva bene la figura di don Milani e la sua esperienza a Barbiana. A volte eccedendo un po' nel cliché del sacerdote controcorrente, al di là dagli schemi tradizionali e contestatario, ma senza mai discostarsi troppo dalla storicità dei fatti accaduti.
Nell'ottima interpretazione di un giovane Castelletto traspariva tutta l'ammirazione sua e dei due registi per una vita donata completamente a servizio dei suoi ragazzi. La novità di una pedagogia capace di valorizzare il singolo alunno rispettandone tempi e modi di apprendimento. Senza la fretta di giudicare, valutare, selezionare. Uno studio mai disgiunto dalla concretezza della vita, dal mondo del lavoro, da uno sguardo ampio, cosmopolita: l'apprendimento delle lingue e i viaggi di studio e lavoro all'estero, la lettura dei giornali, l'attualità, la conoscenza del presente e di cosa stava accadendo intorno a loro. il coraggio di stare sempre dalla parte della verità. Ed è una storia che incanta, che rende partecipe il pubblico mettendone in gioco i migliori sentimenti. I rapporti tra Milani e la sua famiglia sono delineati con grande sensibilità. Molto bella e toccante la scena della morte di don Milani con cui si conclude il film. A settembre, l'ho fatto vedere ai miei alunni in preparazione alla gita di inizio anno della nostra scuola a Barbiana, e ho avuto nuovamente conferma della bontà dell'opera dei fratelli Frazzi. Il problema è come fare esperienza di questa bellezza, come calarla nella vita dei giovani che oggi popolano le nostre scuole quando il mondo è completamente cambiato rispetto a quell'Italia di ormai cinquanta anni fa'. Quí la fiction non aiuta in quanto, per sua natura, tende a semplificare le cose, a renderle leggere, a eliminare il peso della storia, della realtà.
Un nume tutelare
«Nei racconti dei ragazzi riferiti dal loro compagno Edoardo Martinelli, [...] si può cogliere direttamente dalla voce degli allievi della scuola di don Milani l'impronta che quell'esperienza ha lasciato nella loro vita. L'impegno a riuscire, contraddicendo un destino già segnato; un po' di quella superbia, che secondo il priore andava coltivata negli umili; ma anche la memoria grata dello stupore per le scoperte, del senso di responsabilità dei più grandi per i progressi dei più piccoli, delle coraggiose e meravigliose avventure dei viaggi all'estero per imparare le lingue, inimmaginabili nelle loro famiglie, perfino della fatica e dei sacrifici necessari per frequentare la scuola, e magari anche dei rimproveri per un momento di pigrizia o di distrazione. Insomma una crescita personale evidente, riconosciuta e probabilmente mai sperata, come racconta Nevio, poi diventato autista di pullman e militante comunista: "della sua lezione mi sono rimasti oggi i ricordi più belli ed emozionanti. Mi è rimasta dentro una carica esplosiva che uso ogni qualvolta c'è bisogno, sperando di farlo nel modo più corretto e incisivo, mi è rimasta dentro la volontà di sentirmi una persona utile ai bisogni dei più deboli; la consapevolezza di non dover esser pecora e di andare anche controcorrente senza tradire quello che dice la mia coscienza, di dire sempre la verità, anche se questo può essere in contrasto con la mia fede politica, con le mie convinzioni sindacali e sociali e con gli interessi della Chiesa della quale mi sento di far parte". O come dice Edoardo, con le parole forse più belle: "L'orgoglio di comprendere il proprio stato, la propria condizione umana, l'ambiente in cui si cresce e in cui si vive, si lavora, si lotta. La consapevolezza di essere uno e inimitabile". Verità, fede, politica, convinzioni, orgoglio, consapevolezza, chi nella vita di ragazzi come questi, si era mai impegnato a fare simili doni?» (Lorenzo Milani. Gli ultimi e i primi, pp. 58-60).
Ripeto le ultime parole scritte da Giovanna Ceccatelli, «verità, fede, politica, convinzioni, orgoglio, consapevolezza» perché sono quelle cose che cerco di trasmettere ai ragazzi da quando, tredici anni fa, mi sono ritrovato a insegnare a dei liceali. Riuscire a fare questo credo sia il sogno di ogni professore che voglia essere anche educatore. Umili, vite segnate, poveri, sono le altre parole da cogliere, che probabilmente vanno in netto contrasto con la realtà di oggi, dove i ragazzi sperimentano sempre una forma di abbandono, ma insieme ad abbondanza, disillusione, scetticismo, narcisismo. Allora diventa difficile realizzare le altre parole. Ed è forte il rischio di scivolare nel moralismo colpevolizzando i giovani come se la povertà fosse l'unica strada per accettare la necessità di avere dei maestri. Come se il dialogo potesse crearsi solo tra persone umili, che cercano qualcosa, che prima di ottenere prestazioni desiderano conoscere. Solamente realizzare una scuola senza voti, cattedre e registri, sarebbe un problema, ma bisogna trovare il modo di raggiungere gli stessi obiettivi educativi anche oggi. I giovani attendono sempre qualcuno che li liberi. E, tuttavia, non basta leggere in classe Lettera a una professoressa, perché quell'esperienza torni magicamente a vivere. Così, dopo i primi anni di insegnamento, ho smesso di ricorrere a strane bacchette magiche, ma ho semplicemente preso una foto di don Milani da ragazzo, l'ho incorniciata e appesa in aula come un nume tutelare che ti protegge le spalle, che con il suo esempio indica lo scopo ultimo di fare scuola, un percorso particolare da cui prendere ispirazione.
La voce del maestro
Slogan, sogno, esempio, realtà, essere, sono le cinque tappe del percorso del mio avvicinamento a don Lorenzo Milani. Così, lo scorso 22 novembre, sono andato a vedere Barbiana '65. La lezione di don Lorenzo Milani, il documentario di Alessandro G.A. D'Alessandro (Italia 2017) prodotto da Laura e Silvia Pettini per Felix Film in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e Fondazione Don Milani. Al Nuovo Cinema di Figline Valdarno, dove ha avuto luogo la proiezione, era presente una delle produttrici, Laura Pettini, che, presentando il documentario, ha ripercorso brevemente la lunga storia della sua genesi partendo dall'occasione che cinquantadue anni fa aveva portato il padre di D'Alessandro a salire a Barbiana. Il regista Angelo D'Alessandro, autore di sceneggiati importanti per la Rai come Zanna Bianca e Ciuffettino, si era recato da don Milani per un'inchiesta sull'obiezione di coscienza. Si era, poi, proposto di fare una lezione di cinema a quei giovani come ne faceva tante ai suoi studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia. In particolare, mostrare ai ragazzi un film di Georg Wilhelm Pabst, La tragedia nella miniera, considerato uno dei principali film pacifisti del tempo. In effetti, appena a Barbiana arrivò la corrente elettrica, una delle prime cose che fece don Milani fu quella di procurarsi un proiettore da 16 millimetri con cui studiare con i ragazzi film d'autore, analizzandone linguaggio e montaggio, fotogramma per fotogramma. Ed effettivamente, come ha ricordato il figlio di D'Alessandro nel comunicato stampa a cura di Laura Pettini per la Felix Film, il film «venne visionato varie volte dal priore e dai ragazzi che alla fine dimostrarono come sí trattasse in realtà di un film mediocre. Mio padre raccontava di come avessero perfettamente ragione: era salito per fare lezione ai ragazzi ma la lezione l'avevano fatta a lui». Nacque, così, un dialogo profondo sui temi della fede, del Vangelo, dei diritti umani, della guerra e della pace, tra il regista e i giovani di don Milani, che lo porterà a tornare più volte a Barbiana. Fino a quando, comprendendo la sua sincera partecipazione all'esperienza della Scuola, sarà lo stesso don Milani a offrirgli la possibilità di riprendere e di girare un documentario sul metodo di Barbiana.
I filmati originali – circa 40 minuti in pellicola bianco e nero, mentre la colonna sonora era stata registrata a parte su nastro magnetico, come si usava in quegli anni – mostrano alcuni momenti fondamentali della Scuola di Barbiana: la scrittura collettiva, la lettura dei giornali, i ragazzi píù grandi che insegnano ai più piccoli, il lavoro manuale svolto dai ragazzi e la partecipazione alla Messa, in cui vediamo don Milani celebrare, ma solo "per finta", per la macchina da presa. Spezzoni di pellicola e riflessioni personali del regista rimasti per lunghi anni separati, fino a quando il figlio, dopo la morte del padre, dopo un lungo lavoro di riflessione e preparazione, non ha trovato l'ispirazione per unirli in una narrazione. Nel tentativo di farsi guidare dalla viva voce di don Milani, che al momento delle riprese stava scrivendo con i suoi ragazzi Lettera ai giudici, per difendersi dalle accuse di apologia di reato nel processo che lo attendeva a Roma, per cogliere il senso ultimo, lo scopo del suo fare scuola. Che, nell'interpretazione di D'Alessandro, è: far diventare i suoi allievi dei cittadini veri, uomini capaci di andare in fondo alle cose, ragionare con la propria testa ed essere "sovrani di se stessi". Attraverso uno studio approfondito, la Costituzione italiana e il Vangelo. Come nei loro interventi durante il documentario hanno cercato di chiarire i tre testimoni chiamati a rappresentare i tre pilastri della Scuola di Barbiana: metodo didattico, Adele Corradi, l'insegnante che ha vissuto l'esperienza di Barbiana con don Lorenzo; Costituzione italiana, Beniamino Deidda, ex Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e docente volontario fin dalla scuola a Calenzano; Vangelo, don Luigi Ciotti.
Non saprei dire quanto il documentario possa essere efficace per avvicinare, chi ancora non conosce don Milani, alla Scuola di Barbiana, ma è sicuramente un importante punto di partenza per continuare a studiare e ad approfondirne la figura. Sono rimasto colpito dalle immagini iniziali dove i ragazzi, prima in lambretta, poi a piedi, sotto la pioggia, per strade fangose, raggiungevano contenti la loro scuola. Come partecipavano alle lezioni di don Milani e sapevano interloquire con chi andava a trovarli. Mi ha colpito il suono della sua voce, il suo sguardo, il suo modo di essere, ed è stato come rincontrare un vecchio amico. Ed è bello che il documentario si sia concluso con le immagini di papa Francesco che prega sulla tomba di don Milani, perché quella visita del 20 giugno 2017 ha posto fine a un lungo esilio di sofferenza e solitudine, dando al sacerdote fiorentino il posto che merita nella Chiesa del nuovo millennio. Una Chiesa chiamata a ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani. «Non c'è da parlare della eroica storia di don Lorenzo Milani, ma della eroica storia dei poveri, della nobiltà della classe operaia e contadina che mi ha accolto e aperto gli occhi. In questi anni vi ho educato a sentirvi classe, a non dimenticarvi dell'umanità bisognosa e a tenere a bada il vostro egoismo, perché non si tratta di produrre una nuova classe dirigente, ma una massa cosciente. Il buon cristiano, oggi, non si limita a fare l'elemosina, ma s'impegna a
lottare per rimuovere le cause che tengono i poveri in condizione di sottomissione e miseria» (L. Milani, in M. Gesualdi, Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana, cit., p. 208). «Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con una fede consapevole. Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, in cui solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti spesso confusi messaggi che ci piovono addosso, e di dare espressione alle istanze profonde del proprio cuore, come pure alle attese di giustizia di tanti fratelli e sorelle che aspettano giustizia. Di quella umanizzazione che rivendichiamo per ogni persona su questa terra [...] fa parte anche il possesso della parola come strumento di libertà e di fraternità» (dal discorso di papa Francesco, in occasione del pellegrinaggio a Barbiana, 20 giugno 2017).
(FEERIA 17/1 n. 51, pp.50-55)
La parola chiave del lettore:
Siete occhi che guardano e che sognano!
Continuate a sognare, a inquietarvi, a immaginare parole e visioni che ci aiutino a leggere il mistero della vita umana e orientino le nostre società verso la bellezza e la fraternità universale.
Aiutateci ad aprire la nostra immaginazione perché essa superi gli angusti confini dell’io, e si apra alla realtà tutta intera, nella pluralità delle sue sfaccettature: così sarà disponibile ad aprirsi anche al mistero santo di Dio. Andate avanti, senza stancarvi, con creatività e coraggio!
Papa Francesco
























