Cuori pensanti: scrittori, teologi, musicisti, artisti..

La mia voce matura!
Contemplativi del quotidiano
Uno speciale percorso...attraverso lo sguardo di donne e uomini cogliendo la grazia che ha illuminato la loro esistenza facendone ragione di vita, dono per gli altri e una proposta di vita per tutti noi!
Il Poeta raccoglie i dolori e sorrisi e mette assieme tutti i suoi giorni in una mano tesa per donare, in una mano che assolve perché vede il cuore di Dio. I fiori del Poeta sbocciano per vivere molto a lungo per le vie della grazia.
Alda Merini
"Cari poeti, so che avete fame di significato, e per questo riflettete anche su come la fede interroga la vita. Questo “significato” non è riducibile a un concetto, no. È un significato totale che prende poesia, simbolo, sentimenti.
Questo è il vostro lavoro di poeti: dare vita, dare corpo, dare parola a tutto ciò che l’essere umano vive, sente, sogna, soffre, creando armonia e bellezza. È un lavoro che può anche aiutarci a comprendere meglio Dio come grande «poeta» dell’umanità. Vi criticheranno? Va bene, portate il peso della critica, cercando anche di imparare dalla critica. Ma comunque non smettete di essere originali, creativi. Non perdete lo stupore di essere vivi."
Papa Francesco
«L’autentica bellezza schiude il cuore umano alla nostalgia, al desiderio profondo di conoscere, di amare, di andare verso l’Altro, verso l’Oltre da sé. Se accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, ci ferisca, ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, della capacità di cogliere il senso profondo del nostro esistere, il Mistero di cui siamo parte e da cui possiamo attingere la pienezza, la felicità, la passione dell’impegno quotidiano»
Papa Benedetto XVI
Perché dovrei desiderare di vedere Dio meglio di quanto non lo veda oggi?
Vedo qualcosa di Dio in ogni ora delle ventiquattro, in ogni momento di esse,
nei volti di uomini e donne vedo Dio, e nel mio volto riflesso allo specchio,
trovo lettere inviate da Dio per le strade, ognuna firmata col nome d’Iddio,
e le lascio dove si trovano, perché so che, ovunque mi rechi,
altre puntuali verranno, per sempre e per sempre.
W.Whitman
Italo Calvino...con la sua scrittura ha reso "l'invisibile visibile"
Nelle foto la famiglia di Italo Calvino i genitori Mario e Eva, il fratello Floriano e a seguire la foto con sua moglie Ester e sua figlia Giovanna.

Il giardino incantato di Italo Calvino
40 anni dalla morte 19 settembre 1985
Anita Prati
Si chiamava Italo ed era nato dall’altra parte del mondo… Potrebbe iniziare così la storia di uno dei più grandi scrittori del nostro Novecento, di cui ricorrono in questo mese di ottobre i cento anni dalla nascita.
L’affaire Calvino
Si chiamava Italo Calvino ed era nato il 15 ottobre 1923 a Santiago de las Vegas, una piccola città ad una ventina di chilometri da L’Avana, sull’isola di Cuba.
Il padre Mario, originario di Sanremo, dopo la laurea in scienze agrarie aveva assunto l’incarico di direttore della Cattedra ambulante di Agricoltura della provincia di Imperia – istituzione nata alla metà dell’Ottocento allo scopo di incrementare le conoscenze agronomiche fra i piccoli agricoltori.
Poco più che trentenne, nel 1909, Mario Calvino decise di trasferirsi dall’altra parte del mondo, prima in Messico e poi nell’isola di Cuba. La decisione, motivata apparentemente da ragioni professionali, era maturata, in realtà, a seguito di un intricato affare internazionale di cui solo in tempi recenti si sono potuti tracciare i contorni in modo preciso.
Nel febbraio del 1908 a Pietroburgo era stato arrestato un anarchico, accusato di aver organizzato un complotto per attentare alla vita dello zar Nicola II e del ministro della Giustizia. Dai documenti in suo possesso – un passaporto rilasciato a Porto Maurizio (Imperia) nel settembre 1906 – l’uomo venne identificato con un certo Mario Calvino, nato a San Remo nel 1875. Sottoposto a processo per direttissima, l’accusato fu giustiziato per impiccagione pochi giorni dopo l’arresto.
Nel frattempo, a Sanremo, la Questura era entrata in contatto con un omonimo Mario Calvino, agronomo, ivi residente. Rimane agli atti una deposizione dal tono quasi fiabesco in cui il Calvino agronomo ligure raccontava che, durante un viaggio in treno, aveva incontrato alcuni russi, tra i quali vi era un ricco proprietario terriero. Questi, venuto a conoscenza della sua attività di botanico, gli aveva proposto di recarsi in Russia per avviare la sperimentazione di nuove forme di coltivazione della vite. Proprio per tale motivo, proseguiva Calvino, egli aveva richiesto e ottenuto il passaporto, che gli era stato sottratto dal russo in un incontro successivo e il cui furto, a causa dei mille impegni della sua vita, aveva dimenticato di denunciare.
Troppi punti della deposizione risultavano poco chiari, se non addirittura inverosimili. Quali erano i veri legami che univano il giovane agronomo sanremese con il rivoluzionario impiccato a Pietroburgo, che portava documenti intestati all’italiano Mario Calvino ma che, grazie alle indagini, era stato identificato con l’anarchico russo Vsevolod Vladimirovič Lebedintzev, detto «Cirillo»?
Mario Calvino, la moglie Eva Mameli e il figlio Italo
La situazione si andava facendo piuttosto rischiosa per Mario Calvino, che decise, così, di lasciare l’Italia. Il figlio Italo, con ligure riserbo, non diede mai troppa enfasi a questo episodio della biografia paterna; in una lettera scritta molti anni dopo la morte del padre annotò, però, queste parole:
«Mi proponevo di fargli raccontare dettagliatamente la sua vita avventurosa (che poteva darmi materia per più d’un romanzo!) ma tardai troppo a mettere in atto questo proposito anche perché non abitavo più a San Remo e lo vedevo di rado. A settantacinque anni fu colpito da trombosi ed era ormai troppo tardi. M’è rimasto il rimorso di non aver raccolto le sue memorie».
Imbarcatosi per l’America nel gennaio 1909, Mario Calvino raggiunse il Messico – dove non mancò di partecipare alla rivoluzione di Pancho Villa – e poi, nel 1918, si trasferì a Cuba, chiamato a dirigere la Stazione Agronomica Sperimentale di Santiago de Las Vegas, presso l’Avana. A Cuba, nel 1920, si sposò con Eva Mameli. Ma qui bisogna raccontare un’altra storia.
Eva Mameli
La madre di Italo Calvino, Eva Mameli, nata a Sassari, laureata in Fisica e Matematica all’Università di Cagliari e in Scienze Naturali all’Università di Pisa, fu la prima donna italiana ad ottenere, nel 1915, la libera docenza in botanica. La passione profusa negli studi naturalistici le valse numerosi riconoscimenti, che le diedero notevole fama nell’ambiente scientifico. Fu proprio per cercare di incontrarla e poterla conoscere che, nel 1920, cogliendo l’occasione di un convegno di botanica, Mario Calvino compì un breve viaggio in Italia.
Da quel fuggevole incontro sortì una offerta di collaborazione al suo lavoro di ricerca sulle piante tropicali, comprensiva di proposta di matrimonio e di trasferimento a Cuba. Eva Mameli accettò e nell’ottobre del 1920 era a Cuba, sposata con Mario Calvino.
La scelta di chiamare Italo il primogenito veniva dal desiderio di mantenere una sorta di legame ideale con la patria lontana, quasi nel timore di non potervi più fare ritorno. Ma un paio di anni dopo la nascita di Italo, nel 1925, i coniugi Calvino rientrarono in Italia, a Sanremo.
Mario Calvino riprese il progetto, elaborato già quindici anni prima, di una Stazione sperimentale di floricultura, contribuendo alla diffusione delle pratiche florovivaistiche nel tratto del Ponente ligure che verrà poi chiamato Riviera dei Fiori.
Eva Mameli ebbe la direzione dell’Orto botanico dell’università di Cagliari e vinse il concorso per una cattedra di botanica nel capoluogo sardo; la nascita del secondogenito Floriano, futuro geologo, la costrinse, però, a rinunciare all’incarico. Proseguiva, intanto, la sua collaborazione alla Stazione sperimentale diretta dal marito, insieme al quale fondò la Società italiana amici dei fiori e la rivista Il Giardino Fiorito, pubblicata dal 1931 al 1947.
Donna austera e di grande rigore professionale, Eva Mameli Calvino fu una pioniera nell’impegno a tutela della avifauna; scrisse numerose pubblicazioni attraverso le quali mise in evidenza la relazione vitale tra uccelli e giardini, l’utilità degli uccelli insettivori in agricoltura e nel giardinaggio, e i danni irreparabili della caccia.
«In un giardino senza uccelli si sente che qualcosa manca alla unita armonia dei colori e delle forme naturali: appena un cinguettio rompe il silenzio o un gorgheggìo si leva, guardiamo all’ospite come a un amico che viene a tenerci compagnia e desideriamo in cuor nostro che ci resti a lungo. Purtroppo i giardini senza uccelli sono molti in Italia. Con una caccia sistematica, continuata per secoli, incoscientemente, con tutti i mezzi e in tutte le stagioni, abbiamo distrutto un patrimonio prezioso».
Sanremo, Villa La Meridiana
A Sanremo i Calvino acquistarono una villetta in stile liberty immersa in un grande parco, a mezza via tra il mare e la montagna, tra la rumorosa vita cittadina e il silenzio del podere che il padre dello scrittore coltivava ad orti e ulivi nella campagna alle spalle della città.
Oggi la villa, con il suo giardino incantato di araucarie, magnolie, limoni, bouganville, rosmarini, agavi, essenze aromatiche e piante tropicali, non esiste più, fagocitata dalla speculazione edilizia e da un’urbanizzazione spietata che non risparmia nulla e nessuno.
Ma la matrice della magica originalità della narrativa calviniana, la sua capacità di assumere il reale, tutto e senza sconti, trasfigurandolo nella dimensione del simbolo e della fiaba, non può essere compresa senza rivolgere lo sguardo a quel primo, quasi fantastico, grumo di vicende biografiche, in cui la singolarità delle avventure famigliari e la non comune personalità dei genitori fa da sfondo a un profondo senso di rispetto per la natura, respirato giorno dopo giorno nella confidenza quotidiana con le piccole e grandi creature del mondo vegetale e animale di Villa La Meridiana.
Italo Calvino col fratello Floriano
Quando, a ventidue anni, al termine della guerra e dell’esperienza partigiana, il giovane Calvino lasciò Sanremo per trasferirsi a Torino, dove ebbe inizio la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, le sue prime opere – i racconti di Ultimo viene il corvo, il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno – appaiono già toccate dalla insuperata, pensosa, leggerezza che contraddistinguerà tutte le prove della maturità.
Cifra indelebile della scrittura calviniana è la capacità di trapassare continuamente dal piano del reale a quello dell’immaginifico e del simbolico, e viceversa, senza soluzione di continuità. Personaggi e luoghi, usciti dalla nuda realtà, entrano nei suoi racconti come trasfigurati.
Così, anche la guerra partigiana può diventare una fiaba, feroce come solo le fiabe sanno essere, se a guardarla sono gli occhi di un bambino, il piccolo Pin, protagonista del Sentiero dei nidi di ragno. Così, la natura non appare mai come anonimo fondale, funzionale alla spazialità narrativa, ma è sempre anima viva della stessa trasfigurazione magica del reale, come nel meraviglioso racconto Il giardino incantato:
«Tutto era così bello: volte strette e altissime di foglie ricurve d’eucalipto e ritagli di cielo; restava solo quell’ansia dentro, del giardino che non era loro e da cui forse dovevano esser cacciati tra un momento. Ma nessun rumore si sentiva. Da un cespo di corbezzolo, a una svolta, s’alzò un volo di passeri, con gridi. Poi ritornò silenzio. Era forse un giardino abbandonato?»
Così, nella pesantezza e nell’opacità del mondo è dato di intravedere la speranza di una vividezza, di una forza innocente, di una gioia pura, per quanto fragile e peritura. Come nel bellissimo episodio di Marcovaldo ovvero Le stagioni in città, intitolato La pioggia e le foglie, dove la vita alienata di Marcovaldo sembra trovare riscatto nella cura di una pianta senza nome collocata nell’ingresso della sua ditta.
Marcovaldo innaffia la pianta ogni giorno, ne spolvera le foglie sane, raccoglie tristemente le foglie cadute, sente tutta la sofferenza della pianta perché sa che «a star lì, tra la tenda e il portaombrelli, le mancavano luce, aria e rugiada», e prova compassione per lei, quasi fosse una persona di famiglia.
Un giorno di pioggia Marcovaldo chiede il permesso di portare la pianta all’aperto. E all’aperto la pianta rivive, le crescono nuove foglie, si fa lucida, vigorosa. Allora Marcovaldo decide di caricarsela sul motorino e, con la pianta legata dietro alle spalle, si mette ad inseguire le nuvole di passaggio sulla città.
Bagnata dalla pioggia, la pianta diventa grande, sempre più grande, un albero enorme che si sposta in città legato a un motorino. In quello sforzo di crescita quasi sovrumano, la pianta, però, esaurisce tutte le sue energie. Ad una ad una le foglie cominciano a staccarsi, ed è la fine.
Una fine che è come una festa, un tripudio d’arcobaleno, con le foglie d’oro che, a centinaia, brillano luminose sul fondo nero dell’asfalto cittadino:
«Si staccò anche l’ultima foglia che da gialla diventò color d’arancio poi rossa violetta azzurra verde poi di nuovo gialla e poi sparì».

La Bibbia secondo Calvino
Card Ravasi
Tempo fa, sfogliando la raccolta mondadoriana dei Saggi (1945-1985) di Italo Calvino, mi sono imbattuto in un testo autobiografico del 1960, intitolato Un’infanzia sotto il fascismo, e in un paragrafo ho scoperto una sorta di ritratto di famiglia. Entrambi i genitori erano liberi pensatori: il padre sanremese, educato in un ambito mazziniano anticlerical-massonico, da anarchico era divenuto socialista riformista; la madre, sarda, «laica» e pacifista, era stata allevata nel culto della scienza. Si erano, così, premurati che il loro figlio Italo fosse esonerato dall’insegnamento religioso e da ogni liturgia cattolica, iscrivendolo a una scuola elementare valdese, prima, e a un collegio inglese, poi.
Con questa premessa, è facile riconoscere quanto sia interessante ricostruire la sua intensa visione etica generale, ma anche comprendere quanto sia arduo isolare un profilo «religioso» di Calvino, accanto ai tanti suoi ritratti che in questo centenario della sua nascita cubana sono stati abbozzati, nelle stesse pagine del nostro supplemento. Una via più concreta potrebbe essere quella di identificare gli ammiccamenti, le allusioni o i rimandi a quel «grande codice» della cultura occidentale che è la Bibbia. Questa formula, come è noto, è il titolo di un saggio del critico canadese Northrop Frye, che è stato l’autore anche di un’Anatomia della critica (1957), letta con partecipazione e persino con un’interlocuzione dialogica da Calvino.
Ed è proprio in questo confronto, cristallizzato nell’articolo La letteratura come proiezione del desiderio (1969), che lo scrittore definisce la Bibbia non tanto simile a un «libro archetipico» (così Frye), ma come una biblioteca, cioè una raccolta di opere messe l’una accanto all’altra alle quali si dà un particolare valore globale e attorno alle quali si ordinano tutti gli altri libri possibili. Oltre ai 73 libri in questione (almeno nel Canone biblico cattolico), Calvino non poteva non essere attratto anche da quella regione letterario-teologica lussureggiante rappresentata dagli apocrifi, segni di una creatività che è stata incessante anche dopo i primi secoli cristiani e che ha raggiunto gli stessi nostri tempi (Borges insegna…).
Non siamo ovviamente in grado di sottoporre a radiografia i romanzi e gli altri scritti calviniani alla ricerca di un palinsesto biblico. Un’operazione di questo taglio, sia pure nel perimetro ristretto di una voce di dizionario, è stata condotta da Davide Savio: è questa l’occasione per raccomandare nuovamente – dopo una nostra recensione apparsa in queste pagine nel 2018 – il Dizionario biblico della letteratura italiana, diretto da Marco Ballarini per l’editrice milanese ITL. Ora, Savio riconosce nel libro della Genesi una filigrana, sia pure esile, alcuni scritti di Calvino, a partire dall’«Eden arboricolo» del Barone rampante.
Per ritrovare, però, uno sfondo spirituale cristiano meno etereo, anzi, corposo e corporale, penso – concordando con Savio – che sia rilevante la Giornata di uno scrutatore del 1963. La vicenda è nota: un cittadino di estrazione comunista, tale Amerigo Ormea, è incaricato di espletare questa funzione connessa alle elezioni politiche nel seggio di una sede molto particolare, quella dell’istituto Cottolengo di Torino, un mondo di «minorati», «deboli», «deficienti» piuttosto ripugnante al personaggio che fa professione di essere razionalista. Progressivamente, però, quel contatto penetra oltre la sua corazza di autodifesa e il racconto si trasforma in una storia di catarsi e di metamorfosi spirituale.
Se è abbastanza naturale l’occhieggiare della figura di Giobbe che è il referente tradizionale sul tema, più decisiva e incisiva è l’entrata in scena del Discorso della Montagna, aperto da Cristo con la sequenza delle Beatitudini, la prima delle quali suona: «Beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli». L’incontro con quell’umanità dolente, celebrata da Gesù in tal modo, qualunque sia l’interpretazione della frase, fa sì che Ormea senta vibrare dentro di sé un sentimento cristiano radicale, quello dell’amore che non conosce confini né ripulse, come attestano coloro che operano al Cottolengo, a prima vista attori sconcertanti nella loro carità agli occhi del freddo scrutatore di schede elettorali.
Il paradosso è proprio celato in quella «ultima città dell’imperfezione» che ha però una sua sorprendente «ora perfetta». Essa lietamente si svela a Ormea e rende quella cittadella di poveri e miseri la Città più alta e ideale. Significativa è una frase di quel testo calviniano, opera importante perché segna anche un trapasso nella biografia stessa dello scrittore, che sta lasciando alle spalle il suo impegno politico gradualmente per una nuova stagione di attività sociale e letteraria: «L’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli che gli diamo». Siamo ormai nel territorio evangelico ove lo stesso precetto dell’«Ama il prossimo come te stesso» è travalicato dalla nuova radicale declinazione operata da Cristo: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per la persona che si ama» (Giovanni 15,13).
Una curiosa nota a margine. Mario Barenghi, che è stato uno dei curatori dei Meridiani calviniani Mondadori, nel suo saggio su Calvino pubblicato nel 2009 dal Mulino, segnalava un probabile sottinteso cristiano nel cognome stesso dello scrutatore: Ormea è l’anagramma di «Amore»!
Pierre Reverdy..."è stata la poesia a condurmi a Dio"
“Il mio desiderio di bellezza era troppo al di sopra delle mie forze”.
Pierre Reverdy, il grande solitario della poesia
Forse è tutto lì, il destino, in quella didascalia – a mano, incisa con sicurezza burocratica –, deposta nei registri dell’ufficio civico di Narbonne. Il 13 settembre del 1889 Pierre Reverdy è catalogato come né da père et de mère inconnus. In realtà, nato in una famiglia di scultori, nato due giorni prima di quanto asserisce il genio comunale, Reverdy sa chi sono i genitori – ostia di indecise identità. Il padre è un viticoltore, emigrato in Argentina senza successo; la madre, in disastro, preferisce lasciarlo a cure altrui: il bimbo, fin da subito, frequenta l’inconnu. Scagliato nell’ignoto, ignoto a se stesso, senza porzione di parentela da spartire sul desco del tempo. L’inconnu è la cifra incantatoria di Pierre Reverdy: scalfire lo sconosciuto, disconoscerlo, disfarsene – incitare le sconfitte.
Mollò presto gli studi, da adolescente capisce che deve donarsi alla letteratura, fino all’ultima stilla verbale; nel 1910 è a Parigi, a Montmartre, sodale di Apollinaire, Aragon, Tristan Tzara. Il ragazzo, di avveniristica precocità, è la dinamite delle avanguardie: intuisce il cubismo, lavora con Picasso, Amedeo Modigliani ne fa l’oggetto di un suo ritratto, si appassiona all’opera di Georges Braque. Durante la Prima guerra, debilitato dagli stenti, è costretto a vendere “un piccolo Braque, che per lui era molto più di un quadro: prima di abbandonarla all’acquirente, pari al gesto che precede l’esecuzione, afferrò la tela con ferocia per baciarla”, ricorda Aragon.
I dada lo adoravano; “nel Manifeste du surréalisme del 1924 André Breton lo esalta come precursore e profeta della nuova poesia” (François Livi). Nel 1917 fondò la rivista “Nord-Sud”: i fascicoli, per lo più mensili, durarono sedici numeri: tra i collaboratori, figura la ‘crema’ avanguardista, puro banditismo artistico; Breton, Max Jacob, Apollinaire e Tristan Tzara, Vicente Huidobro, Philippe Soupault e Alberto Savinio fanno la parte dei leoni a tre teste. Per tutti, Reverdy – che per un po’ va dietro a Coco Chanel, sua amante, muso da musa – è il cardinale della nuova lirica, il papa-re, il poeta più grande di Francia, “uno dei quattro o cinque, in Francia e fuori di Francia, meritevoli di onori”, precisa Giuseppe Ungaretti, un fan. I suoi libri – Les Ardoises du toit, Les Jockeys camouflés, La Guitare endormie – sono realizzati con gli amici artisti, Matisse, Juan Gris, Braque. Nel 1921, per le Éditions du Sagittaire di Simon Kra – che pubblicano, tra i tanti, Thomas Mann e Pirandello, D’Annunzio e Scott Fitzgerald – scrive Étoiles peintes, con un’opera di André Derain (da lì, abbiamo tratto i testi che leggete in calce all’articolo); nel 1924 Gallimard si aggiudica Les Épaves du ciel.
O il maschio o la morte
Ma l’inconnu azzanna Reverdy ovunque, ancora, sempre, non gli dà pace. L’arte, in sé, è una gabbia che il fedele crede un castello, una voliera di uccelli esotici che soltanto l’egotista scambia per il mare aperto. In una delle sue riflessioni più potenti, Reverdy scrive:
“Il mistico si dà a Dio senza riserva e acquista così una libertà incomparabile. L’artista si dà all’arte e vi si trova come invischiato. Lo vedrebbe meglio se potesse, di tanto in tanto, sciogliersene. Il legame con Dio libera perché stacca dalle cose del mondo e perché è l’unico a dare uno spirito veramente disinteressato. L’artista è incatenato al mondo da un doppio interesse. Quello di attingervi la materia della sua arte e quello di creare al di sopra del mondo qualcosa di più elevato. Ma l’artista ricade sempre e più pesantemente sul mondo poiché l’opera da lui realizzata è un nuovo legame che egli stesso si è forgiato”.
Secondo la leggenda, “l’evento decisivo” accade quando Max Jacob interpreta la Passione di Cristo per Reverdy, per gioco. Il poeta, affine, semmai, a una ‘religiosità dell’arte’, non ha mai affrontato il Vangelo, è, per quel che ne sa, ateo. Cristo gli appare pura avanguardia – purificata dal livore dell’utopia, dalla patetica ipotesi dell’uomo-creatore. Il 2 maggio del 1921, nella basilica del Sacro Cuore, Pierre Reverdy viene battezzato; Max Jacob gli fa da padrino. “Conversione immediata, folgorante per un uomo di trentadue anni educato nella più completa ignoranza della religione cristiana… Conversione che non tollera dilazioni e che spinge prepotentemente Reverdy alla ricerca della santità” (Livi).
Scoscendere in Cristo chiede dedizione totale, animalesca: Reverdy, spirito irto, ipersensibile, si chiude a Solesmes, l’abbazia benedettina rifondata da Prosper Guéranger, dal 1926. Con lui, la moglie Henriette, che lo ha seguito nel percorso di conversione. Primo esito della vita reclusa è Il guanto di crine, edito da Plon nel 1927, quaderno di “Appunti scritti per sbarazzare lo spirito privo della facoltà di ragionare dalle idee che lo ossessionano, come gli insetti notturni inquietano le splendide penne del lofoforo. Queste idee sono infilzate sulla pagina come la farfalla sulla panoplia”, scrive il poeta. Gli appunti – stillicidio di parole-stilita – precisano lo stile di Reverdy, cristallino fino alle porte d’avorio del sogno, che procede per scintille. Alcuni di questi appunti – genere letterario da affiancare agli scolii, escolios, di Nicolás Gómez Dávila – sono micidiali:
“Il mio desiderio di bellezza era troppo al di sopra delle mie forze”
“Il poeta è un palombaro che va a cercare nelle più intime profondità della sua coscienza i materiali sublimi che si cristallizzeranno quando la sua mano li avrà portato alla luce”
“La mano di Dio ci sembra sovente ruvida perché tratta i suoi amici deboli con un guanto di crine”
“In arte i grandi spesso divorano i piccoli. Da soli non creiamo nulla: assorbiamo e assimiliamo. I piccoli forniscono spesso ai grandi buona parte della materia che questi ultimi consumano. E i piccoli, troppo deboli, non sanno nutrirsi a loro volta degli esempi che i grandi danno loro”.
Il guanto di crine, per altro, è uno dei rarissimi libri ancora reperibili in Italia di Pierre Reverdy, poeta tradotto troppo poco (nel 1966 Guanda pubblica La maggior parte del tempo, a cura di Franco Cavallo; nel 1972 Antonio Porta traduce, per Einaudi, Il ladro di talento) rispetto all’immensità del valore lirico. Il guanto di crine, per la cura di François Livi, è edito da Ares nel 1993, nella collana ‘Ossidiana’. Me ne donò copia, molti anni fa, Cesare Cavalleri: lo diceva necessario alla mia formazione, “uno dei libri più importanti del secolo, scritto da uno dei poeti più grandi di sempre”. Non era ostile il suo dire, non osteggiava la mia ignoranza – ero un ragazzo, stupefatto come tanti – parlava come se stesse parlando a un’ombra, a un consesso di anime simili. All’epoca capii poco Reverdy – mi colpì moltissimo, invece, Saint-John Perse – ma l’asserzione di C.C., così perentoria, spadaccina, mi costrinse, negli anni, a tornare a quel libro, un breviario spirituale che non consola, intimorisce.
D’altronde, l’inconnu, lo sconosciuto, trafigge proprio quando credi di averne circoscritto l’infinito mistero. Ti getta fuori di casa quando credi di abitarne la stanza regale, o di averne intuito il sottoscala, le vie di fuga. Ti toglie la sedia da sotto, ecco.
Secondo la critica, Reverdy scrive i libri più belli in quella solitudine: Le Chant des morts, ad esempio, uscito nel 1948 con venticinque litografie di Picasso. A volte tornava a Parigi – già fuori dal tempo, senza bordeggiare le fiumane della malinconia. Secondo alcuni, Reverdy fu così a lungo al cospetto dell’inconnu da perdere la fede, da non sapere più cosa fosse. Morì a Solesmes il 17 giugno del 1960, “dopo trentaquattro anni di una caparbia ricerca e di una solitudine che adombra non pochi drammi” (Livi). Dei postumi proclami, delle liturgie in onore, se ne sarebbe fatto poco – una vita è a sua volta una nota, una falena verbale, qualcuno che si inchina, prende l’acqua e te la offre.
**
Pierre Reverdy, Étoiles peintes
La meccanica verbale e il dono di sé
Nessuna parola potrebbe esprimere meglio, è indubbio, la sua gioia.
Lo disse e quelli che attendevano, contro il muro, tremarono.
Al centro: una grande nuvola – una testa enorme e gli altri che fissano i miseri passi sul sentiero.
Non c’è niente e nel silenzio gli atti si fanno difficili. Un treno passa dietro le barriere e fa brillare nell’oblio le linee che serrano il paesaggio.
Poi tutto scompare, mescolato all’ininterrotto brusio della pioggia, del sangue perduto, del tuono e delle parole meccaniche pronunciate dal più importante dei personaggi.
*
L’ombra e l’immagine
Se rido non è per il mondo luminoso e gioioso che mi passa davanti.
Le teste che pendono come quelle diritte mi fanno paura e la mia risata risorge in una smorfia.
Le gambe che corrono tremano e i piedi, troppo pesanti, mancano il passo.
Non rido del mondo che mi passa davanti – ma sono solo, più tardi, nei campi, davanti all’enorme foresta placata e ci sono voci che, nell’aria che dorme, si rincorrono.
*
Movimenti all’orizzonte
I cavalieri tengono la strada, di profilo. Non sappiamo quanti siano. Contro la notte che blocca il sentiero, tra il fiume e il ponte una sorgente che piange – un albero che ti segue.
Se guardassi la folla che passa, non ti vedrebbero. È una vera armata in marcia oppure un sogno – sullo sfondo, una nuvola.
Il bambino piange o dorme. Ci guarda o sogna.
Il cielo è affollato da tutte queste armate. La terra trema. I cavalli scivolano nell’acqua.
Anche i cortigiani in processione scivolano dentro quest’acqua che cancella tutti i colori, tutte le lacrime.
*
Memoria dell’uomo
Ha le spalle larghe contro l’ombra che danza sul muto, occupa il posto dove potrebbero passare altre teste.
Lo strumento è una chitarra le cui note non sono abbastanza alte.
Nessuno sente la musica, eppure le dita pizzicano sulle corde; sta giocando e i piedi battono incessantemente il ritmo.
Un occhio chiuso, l’altro perso dietro il sipario plissettato, quando l’aria si dilata e la folla balla, tutto il mondo balla, tutti gridano e infine due braccia bianche emergono dal fumo della sua pipa e gli cingono il collo.
Sullo sfondo, i ballerini non guardano più il tappeto.
*
Tra due crepuscoli
È in questo cubo di cielo, più chiaro, che si accenderanno le stelle per i fuochi d’artificio.
Sopra il profilo degli alberi – moti del vento, brusii di temporali – appelli minacciosi. Qui è dove si spalanca il cancello.
Raggi si staccano dal muro: un’ombra obliqua sulla strada – corre troppo veloce.
Aspettiamo. Presso il bosco, dove sorge il padiglione, un rumore – certamente di passi tranquilli – nello stesso tempo in cui si alza una preghiera e, più in là, una canzoncina gioiosa.
Poi il giorno entra tra noi del tutto, e i cuori si ristabiliscono.
Dopo tutto, tutto è ancora rimandato.
Pierre Reverdy
Stefano Benni...trasformare l'infinito in parola



Stefano Benni: vedeva l’infinito nelle piccole cose
Roberto Carnero
Scomparso il 9 settembre a Bologna all’età di 78 anni dopo lunga malattia, occupava un posto originale nel panorama della letteratura italiana contemporanea
Stefano Benni, scomparso a Bologna all’età di 78 anni dopo lunga malattia, occupava un posto assolutamente originale, se non si vuole dire unico, nel panorama della letteratura italiana contemporanea. Quello di uno scrittore che nei suoi libri ha optato per una vena comica, ma senza per questo rinunciare a una qualità letteraria sempre molto alta. Non che le due cose - genere comico e valore letterario - siano di per sé incompatibili. Ma è un dato di fatto che nella tradizione italiana il comico ha sempre rappresentato, tra i vari generi, un filone minore e minoritario. Ecco, sotto questo profilo l’opera di Stefano Benni rappresenta una felicissima eccezione.
D’altra parte l’etichetta di “scrittore comico” sarebbe stretta per lui, le cui specifiche tonalità erano soprattutto quelle dell’umorismo. Comicità e umorismo sono soltanto apparentemente sinonimi. Come ci ha insegnato Pirandello, mentre la semplice comicità provoca una risata immediata e irriflessa, l’umorismo presenta e analizza la realtà in modo più sofisticato, spesso rivelandone e denunciandone la tragicità, illuminando e smontando le convenzioni e le credenze che a volte usiamo per indorare la pillola, per renderci la vita meno amara.
Stefano Benni era nato a Bologna il 12 agosto 1947. Fin dall’opera d’esordio, Bar Sport (1976), si è distinto per l’estro creativo e l’impegno satirico: trasfigurava la realtà, facendola quasi esplodere a colpi di esagerazioni fantasmagoriche e intrecci elaborati e divertenti. Diversi sono i generi in cui si è cimentato: dalla poesia (Prima o poi l’amore arriva, 1981) al romanzo di fantascienza (Terra!, 1983), dalla raccolta di racconti (Il bar sotto il mare, 1987) alla prosa fantastica a sfondo ecologico-politico (Spiriti, 2000).
Nel 2012 lo scrittore ha debuttato alla regia teatrale con Le Beatrici, liberamente tratto da un suo testo e presentato al Festival di Spoleto, mentre l’anno successivo ha diretto e interpretato Il poeta e Mary, racconto per musica e parole sul valore sociale dell’arte. Tra le opere più recenti possiamo ricordare Di tutte le ricchezze (2012), Pantera (2014), Cari mostri (2015), La bottiglia magica (2016). E ancora: Prendiluna e Teatro 3 (2017), che ne raccoglie i testi teatrali; il docufilm autobiografico Le avventure del lupo. Storia quasi vera di Stefano Benni (2018); il poema Dancing Paradiso e la favola su Inge Feltrinelli La bambina che parlava ai libri (entrambi del 2019); il romanzo Giura (2020).
La sua satira ha trovato spazio anche nel giornalismo. Nella sua carriera di scrittore, ha collaborato con vari periodici e quotidiani, tra cui “Cuore”, “il manifesto”, “MicroMega”, “Panorama” e “la Repubblica”. È stato anche autore televisivo, tra i primi a scrivere per un giovane Beppe Grillo.
Secondo la migliore tradizione del genere umoristico, le opere di Benni combinano il riso con la riflessione sulle tare della società e della cultura contemporanee. Dietro il sorriso, trapelano infatti una viva inquietudine esistenziale, un acuto disagio per le ingiustizie del mondo, un amore insopprimibile per la libertà. Ma è interessante riflettere anche su un altro meccanismo chiave della comicità di Benni, il quale si diverte a dotare la voce narrante dei suoi libri di uno speciale talento per la similitudine, la metafora e l’invenzione di immagini iperboliche, che fanno sconfinare le vicende e i loro protagonisti nel territorio dell’inverosimile. Si verifica quello che i critici chiamano “sfondamento del realismo”, cioè il passaggio dalla narrazione di eventi possibili a quella di eventi incomprensibili secondo le leggi razionali con cui solitamente interpretiamo la realtà. Così nei suoi libri - più di 20 volumi di romanzi e racconti, tutti pubblicati da Feltrinelli e tradotti in 30 lingue - Benni ha saputo raccontare il nostro Paese con uno sguardo personale, coniugando profondità e leggerezza, impegno e immaginazione.
Enrico Palandri, che lo conobbe a Bologna nella seconda metà degli anni ‘70 quando frequentava il Dams, ne ricorda il carattere: «Da un lato era un tipo malinconico, perché era consapevole dei guai del mondo e non poteva non vederlo in modo critico, però l’ho sempre incontrato in circostanze molto allegre. Quando nel ‘79 uscì Boccalone, il mio primo romanzo, venne a trovarmi nella mia stanza di studente fuori sede in via Begatto per presentarmi Goffredo Fofi. Nella mia stanza c’era solo un letto, e facemmo una lunga chiacchierata tutti e tre seduti su quel letto. Ricordo la sua disponibilità umana e l’attenzione verso i giovani. Il gradimento che i lettori giovani continuano a tributargli è il segno della genuina freschezza della sua ispirazione. Fin che ci saranno scrittori come lui (ci sono ancora, ma sono sempre meno), si potrà ridere del potere. La cosa terribile è quando non si può più ridere di chi è al comando. Il narcisista Trump che trascina in tribunale chi lo critica è il segno del fallimento di una società democratica».
Da critico e storico della letteratura, Marco Antonio Bazzocchi, ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso l’Alma Mater, l’ateneo della città di Benni, sottolinea un aspetto peculiare del suo stile: «Benni rappresenta l’ultimo scrittore che coglie l’atmosfera di un mondo e di una città attraverso elementi minimi che diventano enormi grazie alla sua scrittura. Il suo è una sorta di surrealismo che però non si esaurisce nel sogno, ma vede il sogno dentro la realtà. È un surrealismo che a volte diventa visione cosmica sulla cui base Benni si prende gioco del mondo».
Nel post su Facebook con cui ha comunicato la notizia della sua morte, il figlio dello scrittore suggerisce un modo per celebrarlo: «Una cosa che mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Quindi, se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le sue opere che vi stanno più a cuore a chi vi è vicino. Sono sicuro che, da lassù, vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe una grande risata».

Stefano Benni: Ultima cena. Gesù e i suoi trentasei apostoli
Tutti mangiano con appetito e cantano. Solo Gesù sembra triste. -Maestro, cosa ti cruccia ? - chiede Pietro. -Ahimè! Io mi sono dato da fare. Ho fatto miracoli. Ho fatto del bene a tutti. Ma nessuno lo riconosce.
-Ma cosa dite Maestro? - dice Giovanni- tutti noi vi ammiriamo e siamo al vostro fianco.
- No - dice Gesù con voce piagnucolosa - ce l'hanno tutti con me. La stampa è in mano agli ebrei, ai romani e ai comunisti.
-Ai cosa?
-Una setta che ancora non conoscete. Dicono che non ho fatto nulla contro la corruzione, che faccio discorsi sconnessi, che sono un mediocre agitatore di folle, un piazzista di me stesso. Ma voi sapete quante miracolose imprese ho compiuto. Ho resuscitato i vecchi democristiani, e la pidue, ho sdoganato i fascisti, ho riciclato la mafia. Ho messo ordine nei media
. -Usate parole latineggianti, ora ? - dice Luca.
-Mi capita, talvolta. L'aramaico è così obsoleto. E poi ho detto bugie, tante bugie ma a fin di bene, per dare speranza a questo popolo bue. Ho fatto leggi ad personam...
-E dai - sbuffa Pietro.
-Ma non esiste dottrina senza legge. E con me l'economia è fiorita, sono spuntati milioni di posti di lavoro, nessuna industria è fallita, ho abolito la censura, ho ridotto le tasse e ho in mente autostrade senza curve, e un ponte che collegherà la Magna Grecia a Opitergium. Ma la stampa non me ne dà merito, e il sinedrio mi perseguita.
Gli apostoli iniziano a ridere, dapprima con garbo poi abbastanza sgangheratamente.
-E quando mio padre lassù oltre l'Oceano mi ha dato l'ordine di combattere gli infedeli ho obbedito e ho portato in quei luoghi pace, sicurezza e appalti per tutti.
Altre risate.
-E tutto questo contro i miei interessi, perché in questo lavoro non ho guadagnato nulla, sono povero come ero una volta, ho a malapena qualche piccola società all'estero, e nessuno può certo dire che ci sia un conflitto tra i miei interessi divini e quelli terreni.
-Certo che no - dice Giuda.
-In quanto a te, Giuda, infido alleato so che alla prima elezione sfavorevole mi tradirai. E tu Maddalena stai lontano dai filosofi. E tu Pietro, prima che il Mibtel cali tre volte...
-Maestro si calmi, le sta cedendo il lifting.
-La gente vuole un Cristo giovanile e manageriale, non un vecchio clochard - si lamenta Gesù - anche questo restauro l'ho fatto per voi. Ma nessuno capisce i miei miracoli, sono un incompreso, sono un Dio ma nessuno lo capisce.
Un grande applauso si leva dal tavolo. Gesù alza il calice, e con una gran risata esclama:
-Che ve ne pare ragazzi?
-Sei grande, Maestro - dice Giovanni. Quando fai l'imitazione di quel cretino ci fai morire dal ridere.
-Dovresti fare l'attore - dice Efisio, discepolo poi misconosciuto.
-Dài raccontaci ancora come hai moltiplicato dal nulla il capitale iniziale..
. - No, racconta di quando non sapevi che il tuo avvocato era andato a corrompere Pilato..
. -No a me piace la storiella che tu non ti occupi della Rai...
Tutti ridono. Solo Tommaso sta serio in disparte.
-Tommaso che c'è? Ancora dubbi?
-No Maestro, ma... è mai possibile, come tu hai profetizzato, che un giorno un paese possa essere governato da un incapace vittimista, vendicativo e mediocre come costui?
-E' possibile. Il mondo conoscerà tiranni e tirannelli. Ma non temete: tutto andrà bene, se avrete fede.
-L'abbiamo, Maestro - dice Romina, discepolo assai trasgressivo.
-Tre urrah per il Maestro - grida Alì Giacomo, l'apostolo più combattivo ed estremista, imbraccia il fucile e spara in aria in segno di giubilo.
Si ode il rumore di un elicottero.
-Giacomo - dice Gesù -l'hai fatta grossa.
L'elicottero, credendo di trovarsi di fronte a un'adunata di terroristi, rade al suolo il ristorante.
Dal cumulo di macerie escono Luca Matteo Giovanni e Romina.
-E adesso che è finita così, chi ha il coraggio di raccontarla?
-Ci inventiamo una storia - dice Luca - allora, mettiamoci d'accordo. Dunque, c'è un monte che si chiama Golgota... sì, lo picchieranno e lo umilieranno, ma sarà un caso isolato...
Gli altri prendono appunti.
Cesare Pavese..."E' bello vivere, perché vivere é cominciare sempre, ogni giorno"


Pavese fermo sulla soglia
di Cristo
Ho conosciuto Lorenzo Mondo nella primavera del 2001 quando organizzai una giornata di studi su letteratura e cattolicesimo nel Novecento per conto del Pontificio Consiglio della Cultura e pensai di invitarlo a parlare di Cesare Pavese. Era un autore “suo”, così come Fenoglio e cercavo una voce autorevole su questa grande, drammatica figura del Novecento italiano. Venne a Roma insieme agli altri relatori per l’evento che si svolse presso la Casa delle Letteratura il 28 marzo alla presenza del cardinale Poupard e mi colpì per l’eleganza dei modi, la finezza del pensiero, la passione più che per la letteratura direi proprio per la persona di Pavese. Un gentleman raffinato e discreto per nulla “seduto sulla cattedra” di una fama e di una competenza per altro inoppugnabili. È con grande piacere, con un senso di gratitudine a distanza di più di 20 anni, che pubblichiamo ampi stralci di quell’intervento che poi fu raccolto insieme alle altre relazioni nel volume degli atti curato e pubblicato dalla Rivista «Communio» partner insieme al Pontificio Consiglio dell’organizzazione dell’evento.
Andrea Monda
Dopo l’8 settembre 1943, data di proclamazione dell’armistizio, Cesare Pavese lascia Torino e si rifugia a Serralunga di Crea, in Monferrato. (...) È un Pavese inconsueto che si afferma, insospettato anche dagli amici più stretti, e questo dà la misura tra l’altro della sua solitudine.
C’è intanto l’episodio del taccuino 1942-43, rimasto inedito e pubblicato postumo, con grande stupore e scandalo. Pavese appare stranamente sensibile all’idea di patria, ripone qualche speranza nella Repubblica sociale Italiana e, davanti allo sfascio dell’Italia, professa ammirazione per la disciplina della Germania (con torbide concessioni al culto pagano della terra e del sangue). Lo sviamento, che dura fino al dicembre del ’43, viene superato sulla spinta di nuove, più acute preoccupazioni. Lo scrittore (...) ha trovato lavoro nella vicina Casale: come ripetitore e assistente di studio nel Collegio Trevisio, tenuto dai Padri Somaschi.
E in quell’ambiente che matura in lui una crisi religiosa e si accosta al cristianesimo. Un giovane religioso, padre Giovanni Baravalle, racconterà di averlo confessato e comunicato il 1 febbraio del 1944. Il diario offre numerosi riscontri, a partire da una nota del 29 gennaio 1944: «Ci si umilia nel chiedere una grazia e si scopre l’intima dolcezza del regno di Dio. Quasi si dimentica ciò che si chiedeva: si vorrebbe soltanto goder sempre questo sgorgo di divinità. E questa senza dubbio la mia strada per giungere alla fede, il mio modo di esser fedele. Una rinuncia a tutto, una sommersione in un mare d’amore, un mancamento al barlume di questa possibilità. Forse è tutto qui: in questo tremito del “se fosse vero! Se davvero fosse vero...’’».
E una svolta nel suo atteggiamento verso il cristianesimo. Fino ad ora ha mostrato di apprezzarlo come dottrina di vita, come fondamento di una norma etica (....). Ma la sua «strada» verso la fede non sa prescindere dal percorso culturale e stilistico. Si applica coscienziosamente a libri di carattere religioso e teologico (Romano Guardini, Peter Wust, Alphonse Gratry), si prova ad allineare, in base alla lettura della Bibbia e dei suoi esegeti, le «prove certe», in realtà datate, dell’esistenza di Dio.
Ma ciò che conta è lo «sgorgo di divinità», la sublimazione dell’atteggiamento estatico che prova da sempre nei confronti della natura, del richiamo folgorante che esercita su di lui la memoria dell’infanzia. «La ricca e simbolica realtà dietro cui ne sta un’altra, vera e sublime, è altro dal cristianesimo? Accettarlo vuol dire alla lettera entrare nel mondo del soprannaturale» (1 febbraio 1944).
D’altra parte non cessa di indagare (...) la consistenza del mito, dei modelli esemplari che si trovano nella cultura greca, nella «sapienza» presocratica. Il mito è all’origine dell’umanità come l’infanzia è all’origine dell’individuo e rappresentano entrambi una riserva inesauribile dello spirito. L’analogia tra preistoria e infanzia, tra questi due momenti aurorali, sembra tuttavia incrinarsi alla considerazione che il primitivo si accompagna sempre al selvaggio, allo scatenamento di sesso e violenza. Italo Calvino ha segnalato nelle concezioni di Pavese l’affioramento vago di una anamnesi platonica, che di per sé non sarebbe avversa al cristianesimo ,ma che mal si concilia con l’idea di un uomo intrinsecamente corrotto. Mancherà sempre a Pavese il senso di una natura caduta e, in quanto tale, capace di riscattarsi; la distinzione che restava in Leopardi, tra il primitivo e il selvaggio, quest’ultimo destituito della originaria innocenza.
Resta il fatto che, mentre insegue affannosamente le metafore del sacro, Pavese ammette, all’aprirsi del 1945, di avere vissuto una «annata strana, ricca. Cominciata e finita con Dio»; «il semplice sospetto che il subcosciente sia Dio, che Dio viva e parli nel nostro subcosciente ti ha esaltato». Non si tratta, di necessità, del Dio cristiano. La divaricazione è suggerita dallo stesso Pavese quando (siamo ai primi del ’46) scrive: «Certo il mito è una scoperta di Crea, dei due inverni e dell’estate di Crea. Quel monte ne è tutto impregnato».
Non si riferisce dunque al santuario cristiano (...) ma al bosco che viene prima e le annuncia, quello che rappresenta un percorso iniziatico ai Dialoghi con Leucò Cristo sembra svanire dietro le sembianze di Dioniso (...). Perché i Dialoghi, il libro più amato da Pavese si definisce pur sempre un «colloquio tra l’umano e il divino», manifesta un’ansia di sacralità che resiste alle forti contestazioni storicistiche e illuministiche. È là che un personaggio esperto di generazioni divine come Esiodo ammonisce: «Ogni gesto che fate ripete un modello divino. Giorno e notte, non avete un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal silenzio delle origini».
E sono gli stessi Dialoghi che si concludono con questa ambigua, riluttante affermazione di sconfitta: «Credo in ciò che ogni uomo ha sperato e patito. Se un tempo salirono su queste alture di sassi o cercarono paludi mortali sotto il cielo, fu perché ci trovavano qualcosa che non sappiamo. Non era il pane né il piacere né la cara salute. Queste cose si sa dove stanno. Non qui. E noi che viviamo lontano lungo il mare o nei campi, l’altra cosa l’abbiamo perduta». L’altra cosa cui allude Mnemòsine, la memoria, con un brivido di nostalgia è l’incontro con gli dei.
Ma Pavese, in quel di Casale, oltre a padre Baravalle ha conosciuto un altro, eccentrico personaggio. Carlo Grillo appartiene a una vetusta nobiltà di provincia. E anche lui, a suo modo, un fuggiasco. Ha combattuto come aviatore nei cieli di Malta, è tornato a casa minato nel fisico e nel morale. Prende cocaina in dosi massicce. (...) è in rotta con il suo mondo. Pavese lo incontra, forse ai primi del 1945, sul piazzale del santuario di Crea. È incuriosito dalle sue elucubrazioni sulla droga come fonte di conoscenza, sulle «profondità tragiche e misteriose della mente» che si possono raggiungere con la polvere bianca. Parla di Dio, di libertà e destino. (...) Del conte Grillo si ricorderà facendone il personaggio di Poli, il debosciato, infelice «rentier» del Diavolo sulle colline. Per qualche tempo, dopo il ritorno di Pavese a Torino, alla casa editrice Einaudi, si scrivono. Il conte Grillo continua a battere, confusamente, sul tasto religioso. Pavese reagisce con un bonario scettico distacco: «Quando mi racconterà per quali strade è giunto a Damasco? Io resto incorreggibile, sebbene parecchi Sinistri cristiani facciano di tutto per salvarmi».
Allude certamente al filosofo Felice Balbo, alla stessa Natalia Ginzburg, al piccolo gruppo di comunisti cristiani annidati nella casa Einaudi.
Siamo nel 1946, e sembrano allontanati i giorni di Canale (...). Che rispuntano, con intonazione patetica in una pagina del Mestiere di vivere, due anni dopo: «Perché quando riesci a scrivere di Dio, della gioia disperata di quella sera di dicembre al Trevisio, ti senti sorpreso e felice come chi giunge in un paese nuovo? (oggi, pagina del capitolo xv della Collina)». Pavese sta scrivendo uno dei suoi romanzi più significativi, La casa in collina, appunto. E nel capitolo accennato il prof. Corrado, alter ego dello scrittore, trova un bel sollievo alla guerra, al sangue versato, alla propria inadeguatezza e viltà, entrando in una chiesa. Sente una beatitudine inattesa, un trasalimento, uno «sgorgo di gioia» (...). Così, il successivo riparo nel Convento di Chieri si rispecchia nel Collegio Trevisio, mentre la figura di padre Felice è esemplata su quella di padre Baravalle. Corrado, ripensando al suo «incontro» con Dio «cova un tumulto terribile», riprova a pregare, scopre nella liturgia cattolica i ritmi delle care stagioni, il battito di una natura perenne. Il pericolo incalza, bisogna lasciare il Convento, cercare una dubbia pace sulle colline materne. Con un parallelo allontanamento delle suggestioni cristiane. Il viaggio è segnato non a caso da profili di chiese e cappelle che svaniscono sui crinali (...).
Ritorneranno, a intervalli, le sensazioni di un tempo. Siamo ormai al dicembre 1949 quando scrive: «Quel senso dell’inverno ’44 (dicembre), quel raccogliersi in una stanza, tra l’odore della cucina e la finestra appannata davanti ai colli nevosi, quei ritorni dalle colline pregustando la pace tiepida tornerà ancora? Né mancavano i pensieri di tranquilla lettura spirituale, la speranza di una pace suprema (...)». Ma la rimembranza era stata preceduta da una ben più esplicita ammissione. Pavese è in corrispondenza di lavoro con Rosa Calzecchi Onesti, la accompagna e sostiene nella sua traduzione dell’Iliade. La Calzecchi ha letto Prima che il gallo canti (il dittico pavesiano che contiene La casa in collina), vi ha intravisto un tormento religioso. Pavese risponde: «Quanto alla soluzione che mi augura di trovare, io credo che difficilmente andrò oltre al capitolo iv del “Gallo”. Comunque, non si è sbagliata sentendo che qui è il punto infiammato, il locus di tutta la mia coscienza» (14 giugno 1949).
Il disagio religioso, trascurato dalla critica a vantaggio di aspetti più laterali, è una delle componenti essenziali della sua opera. E il cristianesimo scavalcato all’indietro o storicizzato al pari degli altri «miti» (ma la tensione resterà fino all’ultimo irrisolta) sarà sempre presente in lui come una trafittura (.... ).
Ma nel diario, al 18 agosto 1950, il congedo diventa un grido strozzato: «Scrivo: o Tu, abbi pietà. E poi?».
Il resto è silenzio.

Pavese: il mestiere di credere
Filippo Rizzi
Da Sanguineti a Barsotti, da Calvino all’amico padre Baravalle, tutte le testimonianze sull’inquieta ricerca dello scrittore, uno «spirito religioso» morto suicida a Torino sessant’anni fa.
«Mi scriveva da Roma, in un periodo di sconforto. Diceva di essersi recato in una chiesa, ma che gli era parso che una mano invisibile lo respingesse: "Forse non sono degno di avvicinarmi a Dio"». Fu lo sfogo amaro che espresse in una lettera Cesare Pavese, pochi anni prima di morire, al suo amico e confidente il religioso somasco padre Giovanni Baravalle. Sono trascorsi sessant’anni da quel tragico 27 agosto quando in serata venne trovato morto in una stanza dell’albergo Roma di Torino lo scrittore Cesare Pavese (1908-1950): il grande poeta delle Langhe si era tolto la vita con sedici bustine di sonnifero. La sua opera, nel corso di questi sessant’anni, è stata solcata dalla critica di ogni segno e direzione mettendo in evidenza il suo dramma esistenziale ma anche religioso. Anzi buona parte della critica, da angolature ideologiche diverse, ha affermato che è giusto mettersi di fronte alla sua opera con l’umiltà tipica che si deve avere nei confronti degli spiriti religiosi. Non a caso molti critici, da Edoardo Sanguineti a Bona Alterocca, dal gesuita Domenico Mondrone a Geno Pampaloni, dal monaco Divo Barsotti fino ai recenti studi dell’arcivescovo dell’Aquila Giuseppe Molinari, di Vincenzo Arnone e di Antonio Spadaro, non hanno dimenticato le suggestioni religiose che hanno attraversato la breve vita di Cesare Pavese. Ancora oggi rivelatore di questa ricerca del trascendente è il giudizio di Geno Pampaloni nel trentennale della morte: «Credo in definitiva che Cesare Pavese sia stato quello che via via ha rappresentato; e credo che per rileggerlo con giustizia sia necessaria l’umiltà del dolore con cui i trentenni del’50 accolsero la notizia della sua morte. L’umiltà, vorrei aggiungere, che occorre di fronte agli spiriti religiosi». In molti scritti, da Il mestiere di vivere ai diari, dai suoi romanzi a – soprattutto – le lettere indirizzate, ad esempio, agli amici di sempre come Fernanda Pivano, Davide Lajolo, il cattolico e antico compagno al liceo d’Azeglio Tullio Pinelli, alla sorella Maria emerge il grande fascino che Pavese avverte per la figura di Cristo come personaggio storico, associata per grandezza nel campo della carità a Dostoevskij – «Tutto il resto sono balle» –, ma ricorrono anche gli interrogativi sulla vita, la morte, il peccato, l’aldilà, l’esistenza di Dio. In particolare, sul finire degli anni Venti, si confronta con Tullio Pinelli sulla sua opera giovanile Il crepuscolo di Dio, dove affronta in modo fantastico ed originale, in uno stile quasi da pamphlet teologico, il tema dell’aldilà. Sono gli anni in cui Pavese, grazie a Pinelli, frequenta un sacerdote di simpatie moderniste, don Brizio Casciola. Con l’antico compagno di liceo manterrà una fitta corrispondenza fino all’agosto del 1950. Sarà lo stesso Pinelli, oramai divenuto famoso sceneggiatore di molti film di Fellini, nel 1996, in una intervista rilasciata a "Jesus", a raccontare la religiosità del suo amico: «Era uno spirito religioso, tormentato dal dubbio, dall’incertezza. Il punto terminale, su questa terra, della nostra discussione è stato sulla religione e su Dio». Nonostante le crisi esistenziali e religiose il pensiero di Dio diventa, come testimonia lo stesso poeta delle Langhe ne Il mestiere di vivere: «Lo sgorgo di divinità lo si sente quando il dolore ci ha fatti inginocchiare». Ed è proprio durante il periodo di confino e di prigionia prima a Roma a Regina Coeli e poi a Brancaleone Calabro, negli anni Trenta, per le sue posizioni contro il regime fascista, che confida in alcune lettere alla sorella Maria di essersi appassionato alla lettura della Bibbia e delle Osservazioni sulla morale cattolicadi Alessandro Manzoni. Nel 1939 Pavese giunge, addirittura, ad affermare che la religione è la soluzione del più gravoso problema della vita, quello relativo a come uscire dalla propria solitudine: «La preghiera è lo sfogo come con un amico. L’opera equivale alla preghiera, perché mette idealmente in contatto con chi ne usufruirà». Ma nell’itinerario religioso dello scrittore delle Langhe è il 1944 quello che lui stesso definirà «l’annata strana e ricca, cominciata e finita con Dio». In quel periodo, per sfuggire ai tedeschi e fascisti e agli orrori della guerra e non essere di peso alla sorella Maria, Pavese cerca un lavoro e lo trova presso i padri somaschi nel collegio Trevisio di Casale Monferrato, come assistente e guida nelle ripetizioni agli studenti. Stringe una particolare amicizia con padre Giovanni Baravalle. È il religioso somasco a procurargli i libri durante il suo ritiro forzato: dall'Action di Maurice Blondel allo Spirito della liturgia di Romano Guardini, alla Storia delle religioni di Pietro Tacchi Venturi. Non a caso la mite figura del padre Baravalle ritornerà, nella narrativa pavesiana, in La casa in collina, sotto il nome di padre Felice. Il dialogo con il religioso somasco sfocerà in una sincera amicizia che porterà il poeta delle Langhe a ricevere il sacramento della confessione e il giorno successivo il 1 febbraio del 1944 la comunione. Durante il soggiorno a Casale Monferrato e a Serralunga di Crea frequenti sono le visite di Pavese al santuario della Madonna nera, dove si confronta sul tema del credere con un sacerdote di quel luogo. Dopo il 1945 si diradano gli incontri con il "suo prete", padre Baravalle, ma continua la corrispondenza testimoniata dalle tante interviste e testimonianze rilasciate dal religioso negli anni successivi alla morte di Pavese, dal 1970 al 1990 al "Secolo XIX", "Gente" e "Il Corriere della Sera". E proprio sulle colonne del "Secolo" di Genova padre Baravalle, in un’intervista concessa a Carlo Repetti, tornerà con la mente alla drammatica lettera di Pavese in cui una «mano invisibile pareva che respingesse» lo scrittore delle Langhe da una chiesa di Roma: «Gli risposi immediatamente esortandolo a superare la crisi. Forse avrei dovuto essergli maggiormente vicino con gli scritti; è un rimorso che di quando in quando mi assale, come mi assalì la prima volta allorché leggendo il giornale del 28 agosto 1950 vi lessi la notizia del suicidio». E vent’anni dopo, nelle memorie stese e affidate alla cura di Cesare Medail, sul "Corriere" aggiungerà: «Aveva un fondo di religiosità. Le tirannie della vita, le letture disordinate lo avevano gettato nel dubbio. Tutto questo mi convinse che il problema di Dio era rimasto ben presente in Pavese, dopo Casale, pur escludendo che i mesi del chiostro ne avessero fatto un fervente cristiano». Un’irrequietezza forse di vivere che ancora oggi è ben scolpita dalle parole di Italo Calvino dedicate all’amico nelle sue lettere dal 1940-85: «La sua disperazione non era vanità del vivere, ma di non poter raggiungere quell’interezza di vita che desiderava». A sessant’anni dalla sua scomparsa rimane ancora attuale e intatto, nella sua lucidità e freschezza, il giudizio, scritto nel 1968, da don Divo Barsotti sul dramma esistenziale del poeta delle Langhe: «Pavese è stato consapevole di essere un vinto: ma da chi? L’impotenza a costruire una sua vita può essere stata la condizione, per lui, di abbandonarsi a Dio. Allora l’atto dell’abbandono avrebbe concluso la sua vita meglio di come egli poteva aver sognato». Il suo gesto estremo mette a nudo la sua «protesta di vita» come ebbe a scrivere ne Il mestiere di vivere. Su questa protesta riecheggiano ancora oggi le ultime parole del diario di Pavese, scritte il 18 agosto del 1950: «O Tu, abbi pietà. E poi?».
Ezio Bosso..."la musica é un gesto d'amore"
«Suono Bach, quindi mi rapporto ogni giorno col divino. Tutti, tutti i giorni, ci rapportiamo col divino, in un modo o in un altro, poetico, religioso, critico. Fa parte del nostro essere umani. Io potrei definirmi diversamente credente oppure sono uno così ateo che non sopporta gli atei. Piuttosto direi che alla giustizia divina ci credo, non a quella degli uomini attraverso Dio. Credo nella vita, e non ho rapporto con la morte come una chiusura. Ho dedicato la composizione Sixt breath, sesto respiro, all’ultimo respiro, che è quello che continua a vagare, continua in un altro modo negli altri, noi continuiamo a esistere. Noi facciamo di tutto per dimenticare che siamo un ciclo di vita e non un ciclo di morte».
Ezio Bosso

Ezio Bosso: «La musica è un gesto d’amore»
data di nascita 13 settembre
Il compositore e direttore d'orchestra è morto nella sua casa di Bologna nel 2020: aveva 48 anni. Nel 2011 era stato operato al cervello ed era stato colpito da una sindrome neurodegenerativa, ma non aveva mai smesso di lottare e di far amare l'arte e la bellezza.
“La musica per me è vita: è una un’amica, una compagna sincera… è la mia salvezza, la nostra salvezza”.
Bosso, in quell’occasione, aveva affrontato anche temi impegnativi come il senso del dolore e della gioia, a partire dall’esperienza personale di una grave sindrome neurodegenerativa che tuttavia non gli ha impedito di continuare a comporre, incidere dischi ed esibirsi in tutto il mondo.
Un percorso di riflessione sulla vita, la bellezza e la fede. “Nella fede – spiegava Bosso – troviamo una radice in cui poterci ancorare per non essere spazzati via”.
John Ronald Tolkien... l'esistenza come cammino di Fede. Il Bene vince sul male.

Tolkien, "Il Signore degli Anelli" e le Sacre Scritture
ricorrenza morte Tolkien 2 settembre
Pugni, Paolo Curatore
'Il Signore degli Anelli' è fondamentalmente un'opera religiosa e cattolica scrive Tolkien nella lettera del 2 dicembre 1953 a padre Robert Murray: notizia per nulla sorprendente se si considera appunto la vita del suo autore, plasmata da una profonda fede ereditata dalla madre, convertita dalla religione protestante della sua famiglia d'origine - il padre di Mabel, educato in una scuola metodista era poi diventato unitariano - al cattolicesimo, scelta che pagò con la vita, essendo stata ripudiata e abbandonata alla miseria con disprezzo dai suoi.
Questa è la giusta lente con la quale osservare e comprendere tutta l'opera di JRR e il suo capolavoro in primis, come giustamente fanno notare sia Paolo Gulisano, altra conoscenza di queste pagine, nel bello studio Il mito e la grazia (Ancora), sia Andrea Monda e Saverio Simonelli nel loro interessante saggio Tolkien il signore della fantasia (Frassinelli).
I pregevoli testi di Gulisano e di Monda-Simonelli, per certi versi abbastanza simili, muovono saggiamente dalla biografia di Tolkien per notare come la sua opera completa, e non solo Il Signore degli anelli, sia un inno alla Grazia con rimandi continui alla Sacra Scrittura. Entrambi i testi si soffermano a lungo sull'intreccio tra biografia e bibliografia, ed entrambi illustrano chiaramente fin dall'inizio il pensiero fondamentale di Tolkien sul senso della vita e della scrittura: il famoso concetto della subcreazione, che vede l'uomo accanto a Dio nell'opera di formazione della realtà, evidentemente con dei distinguo: il subcreato dell'uomo è il mondo dei miti, delle vicende che rimandano a messaggi completi. Se Dio, "scrivendo" la Bibbia ha dato vita a quegli eventi che narrava - la Parola si è fatta carne! - l'uomo può solo "creare" mondi che rimangono prigionieri della scrittura. Questo è, secondo il nostro autore, il contributo che l'uomo può offrire al Dio nell'opera di creazione.
Se Monda e Simonelli paragonano Tolkien al nostro Manzoni, mettendone in evidenza i numerosi elementi in comune, io credo che si possa accostare lo scrittore inglese a Dante: entrambi hanno inteso conferire il senso anagogico al loro lavoro: non simbolo, ma esperienza vera che rimanda ad altri significati o eventi. Non dunque una fiaba o un'opera simbolica è quella di Tolkien, né una parodia o ancora peggio una allegoria. Ma una creazione che rimanda ad altro, così come lo è la Divina Commedia nelle intenzioni di Dante: il fiorentino lo illustra chiaramente nella ben nota lettera a Cangrande della Scala.
Soffermiamoci ora sulla più nota delle opere di Tolkien, riportata all'attenzione generale dall'evento cinematografico. Se le vicende della trilogia potrebbero essere riassunte dagli ultimi due versi del Padre Nostro, il sugo di tutta la storia può essere espresso citando la conclusione della liturgia della parola della Messa in onore di S.Agnese - 21 gennaio - che recita: "O Dio onnipotente ed eterno (che) scegli le creature più miti e più deboli per confondere la potenza del mondo". In questa frase è racchiuso il messaggio di Tolkien: la fiducia illimitata nel Dio cattolico e nel Suo progetto sulla storia, l'esaltazione degli umili, la "follia" che, come esclama Gandalf durante il consiglio di Elrond, sarà "il manto agli occhi del nemico" così da confondere la potenza del mondo. Parole simili, queste ultime, a quelle contenute nel Magnificat: "ha esaltato l'umiltà della Sua serva… ha rovesciato i potenti dai troni… ha innalzato gli umili".
Umili e fragili: questa mi sembra essere la fondamentale e decisiva differenza tra il pregevole universo tolkieniano e il divertente, ma anche superficiale mondo di Harry Potter, dove i buoni sono splendidamente buoni e i cattivi perversamente cattivi. Spaccatura manichea pressoché assente nell'opera di Tolkien dove tutti, persino Gollum, possono riscattarsi e dove tutti, persino Frodo, persino Aragorn, persino Gandalf, sono costantemente tentati e non necessariamente capaci di superare la tentazione. Solo gli orchi, scimmie di uomini creati dal fango, e gli emissari di Sauron sono presentati come impermeabili alla salvezza: come peraltro i demoni e satana, secondo quanto scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica.
Tutto Il Signore degli Anelli è pervaso dal senso della fragilità umana che solo in Dio trova compimento e appoggio. In effetti, come fece già notare Emilia Lodigiani nel primo, ed imprescindibile saggio Invito alla lettura di J.R.R.Tolkien (Mursia), il tratto saliente di questo romanzo, come di tutto ciò che ha scritto Tolkien, è la rinuncia. La vittoria sul male è possibile solo rinunciando, con libertà, a qualche cosa di caro. Se è ben noto che è proprio la rinuncia all'anello a salvare la Terra di Mezzo, sono molti altri gli esempi di questa rinuncia presenti nel testo, che si apre proprio con la rinuncia di Bilbo al suo prezioso tesoro che Gandalf affiderà a Frodo. Lo stesso Frodo rinuncia alla vita tranquilla per farsi carico di condurre a termine una missione preclusa agli eroi "istituzionali" Aragorn e Gandalf. Gandalf prima e Galadriel poi rinunciano al possesso dell'anello ingenuamente offerto loro da Frodo, superando la prova - e Tolkien utilizza in entrambi i casi questo vocabolo - come Cristo nel deserto sconfigge il diavolo che gli offre il possesso di tutti i regni della Terra.
Proprio perché il tema della rinuncia è ben noto, non sembra opportuno soffermarsi su di esso. Vorrei portare invece l'attenzione su altri argomenti che trovano la loro radice nelle Scritture e nella fede cattolica. Mi sembra che questo territorio sia stato poco esplorato; non si è andati alla ricerca della subcreazione tolkieniana legata alla fonte principale della creazione: la Sacre Scritture.
Che invece sono evocate di continuo e costituiscono una colonna sonora costante, lieve e ineludibile del testo, a cominciare dalla famosa frase di San Paolo: "Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio" (Rm 8, 28). Così infatti accade nel libro. Situazioni che paiono tragiche, estremamente negative, si dimostrano invece preziose per produrre il bene: se Gandalf il grigio non "morisse" a Moria, non potrebbe rinascere come Gandalf il bianco (e qui riecheggia anche la parola di Gesù: "se il chicco di grano non muore…" - Gv, 12,24).
Senza l'attacco di follia che colpisce Boromir e lo spinge a strappare l'anello a Frodo e senza l'assalto degli orchi la compagnia non si scioglierebbe e l'anello non "andrebbe a est".
Se Pipino e Merry non fossero rapiti dagli orchi non risveglierebbero la foresta di Fangor e gli ent.
Se Gollum non fosse fuggito agli elfi e non avesse tradito gli hobbit, l'Anello non sarebbe stato gettato nella fornace ardente.
La figura del vero protagonista della vicenda, Frodo, è poi ritagliata sulla figura del Santo: un intreccio tra Abramo, pronto a lasciare tutto, la casa, la ricchezza, la posizione, per andare nell'abominio della desolazione; Mosé, il profeta che si sente inadeguato per il compito affidatogli; e lo stesso Gesù, del quale condivide la profonda umiltà e la forte volontà di portare a termine il compito affidatogli a costo della vita. Come scrive acutamente Greta Bertani, nella sua tesi di laurea discussa all'Università di Bologna nel 1995, un saggio che meriterebbe fortuna letteraria per la profondità, la freschezza e la novità delle argomentazioni: "Frodo ha risposto ad una chiamata sebbene avesse voluto evitarla e non sapesse nulla in fatto di armi e guerre". E una volta "chiamato" non si tira più indietro.
Stranamente nessuno, che mi risulti, ha preso in esame il fatto che Moria, il regno dei nani ormai controllato dagli orchi che la Compagnia dell'Anello attraversa nel primo libro, ha preso il nome dal monte sul quale Abramo viene inviato a sacrificare Isacco.
Moria infatti è il luogo sul quale verrà costruita, secoli dopo la vicenda di Abramo ed Isacco, la città di Ieru-Salem, il cui Re al tempo del patriarca è quel famoso Melkisedec, re appunto di Salem.
Uno dei colli di Moria è il Calvario, dove un altro sacrificio verrà officiato: quello di Nostro Signore.
Ebbene è proprio in Moria che Gandalf muore per poi risorgere: un caso? Credo proprio di no. Una indicazione piuttosto, e molto marcata, che rimanda al vero senso del sacrificio.
Anche la comunione dei santi è presente nel libro: è la pietà che Bilbo ha mostrato in passato verso Gollum, che nonostante appaia tutto corroso dal male, gli ispira compassione a permettere che la missione giunga a compimento. Gli sforzi che i personaggi compiono nella loro battaglia con le forze di Sauron sospingono Frodo aiutandolo a reggere il peso dell'Anello che aumenta man mano che si avvicina a Monte Fato. Palese è il messaggio di come il male corrompa con la sua vicinanza: l'anello, che ben rappresenta il peccato, corrode tutti coloro che ne vengono a contatto: non solo Gollum, che lo ha custodito a lungo, è ridotto ad una scimmia di ciò che era in origine, ma gli stessi Bilbo e Frodo subiscono gli attacchi dell'Unico e sopravvivono solo in funzione di uno sforzo di volontà libera. Frodo almeno fino a quando non sarà così piagato dall'anello da perdere, con la ragione, anche la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si trova a poter gettare nella voragine di Monte Fato il "suo tesoro". L'anello è capace di scatenare le tre concupiscenze di S.Paolo: concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia di vita. Lo si nota in particolare nella vicenda di Boromir: il suo desiderio morboso di impossessarsi dell'anello lo spinge ad aggredire Frodo pronunciando parole che si possono collegare direttamente alle tre concupiscenze sopra citate.
Lo sguardo capace di svelare i pensieri del cuore, che Galadriel, la dama di Lothlorien che può far pensare ad una icona della Madonna, rimanda allo sguardo di Gesù che, come la Parola, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e discerne i pensieri e gli intenti del cuore (Eb, 4,12).
La parabola dei talenti riecheggia in questo splendido dialogo tra Frodo e Gandalf:
"Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!", esclamò Frodo. "Anch'io", annuì Gandalf, "come d'altronde tutti coloro che vivono questi avvenimenti. Ma non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato". Dialogo che rimanda anche a questa affermazione di San José Maria tratta da Amici di Dio (212): "L'importante è fare buon uso del tempo, che ci sfugge dalle mani e che, per chi ha criterio cristiano, vale più dell'oro, perché rappresenta un anticipo della gloria che Dio ci concederà".
La Grazia è presente in ogni pagina del romanzo e si svela proprio al momento decisivo: nessuno può arrogarsi il merito di avere salvato la Terra di Mezzo anche se tutti hanno offerto il loro contributo: tutti i protagonisti dell'opera portano i loro pani e pesci, ma nessuno di loro può moltiplicarli. E' la Grazia, che si è servita di hobbit e uomini, come di elfi e nani, che si è alimentata della pietà di Bilbo e della misericordia di Frodo, dell'eroismo di Sam e della caparbietà di Aragorn, a giocare l'ultima carta.

Tolkien, la scrittura come mistero
Francesco Marzella
Giuseppe Pezzini ha studiato il processo creativo dello scrittore inglese: l’autore non inventa nomi e storie ma questi affiorano nella mente e devono essere portati alla luce
Un recente saggio di Giuseppe Pezzini, docente di Oxford che si dedica con pari interesse allo studio del latino e a quello delle opere di Tolkien, getta nuova luce sul processo creativo che regola l’origine dei capolavori del Professore. Si intitola Tolkien and the Mystery of Literary Creation (Cambridge University Press, pagine 430, euro 36,40): sei capitoli che affrontano altrettanti temi fondamentali per illustrare riflessioni e auto-esegesi di Tolkien, con un epilogo in forma di commento all’Ainulindalë, la storia della creazione del mondo che apre il capolavoro postumo, Il Silmarillion. Il mistero della creazione letteraria, quindi. Meglio ancora, si direbbe, la creazione letteraria come mistero, la scrittura come disvelamento e scoperta, così come emerge dalle opere, dai saggi e dalle lettere del creatore della Terra di Mezzo.
In principio erano i nomi. E con i nomi i personaggi e poi la loro storia. Come nel caso dei misteriosi “gatti della regina Berúthiel”, da cui prende le mosse il primo capitolo. Vengono citati da Aragorn e Tolkien inizialmente ammetterà di non saperne nulla o quasi, salvo poi provare in un secondo momento ad abbozzarne – o meglio, a conoscerne – la storia, almeno per sommi capi. Perché questo, per Tolkien, deve fare l’autore: cercare di scoprire quanto più possibile su nomi e profili che improvvisamente gli si presentano chiedendo di essere conosciuti. Il caso degli hobbit è piuttosto eclatante. “In un buco nel terreno viveva uno hobbit” è il celebre incipit del primo successo di Tolkien, appuntato mentre correggeva gli elaborati di un esame, senza sapere minimamente cosa fossero gli hobbit, poi destinati ad avere un ruolo tutt’altro che secondario nei suoi lavori. Nomi che affiorano nelle mente e affascinano per il loro suono, prima ancora che per il loro significato: per Tolkien, infatti, la sua opera è essenzialmente “un saggio di estetica linguistica” e anche per questo motivo l’invenzione delle lingue è centrale nelle sue creazioni letterarie e precede il racconto stesso.
Dunque, più che di invenzione si deve parlare di scoperta che segue un momento epifanico, fra “inconsapevolezza” e “sogno”, accompagnato da meraviglia e stupore, le stesse sensazioni che suscita la contemplazione del creato. C’è un legame stretto, infatti, fra creazione primaria (la realtà) e secondaria (il racconto), una relazione che si alimenta di bellezza e verità. Il sub-creatore (l’autore) continua l’opera del Creatore, governando la sottile tensione fra disvelamento e nascondimento. Il racconto, in qualche modo, è già lì, come le statue nascoste nel blocco di marmo, secondo la concezione michelangiolesca opportunamente richiamata da Pezzini.
Ecco quindi che l’impiego di una cornice metanarrativa – l’idea che Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli siano basati sul Libro Rosso dei Confini Occidentali, compilato da Bilbo, Frodo e Sam – è funzionale a garantire l’unità (nella diversità) dei due principali lavori pubblicati in vita, spiega le variazioni di stile e prospettive (riconducibili alle diverse “voci” narranti dell’originale) rendendo il racconto più credibile, ma soprattutto ridefinisce il ruolo del sub-creatore primario, che è chiamato a riscrivere, in maniera necessariamente “approssimativa”, quanto già scritto “da qualcun altro”.
Su tutto, poi, aleggia una presenza discreta. Siamo davanti al paradosso di un racconto intriso di religiosità in cui la divinità non si manifesta mai, pur essendo presente. Sembra quasi che l’Uno, Eru/Iluvatar, e con lui i Valar, entità angeliche, siano stati deliberatamente rimossi. Pezzini mostra come questa rimozione solo apparente sia da ricondurre tanto alla poetica del nascondimento quanto al desiderio della divinità di garantire uno spazio alla libertà e permettere che a indirizzare concretamente la storia sia piuttosto chi sembra “sconosciuto e debole”.
A questa presenza silenziosa si collega, nel mondo primario, anche la consapevolezza da parte dell’autore che l’opera, in definitiva, venga dall’unica Persona “mai assente e mai nominata”, che governa tanto il mondo primario quanto quello secondario. L’autore Tolkien è quindi chiamato a una “morte” – nell’accezione barthesiana – per poi risorgere e farsi strumento. Deve rinunciare al desiderio di controllo sull’opera e sul suo significato e mettersi piuttosto al servizio della storia, lasciando che lo conduca in universi narrativi inattesi e sconosciuti per (ri)scrivere un racconto “pieno di vita” e in qualche modo profetico.
Sono questi solo alcuni fra i suggestivi temi discussi da Pezzini, cui va riconosciuto il merito di aver messo bene in luce, con un saggio estremamente accurato e piacevole, la profondità dell’opera di Tolkien e la sua complessa genesi regolata da precisi criteri estetici. La speranza che accompagna la pubblicazione di questo importante contributo – di sicuro impatto nella Tolkien scholarship ma accessibile anche agli appassionati – è che i tempi siano davvero maturi, magari persino in Italia, per rivalutare definitivamente la qualità letteraria del corpus tolkieniano.
Grazia Deledda..."cuore bisogna avere, null'altro"

Con Grazia Deledda per riscoprire il ruolo delle donne in letteratura
Roberto Carnero
Una biografia dell’autrice e una nuova edizione di “Canne al vento” evidenziano tratti della sua produzione e della sua personalità inediti
Si parla con insistenza, da alcuni anni a questa parte, della necessità di valorizzare la presenza femminile nel canone letterario. La questione riveste notevole importanza sul piano critico, storico e didattico. In realtà non serve “inventare” nulla: basterebbe “vedere” le scrittrici là dove esse sono. Il problema è che molto spesso si tende a non vederle. Questo è anche il caso di Grazia Deledda (1871-1936). È stata l’unica donna italiana a ottenere (nel 1926) il Nobel per la letteratura, eppure lo spazio che le riservano i manuali scolastici è quasi sempre minimo. Ora due recenti pubblicazioni giungono a sottolineare il posto che questa autrice merita nella storia della letteratura del Novecento.
La prima è una bella, partecipata monografia a firma di Laura Vallieri, Grazia Deledda. Cuore indomabile (Ares, pagine 232, euro 16,00), che ne ripercorre la vita e le opere, soffermandosi in particolare su alcune di esse, ritenute particolarmente emblematiche (da Cenere a Elisa Portolu, da L’edera a La madre).
Negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, l’arcaica quiete domestica della vita nuorese di Grazia, quinta di sette figli, è dominata dalla figura del padre Antonio, verso il quale la figlia nutriva un grande trasporto. Dalle pagine del romanzo autobiografico Cosima, apprendiamo anche che la sua giovinezza fu segnata da una ininterrotta catena di sciagure e lutti familiari.
In virtù di questa non facile situazione personale e del clima di generale arretratezza della società isolana del tempo, si comprende facilmente l’anelito alla fuga coltivato sin da ragazza dalla futura scrittrice. Tale desiderio si realizzerà nel 1900 attraverso il matrimonio (con un impiegato di Roma, che Grazia raggiunge nella capitale), ma probabilmente tale scelta non fu vissuta in maniera psicologicamente pacificata: una causa possibile del senso di colpa che aleggia un po’ ovunque nei romanzi deleddiani può essere individuata proprio in questo “peccato di sradicamento”. L’abbandono dell’isola-terra-madre sembra essere stato vissuto dall’autrice come colpa originale, come tradimento degli affetti nativi. S’innesca così la necessità dell’espiazione di una supposta indegnità: penitenza da condurre, magari, attraverso la stessa letteratura.
Anche a Roma, infatti, Deledda conduce una vita austera, lontana dalla mondanità salottiera, chiusa nel ristretto cerchio di famiglia e lavoro. Scrive moltissimo e pubblica romanzi e racconti con una cadenza quasi annuale, in un’esistenza appartata, come se la sua vita di donna non meritasse più di avere uno spazio proprio. Consegnatasi a un uomo, a un marito, costituito il nucleo familiare, la donna che era stata sino a quel momento cede il posto alla sposa, alla madre, alla scrittrice, la quale si proietta con tutto il potere della fantasia nel passato, abbandonato con la partenza dalla Sardegna e con il matrimonio. «A Grazia», spiega Laura Vallieri, «non sfugge che scrivere sia per le donne un sacrificio doppio o forse triplo, rispetto a quello di un uomo. Dedicare il proprio tempo alla letteratura costringeva quasi sempre a escludersi dal mondo in cui le altre donne si muovevano, eppure affronterà senza rimpianti questo sacrificio».
Il capolavoro di Grazia Deledda viene unanimemente indicato nel romanzo Canne al vento, del quale Feltrinelli manda in libreria una nuova edizione a cura di Mauro Novelli (pagine 240, euro 10,00). Ester, Ruth e Noemi Pintor sono sorelle, discendenti di un nobile casato, ormai economicamente decaduto, in un paese di nome Galte. Le tre donne vivono quasi da recluse nell’antica casa in rovina, assistite dall’anziano servo Efix, che coltiva l’ultimo podere rimasto loro degli immensi possedimenti di un tempo. Con la sua devozione alle “padrone” Efix intende espiare la colpa di aver ucciso molti anni prima, seppure involontariamente, il padre delle donne, don Zame: il servo aveva infatti cercato di agevolare la fuga di una quarta sorella, la più giovane, Lia, dalla tirannia del padre, che teneva le figlie segregate in casa affinché non si mischiassero con la gente del paese.
Un giorno, d’improvviso, giunge dal continente Giacinto, il figlio di Lia, rimasto orfano e licenziato per un furto dal suo impiego alle dogane. Il ragazzo - che Efix inizialmente sperava potesse essere di sostegno alle zie - si rivela invece debole, scioperato e spendaccione, al punto da sperperare un’ingente somma di denaro prestatagli da un’usuraia. L’irruzione di Giacinto innesca tutta una serie di eventi che condurrà le tre sorelle sull’orlo della rovina.
Canne al vento è un concentrato dei temi della poetica deleddiana. C’è la Sardegna arcaica, anche se l’interesse per il folclore e il regionalismo sembra l’espressione, più che di un approccio verista, di un’attitudine romantica e decadente, che mira a una rappresentazione lirica di ambienti, paesaggi e personaggi, raffigurati come parte di un mondo primitivo e favoloso. C’è il motivo del destino associato a quello della colpa: nella visione religiosa della scrittrice, il destino finisce con il confondersi con la volontà di Dio. Qui èEfix è il personaggio che rappresenta più compiutamente tale visione del mondo, nella quale la concezione pagana (del destino) e quella cristiana (della Provvidenza) si intrecciano e si confondono su un piano di sostanziale sincretismo: «Non voleva, a sua volta, forzare la sorte, e pensava ch’era peccato cercare di opporsi ai voleri della Provvidenza. Bisogna abbandonarsi a lei, come il seme al vento. Dio sa quel che fa». C’è la visione dell’amore come colpa: il peccato dell’eros fatalmente abbatte sugli uomini una pesante sequenza di castighi. L’amore è una forza prorompente e prepotente, il portato di una fatalità a cui non ci si può opporre, ma la pulsione erotica è sempre pericolosa, perché sovverte l’ordine morale e sociale.
È perciò senz’altro da sottoscrivere il giudizio vergato da Mauro Novelli nella sua intelligente postazione: «Canne al vento è un libro sardo, ostinatamente sardo, integralmente sardo, sebbene di respiro universale».

La Madonna del topo
Grazia Deledda
Il racconto è tratto dal volume di Grazia Deledda, La Madonna del topo e altri racconti.
Non che fosse strampalato il pittore che dipinse questa Madonnina, ma, forse, lo ispirò un bizzarro grottesco spirito francescano, che lo spingeva ad amare tutte le bestie create.
Il modello della Vergine era una sua bionda servetta, procuratagli da pochi giorni dal padrone di casa: una bimba quasi, con le lunghe trecce attorcigliate intorno alla testa, con la fronte d’avorio, grande, prominente, e i nerissimi occhi lunghi, pieni di languore e di sofferenza. Il resto del visetto scivolava giù con la bocca quasi invisibile e il mento giallino, non più grosso di una ciliegia acerba. Era triste, silenziosa, timida; e forse la sua morbosa paura dei topi aveva dato al pittore la prima idea del quadretto.
Anche il bambino non sembrava dei soliti: grasso, bianco, traboccante dalle braccia della servetta, si piegava però con naturalezza, tentando di scendere sul pavimento polveroso: e pareva guardasse davvero, coi tondi occhi azzurrognoli, tendendogli le manine pienotte, il topolino grigio. Questo era di maniera: poiché il pittore non poteva, per molte plausibili ragioni, pigliarne uno vivo a modello; ma era ben fatto, magrolino, con la coda molto lunga, i baffi, il muso di lupo in miniatura; e stava ai piedi della Madonnina, con le zampine anteriori supplici, gli occhi lucenti di adorazione o forse di voglia di rosicchiarle il lembo della veste stellata.
Eppure il quadretto trovò subito un compratore; il più imprevisto, se non il più competente e generoso: lo stesso padrone di casa del pittore.
Era un proprietario di case e di terre, delle quali egli stesso teneva l’amministrazione. Bell’uomo, alto, forte, aveva tuttavia, con quei suoi lunghi baffi biondi spioventi, un’aria quasi sentimentale, o meglio preoccupata, come se gli andassero male gli affari. E infatti la spiegazione che diede al pittore, per l’acquisto del quadretto, si riferiva ad un flagello dei suoi campi.
«Ho, in un podere di mia moglie, seminato molto frumento, per concorrere al premio: è già bello, alto, granito, ma quest’anno, come anche gli altri anni, meno però di questo, i topi campagnoli vi fanno strage. Si mangiano le spighe più mature, e rodono anche i gambi: un disastro. E non si trovano rimedi. E mia moglie piange sempre; già, ma lei piange anche quando l’annata è buona. Allora ho pensato che forse, mettendo questo quadretto nell’atrio della casa colonica, la Madonna potrà proteggere il campo, facendo morire i topi».
Il pittore si guardò bene dal ridere: solo osservò a sé stesso, che la sua intenzione nel dipingere il quadro non collimava precisamente con quella del padrone di casa: il quale, a sua volta, l’assicurò che, al riparo dell’atrio, molto in alto sul muro sopra la porta, con un bel vetro solido, l’opera d’arte non avrebbe mai sofferto danno.
«La prego di non dir niente a mia moglie, per adesso, tanto lei non viene mai al podere. Se sa che faccio questa spesa, sebbene ella sia molto religiosa, le scoppia l’itterizia».
«E allora si fa così», aggiunse, «si va oggi stesso al podere, col mio biroccino: là si appende il quadro e si fa uno spuntino: alle sette siamo a casa».
«Va be’», disse l’artista, sedotto dall’idea della passeggiata e dello spuntino, ed anche dai modi mansueti e quasi ingenui del suo rustico mecenate. Decisero dunque di partire subito. La giornata di mezzo giugno sembrava fatta apposta per una gita di quel genere: spirava un vento fresco, di ponente, e i fiori dei quali i campi erano coperti gli si abbandonavano con gioia viva. Il podere, tutto circondato di un’alta siepe di prunalbi ancora fioriti, con una cavedagna centrale che pareva un viale ornato per una processione, e lungo il quale le viti, glauche di solfato di rame, si slanciavano da un gelso all’altro in un inseguimento infantile, dava l’idea di un paradiso terrestre a coltivazione intensiva. Dalle arcate di quel portico fantastico s’intravedevano i prati rosei di trifoglio, e le distese del grano ondulanti e balenanti come le acque di un lago. E di uno sfondo equoreo si aveva l’impressione anche a guardare in alto la rustica terrazza della casa colonica, dove sull’azzurro denso del cielo bianchissime lenzuola tese ad asciugare si gonfiavano come vele.
Il viale non finiva mai: il pittore, appoggiato allo scudo del quadretto, si sentiva ubbriaco di tutta quella generosità d’aria, di trasparenze, di colori teneri e decisi che si accordavano con un’armonia quasi musicale: e il pensiero dello spuntino che la massaia avrebbe preparato con impegno lo rendeva più felice. Ricordava con insolita tenerezza la moglie e il grasso bambino, lasciati a casa; ed anche la servetta che gli portava una certa fortuna. Dopo tutto era un buon uomo anche lui, grassone, pancione, che, se aveva dipinto l’arcobaleno fra le nubi, e il riflesso di una stella sul mare, non sdegnava le quaglie coi funghi.
Il padrone, invece, s’immalinconiva sempre più: con gli occhi, dove stagnava un pensiero fisso, guardava solo la groppa del cavallo, aizzando di tanto in tanto la bestia con un grido gutturale, selvaggio, quale il pittore aveva sentito, durante un suo soggiorno in Africa, dagli indigeni del luogo.
Ma il cavallo non meritava di essere aizzato neppure benignamente: volava, e pareva avesse solo due zampe: si fermò di botto in mezzo all’aia, che ricordava anch’essa un tratto di spiaggia marina, affollata di tutto un popolo sbarcato da qualche arca di Noè.
Con beatitudine del pittore, un porcellino nero, con gli occhi e la codina lucidi come gioielli di smalto, corse incontro al cavallo, drizzandosi quasi volesse baciarlo: anche i cani facevano festa, le oche salutavano solenni come grandi dame, e gli anatroccoli in numerose squadre si misero al seguito del padrone che, a dire il vero, gettava loro certe molliche che aveva in tasca. Con questo corteo giunsero all’atrio, e il pittore vide subito che forse si doveva consumare un sacrilegio, togliendo la Madonnina azzurra e rossa che vi era già dipinta sul muro a destra della porta, e ai cui piedi ardeva, entro un bicchiere pieno a metà di olio, una fiammella galleggiante.
Il padrone lo rassicurò: come del resto aveva già avvertito, la nuova ospite sacra doveva trovar ricovero sopra la porta: andò quindi a cercare una scala e dare ordini alla massaia, che già stava affaccendata in cucina a manipolare la pasta.
Questa vecchia contadina doveva essere sorda e di vista corta, perché l’uomo le parlava ad alta voce, ed ella non rispondeva, abbassando la testa a guardar bene la sua sfoglia: ma era forte, robusta, coi piedi e le mani che sembravano badili. Non s’impicciò nella faccenda del quadro, che lo stesso padrone volle attaccare il più alto possibile, quasi rasente alla volta, in modo che la Madonnina numero due pareva volesse nascondersi e sfuggire allo sdegno della prima protettrice del luogo. Il bambino però si piegava prepotente e curioso; e non più verso il topolino che, adesso, in quella mezza luce, sembrava vero, arrampicatosi di nascosto sul muro; ma a tentare di attaccar briga con lo scialbo bambino di sotto che tendeva anche lui gli stecchini delle sue braccia a scaldarsi alla fiammella del bicchiere.
Il pittore guardava e lasciava fare: del resto il quadretto non stava male, lassù; inoltre si sentiva venire dalla cucina un odore d’intingolo che profumava anche le considerazioni più melanconiche a proposito della dignitosa povertà degli artisti d’oggi, costretti, in certe città, come si legge sui giornali, a vendere i loro quadri in cambio di commestibili e combustibili.
Però, un certo senso di mistero si avvertiva intorno: e troppo intelligente era l’uomo per non accorgersi che il padrone aveva un fare strano. Infatti, quando l’operazione fu compiuta, egli riportò rapidamente la scala a posto, con un’aria ladresca; poi guardò di qua, di là, da ogni angolo dell’atrio, l’effetto del quadro; infine si scosse e parve non pensarci più. Allora condusse il pittore a vedere la vigna, il grano, il frutteto. Tutto era bello, ben tenuto; e gli uomini che vi lavoravano, illuminati dal sole al declino, avevano anch’essi luci e colori che entusiasmavano l’artista. Ma quello che più lo colpì, nella stalla levigata come un salone da ballo, fu un ciclopico toro rosso, feroce e bramoso, che pareva avesse il fuoco nelle viscere e, oltre le belle figure mitologiche, ricordava qualche bisonte antidiluviano. Le miti vacche mulatte pareva ascoltassero i suoi muggiti come note d’amore.
«Con tutto questo ben di Dio, sua moglie si lamenta?», disse il pittore: e il padrone rispose con un sospiro.
Quando rientrarono, lo spuntino era pronto, sulla grande tavola della cucina. Solo mancava il vino, e il padrone andò lui in persona a sceglierlo in cantina.
Allora il pittore, preso da un estro, si avvicinò alla massaia, le sorrise, parve volesse baciarla. Le domandava all’orecchio:
«Avete veduto la nuova Madonnina?».
L’aveva ben veduta, la vecchia sorniona, con gli occhiali legati con lo spago: e tutto aveva veduto e sentito. E una subita complicità di malizia unì i due curiosi.
Disse la vecchia:
«L’è ben la figura della Giglina, l’amica del padrone, morta quest’inverno».
«Ma se è la mia servetta Maria!».
«È ben la figliuola della povera Giglina, la Maria, che è tutta la madre».
Card Martini...profeta della Chiesa che verrà

In ricordo del card. Martini: parola di confratello
morte 31 agosto 2012
Card Martini
Un comunicatore innato
Carlo Maria Martini è andato negli anni sviluppando le sue doti innate di comunicatore, nutrendo una viva sensibilità per gli avvenimenti, preoccupato di tastare il polso dell’opinione pubblica, curando di trasmettere le verità più profonde in un linguaggio accessibile secondo regole espositive piane ed efficaci: in altre parole, come egli stesso ha confessato, da ragazzo sognava di diventare giornalista. Sotto questo profilo, nell’atto di comunicare egli ha sempre privilegiato il «cuore» del messaggio e l’attenzione al destinatario piuttosto che la qualità della prosa; pur a fronte dello straordinario successo che i suoi libri hanno conosciuto in tutto il mondo, il suo stile era orale, al punto di non rivedere i manoscritti in vista della pubblicazione. Martini non si è curato di raffinare la sua scrittura, proprio in quanto ciò che contava per lui era aprirsi e aprire al senso dell’unica Scrittura.
Uomo di Chiesa e di confine
Se ha potuto sorprendere la diocesi ambrosiana per l’insistenza con cui ha richiamato il primato della dimensione contemplativa, pure ha ricercato con intensità, curiosità e audacia – da taluni ritenuta quasi spericolata – di entrare in dialogo con gli uomini di oggi per incalzarli a riflettere sul senso dell’esistenza e sollecitarli all’incontro con il Padre di tutti, riscuotendo interesse e attenzione nel mondo laico, come nessun’altra personalità del mondo cattolico. Di lui si è detto che è stato ed è «uno straordinario uomo di Chiesa e di confine» – di confine per tutti.
Il criterio che ha regolato la sua spiritualità è il soli Deo gloria. Forgiato dalla familiarità con la Bibbia, filtrata dalla lezione ignaziana dell’assoluta sovranità di Dio, Martini ha inteso procedere nel «cammino che ciascuno di noi deve compiere e che bisogna far compiere a una comunità. Cammino da riprendere continuamente, senza domandarci a che punto siamo». Chiamato ad attendere a un ministero di carattere pastorale verso cui credeva di non essere predisposto, accettò per obbedienza, senza tuttavia soffrire della responsabilità di dover prendere decisioni, assunte con realismo, dopo attenta valutazione, ma senza lacerazione interiore.
Cé, Ballestrero, Kasper
Per evitare il rischio di ripetere cose già risapute, o di cadere in sperticati elogi, un piccolo omaggio alla figura del cardinale corre sul filo della testimonianza di tre suoi fratelli nell’episcopato. Non si tratta di discorsi ufficiali, ma di battute inedite, che ho potuto raccogliere in forma colloquiale.
Forse con un po’ di audacia si potrebbe allargare lo spettro di tali apprezzamenti: quanto inizialmente era riferito all’arcivescovo, può essere attribuito alla Chiesa ambrosiana e alla Chiesa tutta.
«La nomina di padre Martini ad arcivescovo di Milano sarà una primavera per la vostra Chiesa».
Il giudizio autografo, risalente agli inizi del 1980, è di mons. Marco Cé, che a breve sarebbe divenuto patriarca di Venezia. Dalle sue parole traspariva l’affetto del compagno di studi all’Istituto biblico, eppure il compiacimento era rivolto alla Chiesa di Milano, ai benefici che avrebbe tratto dal nuovo pastore. Ebbene, a distanza di più di cinquant’anni, è possibile vedere qualche bocciolo della fioritura primaverile? Anzitutto, in questi anni si è fatta strada l’idea di «progettare la pastorale». Lungi dall’essere una serie di attività pratico-organizzative, la pastorale è il «farsi» della Chiesa, la decisione responsabile e creativa di obbedire alla missione del Vangelo, fissando priorità, obiettivi e forme concrete del suo esercizio. In secondo luogo, siamo stati sollecitati dal card. Martini a «rifuggire la logica del successo ad ogni costo». La comunità cristiana sa che la forza dell’annuncio non proviene dalla sua abilità o dai suoi successi, piuttosto sa di dover confidare unicamente nell’azione dello Spirito, i cui tratti sono la mitezza, la pazienza, la persuasione, l’amore che non prevarica sulla libertà altrui.
«Il cardinal Martini è alto, forse troppo alto…rischia di fare ombra a qualcuno».
Con un’esplosiva miscela di sincero affetto e di birichina arguzia, il cardinale Anastasio Ballestrero metteva l’accento sull’obiettiva qualità fisica e spirituale del Nostro. Fuori di metafora, la nostra Chiesa è sollecitata a innalzare lo sguardo, per non lasciarsi imprigionare dalle preoccupazioni troppo anguste dell’ordinaria amministrazione. L’invito ad affrontare la complessità dei problemi, a raccogliere la provocazione delle giovani Chiese, a lasciarsi interpellare dai non-credenti, a confidare nei racconti dello Spirito, a recuperare uno stile di comunicazione fraterna e sinodale, fanno parte di uno stile che via via comincia a essere interiorizzato nel nostro agire ecclesiale.
«Il tuo cardinale pone all’interlocutore continue domande, attende con curiosità la risposta, per poi proseguire con nuovi interrogativi alla ricerca di risposte sempre nuove…»
Così l’allora mons. Walter Kasper, quando guidava la diocesi di Stoccarda, tratteggiava in chiave psicologica l’atteggiamento di Martini. Quello che è possibile augurare alla nostra Chiesa è di coltivare una «sana inquietudine del cuore», nella ricerca appassionata delle vie del Signore. «Fuori da ogni piagnucolosità e nostalgia del passato – scriveva – è necessario farsi carico delle urgenze dell’oggi e prepararsi alle sfide del domani, facendo affidamento sull’assistenza dello Spirito di Gesù che non ci lascia soli e ci sollecita a un discernimento culturale e spirituale».
Marco Vergottini

Martini, la salutare inquietudine della Chiesa
Francesco Cosentino
Un’affettuosa lettera indirizzata al Cardinal Martini, che fu arcivescovo di Milano e del quale, a dieci anni dalla morte, si sente ancora nostalgia, apre il nuovo libro di don Armando Matteo La Chiesa che verrà. Riflessioni sull’ultima intervista di Carlo Maria Martini, edito da San Paolo.
Pungolo profetico
Il teologo calabrese, docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana, oggi chiamato da papa Francesco nel ruolo di Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, offre al pubblico una riflessione serrata sull’attuale crisi della fede nell’Occidente, prendendo spunto dalla statura e, ancor più, dallo stile del cardinal Martini, che viene descritto così: «Lo stile dell’intercessione: lo stile di chi procede sforzandosi di far dialogare mondi diversi» (p. 10).
Martini ci è riuscito egregiamente e rappresenta un pungolo profetico anche per noi. Partendo da qui, l’autore rilegge in modo straordinariamente efficace e attuale quella nota ultima intervista che il Cardinale rilasciò poco prima di essere consumato dalla malattia, nella quale denunciò il ritardo della Chiesa, il suo immobilismo, la sua incapacità di scuotersi; ma l’intuizione di fondo del testo – senza dubbio originale – è quella di indicare proprio nella figura e nel Magistero di papa Francesco la via per superare la paura paralizzante che ci contraddistingue e per edificare la Chiesa del futuro. Infatti, «nessuno più di lui ha invitato i credenti, in questi anni, allo sforzo di una nuova immaginazione del possibile ecclesiale… Francesco è la via per la Chiesa che verrà» (p. 19).
La tesi viene sviscerata anzitutto attraverso un’analisi che fa «vedere» plasticamente il ritardo accumulato dalla Chiesa e denunciato da Martini. In particolare, Matteo denuncia una visione ecclesiale e pastorale che non ha ancora preso sul serio il cambiamento in atto in Occidente, limitandosi a pensare che si tratta solo di qualcosa di nuovo e di diverso che si aggiunge al passato e che, quindi, richiederebbe al massimo qualche aggiustamento pastorale e niente di più.
Invece, siamo in presenza di un «mondo altro», i cui cambiamenti attestano la crisi attuale dell’agire ecclesiale, specialmente riguardo al contenuto dell’annuncio, alla relazione con l’universo giovanile, alla questione femminile. In questo contesto di crisi, tuttavia, la fede cristiana può essere ancora una parola fondamentale nelle terre del benessere, laddove le persone non sono più minacciate dalla povertà, dalla privazione e dalla durezza del vivere quanto da una pienezza e potenza che è diventata «egolatria»: un eccesso che stordisce e rende frenetici. La fede ci ricorda invece la nostra destinazione, il «per chi vivere», la mitezza di Gesù che è capace di orientarci al futuro migliore per tutti.
Inquieta domanda
Occorre pertanto passare «da una pastorale del cambiamento a un cambiamento della pastorale: è l’insieme che non funziona più e che richiede una totale riscrittura» (p. 100), oltre le resistenze tradizionaliste e identitarie, oltre lo spirito del risentimento. L’autore afferma che per il cristianesimo «è scattata l’ora della rinascita» (p. 131) e ne tratteggia il volto: una Chiesa in cui si possa realmente incontrare Gesù e la sua bellezza, che rimette al centro la Parola di Dio; che diventa luogo dove «si insegna il gesto della preghiera» (p. 145).
Una Chiesa che, nella liturgia come in altri momenti della sua vita, propone un’esperienza di festa e di incontro, rompendo il binomio fede-depressività e che, prima della disciplina appaia come luogo della prossimità e della comunione, uno «spazio autentico e concreto di comunione, di riconoscimento, di partecipazione» (p. 155).
Il testo si chiude in modo suggestivo con un capitolo in cui l’autore fa quasi «incontrare» il cardinal Martini e papa Francesco. La proposta finale si declina in dieci domande formulate a partire dal magistero di Francesco, affrontando le quali ci si potrebbe far carico del ritardo denunciato da Martini; esse riguardano il modo di immaginare la fede, la felicità nell’essere credenti, l’interesse per il destino del mondo, la misericordia, l’amore, la santità della vita quotidiana, il «quanto» sentiamo davvero la mancanza dei giovani, i sogni per la Chiesa e per il mondo e, infine, una domanda che resta al cuore di ogni domanda e di ogni cammino di fede: che fine ha fatto la tua inquietudine?
Nessuno più di Martini ci ha dato testimonianza di quella che papa Francesco chiama l’inquietudine interiore, scrive Matteo. Leggendo questo libro, si può ben dire che anch’esso pone al nostro cammino di credenti quella «inquieta domanda» che ci tiene desti e che, custodita nel cuore, apre spiragli nuovi per la Chiesa che verrà.
Armando Matteo, La Chiesa che verrà. Riflessioni sull’ultima intervista di Carlo Maria Martini, San Paolo, Milano 2022, pp. 207, € 18,00. Pubblicato su L’Osservatore Romano, 1° luglio 2022.
Antonietta Potente...una vita religiosa per tutti

Antonietta Potente. Credenti, più gentili con le cose e con la terra
Laura Badaracchi
Si rivolge anzitutto a chi non conosce da vicino la vita consacrata, e a chi la guarda con diffidenza, l’ultimo saggio scritto dalla teologa Antonietta Potente, delle Suore domenicane di San Tommaso d’Aquino, edito dalle Paoline col titolo È vita ed è religiosa. Una vita religiosa per tutti. Dopo il dottorato in teologia morale e l’insegnamento a Roma e Firenze, ha vissuto per oltre un decennio in Bolivia con una famiglia di etnia Aymara, guadagnandosi il pane come docente all’Università di Santa Cruz e Cochabamba. Nelle pagine del suo nuovo libro si respira profumo conciliare. Chi professa i voti - dice fra le righe la religiosa di origine ligure, trapiantata a Torino - non è un superuomo o una superdonna, ma un battezzato e una battezzata che desidera vivere radicalmente il Vangelo:«"Non siamo noi la liberazione e la salvezza, né degli eroi, ma dei compagni di viaggio». Che hanno ispirato i Padri e le Madri del deserto nei primi secoli del cristianesimo e oggi possono suggerire a tutti uno stile di vita alternativo, diventando una bussola in tempi di crisi etica, oltre che economica. Un discorso decisamente controcorrente.In un mondo dominato da superficialità e approssimazione, lei invita a essere particolarmente attenti al soffio della vita e dello Spirito.«Credo che il soffio debba rimanere una costante nella vita cristiana. Nel senso della precarietà, nella coscienza che - in fin dei conti - la vita in generale è qualcosa di molto bello e altrettanto sfuggevole, con dei limiti. Una costante che vale per congregazioni, gruppi, movimenti in cui si sente e si palpa questa fragilità dell’esistenza. Questa premessa del Vangelo sembra comunque accompagnarci sempre, sollecitando attenzione e sensibilità a quello che la storia e la realtà ci mostra come possibili cammini».In che modo oggi la vita religiosa è chiamata a rinnovarsi per essere autentica? E come evitare le spinte verso un anacronistico ritorno al passato?«Non ho delle risposte. Sono convinta che dobbiamo ritornare all’essenzialità più profonda: non è questione di esteriorità (rimettersi il saio, ripristinare la tonsura, ad esempio), ma di trovare un senso più evangelico che ci accomuna tutti, oggi come oggi. Tornare alle origini non dell’esteriorità, quindi, ma dell’essenzialità. La vita è fatta per ricercare il mistero, non per esserne sicuri, indipendentemente dalle varie scelte; per essere consapevoli e provare la passione di questa ricerca che è invisibile, soffio, Spirito. Si sceglie di consacrarsi a Dio per avvicinarsi non alle strutture, ma a una vita abbandonata alla gioia e alla precarietà». Significa attualizzare i carismi delle diverse congregazioni?«Bisogna guardare i disegni della storia: i carismi sono nati in un clima di consapevolezza evangelica, rappresentano una modalità con cui questa salvezza e gioia possono entrare nella vita di tutti, perché tutti ne possano beneficiare. Se le persone riescono a rendersi conto di questo, diventeranno fruttuose. Oggi le congregazioni più aperte hanno poche vocazioni, perché danno meno sicurezze ed esteriorità, hanno poche opere e lavori, scarsi posti di responsabilità».Quale la contaminazione positiva tra la vita religiosa e quella dei laici?«Siamo tutti chiamati, uomini e donne di ogni cultura, alla pienezza della vita. Credo che tutte le divisioni siano negative, a cominciare da quelle gerarchiche. Sappiamo che nella storia si sono create delle strutture che ci hanno separati, per quanto riguarda la partecipazione alla conoscenza del mistero. Pur mantenendo la diversità, lo specifico che è l’identità delle persone, bisogna riconoscere che la vita religiosa non è un ruolo, ma entra a far parte di donne e uomini consapevoli della loro sensibilità e passione. Invece, facendone quasi un mestiere - in passato anche con alcuni privilegi - abbiamo sbagliato. Le vocazioni vere non sono poche oggi: sono sempre state poche e nella Bibbia corrispondono a quelle profetiche. Nella comunità credente nella Chiesa alcuni uomini e donne percorrono questo cammino alla ricerca di una spiritualità specifica». Afferma che la vita religiosa femminile ha dettagli che quella maschile non ha: cosa intende?«Non siamo soldatini, non si tratta di arruolarsi ma di cercare la propria posizione nella storia, legare la vocazione alla propria identità. Ci sono delle mediazioni, io l’ho trovata nella spiritualità domenicana con la sua grande larghezza, nata nella consapevolezza che il Vangelo è di tutti. La categoria delle donne ha sempre appartenuto alle minoranze, con la consapevolezza di essere popolo, mentre gli uomini (da quando la vita religiosa è diventata anche sacerdotale) sono consapevoli di appartenere a una categoria. Essere popolo ha dato la possibilità di crescere vicine all’umano sia nelle relazioni comunitarie, sia nell’impegno missionario, affrontando le situazioni non solo in forma intellettuale. Invece la vita religiosa maschile ha avuto la grande fortuna di essere più dedicata allo studio della teologia». Come s’intrecciano povertà, castità e obbedienza al rapporto cruciale con il creato?«Vogliamo partecipare alla costruzione della storia (obbedienza), vivere relazioni non violente (castità), in una giustizia dignitosa senza assurde penitenze, alla ricerca del bene comune (povertà). Insieme impariamo che la terra non è nostra ma di tutti. Abbiamo abusato del creato perché diventasse denaro e merce. Se la vita religiosa fosse essenziale nei rapporti e sobria nelle scelte, dalla parte di coloro che ancora vogliono prendersi cura di un pezzo di terra, sarebbe possibile per i consacrati proporre uno stile esistenziale alternativo: la missione è questa, non andare a salvare gli altri ma testimoniare concretamente l’intensità del rapporto con Dio. Non bisogna essere tutti francescani per capire che in questo momento storico dobbiamo cambiare la relazione con le cose e la natura, renderla più gentile, meno prepotente e invadente. Questa è l’umiltà di stare nella storia: imparare a muoverci in questo deserto abitato con normalità, gioia e disponibilità. Perché la vita si salva se siamo davvero solidali».

Il nocciolo e la scorza…
Giordano Cavallari
Antonietta Potente è teologa, docente e scrittrice.
nascita 31 agosto
Antonietta, in quale contesto hai scritto questo ultimo tuo libro?
Nella serie di piccoli libri che sto scrivendo per le Paoline mi sto proponendo di leggere la realtà dal di dentro. Quest’ultimo libretto è stato scritto verso la fine del periodo di isolamento: ciò mi ha dato idee sulla fatica che la realtà sempre comporta insieme alla speranza in cui la fatica si risolve per la vita. Mi ha fatto pensare, in particolare, la fatica di respirare determinata dalla malattia: il dramma di non poter respirare coi polmoni è figura di una difficoltà che stavamo già vivendo nell’anima. Siamo in una società che non respira bene. Ho intuito quanto sia vitale il respiro di cui andiamo alla ricerca: un respiro profondo.
Questa mia ricerca vorrebbe portare a un senso nascosto che, per una persona credente, è la sua vita di fede, se non si tratta di una fede istituzionale o di carattere culturale, bensì di un’esperienza. In tal modo auspico che queste mie riflessioni possano spingere a loro volta i lettori a una ricerca più intensa, ciò che purtroppo avviene normalmente sempre meno, perché si ha paura e facilmente si aspetta che altri dicano chi siamo e che cosa dobbiamo fare. Mentre penso che la cosa più bella sia continuare a cercare e a darci nuove possibilità.
Come interpretare il titolo?
È un’idea che mi è venuta leggendo testi sufi. Esprime in breve un modo di vedere la vita. Il nocciolo possiamo dire che sia l’anima della realtà, cioè quel respiro o soffio invisibile dal quale siamo caratterizzati ma anche stupiti. Dico, dunque, che il nocciolo nascosto è simile al respiro della vita umana e di tutto l’ecosistema. Riconoscere questo nocciolo è molto importante perché significa entrare in relazione con la realtà in modo profondo. Solo nell’intensità e nella profondità noi umani possiamo scoprire la nostra vera identità e, insieme, scoprire le persone che abbiamo dinnanzi.
La quotidianità e la fede
La scorza è pure importante perché è l’unico accesso al nocciolo, ovvero l’unico modo per arrivare dalla realtà al respiro, al senso profondo della stessa realtà. Dobbiamo necessariamente passare attraverso la scorza. La quotidianità è infatti l’unica superficie porosa attraverso la quale possiamo giungere all’incontro più profondo con la vita.
Non si può dare dualismo: non possiamo togliere e buttare via la scorza per tenere solo il nocciolo. Non è possibile e neppure auspicabile. Va mantenuta l’unicità e la completezza. Vero è che, in una società come la nostra, ci fermiamo spesso sulla scorza. Nei miei scritti vorrei dire che c’è molto di più.
Hai scritto che il passaggio dalla scorza al nocciolo non è per tutti: in che senso?
Questo lo dicono alcuni grandi maestri di sapienza, ma non è assolutamente da intendere nel verso dell’esclusione: l’accesso non è escluso a molti e riservato solo ad alcuni eletti. L’accesso di cui tratto è semplicemente la porta stretta del vangelo: bisogna essere fatti in un certo modo per riuscire a passare. Magari per la porta stretta ci passiamo tutti – io naturalmente lo spero –, ma è chiaro che passano tutti quelli che vogliono passare e che vogliono passare insieme ad altri.
Ci vuole allenamento per passare e per allenarsi servono delle pratiche di vita. Ovvero, ci vuole oggi un atteggiamento contemplativo che certamente la nostra società non favorisce. Dovremmo aiutarci allora gli uni gli altri perché questo atteggiamento sia di tutti. La Chiesa stessa non aiuta molto. Nella sua lunga storia di secoli di catechesi, non ha aiutato molto i fedeli a diventare persone contemplative: li ha riempiti di cose da sapere e da fare. È semmai questa l’esclusione.
Il libro procede più per accostamenti che per sviluppo: è il tuo metodo di scrittura?
È la mia metodologia di ragionamento – poco ragionato – che porta quindi alla mia scrittura. Viene dalla considerazione che noi umani ci avviciniamo alla realtà per intuizioni, soprattutto perché altri ci svelano di continuo qualcosa di nuovo. Citare altri autori, anche al di fuori dello specifico teologico, non può servire, per me, a confermare il proprio pensiero, bensì a scoprire altra sapienza. Chiunque fa esperienze ed è eloquente può diventare maestro o maestra.
Le faglie della ragione
Secondo me, questa è la via: nella nostra testa, nella nostra fredda ratio, noi ragioniamo molto geometricamente, ma la vita reale assomiglia molto più alla geometria frattale che non a quella euclidea.
Se osserviamo attentamente, ad esempio, le foglie di una stessa pianta, scopriamo che non c’è una foglia che sia uguale all’altra. Perciò, prima di organizzare il pensiero e di cominciare a scrivere, io penso che si debba passare molto tempo ad osservare questa realtà così complessa, tanto da insegnare sempre qualcosa di diverso con le sue cangianti tonalità.
Questa, peraltro, non è soltanto una via metodologica del pensiero e della scrittura: naturalmente è il modo per stare in una vita che è ricchissima di differenze e a cui dovremmo prestare molta più rispettosa attenzione. Il mio lavoro non è dunque quello di dividere o di separare per chiarezza logica, bensì quello di congiungere e di ricucire anche parti della realtà che appaiono opposte – quali concetti e cosmo-visioni teologiche o atteggiamenti religiosi molto diversi tra loro – scoprendo che c’è un filo che comunque congiunge il tutto. Anche le cose sbagliate e negative ci dicono qualcosa al riguardo: anche l’errore e l’avversario diventano in qualche modo rispettivamente motivo e maestro di sapienza.
fede
Un’altra caratteristica mi sembra quella dello sguardo d’insieme. È così?
La verità affiora in miriadi di contesti diversi. Diversi, infatti, sono i contesti dei popoli in cui sono coltivati pensieri teologici e teosofici. C’è poi il contributo che alla teologia possono dare innumerevoli altre discipline.
Certamente i teologi non possono diventare tutti fisici, chimici, biologi o matematici, ma penso che debbano necessariamente dialogare con altri che leggono la realtà con criteri diversi, oggi di fondamentale importanza. Dobbiamo lasciare che siano altri ad insegnare qualcosa.
Viviamo in un mondo che scambia sempre più merci e denari, ma che ancora non sa scambiare adeguatamente la sapienza. La mia vita e il mio lavoro hanno conosciuto via via una trasformazione nell’ascolto e nell’interlocuzione con altri. Mi sembra che tutta la teologia dovrebbe farlo e con urgenza.
Quale teologia?
Stai indicando una strada per la teologia?
Io ho sempre sognato un diverso modo di fare teologia, senza peraltro inventare nulla: se guardo alle università del Medioevo, vediamo certamente che la teologia è stata posta su trono, ma in mezzo ad una vivace e ampia discussione tra i banchi. Se si vanno a leggere le vite e le opere dei grandi maestri medievali, si scopre come questi sapessero di biologia, di alchimia, di anatomia e di medicina. Pensiamo ai monasteri.
Mi sembra che la teologia si sia, via via, svilita, sino al punto di giungere alla teologia dei seminari, in cui gli “altri” non entrano; è una teologia pensata per il solo ruolo presbiterale. A tal punto, è divenuta una disciplina per pochi specialisti e che non serve ai più, mentre una sapienza che sia tale dovrebbe servire e aiutare tutti.
Non sto dicendo che la teologia debba perdere la sua specificità, ma dico che la teologia (o teosofia) è il tentativo di parlare di un grande mistero e perciò non può mai risultare esclusiva e tanto meno arrogante: è molto arrogante, infatti, ritenere di poter dire qualcosa di sicuro su Dio. L’attuale teologia serve, forse, a formare persone di Chiesa, non uomini teologi e donne teologhe che vivono nel mondo più grande.
Come parlare di Dio?
Forse, più che parlare di Dio dovremmo lasciar parlare Dio. Io penso che la scoperta della profondità della realtà sia molto importante, anche senza parlare di Dio. Senza nominarlo, potremmo riuscire ad aiutare tante persone a rendersi conto che la vita ha radici profondissime. Ci sono ormai altre discipline che aiutano a guardarsi dentro.
A me colpisce il fatto che tante persone che conosco – anche giovani – seguano le religioni orientali in certe pratiche senza peraltro approfondirne la filosofia. Le ascolto: mi parlano di meditazione. Per loro la meditazione è una posizione, è avvertire il proprio corpo e il proprio respiro, sintonizzarsi con l’ambiente.
Penso che, nella tradizione cristiana, questo pure c’è – ad esempio, nell’ascolto della Parola, nella ruminatio e nella meditatio –, ma ciò non è stato insegnato e trasmesso.
Queste pratiche non sono puramente ecclesiali: possono aiutare tutti a vivere l’umano vero, un umano che si riconosce una piccola parte di questo grande universo e, quindi, una piccola parte di un grande mistero.
Che cosa dire di Gesù Cristo?
Mi è caro definire Gesù il “Poeta increato” (sottotitolo del mio precedente libretto), Achiropoieta: sta là dove stanno i giusti, dove sta la verità, dove c’è l’amore per la bellezza, dove c’è la cura per tutto l’umano.
Non penso che si possa subito parlare di Cristo. Penso piuttosto che ci sia da dire a chi e a cosa assomiglia Gesù Cristo nella nostra realtà, perché certamente assomiglia a tutte le persone che hanno una grande passione per la vita, che la rispettano e che hanno il senso del limite.
Il rimando costante della figura di Cristo è all’arché, cioè al principio di ogni creatura e di ogni esistente, ossia a Dio: questo principio che nessuno ha mai visto e che – come dice il vangelo Giovanni – solo la manifestazione della sublime umanità di Cristo lascia intravvedere. Noi possiamo vedere, infatti, attraverso questa umanità ciò che non si lascia esaurire nello strato superficiale della realtà, ma che sempre rimanda, rimanda e va sempre oltre, in profondità.
Come presentare Cristo? Penso che, innanzi tutto, ci sia da cogliere la altrimenti inspiegabile sete di umanità di Cristo che c’è naturalmente nelle persone, mostrare quindi che neppure Cristo ha dato completa soddisfazione a tutta la sete che c’è nell’umano, ma che ha indicato “semplicemente” la via della soddisfazione della sete. Se continuiamo ad annunciare Cristo in modo immediato, come se fosse il contenuto di un libro, penso sia normale non incontrare un riscontro favorevole.
Penso, inoltre, che si debba parlare in totale verità, non per fare proseliti. I giovani hanno sete di verità autentica, non di un sapere che vuole inglobarli.
L’habitat umano
I tempi cambiano e, se cambiano, c’è motivo pure per cambiare quel che diciamo. Questo non vuol dire che quel che è stato detto prima fosse sbagliato. Questo è il tempo di andare in profondità, alle radici, al nocciolo, attraversando tutte le strutture esteriori che, nel frattempo, mi sembrano aver ricoperto le profondità, quelle profondità che ancora sono in grado di dare senso alla vita.
Hai usato l’immagine della grotta in un intero capitolo: perché proprio la grotta?
Quella della grotta non è un’immagine solo biblica. Ricorre in molte ricerche degli esseri umani. È immagine di un’esperienza di interiorità, forse perché il nostro habitat originario è come una grotta: indica una cavità e una profondità; è un’immagine importante per la penetrazione nella realtà, per rintracciare il respiro che anima il tutto, per arrivare al nocciolo.
Per me la grotta va vissuta in un certo modo: stando, cioè, sulla soglia, ossia nel passaggio. Noi viviamo, in fondo, sulla soglia di una grotta, sapendo di non essere ancora giunti alla profondità della stessa, pur percependo chiaramente che c’è tanta profondità.
fede
La soglia della grotta rappresenta per me anche il limite in cui saper sostare con discrezione: ad esempio, di fronte alla libertà e al segreto che le altre persone portano in sé e di cui non possono o non vogliono dire sino in fondo. Questa immagine dovrebbe suggerirci maggiore rispetto degli altri.
Viviamo in tempi violenti, in cui si vuol sempre sapere e spiegare tutto dell’umano e degli umani, ma non può essere così. Meglio restare rispettosamente sulla soglia del mistero per mille anni – come dice il salmo – piuttosto di abitare da violenti nelle tende degli empi. Nelle culture andine, ad esempio, il segreto è dire davvero tutta la verità senza tuttavia svelarla: penso che dovremmo ricevere questa idea ed essere grati.
Un altro capitolo è dedicato a ciò che è insignificante, perché?
Può apparire un gioco di parole: ciò che spesso si ritiene insignificante cela il senso vero delle cose e dell’esistenza. Il nocciolo è dentro realtà che non riusciamo più a guardare, che giudichiamo male o che disprezziamo. Io cerco perciò di elevare l’ode dell’insignificanza. Viviamo in un tempo che continua a calpestare persone e dignità culturali di popoli. È un dramma – quello che sta accadendo – mosso dall’orgoglio e dalla paura. È perciò tempo di trovare strade politiche alternative, di riconoscimento della saggezza altrui, ovunque si possa trovare.
Mi avvalgo dell’idea di uno dei canti del servo di Isaia, uno dei testi che più chiaramente esprime la difficoltà umana di riconoscere l’altro, specie quando questi è sfigurato dal dolore che gli è stato ingiustamente prodotto.
L’esperienza della fede
La vita degli altri resta insignificante – nel senso negativo del termine – sinché non diviene la porta per un passaggio alternativo che senz’altro reca a riconoscere il significato nascosto della vita stessa. È un passaggio però molto delicato e rischioso: sinché l’insignificante è oggetto di un certo modo di intendere la carità e l’amore, si corre il rischio di banalizzare il bene e la stessa carità.
Spesso ci basta beneficare gli insignificanti –rimetterli un poco in sesto nella loro insignificanza – restando sulla superficie dell’umano. Mentre nella loro profondità queste persone – ritenute insignificanti – hanno qualcosa da dire per cambiare le cose e per cambiare noi stessi: ogni essere vivente è maestro o maestra.
Nella Chiesa – e non solo – sono chiaramente presenti moti di carità per le classi sociali più deboli, ma non ancora o non sempre perché diventino interlocutori autentici nella ricerca di un mondo alternativo. Ormai non possiamo più presumere di pensare solo noi (occidentali) questo nuovo mondo. La mia ode dell’insignificanza ha dunque questo significato: non possiamo continuare a voltare la faccia da un’altra parte.
C’è una profezia in quel che scrivi?
La profezia chiama alla conversione. Abbiamo un gran bisogno di “rivoltarci” e di farlo ascoltando gli altri. La verità è immensa ed ha bisogno di tutti per manifestarsi. Vorrei perciò la profezia di una Chiesa meno preoccupata di sacramentalizzare la vita e più interessata a riscoprire i sacramenti della vita, ossia come la vita stessa, nelle sue infinite espressioni, sia rivelatrice.
Vorrei vedere un forte desiderio di cogliere la bellezza negli altri, nella diversità: non per diventare tutti uguali ma per scoprire che, nella diversa bellezza, c’è qualcosa di comune. Per esperienza, noto che le cose cattive e brutte sono brutte per tutti e le cose più buone e belle sono belle per tutti.
Elsa Morante-Scrittrice...attraversare il sentimento religioso con autenticità

"In mancanza di compagni o di seguaci, di ascoltatori o di spettatori, lo spirito libero è tenuto alla sua lunga marcia lo stesso, anche solo di fronte a sé stesso e dunque a Dio. Niente va perduto!"
Elsa Morante
Il termine "Paradiso" percorre in modo costante l'opera di Elsa Morante. L'esistenza di Dio, legata alla sua negazione, corrisponde alla visione umana e spirituale, sdoppiata e contraddittoria, della stessa autrice, in chiara corrispondenza con la coppia di personaggi innocenti e idioti, portatori della grazia, contrari alle figure degli intellettuali e colti, quelli che vivono senza il "conforto della religione". Nella linea di difesa del Paradiso dobbiamo ricordare il saggio di Morante Il Paradiso terrestre, pubblicato in Pro e contro la bomba atomica. Questo scritto apre la strada, all’interno della stessa raccolta morantiana, alle riflessioni di Morante sull’importanza sacra della luce nell’opera pittorica del Beato Angelico, Il beato propagandista del Paradiso, testo che segue da vicino una visione cosmica di chiaro sapore medievale e dantesco. I saggi "teorici" di Morante riprendono la tensione metafisica della scrittrice, contorta e discordante, la stessa che porta avanti nel capitolo 1947 all’interno della Storia. Questo saggio analizza alcuni passaggi di questo stesso capitolo, ma studiandoli attraverso la visione dantesca del Paradiso e attraverso l’importanza della metafisica della luce, in stretta corrispondenza con la potenzialità sacra della creazione poetica e la grazia, tragica e salvifica, della Poesia.

Elsa Morante tra lune e maree
Caterina Sansoni
«Io sono il punto amaro delle oscillazioni
fra le lune e le maree».
(Il Mondo salvato dai ragazzini)
«[…] tu che ti leghi per la vita e per la morte, quasi t'identifichi con le cose che fai. Ma vedi, tu appunto hai questo dono di ricondurre ad unità gli elementi più disparati […]. Tu senti che il mondo è fatto a pezzi, che le cose da tener presente sono moltissime e incommensurabili tra loro, però con la tua lucida e affezionata ostinazione riesci a far tornare sempre i conti».
(Lettera di Italo Calvino a Elsa Morante, 2 marzo 1950).
Se proprio fosse necessario definire Elsa Morante, gli appellativi che troverebbero il suo consenso sarebbero, forse, “poeta” e “cantastorie”. La sua parabola narrativa parte dalla seconda guerra mondiale e arriva alla soglia degli anni Ottanta, cristallizzando in romanzi e poesie la sua visione della realtà del XX secolo. Autrice-crisalide, che costruisce la sua poetica e il suo stile come un bozzolo attorno alla vocazione di scrittrice (già avvertita nella prima infanzia), riutilizzando tematiche, topoi e modelli narrativi del romanzo ottocentesco, si leva sul panorama letterario a lei contemporaneo con estrema indipendenza, disancorata da qualsiasi corrente o gruppo. Il suo bagaglio di letture, vastissimo ed eterogeneo, la sua capacità di rielaborare archetipi e modelli per creare il suo personalissimo stile e i suoi indimenticabili personaggi fanno di lei una figura di intellettuale che modella la propria coscienza metaletteraria e la propria sensibilità umana nel corso delle esperienze della vita.
Elsa nasce a Roma il 18 agosto 1912. Sua madre, Irma Poggibonsi, ebrea originaria di Modena, è una maestra elementare, mentre il padre, Augusto Morante, è istitutore in un riformatorio. Il padre biologico di Elsa e dei suoi tre fratelli (Aldo, Marcello e Maria) è, però, Francesco Lo Monaco, amico di famiglia, il cui ruolo ambiguo pare accettato dal capofamiglia. La religione ebraica della madre e la sfuggevolezza della figura paterna saranno due fra i temi ricorrenti nell'opera della scrittrice. Elsa inizia a scrivere le sue prime storie e poesie già da bambina.
Dopo il liceo, decide di andare a vivere da sola. Si iscrive alla Facoltà di Lettere, ma l'abbandona per iniziare a mantenersi con varie collaborazioni a riviste, come «Il Corriere dei piccoli» e «I diritti della scuola», traduzioni, e lezioni private. Sotto pseudonimi scrive anche su «Oggi» (su questa rivista sotto la firma Antonio Carrera e Renzo Diodati, o solo Diodati). Nel 1941 traduce Scrapbook di Katherine Mansfield, per Longanesi, col titolo Il quaderno degli appunti. Sempre quell'anno sposa Alberto Moravia, che aveva conosciuto nel 1936: accusato di antifascismo, lo scrittore si nasconderà in Ciociaria con Elsa fino alla fine della guerra. Intanto esce per Garzanti, Il gioco segreto, una raccolta di racconti che, insieme alle pubblicazioni della sua giovinezza, costituirà l'humus letterario che ispirerà il primo romanzo: elementi tematici legati alla teatralità, alla dimensione onirica, alla sensibilità verso personaggi smarriti in cerca di appagamento.
Nel '42, per Einaudi, esce la fiaba Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina, la cui origine risale agli anni ginnasiali di Elsa. In quegli anni Elsa redige il suo primo romanzo, Menzogna e sortilegio, che uscirà, grazie all'interesse di Natalia Ginzburg, per Einaudi nel 1948 e vincerà il Premio Viareggio. Il romanzo familiare di Elisa, la narratrice, è un viaggio fra i morti, la narrazione di generazioni di personaggi in preda a passioni e istinti ineluttabili, in un Sud caratterizzato da immobilismo sociale e rassegnazione indolente. Del 1957, invece, è la pubblicazione de L'isola di Arturo (Premio Viareggio), la storia, sempre raccontata in prima persona, dell'adolescenza del protagonista, Arturo, sull'isola di Procida, in un luminoso mondo ciclico, ritmato dalle stagioni e dalla natura, che il giovane abbandonerà dopo l'amore impossibile per la matrigna Nunziata e la conoscenza “umana” di un padre vissuto come una divinità sempre sfuggente e inaccessibile. Il Bildungsroman diventa, sotto la penna fervida della Morante, un'occasione di apertura alla vita, in senso mitico ed esistenzialista, con la Storia che resta ai margini, a cui si allude con qualche cenno al fascismo e con la partenza di Arturo per la guerra, come “rivoluzionario”. La complessa gamma di sentimenti di Arturo si amalgama con l'atmosfera protettiva e allo stesso tempo oscura dell'isola su cui domina il famoso penitenziario. I lati più misteriosi dell'inconscio si accordano all'asprezza e all'irregolarità del paesaggio mediterraneo. Su tutti i personaggi, si staglia la giovane “matrigna” napoletana, con la sua ingenua forza vitale (Morante afferma in un'intervista di aver descritto in Nunziata quella che per lei è la donna ideale) e la sua verità sostanziale.
Gli anni '60 costituiscono un tornante per il percorso letterario della scrittrice. Se l'uscita della raccolta Lo scialle andaluso (1963) rientra ancora nella produzione del primo periodo, l'amore e il dolore per la perdita del giovane pittore americano Bill Morrow (morto precipitando da un grattacielo a New York), la redazione del saggio Pro o contro la bomba atomica (1965) e de Il Mondo salvato dai ragazzini (1968) segnano la decisione incontrovertibile di scontrarsi con il mondo esterno: «l’arte è il contrario della disintegrazione. […] la sua funzione è appunto questa: di impedire la disintegrazione della coscienza umana nel suo quotidiano, e logorante, e alienante uso col mondo; di restituirle di continuo, nella confusione irreale, e frammentaria, e usata, dei rapporti esterni, l'integrità del reale, o in una parola, la realtà» (Elsa Morante, Opere, vol. II, op. cit, p. 1542). Già nelle risposte alle domande della rivista «Nuovi Argomenti» (1959), Elsa paragonava la funzione del romanziere-poeta «a quella del protagonista solare, che nei miti affronta il drago notturno, per liberare la città atterrita» (Ibidem, p. 1546). Morante realizza con dolore che la contemporanea «cultura piccolo-borghese burocratica [è] già infetta da una rabbia di suicidio atomico» (Ibidem, p. 1540).
«“Useppe…” lo chiamò a bassa voce.
Useppe si rigirò al suo richiamo, però gli rimaneva negli occhi lo stesso sguardo fisso, che, pure all'incontrarsi col suo, non la interrogava. C'era, nell'orrore sterminato del suo sguardo, anche una paura, o piuttosto uno stupore attonito ; ma era uno stupore che non domandava nessuna spiegazione». (La Storia)
E contro lo scandalo della Storia dei potenti, Elsa Morante declina nei toni romanzeschi la propria concezione di flusso storico. Nel romanzo del '74, La Storia, criticato in maniera caustica da molta parte della critica militante, perché considerato troppo populista, l'autrice affianca la storia ufficiale della seconda guerra mondiale (rappresentata in liste di avvenimenti in ordine cronologico) con la misera storia di una coppia insolita ma inscindibile, la maestrina Ida e il suo figliolino Useppe, nella Roma occupata dai nazisti. Questo romanzo ponderoso ha il fascino cinematografico del susseguirsi di inquadrature della vita quotidiana dei tanti personaggi vittime della Storia, che cercano attraverso dialoghi scarni eppure straordinari il senso della loro vita e della esperienza che condividono: gli ebrei, i giovani mandati alle armi o in fuga, gli sfollati. La lingua utilizzata si rivolge a quelli che Morante, nel saggio sul Beato Angelico, definisce gli “idioti”, ovvero coloro il cui intelletto è confinato nella dimensione del tempo e dello spazio; la scrittura è caratterizzata dal connubio efficace fra immediatezza della comunicazione quotidiana e ricerca di uno stile che colga tutte le sfumature del reale (le similitudini rappresentano in questo senso uno strumento molto utilizzato dalla scrittrice).
La trama è tessuta dalla voce di un narratore onnisciente, e come sempre non manca la presenza benefica del mondo animale. L'influenza del pensiero di Simone Weil è evidente in diversi punti. Anna Maria Ortese scrisse a Elsa Morante di aver apprezzato sia La Storia che Aracoeli, l'ultimo romanzo, uscito nel 1983: il viaggio dantesco di un solitario protagonista maschile, Manuele, alla ricerca del suo paradiso perduto: la madre andalusa, Aracoeli. Ed è proprio alternando passato e presente che viene a galla la storia del protagonista e della madre, del loro amore, della fine di Aracoeli e dell'ossessione del figlio per la sola che lo abbia amato veramente. La borghesia con i suoi falsi valori viene smantellata, così come tutte le illusioni di rivoluzione del '68: la società descritta, sia quella degli anni dell'infanzia del protagonista, durante il fascismo, sia quella della sua maturità, negli anni '70, ha le sembianze inquietanti di un quadro futurista o di una perversa immagine circense.
L'angoscia, la perdita dell'amico Pier Paolo Pasolini, la gamba fratturata, il tentato suicidio e la diagnosi di idrocefalia sono gli ultimi dolorosi accordi dello spartito dell'opera e della vita di Elsa. In seguito all'appello di Moravia per ottenere un contributo dallo Stato per le costose cure di Morante, all'epoca in ristrettezze economiche, viene varata la discussa legge Bacchelli. La scrittrice si spegne il 25 novembre 1985, testimone acuta e libera del secolo breve e delle sue innumerevoli contraddizioni.
Michela Murgia-Teologa...e la sua sete di Assoluto

Era credente, e non ne aveva mai fatto mistero. Non le dispiaceva definirsi "teologa". La sua simpatia per papa Francesco non aveva niente di ideologico. Il ricordo di chi l'ha conosciuta da vicino
ricorrenza morte 10 agosto
Alessandro Zaccuri
L'ultima volta che ci siamo visti, Michela Murgia aveva appena donato a papa Francesco una copia della rivista di cui era stata direttrice per un solo numero. In copertina c’era lei, elegantissima e sorridente come sempre appariva da quando, nel maggio scorso, aveva deciso di rendere pubblica la fase terminale della sua malattia. “Aspetta, ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, aveva detto mentre cercava uno sgabello. Era affaticata ma orgogliosa: di quel giornale che era diventato un manifesto delle sue convinzioni (“La famiglia è di tutti”, annunciava il titolo principale) e del fatto di averlo potuto consegnare nelle mani del Papa che proprio lei, conosciuta come iconoclasta, aveva difeso dalle accuse piovutegli addosso all’indomani dell’elezione (a proposito di titoli, quel “Bergoglio e pregiudizio” scelto per sintetizzare le sue posizioni resta memorabile).
Michela Murgia era credente e non ne aveva mai fatto mistero. Fin dal suo libro di esordio, Il mondo deve sapere del 2006, non le dispiaceva definirsi teologa, una qualifica poi rivendicata in modo militante attraverso i suoi saggi, in particolare Ave Mary del 2011 e il controverso “catechismo femminista” God Save The Queer del 2022. Non erano mere provocazioni, anche se come tali si è cercato di farle passare. Tutto sommato, anche a Michela Murgia sarebbe convenuto metterla sul piano del paradosso intellettuale, dell’esagerazione argomentativa. Alla peggio, la si poteva buttare in politica, che in certi casi è il modo migliore per chiudere il discorso. Il punto è che la narratrice di Accabadora (il suo libro più celebre e compiuto, pervaso da un’incombenza del sacro per la quale è difficile trovare corrispettivi nella recente letteratura italiana) non si limitava a essere orgogliosa. Era anche una persona esigente, con gli altri e con sé stessa, con la propria scrittura e con le proprie convinzioni, sempre messe alla prova. Prendeva sul serio la fede e proprio per questo si aspettava molto dalla Chiesa.
La sua simpatia nei confronti di Francesco non aveva niente di ideologico. Era la condivisione intima e istintiva di una dottrina della misericordia dalla quale nessuno, per nessun motivo, può sentirsi escluso. Su questi, che erano i temi che più le stavano a cuore, sapeva essere polemica come sono a volte gli adolescenti, che alzano la voce e sbattono le porte solo per essere sicuri di essere amati nonostante tutto, senza condizioni. A volte esagerano, d’accordo, ma hanno dalla loro la certezza che un amore che ponga condizioni semplicemente non è amore.
Di tutto il resto si può discutere, ma a questo desiderio di assolutezza non si può né si deve aggiungere nulla. “Ho bisogno di appoggiarmi un attimo”, diceva Michela Murgia l’ultima volta che ci siamo visti. Ne abbiamo bisogno tutti, sempre, solo che spesso non abbiamo il coraggio di ammetterlo. Lei, invece, non ha voluto nascondere la sua fragilità finale. “Voglio andare avanti così, fino alla fine”, ripeteva. “Riesco a scrivere solo quando mi sento minacciata, quando il cuore mi impazzisce per la paura”, aveva confidato in un’altra occasione. Non so se fosse intenzionale, ma stava citando san Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, “quando sono debole, è allora che sono forte”. È una bella definizione della fede. Senz’altro, è la definizione migliore per la fede di Michela Murgia, che sorrideva al Papa e si aspettava tanto – tutto – dalla Chiesa.

Michela Murgia. Ribelle sì, ma non senza causa
Gennaro Ferrara
Il ricordo del giornalista e presentatore di Tv2000: "Era il 2001, finiva il triennio di Azione Cattolica e le chiesi 'cosa farai'?". Mi rispose: "Farò l'allevatrice di lumache"
Era il 2001, Michela non era ancora famosa. Ci trovavamo al termine di un triennio in Azione Cattolica, che ci aveva visto lavorare insieme: lei come responsabile dei giovani della Sardegna, io come responsabile nazionale. “Che farai ora?”, le chiesi. “Farò l’allevatrice di lumache”, mi rispose. La salutai frastornato da un misto di nostalgia anticipata (pensavo infatti che difficilmente ci saremmo rivisti) e di rabbia (ma come è possibile – riflettevo – che una persona di così grande talento non trovi altro spazio nel nostro paese che quello di allevare gasteropodi?). Fortunatamente mi sbagliavo su entrambi i fronti: il talento di Michela è esploso rapidamente e io ho avuto la fortuna di continuare a frequentarla. Non credo che Michela abbia mai allevato lumache, di mestieri però ne ha fatti tanti: i più noti sono quelli di portiere di notte in un albergo e di venditrice attraverso un call center.
C'è una costante però nelle diverse vite (la definizione è sua) che ha vissuto: quella di brillare e illuminare. Così quando lavorava in albergo ha incontrato Vinicio Capossela e insieme hanno registrato un brano a due voci, che spero un giorno avremo modo di ascoltare; il racconto dell'esperienza nel call center invece è diventato il suo primo grande successo letterario, quello che le ha aperto nuove e inaspettate vite: scrittrice, sceneggiatrice, saggista, attivista, candidata alla presidenza della regione Sardegna e tante altre ancora. Quando le ricordavo quello che pensavo sarebbe stato il nostro ultimo dialogo, lei spiegava tutto con una metafora da campagna sarda: ho fatto la mossa del topo, quello che costretto in un angolo da una scopa, non avendo più vie di fuga, per evitare il colpo ferale, aggredisce.
Ecco allora un'altra costante che ho trovato in Michela dagli anni giovanili ad oggi: la ribellione. Parola quest'ultima che però non va fraintesa. Michela sulla scena pubblica è stata troppo spesso interpretata come una barricadera, un'icona di posizioni ideologiche di un'area ben precisa. Un ritratto falso e semplicista questo, che non dice nulla di chi è stata Michela Murgia. Torno alla metafora del topo: Michela ha lottato per quelli che via via ha ritenuto fossero i più deboli, lo ha fatto con la forza delle sue parole, della sua prorompente personalità, a volte in maniera urticante, nella società come nella Chiesa, ma non è mai stata un'intellettuale da salotto. Le battaglie che ha sostenuto (al di là della valutazione di merito che ciascuno di noi può dare) le ha fatte sulla base di una ricerca, di uno studio, mai attraverso scorciatoie ideologiche. Michela si è esposta e ha pagato di persona. Michela ha detto parole dure non per odio verso qualcuno, né per compiacere circoletti intellettuali, Michela ha parlato in coscienza e consapevolezza, attirandosi per questo, oltre ad ammirazione, anche l'odio di molti. Circostanza per cui ha sofferto. Il sogno di trasferirsi in Corea, coltivato negli ultimi anni, veniva proprio da questo: dalla sofferenza di essere insultata, magari mentre era in fila al supermercato, in ragione delle sue idee.
C'è poi un'altra dimensione meno conosciuta di lei che, per questo, vale la pena di raccontare: quella della fede. Michela ha studiato teologia, animata da quella che Ignazio chiamava la santa inquietudine. Michela ha polemizzato e fatto a botte con la religione, non con la fede che mai ha rinnegato. Michela è stata un'intellettuale credente che ha provato sempre, nella sua coscienza come nelle pagine scritte, a far dialogare la cultura e le istanze del nostro tempo con il Vangelo, con tutta la fatica e le incongruenze che questo comporta. Non spetta a nessuno giudicare il suo percorso, per quanto mi riguarda sento di ringraziarla anche per la testimoninaza, profondamente evangelica, di come ha vissuto la malattia, per averci dimostrato, come ha scritto Chiara Valerio, che “i legami tra le persone sono più persistenti delle persone stesse” e per averci lasciato una delle più belle definizioni di Paradiso che mi sia toccato di ascoltare: “una comunione continua senza intervalli”.
Goffredo Fofi, il filosofo sempre in cerca di un altrove

L’eredità di Goffredo Fofi è inscritta nel volume, introvabile, "Pasqua di maggio. Un diario pessimista", (Marietti, 1988) in cui chiede all’intellettuale «di trasformarsi semplicemente in qualcuno che, nel suo quotidiano uso della cultura, non dimentichi cosa questo comporta. E cioè l’ossessiva memoria dei fini, il dovere di non mentire mai, l’obbligo di parlare di cose che si conoscono davvero e nei modi più chiari per il destinatario che si ha in mente, la diffidenza nei confronti delle mode, il non aver paura di essere minoritari ma senza affatto vantarsene, il non subordinare mai nulla di tutto questo al proprio narcisismo (…) Altrimenti avremo (e abbiamo) solo intellettuali che sono una specie di parodia dei politici (…) o intellettuali che sono una specie di parodia dei giornalisti, e anime belle, infine, convinte della loro indipendenza e della neutralità del loro pensiero quando esso invece è ben funzionale ai poteri e alle logiche – non fossero che quelli della loro corporazione – che di fatto essi servono, anche se fanno finta di non saperlo». (pp. 219-220)

Goffredo Fofi, l’intellettuale nomade che ha insegnato a dire “no”
Il ricordo dell’intellettuale, morto lo scorso 11 luglio a 88 anni
Goffredo Fofi, l’intellettuale nomade che ha insegnato a dire “no”
Se ne va con l’estate, come certi maestri che non si annunciano. Goffredo Fofi è morto lo scorso 11 luglio, a 88 anni. Se n’è andato senza clamore, com’era suo costume. Lasciandoci in eredità una voce o, meglio, una posizione: quella di chi non fa mai pace con l’ingiustizia. Fino a poco tempo fa lo si poteva incontrare (sempre meno ultimamente a causa di acciacchi e malanni fisici) con il suo zaino consunto e lo sguardo limpido, attraversare Roma come attraversava le idee. Sempre in cerca di un altrove, di un margine dove ancora valesse la pena seminare. “Ogni venticinque anni bisognerebbe cambiare nome e identità”, scriveva. Era il suo modo di dire che l’intellettuale, per non diventare funzione, deve restare nomade.
Una vita nei margini
Era nato a Gubbio nel 1937, da una famiglia contadina. Ma la sua vera patria fu l’Italia che non si vede: le periferie, le minoranze, gli esclusi. A diciassette anni era già in Sicilia con Danilo Dolci, a battersi contro la miseria e la mafia con gli “scioperi al rovescio”. Da lì in poi, una sola linea, irregolare ma netta: fare cultura come si fa il pane, tra la gente, per la gente, senza mai separarla dall’etica. Fofi non fu mai accademico. Non fece scuole né carriere. Fondò riviste: Quaderni Piacentini, Ombre Rosse, Lo Straniero, Gli Asini. Scrisse reportage, editoriali, saggi, pamphlet. Fu critico cinematografico, letterario, teatrale. Ma più di tutto fu una coscienza. Un disobbediente sistematico. Il suo motto? “Siamo qui per contraddire, non per compiacere”.
Il cinema come gesto di insubordinazione
Nessuno in Italia ha raccontato il cinema con la stessa radicalità di Goffredo Fofi. Per lui non era mai solo linguaggio o forma, ma una questione di posizione. Di giustizia. Un film, diceva, deve essere utile. Non nel senso didascalico, ma in quello esistenziale: deve disturbare, risvegliare, scoperchiare. “Strappare la maschera della borghesia, anche con il pugnale della macchina da presa”. Dal pamphlet Il cinema italiano. Servi e padroni (1971) a Il cinema del no (2015), da Capire con il cinema (1977) alla Breve storia del cinema militante (2023), ha scritto per generazioni di studenti, di insegnanti, di cinefili fuori asse. E ha formato uno sguardo: quello che cerca il vero nel falso, il povero nel rappresentato, il rifiuto nella bellezza. Totò fu il suo profeta laico: “poeta degli ultimi”. Keaton più di Chaplin, perché “metafisico, irriducibile alla storia”. Pasolini, il suo doppio dialettico: “è con lui che ho litigato di più”. Ermanno Olmi, il compagno di viaggio più vicino. Amelio, Rohrwacher, Ciprì e Maresco, gli eredi. Il suo “cinema del no” non è una poetica: è una forma di resistenza al mondo così com’è.
Un cattolicesimo degli ultimi
Eppure, a definirlo solo militante si rischia la caricatura. Fofi è stato anche altro: un laico che ha parlato ai credenti. Anzi, con loro. Collaboratore di Avvenire, ha scritto di santità minori, di evangelismo delle periferie, di figure come don Milani, don Tonino Bello, Dorothy Day. Ha riconosciuto nel cristianesimo “minoritario” — quello che traduce il Vangelo in pane, scuola, accoglienza — una delle forze più vive del Novecento. “Un confronto tra cristianesimo e anarchismo è oggi più che mai necessario”, scriveva. E ancora: “La parabola del seminatore è per me un riferimento politico: si semina senza sapere dove il seme cadrà”. Il suo pensiero — libertario ma spirituale, irriducibile a etichette — ha messo in dialogo il Vangelo e l’utopia, la povertà e la dignità, l’intelligenza e la tenerezza. È anche questo che lascia: una fede laica nell’altro.
L’eredità
Goffredo Fofi non era un intellettuale “organico”. Non era organico a nulla, se non a un’idea di giustizia radicata nella vita concreta. Per questo resta. Resta nei libri e nei documentari, nei cineclub e nelle biblioteche scolastiche, nei lettori giovani che lo scopriranno nelle pagine di Lo Straniero o in una nota a margine di Capire con il cinema. Resta in chi ancora si ostina a leggere il mondo con sguardo laterale. Non lascia una scuola, ma una postura. Non un metodo, ma un’etica. Leggere dentro le pieghe. Prendere parte. Scegliere di essere minoranza. “Resistere, studiare, fare rete. Era una dichiarazione d’amore.

Goffredo Fofi: lo sguardo critico di uno "Straniero"
Massimiliano Castellani
Saggista, critico cinematografico e letterario e intellettuale impegnato a tutto tondo, collaborò a lungo con "Avvenire"
È morto un amico. Un amico di "Avvenire", un amico di quasi tutti: Goffredo Fofi. In estate arrivava puntuale nella nostra redazione milanese sempre vestito da eterno viandante, scendeva da un treno preso al volo con il sandalo consumato e la gerla sulle spalle carica di libri e di appunti. Immagini che rimandano al docufilm che gli ha dedicato Felice Pesoli, dal titolo emblematico Suole di vento. Impossibile sintetizzare gli 88 anni vissuti da quest’uomo abitato dalla voglia di conoscere e di andare sempre a fondo alle cose e alle storie, armato solo da quella lanterna da Diogene del '900 proiettato sul futuro. Non basterebbe un intero giornale per descrivere tutto ciò che è stato, che ha fatto, che ha detto e che ha scritto anche sulle rubriche che per anni ha portato avanti con penna certosina e con altrettanto “empirismo eretico” su "Avvenire", che per questo gli sarà sempre grato.
Fofi è stato essenzialmente un nomade, un pensatore libero come pochi altri nati nel secolo scorso, a Gubbio, nel 1937. “La città dei matti e un po’ mi ci sento sai” confidava nelle nostre lunghe chiacchierate, molte telefoniche, in cui ricordava quella fuga dal piccolo mondo antico eugubino avvenuta a 18 anni. Un treno solo andata per Palermo per raggiungere il filosofo pacifista Danilo Dolci e alzare assieme a lui le prime barricate con gli “scioperi a rovescio”, a difesa dei lavoratori sfruttati e poi per gridare il primo assordante “no alla mafia” che non era ancora quella bombarola degli anni '90. Ma il genio ribelle di Goffredo, laggiù nella terra del Gattopardo si beccò il primo marchio di “incompreso”, macchiandosi del reato di insubordinazione per aver insegnato ai braccianti analfabeti senza prendere regolare stipendio. Delitto d’alfabeto si intitolava l’editoriale difensivo di Lucio Lombardo Radice apparso su "L’Unità", che di fatto dava il benvenuto a Fofi nella comunità degli uomini rari di questo Paese destinati ad andare sempre in direzione ostinata e contraria.
Un esule in patria che a Parigi assaporò il gusto pieno della sua più grande passione, tra le tante, che ne fanno un saggio superiore ancor prima che un saggista straordinario, il cinema. Nella Ville Lumiere, dove non mancava mai di tornare, lasciò articoli pubblicati sulla rivista "Postif" e rientrato in Italia era pronto ad aprirne una, i "Quaderni piacentini", con Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi. Tanta critica letteraria, certo, ma a Goffredo in quel momento di radicali e profondi cambiamenti sociali interessavano gli ultimi, gli emarginati. Così su quelle pagine di accademismo letterario pubblica una dirompente, per i tempi, inchiesta come L'immigrazione meridionale a Torino sulla classe operaia che andava sempre più all’inferno nella pressa del lavoro a catena avvolto nebbia torinese. Solo Feltrinelli ebbe il coraggio di pubblicare gli scritti sulfurei del giovane Fofi che nella città della Fiat nel ’68 aprì la redazione della rivista "Ombre rosse." Cinema e politica si fusero come non mai e l’agitatore di popolo accendeva polemiche incendiarie che creavano inevitabilmente dibattiti accaldati e talora scandalo, come la sua casa editrice sessantottina La Forum Editoriale.
Ribelle e sognatore, orgoglio, senza pregiudizio, questa la cifra fofiana che si contrapponeva all’altro pensiero forte di quel periodo di saggistica e di poesia civile, lo spirito pasoliniano. “È con Pasolini che ho litigato di più è da lui che mi sono sentito più provocato, chiamato in causa su argomenti fondamentali della nostra storia civile, e dunque della mia stessa storia”, ha scritto in uno dei suoi innumerevoli saggi sul Poeta di Casarsa con il quale all’inizio si trovò in piena sintonia sul meridionalismo di Danilo Dolci ed Ernesto De Martino, ma poi come un Donnarumma, Fofi andò all’assalto, senza mai risparmiare critiche ai suoi film, al Vangelo secondo Matteo e ai Racconti di Canterbury. Onore delle armi a un antagonista con cui il livello dialettico si alzava e quello degli anni ’60-’70 era ancora un Paese dove la voce degli intellettuali aveva il suo peso. Mentre oggi, scriveva Fofi dalle colonne di "Avvenire", “in Italia la figura dell'intellettuale è completamente appannata. Non gli si chiede più nulla, manca ogni dialettica tra la cultura, da una parte, e la politica e la società, dall'altra». Parole scritte a macchina da un camminatore solitario, stanco, distante dal Goffredo impavido che nel ’72 (l’anno di Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio con cui aveva scritto e riscritto la sceneggiatura) a Napoli animava la Mensa dei bambini proletari cantata da Enzo Moscato. Napoli città teatro, uno dei suoi tanti luoghi dell’anima dove con Stefano De Matteis ha fondato un’altra rivista ultralternativa, Dove sta Zazà.
Fofi è stato un creatore quasi longanesiano di periodici sempre pieni di pagine di approfondimento, e se possibile corrosive. Viveva la banalità come un male estremo, ma non ha mai rinunciato all’ironia e a quel sorrisetto sardonico sopra a quella barba diventata candida come la neve dell’Appennino da cui era scollinato. Così, quando gli ricordavi che era rimasto l’ultimo critico davvero militante di questa Italietta incolta e barbara, lui rispondeva ironico, “sì sono un militante ignoto”. L’essenza di quel mestiere naturale del critico è in queste righe in cui elogia Un altro Proust di Giacomo Debenedetti. “Ha sempre qualcosa di commovente la dedizione di un critico a un autore nel cui percorso si è riconosciuto, che lo ha chiarito a se’ stesso. Sulle sue idee egli ha costruito le sue convinzioni in un confronto dapprima istintivo e poi via via più adulto, vedendole espresse meglio di quanto egli non saprebbe mai fare e dandosi di conseguenza il compito di farle conoscere. Studia, traduce, presenta, commenta al fine di divulgare quelle idee a una cerchia di lettori che sogna sempre più vasta, perché ne possano trarre giovamento, nutrimento”.
Noi siamo l’ultima generazione che si è nutrita dei libri di Goffredo Fofi che andrebbero riletti tutti, dai saggi sociopolitici a quelli sul cinema e il teatro in cui come un rabdomante andava sempre alla ricerca del genio perduto cancellando quelle smemoratezze imperdonabili su stelle indimenticabili come Anna Magnani e Totò. “La cultura, l’arte, va cercata nel fondo del popolo”, mi disse una volta mentre parlavano di musica pop e di Nino D’Angelo il quale ricordava in una intervista concessa ad Avvenire: «Non smetterò mai di ringraziare un intellettuale onesto e coraggioso come Goffredo Fofi. E’ stato lui a sdoganarmi e a comprendere il senso profondo di un brano come Ciucculatina d' 'a ferrovia e a dire ad alta voce che io non ero semplicemente un cantante neomelodico, ma la vera voce del sottoproletariato napoletano». A Fofi deve dire grazie forse la metà della saggistica e della narrativa italiana tuttora in voga, da Alessandro Baricco fino a Roberto Saviano. Un talent scout quasi inconsapevole che fiutava prima il senso e la portata dell’opera e del messaggio da trasmettere al lettore e solo dopo la possibilità di ottenere un consenso, che andava ben al di là della bieca logica commerciale dominante. Goffredo straniero tra gli stranieri. E non a caso la sua rivista più acclamata e duratura è stata Lo straniero: nato nel 1997, e chiuso nostalgicamente nel 2016 per lasciare il posto a Gli asini. Un visionario Fofi che tra i tanti incontri fatti per le strade del mondo che ha solcato, ha avuto anche la fortuna di imbattersi nel più visionario degli scrittori, Borges. Del genio argentino amava tutta l’opera, comprese le sue grandi “contraddizioni filosofiche” ed era affascinato da quell’ aforisma in cui forse si rispecchiava la sua anima: “Per certi comunisti, se sei anticomunista sei subito definito fascista. Questo è incomprensibile, quanto affermare che se non sei cattolico sei un mormone”.
San John Henry Newman-Dottore della Chiesa..."luce gentile" della Chiesa

IL 31 luglio 2025 Leone XIV ha dato parere favorevole all'attribuzione del titolo di Dottore della Chiesa al cardinale anglicano che si convertì al cattolicesimo, canonizzato nel 2019 da Francesco

Il mio Si
San John Henry Newman
Io sono creato per fare e per essere qualcuno
per cui nessun altro è creato.
Io occupo un posto mio
nei consigli di Dio, nel mondo di Dio:
un posto da nessun altro occupato.
Poco importa che io sia ricco, povero
disprezzato o stimato dagli uomini:
Dio mi conosce e mi chiama per nome.
Egli mi ha affidato un lavoro
che non ha affidato a nessun altro.
Io ho la mia missione.
In qualche modo sono necessario ai suoi intenti
tanto necessario al posto mio
quanto un arcangelo al suo.
Egli non ha creato me inutilmente.
Io farò del bene, farò il suo lavoro.
Sarò un angelo di pace
un predicatore della verità
nel posto che egli mi ha assegnato
anche senza che io lo sappia,
purché io segua i suoi comandamenti
e lo serva nella mia vocazione.

Il Cardinale Santo Sir John Henry Newman
proclamato santo da Papa Francesco.
Card Ravasi
John Henry Newman, nato a Londra nel 1801 e morto a Birmingham nel 1890, dopo una vita segnata da colpi di scena. A 15 anni ha una svolta religiosa che lo conduce a Oxford per i suoi studi filosofico-teologici e per l’ordinazione a ministro della Chiesa d’Inghilterra a 24 anni. Inquieto all’interno di questa comunità di gente perbene – come egli stesso confesserà – si impegna a un’opera di rinnovamento di tale istituzione, sostenendo il cosiddetto “movimento di Oxford” che voleva risalire alle fonti originarie della fede anglicana, occhieggiando ecumenicamente alla Chiesa cattolica, che lo attira per il suo essere una comunità più di peccatori che di benpensanti, per stare ancora alle sue parole.
Fieramente criticato dalla gerarchia accademica ed episcopale anglicana, dopo una crisi tormentata, decide di compiere un salto di frontiera, allora scandaloso: nel 1845 si fa cattolico, due anni dopo è ordinato sacerdote ed entra nell’Oratorio di San Filippo Neri, una congregazione religiosa italiana, segnata da un santo così libero e vivace. Su di lui piombano i fulmini dell’establishment inglese, tant’è vero che è costretto a comporre un’Apologia pro vita sua, che però si trasforma in un’intensa autobiografia spirituale. La sua vita, però, avrebbe avuto un sussulto ancor più forte: nel 1879 il papa Leone XIII nomina lui, ex-prete anglicano, cardinale di Santa Romana Chiesa, assegnandogli – come è tipico di ogni porporato che diventa membro del clero di Roma – un “titolo”, cioè una chiesa specifica romana.
A lui è assegnata la mirabile basilica di San Giorgio in Velabro, accanto all’Arco di Giano, nei pressi del Campidoglio: per molti romani è la memoria del luogo del loro matrimonio secondo una consuetudine che ancor oggi persiste; per me è un legame straordinario col nuovo santo e grande intellettuale, essendo attualmente io il cardinale titolare di questo tempio. È necessario gettare ora uno sguardo sulla sua bibliografia, un’impresa ardua, se si pensa che l’edizione originale dell’Opera omnia, iniziata già quand’era ancora in vita a Londra (1878), si concluderà nel 1921 con ben 40 tomi. Molti testi di Newman verranno tradotti in italiano dalla milanese Jaca Book e dalla bresciana Morcelliana. Noi punteremo solo su un paio di scritti particolarmente rilevanti che hanno lasciato una traccia marcata nella riflessione filosofico-teologica.
Il primo è quello che è considerato il suo capolavoro, la Grammatica dell’assenso (l’originale inglese del 1870 suonava più modestamente: Essay in aid of a Grammar of Assent). Si tratta di un’analisi molto raffinata e articolata dell’atto di fede, collocato però all’interno del dinamismo del pensiero e dello spirito. Una vasta porzione di questa mappa del credere è riservata al vaglio delle strutture dell’«assenso reale» incondizionato richiesto dalla fede in confronto con le esigenze della dimostrabilità scientifica. È interessante la ricostruzione della polimorfia gnoseologica che caratterizza il nostro conoscere che si esercita secondo un ventaglio di percorsi, per cui non ci si può arroccare sul solo sentiero rigidamente razionale. La fede e la prova dimostrativa stanno tra loro in un reciproco rapporto di condizionamento.
Il suo è un lessico originale che esige un esercizio severo di lettura: ad esempio, il real assent, l’assenso pieno, si basa sull’aprehension, la comprensione, ma anche sull’inference che è un andare oltre, appunto un’«illazione» che non esclude l’immaginazione, per cui non pratichiamo solo un’epistème, una conoscenza logico-formale ma anche una phrónesis che è simbolico-esistenziale. Per questo anche la persona «non istruita» e semplice (cioè non dotata dell’attrezzatura filosofica e teologica) può essere la sede di una conoscenza autentica di fede con un suo percorso e un suo organon investigandi. Suggestivo è, perciò, il primato da lui assegnato alla coscienza personale come «primo vicario di Cristo», accostata all’altro vicario di Cristo, il papa, espressione della dottrina teologica generale.
Pur nella semplificazione della nostra sintesi, è evidente il desiderio di Newman di interloquire con la cultura moderna, anche perché egli operò a lungo, come si diceva, nell’orizzonte accademico oxoniense. Da questo ambito estraiamo la seconda opera che desideriamo evocare. Si tratta dell’Idea of a University, nove lezioni tenute nel 1852 a Dublino nella veste di fondatore e rettore dell’università cattolica d’Irlanda. Si configura in questi interventi il profilo dell’istruzione superiore destinata non solo a offrire una capacità operativa, ma soprattutto a formare la persona nella sua pienezza, a creare quello che Newman definisce il vero gentleman. In questa luce ritorna il tema della polivalenza della conoscenza che adotta metodi differenti ma complementari, compresa perciò la teologia.
Anzi, il programma ideale dell’università deve coinvolgere tutte le dimensioni dell’esperienza umana, anche sotto il profilo etico: non è solo un “istruire”, cioè un indurre dati e competenze, ma anche un “educare”, un estrarre le potenzialità della persona umana, amputandone le degenerazioni. Come già aveva sottolineato in ambito ecclesiale, il futuro santo non esitava a marcare il protagonismo del laicato cristiano, evitando di delegare tutto alla gerarchia ecclesiastica.
Una nota finale. Newman fu anche poeta, nelle sue circa duecento composizioni, molte brillano per autenticità. È il caso della più famosa, The pillar of the cloud (La colonna di nube), un simbolo dell’esodo biblico.
Alle Bocche di Bonifacio tra Sardegna e Corsica, l’imbarcazione su cui Newman viaggiava era incorsa in una tempesta. Sotto quel cielo cupo e minaccioso, egli si era affidato alla stesura di una preghiera in versi, divenuta poi famosa per il suo incipit: «Lead, kindly Light». Riproponiamo questo avvio per il valore simbolico che riveste anche nel ritrarre la ricerca umana e spirituale newmaniana: «Guidami oltre, Luce gentile, nell’oscurità che mi circonda, / guidami oltre! / La notte è buia, e io sono lontano da casa. / Guidami oltre! / Tienimi in piedi! / Non chiedo di vedere / la scena distante, / un passo mi è sufficiente».

Il cardinale Newman genio e poeta mistico
Fortunato Morrone
John Henry Newman Dottore della Chiesa. Notizia del 31 luglio2025. Finalmente! Dopo la canonizzazione del beato cardinale, proclamata da Papa Francesco il 13 ottobre 2019, si attendeva che la Chiesa, nella persona del Santo Padre Leone XIV, riconoscesse in lui uno dei suoi dottori (da notare che nel 1879 era stato Leone XIII elevarlo alla porpora). Immagino, tuttavia, un Newman in qualche modo imbarazzato e sorpreso davanti a tali riconoscimenti da parte della Chiesa.
Cosciente dei suoi limiti caratteriali e culturali, ma anche delle sue notevoli possibilità intellettive e morali, Newman, avanti negli anni, in una corrispondenza, dopo aver elencato una serie di qualità e di doti specifiche necessarie che il teologo deve presentare, confidava: «Questo io non lo sono, né sarò mai. Come S. Gregorio di Nazianzo preferisco camminare per la mia strada e disporre del mio tempo [...] senza pressanti impegni» (LD XXIV, 213).
In tal senso Newman è stato anzitutto un pastore e predicatore di rara finezza linguistica e comunicativa e un credente di notevole cultura e di raffinata intelligenza che — nella contingenza della polemica culturale o della difesa circostanziata di questa o di quella questione teologica o filosofica — ha saputo esibire in massimo grado i motivi della speranza cristiana, ma con uno stile e un’acutezza di riflessione che rivelano la grandezza del suo spirito, capace di elevare il tono del confronto religioso, sociale, educativo o culturale della disputa per dilatare l’orizzonte conoscitivo, razionale e credente dei lettori o dei suoi ascoltatori, fossero essi pro o contro di lui.
Ma la Chiesa non si sbaglia: Newman sarà doctor Ecclesiae poiché, per dirla con san Paolo VI, egli viene riconosciuto come «un faro sempre più luminoso per tutti quelli che sono alla ricerca di un preciso orientamento e di una direzione sicura attraverso le incertezze del mondo moderno» (Discorso agli specialisti e agli studiosi del pensiero del Cardinale Newman, 7.04.1975).
Assiduo lettore e discepolo dei Padri, come loro Newman ha alimentato e motivato il suo esercizio e il suo ministero teologico, attingendo continuamente, nella preghiera, all’ascolto e allo studio della Scrittura. Se con la sua esistenza credente Newman ha testimoniato la bellezza e la praticabilità del Vangelo, con la sua riflessione teologica il presbitero anglicano e professore a Oxford prima, e oratoriano presbitero cattolico poi, ha offerto ragioni valide della credibilità, della sensatezza e della sapienza della fede.
«Genio complesso, poeta e mistico» (Bremond), leader del Movimento di Oxford nel periodo anglicano, Newman è stato riferimento teologico sicuro, nonostante gli anni della diffidenza dei suoi connazionali, della rinata comunità cattolica in Inghilterra dopo il suo sofferto ma lucido passaggio alla Chiesa di Roma. Difendendo la libertà di coscienza in nome di una fede aperta incondizionatamente alla «luce gentile» della Verità e misurandosi dialogicamente e criticamente con le correnti di pensiero religioso, filosofico e teologico dell’epoca vittoriana, Newman ha saputo coniugare magistralmente il rapporto tra fede e ragione, decisivo per il pensiero occidentale, con un approccio fenomenologicopersonalista più che metafisico, aprendo così nuovi sentieri alla ricerca teologica, chiamata a offrire ragioni della speranza che i credenti, specialmente i semplici, sono invitati a testimoniare, ieri come oggi, in questa umana storia amata da Dio. E ai semplici Newman ha dedicato la sua Grammatica dell’assenso (1870), che lo ha impegnato per tutta la vita, nelle linee programmatiche essenziali già tracciate nei Quindici sermoni universitari, tenuti tra il 1830 e il 1843.
Attualmente la sua opera, nell’orizzonte dell’amicizia tra le ragioni della fede, fondata nella Rivelazione, e le esigenze della ragione, ci offre una visione di una gioiosa fede che dà fiducia alla ragione di fronte al relativismo e allo scientismo odierno.
Tra le altre opere teologiche di Newman segnaliamo il Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana (1845), terminato poco prima del suo passaggio al cattolicesimo, in cui viene posta in evidenza la categoria di Tradizione alla luce della vicenda secolare della Chiesa in chiave dinamica e creativa; l’Idea di Università (1854), frutto della sua esperienza di rettore del nuovo Ateneo di Dublino, opera nella quale i temi dell’unità, dell’interdisciplinarità e transdisciplinarietà dei saperi in dialogo con la teologia (cfr. Veritatis Gaudium 4, qui viene citato Newman insieme a Rosmini) sono come anticipati nel contesto del suo tempo. Ancora, Sulla consultazione dei fedeli in materia di dottrina (1859), in cui la visione ecclesiologica — tracciata in The Prophetical Office, edito nel 1837 per offrire consistenza teologica all’anglicanesimo, ma ripreso e corretto nella Terza prefazione alla Via Media (1873) — aiuta oggi a comprendere la natura sinodale della Chiesa. E infine la Lettera al duca di Norfolk, sul delicato tema della coscienza, luogo del cuore nell’esperire se stessi e Dio (God and myself), ma colto all’i nterno dell’atto di fede del credente, come assunzione soggettiva e responsabile dell’oggettiva confessione di fede garantita dalla Chiesa.
Si tratta di testi ancora oggi di riferimento sia per l’ampio dibattito teologico contemporaneo, sia per la missione della Chiesa in questo mondo in continuo e veloce cambiamento, che presenta nuove sfide all’intelligenza della fede e opportunità inedite per l’annuncio del Vangelo, ma in una dinamica relazionale che nel soggetto credente coinvolge anzitutto il cuore che comunica al cuore (cor ad cor loquitur) e che certo implica l’intelligenza.
*Arcivescovo di Reggio Calabria - Bova
San Giovanni M. Vianney..."curatore" di anime


San Giovanni M. Vianney
morte 4 agosto 1859
“Se comprendessimo bene che cos’è un prete sulla terra, moriremmo: non di spavento, ma di amore”. La vita di San Giovanni Maria Vianney è tutta racchiusa in questo suo pensiero. Noto come “il Curato d’Ars”, Giovanni Maria Vianney nasce l’8 maggio 1786 a Dardilly, vicino Lione. I genitori sono contadini e lo avviano sin da piccolo al lavoro nei campi, tanto che Giovanni arriva all’età di 17 anni ancora analfabeta. Grazie agli insegnamenti materni, però, conosce a memoria molte preghiere e vive un forte senso religioso.
“Vorrei conquistare molte anime”
Intanto, in Francia soffiano i venti della Rivoluzione: Giovanni si accosta al Sacramento della Confessione in casa, non in chiesa, grazie a un sacerdote “refrattario” che non ha giurato fedeltà ai rivoluzionari. Lo stesso avviene per la prima Comunione, ricevuta in un granaio, durante una Messa “clandestina”. A 17 anni, Giovanni avverte la chiamata al sacerdozio: “Se fossi prete, vorrei conquistare molte anime”, dice. Ma la strada non è facile, considerate le poche conoscenze culturali. Solo grazie all’aiuto di sacerdoti sapienti, tra cui l’Abbé Balley, parroco d’Écully, viene ordinato presbitero il 13 agosto 1815, all’età di 29 anni.
Lunghe ore nel confessionale
Tre anni dopo, nel 1818, viene mandato ad Ars, piccolo villaggio nel sudest della Francia, abitato da 230 persone. Qui, dedica tutte le sue energie alla cura dei fedeli: fonda l’Istituto “Provvidenza” per accogliere gli orfani, visita gli ammalati e le famiglie più indigenti, restaura la chiesa, organizza feste patronali. Ma è nel Sacramento della Confessione che la missione del Curato d’Ars si esprime al meglio: sempre disponibile all’ascolto e al perdono, trascorre fino a 16 ore al giorno nel confessionale. Quotidianamente, una folla di penitenti di ogni parte della Francia si confessa da lui, tanto che Ars viene rinominata “il grande ospedale delle anime”. Lo stesso Vianney veglia e digiuna per contribuire all’espiazione dei peccati dei fedeli: “Vi dirò qual è la mia ricetta – spiega a un confratello - do ai peccatori una penitenza piccola e il resto lo faccio io al loro posto”.
Patrono dei parroci
Donato interamente a Dio e ai suoi parrocchiani, muore il 4 agosto 1859, all’età di 73 anni. Le sue spoglie riposano ad Ars, nel Santuario a lui dedicato, che ogni anno accoglie 450 mila pellegrini. Beatificato nel 1905 da Pio X, Giovanni Maria Vianney viene canonizzato nel 1925 da Pio XI che nel 1929 lo proclama “Patrono di tutti i parroci del mondo”. Nel 1959, nel centenario della sua morte, San Giovanni XXIII gli dedica l’Enciclica Sacerdotii Nostri Primordia, additandolo a modello dei sacerdoti mentre nel 2009, per il 150.mo anniversario dalla sua scomparsa, Benedetto XVI indice un “Anno sacerdotale”, per “contribuire a promuovere l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti, per una loro più forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi”.
Sant'Alfonso de' Liguori...la santità abbraccia tutti!
Alfonso de' Liguori e la santità "inclusiva"
morte 1 agosto 1787
Un pastore"con l'odore per le pecore", che in anticipo sulla storia insegnò ai laici del Settecento che la perfezione cristiana non era corsia preferenziale di pochi privilegiati ma una larga strada di amore che non conosce discriminazioni. L'Osservatore Romano descrive alcuni aspetti della figura di Alfonso Maria de' Liguori, che la Chiesa festeggia il primo agosto
Mario Colavita
Quello che colpisce di sant’Alfonso è la capacità di incoraggiare e infiammare alla via santa, alla perfezione cristiana, sebbene la mentalità settecentesca avesse messo un blocco, come una barriera per la perfezione al mondo laicale.
"Canzoncine" che raccontano Dio
La proposta alla vita santa per Alfonso è per tutti: laici e religiosi. Per il vescovo di Sant’Agata la santità è una rivalutazione della dignità dell’uomo, un dovere per ogni battezzato.
La vita laicale dei tempi di sant’Alfonso veniva considerata mediocre, regolata solo dai dieci comandamenti, dai precetti della Chiesa e dai doveri del proprio stato, mentre la vita religiosa doveva essere generosa con il traguardo della santità, regolata per lo più dai consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza. Per Alfonso era chiaro che la vita morale-spirituale non poteva essere disgiunta dalla vita pratica. Egli, perciò, ricupera una fondamentale unità della vita cristiana, basata sull’amore di Cristo Gesù all’uomo. Egli elabora un concetto di vita morale e pastorale per tutti, ponendo come principio la chiamata universale alla santità, non riservata solo a pochi, ma proposta ad ogni cristiano.
Un’affermazione di fondo è che la santità è alla portata di tutti. Scriverà nella Selva di materie predicabili (1760): «Dio vuol salvi tutti, ma non per le stesse vie. Siccome in cielo ha distinto diversi gradi di gloria, così in terra ha stabiliti diversi stati di vita, come tante vie diverse per andare al cielo».
Questa idea e proposta cristiana sfocerà nella convinzione, codificata nel best seller della spiritualità settecentesca, La pratica di amar Gesù Cristo (1768), il cui titolo dice quanto Alfonso abbia agito per proporre la santità come strada per tutti concretizzata nell’amare Gesù Cristo.
La sua è una visione realizzabile non una teoria sulle nubi. Da qui l’incipit: «Tutta la santità e la perfezione di un’anima consiste nell’amare Gesù Cristo nostro Dio, nostro sommo bene e nostro Salvatore»; per poi concludere: «Iddio vuol tutti santi, e ognuno nello stato suo, il religioso da religioso, il secolare da secolare, il sacerdote da sacerdote, il maritato da maritato, il mercadante da mercadante, il soldato da soldato, e così parlando d’ogni altro stato».
Alfonso è uno dei quei santi che ci accompagna e ci incoraggia, secondo l’espressione di Papa Francesco nella Gaudete et Exultate. Ci incoraggia alla vita concreta, all’amore pratico a Gesù Cristo e alla Chiesa, ci accompagna con il suo esempio e la sua laboriosità e praticità. A cinquant’anni dalla sua proclamazione a dottore della Chiesa (1871), Benedetto xv nel luglio 1921 ebbe a scrivere del santo: «[Sant’Alfonso] è utile non solo a quelli che studiano o insegnano, ma anche ai fedeli di ogni categoria, nel dimostrare ed appianare la strada che conduce alle solide virtù ed alla perfeziona cristiana».
Nel 1796 fu stampato per i tipi di Remondini di Venezia il Dizionario storico degli uomini illustri; alla voce Liguori si legge: «Fu un uomo apostolico, un modello di santità, e dottrina ai vescovi, ed uno de’ più forti sostenitori della sana, e pratica morale [...]. Scrisse più libri pei dotti, e per gli ignoranti, per gli scolari, pei religiosi, per i claustrali, pei seminari, e pei vescovi, per gl’increduli, e fin pei regnanti».
Nominato vescovo di Sant’Agata, per obbedienza a Clemente xiii nel 1762 prima fece avere la sua rinuncia, poi visto che il Papa non ne voleva sapere l’accettò dicendo: «Questa è la volontà di Dio [...] Gloria Patri! Dio mi vuole vescovo, ed io voglio esser vescovo».
Per l’equipaggiamento vescovile lo portarono a Napoli; Alfonso non ne era entusiasta a quanti gli facevano notare che il vescovo doveva avere una carrozza con livrea, bonariamente rispondeva: «Se per ubbidienza ho accettato il vescovato debbo imitare i santi vescovi, e non mi state a dire carrozze e livree. Che ho da andare facendo il bagascio per Napoli».
A Roma per la consacrazione episcopale Alfonso ebbe la gioia di parlare più volte con Clemente xiii, tra le altre cose il Papa chiese consigli circa la situazione del regno di Napoli. Sappiamo che la conversazione cadde sulla questione della comunione frequente e dell’attacco a opera di Cipriano Aristasio alias don Gennaro Andolfi. Sant’Alfonso prese la cosa così a cuore che non perse tempo di preparare una risposta apologetica in cui confutò l’Adinolfi. Per documentarsi nel maggio del 1762 andò nella Biblioteca apostolica vaticana e a oggi rimane l’unico dottore della Chiesa ad avervi messo piede.
Prima della consacrazione episcopale Alfonso dovette affrontare un esame di “dottorato” con una commissione di cardinali presieduta dal Pontefice nel palazzo del Quirinale. Alla domanda se fosse bene aspirare all’episcopato egli faceva finta di non sentire. Alla fine dell’esame era prassi fare un ringraziamento al vescovo di Roma. Alfonso, candido candido disse poche parole: «Beatissimo Padre, giacché vi siete degnato di farmi vescovo, pregate Iddio che non mi perda l’Anima».
Prima che ripartisse da Roma per l’impegno pastorale nella diocesi di Sant’Agata dei Goti, Clemente xiii lo volle ancora con sé per parlagli; non pochi curiali misero in giro la voce che l’avrebbe fatto cardinale. Il biografo Tannoia ha lasciato scritto: «L’ultima volta, che fu per licenziarsi dal Papa (ed avevalo voluto da sei a sette volte) sopraffatto si vide da maggior finezza. Il Santo Padre non sapeva disfarsi di Alfonso, ed Alfonso supplicò il Papa averlo presente innanzi a Dio coi bisogni della sua diocesi [...]. Il papa istesso non finiva di encomiare la di lui virtù [...]. Mons. Mastrilli arcivescovo di Bettelemme, che fu uomo che assistette alla consacrazione episcopale, attestò che il Papa parlandone con alcuni cardinali disse: Nella morte di Monsignor Liguori avremo un altro santo nella Chiesa di Gesù Cristo».
Infatti egli fu un pastore esemplare, pieno di zelo, aperto, disponibile, un vero evangelizzatore, vescovo con l’odore delle pecore. Dalla lettura delle carte per il processo di beatificazione emerge come la sua azione pastorale fu in favore della perfezione della vita santa. Fondò monasteri e luoghi di ritiro per le persone in pericolo (spirituale). Procurava parroci dotti e santi per la cura delle anime, s’informava minutamente circa i costumi dei suoi diocesani. Nelle visite alla diocesi cavalcava un somaro; sempre predicava, istruiva i fanciulli, visitava gli ammalati. Le due gemme che più risplendettero sulla sua mitra pastorale furono lo zelo della salute delle anime e l’amore sviscerato verso i poveri.
Di questa attenzione ai poveri abbiamo una deposizione giurata di don Matteo Migliore, parroco di San Nicola Magno, fatta al processo di beatificazione: «[Il servo di Dio] aveva amore per li poveri, facendo loro delle frequenti limosine, e soccorrendo ad altri loro bisogni particolari, come provvedere zitelle, che passavano a maritaggio, di sacconi, di lenzuola e rilasciando pure li diritti della curia a taluni poveri con fedi di povertà fatte da’ parrochi».
L’agire del santo napoletano, il simpatico santo, — come lo chiamava Benedetto Croce — diventa motivo di gioia e gratitudine nel ribadire ciò che Papa Francesco si sforza di dirci con la sua vita: ovvero che la santità non è qualcosa di astratto, essa o si incarna nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità, oppure diventa uno slogan zuccheroso che niente a che fare con la vita cristiana.
Padre Ernesto Balducci...il coraggio di costruire "ponti"

Ravasi: «Civiltà, Non muri ma ponti»
Gianfranco Ravasi
Passare dalla multiculturalità alla interculturalità è l'urgenza di questo tempo. Un'analisi del cardinale Ravasi ricordando padre Ernesto Balducci, che nel 1985 aveva già previsto gli odierni scenari
Ravasi: «Civiltà, Non muri ma ponti»
A un ponte aveva dedicato, fin nel titolo, il suo romanzo più celebre lo scrittore serbo-croato Ivo Andric, Nobel nel 1961: Il ponte sulla Drina s’intitolava appunto la sua opera più nota, pubblicata nel 1945 e tradotta in italiano nel 1960. È proprio da quel testo che vogliamo estrarre una deliziosa parabola musulmana messa in bocca al protagonista, il giovane Mehmed Ali, un cristiano deportato dai turchi e destinato a diventare vizir e a edificare quel ponte reale e simbolico al tempo stesso, luogo di incontro tra due etnie e religioni. Ascoltiamo il racconto che idealmente incarna il tema sul quale papa Francesco insiste quando invita ad abbattere i muri e a costruire i ponti.
«Ecco come venne eretto il primo ponte del mondo. Quando Allah il potente ebbe creato questo mondo, la terra era piana e liscia come una bellissima padella di smalto. Ciò dispiaceva al demonio, che invidiava all’uomo quel dono di Dio. E mentre essa era ancora quale era uscita dalle mani divine, umida e molle come una scodella non cotta, egli si avvicinò di soppiatto e con le unghie graffiò il volto della terra di Dio quanto più profondamente poté. Così, come narra la storia, nacquero profondi fiumi e abissi che separano una regione dall’altra. [...] Si dispiacque Allah quando vide che cosa aveva fatto quel maledetto; ma poiché non poteva tornare all’opera che il demonio con le sue mani aveva contaminato, inviò i suoi angeli affinché aiutassero e confortassero gli uomini. Quando gli angeli si accorsero che gli sventurati uomini non potevano superare i burroni e gli abissi per svolgere le loro attività, al di sopra di quei punti spiegarono le loro ali e la gente cominciò a passare su di esse. Per questo la più grande buona azione è costruire un ponte» (cap. XVI).
Il contrasto tra i due simboli del ponte e del muro, valorizzato appunto da papa Francesco, è idealmente uno dei fili conduttori dell’opera di padre Ernesto Balducci che ha proprio nel suo noto saggio L’uomo planetario (1985) una sorta di discorso programmatico. L’oscillazione tra queste due metafore è costante nella realtà storica e ha la sua rappresentazione contemporanea nell’antitesi tra populismo/sovranismo/ nazionalismo (il muro) e l’interculturalità/dialogo (il ponte). Il primo polo, quello nazionalista/ etnocentrico, si aggrappa – oltre che alla paura nei confronti del diverso e dei rischi connessi, talora anche reali – alla convinzione del primato assoluto della propria civiltà, in una scala di gradazioni che giungono fino al deprezzamento di altre culture classificate come “primitive” o “barbare”. Lapidaria era già l’affermazione di Tito Livio nelle sue Storie: 'Guerra esiste e sempre esisterà tra i barbari e tutti i greci' (31,29). Questo atteggiamento è riproposto ai nostri giorni sotto la formula dello “scontro di civiltà”, codificata nell’ormai famoso saggio del 1996 del politologo Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. In questo testo erano elencate otto culture (occidentale, confuciana, giapponese, islamica, hindu, slavo-ortodossa, latino-americana e africana), enfatizzandone le differenze, così da far scattare nell’Occidente un segnale d’allarme per l’autodifesa del proprio tesoro di valori, assediato da modelli alternativi e dalle «sfide delle società non-occidentali».
Certo è che, se si adotta in assoluto il paradigma dello “scontro delle civiltà”, si entra nella spirale di una guerra infinita, come già aveva intuito Tito Livio. Ai nostri giorni tale modello ha fortuna in alcuni ambienti, soprattutto quando si affronta il rapporto tra Occidente e Islam o quello tra paesi europei e persone migranti e rifugiate, e può essere adattato a manifesto teorico per giustificare operazioni politico- militari di “prevenzione” o di “esportazione” di valori come la democrazia. Questo modello è alla base del sovranismo e dei populismi, mentre in passato avallava interventi di colonizzazione o colonialismo (già i Romani in questo erano maestri). Esso è esplicitamente e radicalmente incarnato nel fondamentalismo islamico che ha nel cosiddetto “Califfato” dell’Isis la sua espressione più emblematica. L’altro polo, l’unico più autenticamente religioso e umanistico, è invece quello dell’interculturalità, una categoria dinamica che è un ben differente approccio rispetto alla cosiddetta “multiculturalità”. Quest’ultima, infatti, è una realtà statica di mera giustapposizione o coesistenza, come accade nei vari quartieri etnici di molte metropoli (si pensi a New York con “Little Italy”, “Chinatown”, il Bronx, il quartiere ebraico e così via). L’interculturalità, invece, si basa sul riconoscimento della diversità come una fioritura necessaria e preziosa della comune radice “umana”, un riconoscimento che si compie senza però perdere la propria specificità.
In questa linea si propone l’attenzione, lo studio, il dialogo con civiltà prima ignorate o remote, ma che ora si affacciano prepotentemente su una ribalta culturale finora occupata dall’Occidente (si pensi, oltre all’Islam, all’India e alla Cina), un affacciarsi che è favorito non solo dall’attuale globalizzazione, ma anche dai nuovi mezzi di comunicazione capaci di varcare ogni frontiera (la rete informatica ne è il simbolo capitale). Queste culture, finora estranee all’Occidente, esigono un’interlocuzione, spesso imposta dalla loro presenza imperiosa, tant’è vero che ormai si tende a parlare non solo di globalizzazione ma anche di “glocalizzazione” come nuovo fenomeno di interazione planetaria. Si deve, dunque, proporre un impegno complesso di confronto e di dialogo, di interscambio culturale e spirituale; si deve creare non un duello bensì un duetto ove le voci possono essere molto differenti (come, ad esempio, accade in musica tra basso e soprano) ma creano armonia.
È questo lo spirito di base della fede cristiana. Certo, l’Incarnazione testimonia che la Parola di Dio si è innestata nella lentezza e opacità della storia, come spesso emerge in molte pagine dell’Antico Testamento ove appaiono forme integralistiche e etnocentriche di stampo sacrale e marziale. Tuttavia non mancano già in quelle pagine larghi squarci luminosi di un universalismo che riconosce una qualità “adamica” prima che “israelitica” in ogni creatura (si leggano molte pagine profetiche di grande respiro, vari scritti sapienziali e lo stesso libretto di Giona). Il vertice sarà raggiunto nel cristianesimo con l’affermazione paolina secondo la quale in Cristo «non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Galati 3,28). È, questo, un discorso molto ampio che esige una specifica ermeneutica testuale ma che comprende anche affermazioni impressionanti già nella Torah biblica, come queste due norme che sarebbero da ricordare costantemente a certi movimenti populisti sedicenti difensori della civiltà ebraico-cristiana: «Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che soggiorna in mezzo a voi» (Esodo 12,49); «Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Levitico 19,33-34).
In una sua conferenza in occasione del centenario della scoperta delle Americhe padre Balducci per contrasto dichiarava: «Quando Colombo, all’alba del 12 ottobre 1492, incontrò i primi indigeni nella piccola isola dei Caraibi, da lui battezzata San Salvador, questo avvenne: l’uomo incontrò se stesso e non si riconobbe». In questa linea la testimonianza di padre Ernesto fu continua, con tutta la carica della sua passione, nella convinzione, come dice il titolo di uno dei suoi ultimi libri, che siamo tutti sul Pianeta Terra, casa comune (1991). Evocando uno degli eventi più tragici e infami del secolo scorso, egli ritrovava un altro simbolo per rappresentare questa fede universale nell’amore e nella vita: «“Una libellula rossa è passata davanti a me. Mi sono alzata col cappello in mano per prenderla quando...”. Così scrisse un’allieva di un collegio, sopravvissuta all’eccidio di Hiroshima. La mano infantile tesa verso una libellula nell’attimo dell’apocalisse è come un simbolo dell’amore dell’uomo per tutto ciò che narra il Poema della vita». Non ci resta, allora, che concludere lasciando ancora la parola a padre Balducci con questo bel Decalogo estratto dalle sue molteplici pagine, spesso segnate dal fuoco dello spirito profetico: «1. Non rassegnarsi ma lottare. 2. Non odiare ma amare. 3. Non reprimere lo sdegno ma esprimerlo in forza costruttiva e servizio. 4. Non calcolare ma rischiare. 5. Non servire i potenti ma i deboli. 6. Non cedere ma credere. 7. Non ripetere ma pensare. 8. Non restare soli ma pregare. 9. Non intristire ma godere l’amicizia. 10. Non chiudere i confini ma aprire gli spazi dello spirito».

Balducci, Turoldo, Milani: la fedeltà scomoda di quei preti di frontiera
Emma Fattorini
La rivista “Testimonianze” associa queste figure diversissime, unite da una fede vera e dalla difesa del Concilio Vaticano II quando occorreva coraggio per farlo.
Caro direttore,
«Balducci, Turoldo, Milani. Preti di “frontiera”», la rivista “Testimonianze” associa queste figure diversissime, unite da una fede vera e dalla difesa del Concilio Vaticano II quando occorreva coraggio per farlo e, insieme, dalla fermissima convinzione che mai avrebbero abbandonato la Chiesa, a costo di ogni forma di emarginazione.
Di don Milani si è parlato molto in questi mesi, in occasione dell’anniversario. Si sono scritte biografie, lo si è additato come modello educativo, con il rischio di una lettura sociologica-pedagogica, che è quanto di più riduttivo e deformante si possa pensare di questa figura davvero straordinaria. Se devo ricordare il contributo più ricco di don Milani, allora come oggi, lo vedo tutto in quella lettera a Pipetta ignorata dai più nel revival, pur generoso della sua figura. A Pipetta, un compagno comunista don Lorenzo scrive che quando dopo avere lottato insieme per la giustizia sociale fossero giunti davanti al cancello della grande villa del padrone e, insieme, l’avessero abbattuto, ecco in quel momento lui l’avrebbe salutato e sarebbe tornato dal suo Signore. Non solo perché la giustizia sociale non esaurisce certo la ragione dell’impegno cristiano nel mondo, ma perché soprattutto non può accontentarsi mai di nessun “ idolo”.
Questo spessore formò in profondità le nostre coscienze giovanili nella scelta per gli ultimi. “Esperienze pastorali”, “L’obbedienza non è più una virtù” e la mitica “Lettera ad una professoressa”, superarono fin da subito i confini del cattolicesimo fiorentino, laboratorio di dialogo, per diventare riferimenti imprescindibili di noi giovani appassionati del Concilio che venivamo formando circoli e gruppi spontanei in ogni regione d’Italia. Tra i tanti insegnamenti ne ricordo uno che resta ancora vivo oggi. L’elogio della disobbedienza proponeva l’obiezione di coscienza in una cultura dalle tinte fortemente autoritarie: resta oggi questo appello come principio a non conformarsi ai più accattivanti richiami di un “pensiero corretto” che in nome della libertà non rispetta più i limiti.
Padre Turoldo, è, invece la figura forse meno legata a quella stagione: mistico, poeta permeabile alle emozioni. Molto bello il ricordo di Fioretta Mazzei al suo “Non abbiamo più vino”, che dipinge la giocosità di questo corpo grande, presente, un gigante buono, impulsivo. Una sensibilità vicina al sentire femminile così poco valorizzata in quegli anni. E di lui che cosa è vivo? La dimensione interiore, il bisogno di tornare a un più profondo rapporto con se stessi, sentita come una necessità di tutti, ormai storditi da un mondo esterno fagocitante e impoverente: il bisogno di spiritualità non come “privilegio” di un anima mistica e contemplativa, ma come la postura essenziale per tutti.
Infine, vengo a padre Balducci che ho conosciuto bene, che mi volle nella redazione della rivista “Testimonianze”: «prima donna!» , si meravigliavano, congratulandosi, i redattori maschi. Vigeva una cultura molto diffidente verso le donne, alla quale neppure Balducci sfuggiva, ma con la quale si misurava senza retorica, con autenticità e che un po’ alla volta si piegava, con sempre più coraggio. Convegni sul tema degli anticoncezionali, dell’aborto e del divorzio, della donna nella Chiesa, si susseguivano tra tormenti e riflessioni. Erano gli anni Settanta e nella sede di via Gino Capponi si riunivano i “cattolici comunisti”, La Valle, Gozzini, Meucci, e discutevamo di laicità e politica, di fedeltà alla Chiesa: stare nel modo senza essere del mondo, si misurava con i tormenti e le titubanze del “nostro” papa Paolo VI. E del fluido oratore del monte Amiata che cosa è vivo? Le sue ultime riflessioni sull’uomo planetario, anticipavano l’avvento di quella globalizzazione che portava grandi opportunità e pesanti solitudini. E con quel rovello, girava per l’Italia a presentare il suo libro. Solo, alla guida della sua utilitaria, morì in un incidente stradale vicino a Cesena. Era un’estate calda in Romagna e io ero immersa nel frastuono della riviera quando mi raggiunse la notizia. Mi precipitai all’ospedale di Cesena. Era solo, coperto da un telo bianco che lasciava scoperto quel viso forte. Lo vegliai fino a quando non vennero i suoi “fiorentini”.
Sant'Ignazio di Loyola..."l'ardire di percorrere nuove vie confidando in Dio"


Fiducia e coraggio in Sant'Ignazio
a cura di Roland Muller
Cosa ha da dire sant’Ignazio di Loyola ai credenti dei nostri giorni?
La vita di Ignazio può insegnarci soprattutto due cose: la prima è la grande capacità di cambiare se stesso e la sua vita in modo del tutto inatteso. Sant’Ignazio non si aggrappò spasmodicamente al suo progetto di una vita di successo, ma si lasciò guidare da eventi imprevedibili, come la ferita nella battaglia di Pamplona o il fallimento del suo intento di vivere in Terra Santa, tanto desiderato.
Non si lasciò scoraggiare dai contrattempi e percorse nuove vie. Ebbe in questo fiducia nello Spirito Santo e alla fine fondò i gesuiti. Ignazio ha avuto l’ardire di lasciarsi cambiare confidando in Dio.
– E qual è il secondo punto importante della vita di sant’Ignazio?
Il profondo incontro personale con Cristo. Questo è stato il centro della sua vita ed è anche il centro dell’ordine dei gesuiti e di tutta la Chiesa, ieri e oggi. Come cristiani, siamo chiamati a mettere Cristo al centro della nostra vita, dei nostri sentimenti e delle nostre motivazioni. Ciò fu estremamente importante per Ignazio nella fondazione della Compagnia di Gesù.
Ecco perché noi come ordine ci siamo proposti in questo anno giubilare ignaziano di porre sempre più l’orientamento a Cristo al centro della nostra missione. Di qui il motto di quest’anno: “Vedere tutto nuovamente in Cristo”. Questa inconsueta prospettiva è un arricchimento per il mondo d’oggi.
Ma la gente di oggi ha bisogno di questo nuovo sguardo di Ignazio per lasciarsi cambiare da ciò che non è abituale?
Assolutamente, perché Ignazio ha esperimentato che Dio era all’opera nella sua vita. Il Concilio Vaticano II ha attribuito ai cosiddetti “segni dei tempi” un significato particolare per la Chiesa. Questo è esattamente ciò che anche Ignazio ha imparato: Dio parla nel presente alle persone, alla Chiesa, e invia loro dei segni per il cammino su cui li invita.
Di fronte allo stato attuale della Chiesa, è particolarmente importante saper leggere i segni dei tempi. Fa parte di ciò anche la capacità di discernimento per riconoscere quali segni provengono realmente da Dio e quali hanno origine da altre fonti, come le ideologie o le idee politiche.

Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote, fondatore della
Compagnia di Gesù
nascita nel 1491, morte il 31 luglio 1556
San Ignazio di Loyola nacque nel 1491 ad Azpeitia, nei Paesi Baschi. Essendo un figlio cadetto, era destinato alla vita sacerdotale, ma la sua aspirazione era quella di diventare cavaliere. Suo padre lo inviò perciò in Castiglia, alla corte di don Juan Velazquez de Cuellar, ministro del re Ferdinando il Cattolico. La vita di corte formò il carattere e le maniere del giovane, che prese a leggere i poemi e a corteggiare le dame. Alla morte di don Juan, Íñigo si trasferì alla corte di don Antonio Manrique, duca di Najera e viceré di Navarra, e al suo seguito partecipò alla difesa del castello di Pamplona, assediato dai francesi. Qui, il 20 maggio del 1521, fu ferito da una palla di cannone che lo rese zoppo per tutta la vita. La lunga convalescenza fu per lui l’occasione di leggere la Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine e la Vita di Cristo di Lodolfo Cartusiano, testi che influirono enormemente sulla sua personalità votata agli ideali cavallereschi, convincendolo che l’unico Signore che valeva la pena di seguire era Gesù Cristo.
Un pellegrinaggio provvidenziale
Deciso a recarsi in pellegrinaggio in Terra Santa, Íñigo fece tappa al santuario di Montserrat, dove fece voto di castità e scambiò le sue ricche vesti con quelle di un mendicante. Barcellona, da dove avrebbe dovuto imbarcarsi per l’Italia, era in preda ad una epidemia di peste, e Íñigo dovette fermarsi a Manresa. Questa tappa obbligata lo costrinse ad un lungo periodo di meditazione e di isolamento, durante il quale scrisse una serie di consigli e riflessioni che, rielaborati in seguito, formarono la base degli Esercizi Spirituali. Giunse finalmente in Terra Santa e avrebbe voluto stabilirvisi, ma il superiore dei Francescani glielo impedì, giudicando troppo povere le sue conoscenze teologiche. Inigo tornò quindi in Europa e intraprese gli studi di grammatica, filosofia e teologia, prima a Salamanca e poi a Parigi. Fu proprio nella capitale francese che cambiò il suo nome in Ignazio, in omaggio al Santo di Antiochia di cui ammirava l’amore per Cristo e l’obbedienza alla Chiesa, che sarebbero poi divenuti caratteri fondanti della Compagnia di Gesù. A Parigi Ignazio conobbe quelli che sarebbero divenuti i suoi primi compagni, fece con loro voto di povertà e progettò di recarsi nuovamente in Terra Santa, ma questo progetto sfumò a causa della guerra tra Venezia e i Turchi. Ignazio e i suoi compagni si presentarono perciò al Papa per obbedire ai suoi ordini. Il Papa disse loro: “Perché andare a Gerusalemme? Per portare frutto nella Chiesa, l’Italia è una buona Gerusalemme".
La Compagnia di Gesù
Papa Paolo III nel 1538 diede l’approvazione canonica alla Compagnia di Gesù che fu da subito animata da zelo missionario: i Preti Pellegrini, o Riformati (solo in seguito assunsero il nome di Gesuiti) vennero inviati in tutta Europa, e poi in Asia e nel resto del mondo, portando ovunque il loro carisma di povertà, carità e obbedienza assoluta alla volontà del Papa. Uno dei principali problemi che Ignazio si trovò ad affrontare fu la preparazione culturale e teologica dei giovani: per questa ragione formò un corpo di docenti e fondò diversi collegi che negli anni acquistarono una fama internazionale grazie all’altissimo livello scientifico e ad un programma di studi che venne preso a modello anche da Istituti scolastici non religiosi.
Roma
Per obbedienza al Papa, Ignazio rimase a Roma a coordinare le attività della Compagnia e ad occuparsi dei poveri, degli orfani e degli ammalati, tanto da meritare l’appellativo di “apostolo di Roma”. Non dormiva che quattro ore a notte, e continuò il suo lavoro e il suo impegno, nonostante le sofferenze procurategli da una cirrosi epatica e da una calcolosi biliare, fino allo stremo delle forze. Morì nella sua povera cella il 31 luglio del 1556, e le sue spoglie sono conservate nell’altare del braccio sinistro del transetto della Chiesa del Gesù di Roma, uno dei monumenti più belli del Barocco romano.
Georges Bernanos..."tutto è grazia"


La fede è gioia, non noia.
Chi era Georges Bernanos
Daniele Barale
Ritratto del grande scrittore cattolico francese, autore del "Diario di un curato di campagna", a 75 anni dalla sua morte
È stato tra i più grandi scrittori del Novecento francese, che ha avuto al centro della sua opera l’Eterno, cioè Dio. Pensiamo a Paul Claudel, Charles Péguy, François Mauriac. Non stupisce che la Francia figlia della rivoluzione abbia fornito alla letteratura mondiale alcuni dei suoi volti più importanti, e che questi fossero cattolici; giacché dove dilaga il male, la grazia sovrabbonda.
Aveva anche partecipato, al pari di altri scrittori cattolici, come Péguy e Tolkien, alla prima guerra mondiale, meritando una decorazione. Da giovane era stato membro dei camelots du roi dell’Action française di Charles Maurras; e durante la guerra civile spagnola (1936-1939) aveva partecipato a un’operazione, poi fallita, per ristabilire la monarchia in Portogallo. Una vita avventurosa, ma sempre con lo sguardo rivolto al Cielo. Sì, Bernanos non era un semplice scrittore da Académie française, o un conservatore e polemista. Era soprattutto un cattolico (e per certi versi ricorda il “nostro” Guareschi) impegnato a combattere per quei princìpi plurisecolari che danno libertà e dignità all’uomo, e che la Chiesa custodisce.
Destra e sinistra
Lo scrivere costituiva per lui un apostolato al servizio della verità:
«Scrivo come soffro e come spero. […] Io credo solo a ciò che mi dà pena […] No, non sono uno scrittore. La sola vista di un foglio di carta bianca mi disanima. Lo speciale raccoglimento fisico imposto da un tavolo di lavoro m’è così odioso che l’evito sinché posso […] Scrivo sui tavoli di caffè, perché non saprei per molto fare a meno del viso e della voce umana […] per non cader vittima di immaginarie creazioni, e per riacquistare con uno sguardo gettato sullo sconosciuto che passa la giusta misura della gioia e del dolore».
E ciò riflette alcuni dei suoi talenti: saper scuotere l’intelligenza e l’anima del lettore (anche non credente), provocando la nostalgia del Cielo; seguire la marcia caotica del mondo moderno, allo scopo di smascherarne «le ingiustizie accuratamente “nascoste sotto l’erba”»; ed essere “popolare”. Nel senso di avere un’idea “alta” di popolo, oltre gli astraenti aggettivi “destra” e “sinistra”:
«Esiste una borghesia di sinistra e una borghesia di destra. Non c’è invece un popolo di sinistra e un popolo di destra, c’è un popolo solo. L’idea che io mi faccio del popolo non è per nulla ispirata da un sentimento democratico. La democrazia è un’invenzione degli intellettuali, mentre il popolo esige il lavoro, il pane, e un onore che gli sia affine, che assomigli al suo lavoro e al suo pane […]. La società moderna lascia distruggere lentamente, in fondo alla propria cantina, una meravigliosa creazione della natura e della storia […]: È il popolo che dà a ogni patria il suo carattere originale. […] Per gli immensi cimiteri di domani non occorrerà alcuna giustificazione. Appiccherebbero il fuoco all’umanità per un colpo di Borsa, senza curarsi un istante di sapere come spegnerlo. Nulla sanno dell’uomo che, tra loro, definiscono una macchina per perdere o guadagnare soldi».
Citazione che proviene dal suo I grandi cimiteri sotto la luna, il più celebre atto d’accusa sulla guerra civile spagnola e sul franchismo.
Non vedere la verità
Le opere bernanosiane forniscono altresì un prezioso aiuto nel comprendere le cause e gli effetti del nichilismo come fenomeno di massa (anticipò il “partito radicale di massa” di cui parlò Del Noce negli anni ’70-’80) e della secolarizzazione, che da secoli sfalda quel che resta della societas christiana.
Come scrisse il critico letterario Albert Béguin:
«Ogni romanzo di Bernanos, più che il romanzo d’un prete, la storia di una parrocchia, è, in certo modo, l’immagine ridotta ma completa, del mondo che una volta è stato cristiano. Ciò che vi scopre nell’angoscia e nella goffaggine, nei problemi di coscienza e nell’impostura, con la certezza della Fede e la coraggiosa predicazione, il prete bernanosiano è sempre uno spirituale in un mondo che se ne infischia dello spirito o che, tutt’al più, consente al soprannaturale di svolgere un suo limitato ruolo».
Alcuni dei suoi libri più celebri sono Sotto il sole di satana (1926), considerato l’opera di esordio è che anticipa il più famoso Diario di un curato di campagna. Il protagonista, qui, è l’abate Donissan, che è ossessionato dall’eterno conflitto tra il “bene e il male” e dalla paura del fallimento della sua missione. Donissan è un povero prete di campagna, di poca cultura, ma toccato dalla Grazia di Dio che opera in maniera imperscrutabile.
La Francia contro la civiltà degli automi, un testo profetico (scritto nel ’47), dove l’autore riflette su tecnica, libertà e verità:
«La grande disgrazia del mondo non è di mancare di Verità; le verità ci sono sempre, il mondo ne ha sempre lo stesso cumulo, disgraziatamente non sa più servirsene o, per meglio dire, egli non le vede. Non vede nemmeno le più semplici, quelle che lo salverebbero. Non sa vederle, perché ha chiuso davanti a loro non la sua ragione, ma il suo cuore».
Fanatismo e fede
Dialoghi delle Carmelitane, capolavoro teatrale scritto nel 1949, che presenta molti aspetti drammaturgici interessanti. Esso racconta la pena della ghigliottina inflitta nel 1794 alle sedici monache del monastero carmelitano di Compiègne guidate da madre Thérèse de Saint-Augustin; condannate perché accusate, ingiustamente, di fanatismo dai giacobini (loro sì che lo erano: “i più puri che epurano”).
Udita la sentenza una delle suore, nella sua semplicità, chiederà: «Signor Giudice, per piacere, cosa vuol dire fanatismo?». E il giudice: «È la vostra sciocca appartenenza alla religione». «Oh sorelle – dice allora la suora – avete sentito ci condannano per il nostro attaccamento alla fede. Che felicità morire per Cristo Gesù». Nel 1960 ne fu fatta una trasposizione cinematografica, a opera di Raymond Leopold Bruckberger e Philippe Agostini.
Non miele ma sale
E, ora, è la volta del libro che rese più celebre Bernanos. Diario di un curato di campagna (1936), che venne anch’esso adattato al cinema, grazie alla direzione di Robert Bresson; film che ispirò Luci d’inverno di Ingmar Bergman. Lo scrittore Guido Piovene lo definì «il più bel libro della letteratura francese della generazione dopo Gide». In questa storia, che è un sano “corpo a corpo fra il soprannaturale e il mondo”, Bernanos ci mette in guardia, fin dalle prima pagine, da un grave male diffusosi, come un cancro, nelle comunità cattoliche del Novecento (e ancora oggi lo è): la noia, che è tra le cause dell’indifferentismo e del relativismo.
Il protagonista, il parroco di Ambricourt, è una sorta di Curato d’Ars, giacché dotato di grande fede e zelo apostolico, senza una sterile erudizione, quale ricordano queste sue parole, scotenti anima e intelligenza del lettore: «Una cristianità non si nutre di marmellata più di quanto se ne nutra un uomo. Il buon Dio non ha scritto che noi fossimo il miele della terra, ragazzo mio, ma il sale. Ora, il nostro povero mondo rassomiglia al vecchio padre Giobbe, pieno di piaghe e di ulcere, sul suo letame. Il sale, su una pelle a vivo, è una cosa che brucia. Ma le impedisce anche di marcire». Ma san Giovanni Maria Vianney non è l’unico santo che si incontra nel suo personaggio; vi è anche santa Teresa di Lisieux, come ricorda quel «Che cosa importa? Tutto è Grazia», con cui si conclude il romanzo.
Lo scrittore Charles du Bos, tra i grandi convertiti al cattolicesimo di Francia, ebbe a dire:
«Da più di tre mesi già nell’interminabile tunnel dal quale dovevo uscire più tardi scrivendo La sofferenza fisica, in un momento in cui salvo qualche versetto del Libro di Giobbe non potevo sopportare nulla, lessi il Diario di un curato di campagna e per mesi le insuperabili parole furono il mio solo viatico […]».
Insomma, Bernanos è sempre più attuale ed è una sorta di “pietra di inciampo” nello stile dei profeti: ecco perché non si può definire meramente quale scrittore, polemista e conservatore.

Giù le mani da Bernanos
Daniele Zappalà
Come tesori messi ancor più in risalto dalla bassa marea, le intuizioni e le pagine di Georges Bernanos brillano in questi mesi in una Francia in preda a tanti dubbi e in cerca di riferimenti d’avvenire. Fra gli appassionati di lirica, aveva lasciato una scia d’entusiasmo un recente adattamento dei Dialoghi delle Carmelitane (musiche di Francis Poulenc) dovuto al regista Olivier Py, ovvero il direttore del Festival di Avignone. Adesso, è l’uscita dopo oltre mezzo secolo di una prestigiosa riedizione rivista delle opere romanzesche bernanosiane complete, in due tomi della collezione Pléiade (Gallimard), a suscitare un turbine d’iniziative attorno allo scrittore nato nel 1888 e scomparso nel 1948. Fra queste, un convegno il mese scorso al Collegio dei Bernardini, il centro culturale voluto dal cardinale Jean-Marie Lustiger. Come scrisse François Mauriac, Bernanos aveva il dono di «rendere naturale il sovrannaturale »: una forza di scrittura che, secondo critici letterari come Claire Daudin, continua ad afferrare per il collo e a stendere al tappeto i lettori contemporanei. Tanto più quelli che hanno avvertito le odierne insidie di una certa desertificazione spirituale, talora apertamente promossa oltralpe. Poco importa se lo stile non di rado elevato dell’autore ha potuto contribuire in passato a fabbricare l’immagine di uno 'scrittore difficile'. Sul mistero dell’ispirazione bernanosiana, molto si è scritto. Ma in una Francia dove non sono mancate pure le tentazioni di affibbiare a ogni costo un’etichetta politica a Bernanos, di volta in volta 'conservatrice' o 'progressista', secondo il periodo considerato della parabola creatrice e dell’impegno pubblico, appare ormai chiaro a molti che le opere dello scrittore superano ogni steccato convenzionale della vita in società nel Vecchio Continente. Senza potersi certamente definire un osservatore neutro e tanto meno distaccato, ne è pienamente convinto anche Yves Bernanos, il nipote dello scrittore. Un regista che negli anni passati ha risposto colpo su colpo a certi tentativi dei partiti transalpini di 'orientare' abusivamente il senso del messaggio di colui che amò così tanto «correre il rischio della speranza». «L’eredità che ci ha lasciato è prima di tutto quella di un uomo libero, capace di assumere posizioni forti e di prendere rischi», ci dice appunto Yves Bernanos, a due passi dalla cattedrale di Notre Dame, davanti alla quale non è stato allestito quest’anno l’usuale albero di Natale, dopo la spirale d’orrore del mese scorso. «Ci ha mostrato la via della libertà dello spirito, quella di un creatore che a livello tematico ha osato introdurre ciò che molti oggi chiamano romanzo sacerdotale». Ma per Bernanos, si può parlare davvero di attualità? In effetti, la parola rimbalza da un convegno all’altro. A ragione, secondo il nipote: «In proposito, la prima opera che mi viene in mente è La Francia contro i robot, pamphlet pubblicato nel 1946. Bernanos vi prefigura molti aspetti divenuti oggi realtà: la società delle macchine e del consumo di massa. Per lui, l’uomo che si definisce come consumatore è destinato a rinnegare una dopo l’altra le proprie libertà. Quando osserviamo certe forme di disumanizzazione odierne, quelle pagine possono apparire quasi profetiche. Da un decennio all’altro, la forza di quest’opera continua a crescere ». Il regista ammette di aver masticato a lungo fin dall’adolescenza le pagine scritte dal nonno. «Ho adattato una novella sulla menzogna, Madame Dargent, scritta nel 1922. In questa corta narrazione di un’agonia, sono prefigurati e concentrati tutti i temi di Bernanos. E sto lavorando a un film biografico su un prete parigino che mi è sempre sembrato molto bernanosiano. Del resto, aveva amato fin dall’infanzia i preti bernanosiani. Poi ha ricreato ciò in vita ». Sostenuto dalla diocesi di Parigi, il film per la televisione, scritto con l’italiana Roberta Collu, uscirà nel 2016. Nella memoria tramandata all’interno della famiglia Bernanos, restano custodite alcune chiavi forse utili per capire il percorso del grande scrittore: «Aveva un’unità profonda d’uomo e di cristiano, una fedeltà allo spirito e all’immaginario dell’infanzia, ma anche la capacità di evolvere di continuo con il proprio tempo, senza irrigidirsi o sprofondare in forme di nostalgia. Sul piano spirituale, la sua libertà era tesa verso una ricerca continua della verità. Al di là dei proclami sulla libertà che caratterizzano generalmente molti discorsi pubblici in Francia, era capace d’incarnare questa libertà in ogni atto». Nel tempo, sul filo degli aneddoti evocati in famiglia, il regista è giunto a una conclusione precisa: «La fede e l’umanità formavano in lui un tutt’uno, come mostrano le amicizie che coltivò, spesso pure fra non credenti e personalità con ideali contrari ai suoi». Al nipote, anche come addetto ai lavori, piace evocare 'i due capolavori' cinematografici di Robert Bresson che hanno contribuito a loro volta alla fama dell’opera bernanosiana: Diario di un curato di campagna (1950), Mouchette. Tutta la vita in una notte (1967). In gran parte in esilio, Bernanos scrisse febbrilmente romanzi solo per un decennio, ricorda la presentazione della Pléiade, sottolineando i ruoli della malignità e della grazia all’interno di questi scritti «violenti, notturni, splendidi».
Pablo Neruda...poeta del sogno reale

Neruda e Dio: dalla donna all’amore per i poveri
In occasione della sua nascita a luglio ( 12 luglio 1904)
Il senso del divino nell’opera di Neruda – citerò i titoli delle poesie di Neruda seguiti dalle iniziali dell’opera in cui sono contenute: C (Crepuscolario), CG (Canto generale), FE (Il fromboliere entusiasta), FI (Il fiume invisibile), MIN (Memoriale di Isla Negra), VC (I versi del Capitano), VP (Venti poesie d’amore e una canzone disperata) – emerge specialmente nell’ambito della sua relazione con la donna. È lei la mediazione più importante perché la sete d’infinito affiori: «E lei saprà saziar la sete mia divina» (Laus Deo, FI). Neruda non esita a paragonare la presenza di lei nel proprio intimo a quella di Dio che abita l’acqua che scorre: «Per sentirti nelle mie vene come Dio nei fiumi» (Amore, C).
Non è raro che il suo linguaggio amoroso acquisti tonalità liturgiche, o sembri riferirsi a un progetto trascendente, preesistente, che dà senso alle esperienze più profonde della vita:
E quando t’affacci
tutti i fiumi risuonano
nel mio corpo, scuotono
il cielo le campane,
e un inno empie il mondo.
(La regina, VC)
Forse il tuo sogno
si separò dal mio
e per il mare oscuro
mi cercava,
come prima,
quando ancora non esistevi,
quando senza scorgerti
navigai al tuo fi anco
e i tuoi occhi cercavano
ciò che ora
– pane, vino, amore e collera –
ti do a mani piene,
perché tu sei la coppa
che attendeva i doni della mia vita.
(La notte nell’isola, VC)

TRA CRAVATTA E CUORE
Gianfranco Ravasi
Matilde, dove sei? Notai, verso il basso/ tra cravatta e cuore, in alto,/ certa malinconia intercostale:/ era che d'improvviso eri assente./ Mi mancava la luce della tua energia/ e guardai divorando la speranza,/ guardai come è vuota senza te una casa,/ non restano che tragiche finestre. Tanti anni fa incontrai sul treno una ragazza che stava leggendo un libro di poesie di Pablo Neruda, poeta cileno morto nel 1973, allora molto amato dai giovani. Cominciammo a parlare e lei mi rivelò l'amarezza che l'attanagliava perché il suo fidanzato l'aveva lasciata. Certo, era una delle infinite vicende analoghe che generano dolore e fanno versare lacrime. È il vuoto dell'assenza che provoca
- come dice il poeta - una «malinconia intercostale». A distanza di più di trent'anni, divenuta ormai sposa e madre, quella donna ha voluto di nuovo incontrarmi e mi ha ricordato proprio la pagina di Neruda che allora stava leggendo e che ho sopra citato, pagina in lei rimasta impressa perché segno di un terrore superato. Sì, nella vita bisogna aver accanto una presenza, possedere "la luce dell'energia" che l'altro ti dona. Altrimenti la casa, anche se elegante, è gelida e incolore; ci si appoggia con la fronte al vetro freddo della finestra attendendo un ritorno che forse non avverrà. E dentro il petto, «tra cravatta e cuore», si sente quella «malinconia», segno di un'infelicità. «Non è bene che l'uomo sia solo" Guai all'uomo solo», si legge nella Bibbia. Non è di scena solo la coppia nuziale, ma è coinvolta ogni relazione interpersonale: essa ci è necessaria come l'aria che respiriamo e come la luce che ci avvolge, perché noi siamo stati creati per la comunione e l'amore.

A poco più di 50 dalla morte.
Il nipote Reyes: «Neruda, un uomo di famiglia»
Elisa Roncalli e Marco Roncalli
Il 23 settembre 1973, pochi giorni dopo il golpe di Pinochet e la morte di Allende, in una clinica di Santiago del Cile, moriva a sessantanove anni Ricardo Eliècer Neftalì Reyes Basoalto alias Pablo Neruda - poeta, diplomatico, attivista politico, fra i grandi autori del ‘900. Ne parliamo con Bernardo Reyes, settantadue anni, pronipote di Neruda, poeta anch’egli e curatore dei Cuadernos de Temuco (le prime poesie nerudiane, in parte inedite, apparse dopo la morte), ma soprattutto biografo del Nobel per la letteratura, del quale ha ricostruito vicende attraverso libri come Neruda: retrato de familia; El enigma de Malva Marina: la hija de Pablo Neruda; El guardaespaldas de Fidel.. .
Bernardo sgombriamo subito il campo: la sua parentela con Neruda?
«Mio nonno paterno, Rodolfo Reyes, era il fratello maggiore di Neruda. Non ebbe però il ruolo di primogenito perché nato da una relazione casuale di suo padre, don José del Carmen Reyes Morales, con Trinidad Candia Marvede, prima della nascita di Neruda. Mio nonno aveva 13 anni quando il bisnonno don José sposò in seconde nozze Trinidad, dopo che era morta, nel darlo alla luce, la madre di Neruda, Rosa Neftalí Basoalto Opazo. Trinidad, che per ipocriti pregiudizi non aveva allevato il primo figlio, quando arrivò Neruda si volse interamente a lui, che in seguito la chiamò “mamamadre”. Poi si unì una terza sorellastra: mia zia Laura Reyes Candia. In famiglia, insomma, ci fu un triangolo amoroso. Due madri appaiono registrate nella genealogia dei Reyes. E con le mie ricerche ne ho aggiunta una mai apparsa in documenti. Aurelia Tolrá, madre biologica di Laura Reyes. Un’atmosfera che aiuta a capire Neruda».
Che ricordi ha di lui?
«A casa dei miei era accolto come nella sua di Temuco. Inoltre era vicina a quella dov’era cresciuto. Era ricevuto con affetto dagli adulti e con curiosità dai più piccoli. Spesso allegro, qualche volta giocava con noi bambini che facevamo i fantasmi coprendoci di lenzuola. Nei ritorni dai viaggi trovava sempre tempo per noi. Crescendo rammento che con lui si parlava di tutto fuorché di letteratura, oggetto di scarsa predilezione in famiglia».
Cosa comporta per lei la sua figura?
«Bella domanda. Il 21 luglio scorso ho festeggiato con mia moglie Marycruz 50 anni di matrimonio. 50 anni fa, lo stesso giorno, ricevemmo un pacco da Isla Negra con un libro di pregio fuori commercio: 20 poesie d’amore, con una bellissima dedica del poeta, accompagnata da disegni del pittore Mario Toral, e firmata anche dalle mie zie, sua sorella Laura e Matilde Urrutia, la terza moglie. Nel pacco c’era pure l’invito a trascorrere insieme il capodanno a Valparaíso. Purtroppo poco dopo morì. E in clinica lo raggiunse l’eco di cosa accadeva nel Paese. Presto i militari controllarono anche le università. Marycruz, benché incinta, fu fatta uscire dall’ateneo sotto la minaccia di una mitragliatrice. Eravamo entrambi universitari. Abbiamo perso compagni e docenti. Essere parenti di Neruda per noi ha rappresentato la fine brutale di un modo di vivere segnato dalla nostra tranquillità provinciale a Temuco, che ha lasciato spazio a una scia di torturati, morti, scomparsi».
Restiamo a 50 anni fa quando la morte di Neruda quasi coincise con la fine del Cile democratico: cosa ricorda?
«Sì, il suo funerale fu trasformato nel primo atto della resistenza cilena. Da Temuco, la nostra città, tremendamente di destra, assistemmo improvvisamente alla scomparsa di ogni genere e rifornimento… Ma bisogna ricordare in proposito i documenti della Cia, in cui si afferma chiaramente che Nixon prima aveva finanziato lo sciopero dei camionisti e senza loro nel nostro Paese, una striscia di terra lunga e stretta, niente aveva potuto circolare… Per non parlare di giornali come “El Mercurio” con le sue vergognose montature per distruggere il governo del presidente. Mio padre aveva una panetteria e un’impresa di lavorazione alimentare, spesso, con pretesti puerili, camionette cariche di soldati vi facevano irruzione mentre la gente lavorava. Era tutto assurdo. Solo i suoi nipoti Raúl e Lidia – i miei genitori – riuscirono a recarsi al funerale».
A proposito della morte, a intermittenza tornano le tesi dell’avvelenamento…
«Credo che il mio libro El guardaespaldas de Fidel abbia smantellato questo falso assassinio. Poche settimane fa poi è mancato anche questo presunto testimone di un omicidio immaginario…: Manuel Araya secondo me era un mitomane, ma è stato manovrato da altri al fine di stabilire quello che giuridicamente chiamano “ragionevole dubbio”. In realtà la questione è un po’ vergognosa anche per il Paese. Però dato che faccio parte della querelle, posso confermare, documenti alla mano, che uno degli ideatori del falso, Mario Casasus, morto l’anno scorso, mi ha chiesto perdono in forma scritta. E lo stesso ha fatto con il ministro Mario Carroza».
Nei suoi saggi ha apportato elementi per rileggere la vita di Neruda, pubblica, ma anche privata: penso al caso della figlia Malva, idrocefala, morta piccola, di fatto abbandonata, no? Secondo lei si conosce ormai tutto di Pablo Neruda?
«Vedete la storia di Malva è tragica, non c’è dubbio. Tuttavia, nel saggio che ho scritto su questa bambina, che alla fine è stata mia zia, penso di aver dimostrato che non fu proprio un abbandono. C’erano situazioni diverse e concrete, umane e politiche, e l’Europa dilaniata dalla guerra. Insomma una vicenda più complessa di come appare, con aspetti da chiarire. E scavando anche nella la vita della madre di Malva, la prima moglie di Neruda, María Antonia Hagenaar, che il presidente Gabriel González Videla, aveva fatto venire in Cile come testimone in un processo per un’accusa di bigamia contro Neruda, si scopre che era l’amante di un noto intellettuale cileno: non proprio una donna sola e abbandonata, ma una persona ben integrata, con una grande vita sociale. Dalle mie ricerche sono nati libri piuttosto romanzati a scapito della verità».
Volendo visitare il Cile, sulle orme di Neruda, quale itinerario consiglia per capirne lo spirito e quale libro bisognerebbe portare?
«Vi rispondo citando una frase che mi ha detto Dario Puccini, l’ispanista che ha tradotto quasi tutto Neruda in italiano. Stavamo insieme io e Marycruz, lui e sua moglie, Stefania Piccinato, a Puerto Saïl, poi a Puerto Saavedra, davanti all’Oceano Pacifico. Disse; “Qui c’è la radice di tutta la poesia di Neruda, appena torno in Italia dicò al mio amico Fellini di lavorarci sopra”. Lo ricordo perché il regista morì proprio poco dopo il suo ritorno. In questo senso credo che sarebbe essenziale avere nel bagaglio Confesso che ho vissuto».
E a suo giudizio qual è il capolavoro assoluto?
«Domanda difficile! Da un lato, c’è l’epica del Canto General, lascito importantissimo, ma non va dimenticata la grande poesia d’amore, nata a Temuco, a Puerto Saavedra. E aggiungo una cosa riferitami dal mio amico Giuseppe Bellini: lui teorizzava che 20 poesie d’amore e una parte di Residenza nella Terra fossero nate da un fortissimo impulso creativo. Tanti studiosi non concordano, ma, dopo decenni, credo avesse ragione. Il primo volume di quest’opera, del ’33, è un capolavoro: di Neruda e di tutta la letteratura contemporanea».
Per l’anniversario si vedono riedizioni di Neruda e nuovi saggi. Lei ha appena pubblicato Neruda:Memoria en imágenes, con fotografie e documenti sulla sua vita. Ci sarà un’edizione italiana?
«Presto uscirà una versione in inglese. Ci sono passaggi editoriali un po’ lunghi, e oggi in Europa non si fanno tirature troppo alte… Per la versione italiana servirebbe un bravo traduttore, disposto anche a farci pagare poco…»
Margherita Guidacci..."non c'è limite all'impossibile"

Non obbedire a chi ti dice di rinunziare all’impossibile!
L’impossibile solo rende possibile la vita dell’uomo.
Tu fai bene a inseguire il vento con un secchio.
Da te, e da te soltanto, si lascerà catturare.

La brezza della vita
Margherita Guidacci
La brezza dei boschetti di bambù/ penetra fresca nella stanza. Chiari/ raggi di luna nel cortile danzano./ Rade stelle scintillano; le lucciole/ si spostano nel buio, e presso il fiume/ s'alza il richiamo degli uccelli acquatici./ E meditando su una strana cosa:/ che tutto il mondo si affidi alla guerra,/ non alla pace - in dolorosa veglia/ io trascorro la notte. È stata una nostra fine poetessa, Margherita Guidacci (1921-1992), a tradurre nel volume La voce dell'acqua (ed. C.R.T., Pistoia 2002) i versi di uno dei maggiori poeti cinesi antichi, Tu Fu (VIII sec.), accorato interprete dei mali della guerra e dell'anelito di pace dell'umanità. È ciò che affiora nella poesia citata, immersa nella dolcezza morbida di una notte estiva, striata dalle luci delle stelle, dei raggi di luna, delle traiettorie delle lucciole. Il filo poetico diventa anche morale e sempre attuale: perché devastiamo con la guerra questa "aiuola" - come la chiama Dante - che è la terra? In tutti i secoli l'umanità ha profanato con le distruzioni il santuario del mondo, ha versato sangue sulle pietre, è riuscita a usare le energie stesse della natura per ferirla a morte (pensiamo alla bomba atomica). Anche nel nostro piccolo quante volte abbiamo mal custodito terreni e città sporcandoli, siamo stati crudeli con questa nostra sorella che è la natura attraverso le sue creature viventi vegetali e animali. Riscopriamo, allora, e rispettiamo l'armonia della nostra vita con quella, immensa, dell'universo in cui esistiamo e ci muoviamo.

Margherita Guidacci, poetessa dolcemente audace ed eversiva
Alberto Fraccacreta
La sua esperienza testimonia con forza il bisogno della vita. Ed è questa serietà specchiata che rende così audace, così dolcemente eversiva e attuale la lezione della poetessa
Margherita Guidacci è stata una delle poetesse più interessanti della sua generazione – e potremmo dire del nostro Novecento – ma soltanto negli ultimi anni l’attenzione critica verso la sua opera ha reso parziale giustizia a lei, che oggi compie il suo centesimo genetliaco. Nata il 25 aprile 1921 a Firenze, Margherita ha trascorso un’infanzia dickinsoniana: avide letture, molta introspezione, poche amicizie, una primissima adolescenza punteggiata di lutti con la prematura scomparsa del padre Antonio. Si avvicina alla poesia grazie al cugino (poeta in proprio) Nicola Lisi che, diciottenne, le mette in mano gli Ossi di seppia. Montale – assieme a Leopardi, Eliot, Rilke – segna il suo background letterario, orientandolo verso una linea espressiva di afflato metafisico, distesa e ragionata, dotata di “classicismo paradossale”, distante ugualmente dalle intuizioni orfiche e dal preziosismo della parola pura. Iscrittasi alla Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze, si laurea nel ’43 con un’ardita tesi su Ungaretti discussa con Giuseppe De Robertis.
Dopo qualche tempo, abbandona gli studi di letteratura italiana e incomincia a dedicarsi al versante angloamericanistico, avviando un imponente lavoro di traduzione spalmato su quattro decenni ( John Donne, William Blake, Elizabeth Bishop e altri). Ciò avviene per una ragione d’intenti che riguarda intrinsecamente la poetica: il suo fiuto la conduce sin dagli esordi a una callida iunctura, a un «accostamento drammatico di significati», lasciando in secondo piano le risonanze verbali, l’«accostamento magico di suoni». La Guidacci concepiva la poesia come istintività rabdomantica – e pare che lei avesse il “dono” –, la scossa elettrica dell’ispirazione ne doveva setacciare l’“acqua” (parola spesso ricorrente nei suoi versi), il flusso assoluto e cristallino del mistero essenziale.
Esordisce nel ’46 con La sabbia e l’Angelo ( Vallecchi 1946), una silloge egregia che nel titolo ha qualcosa di betocchiano e, al contempo, con un originale antiermetismo di fondo ci riporta alle terse atmosfere bibliche, alle modulazioni spiritualistico-cristiane della Firenze anni Quaranta («Il mondo è così diviso: in principio è la brezza; / e poi vi sono le cose che con voce o con gesto alla brezza rispondono; / e poi vi è anche la pietra crudele, che tronca il volo alla brezza»). D’altra parte, in un’intervista ha dichiarato di essersi «nutrita dell’Antico Testamento e in particolare i Salmi, l’Ecclesiaste, Giobbe ed i profeti, Geremia, Daniele ed Ezechiele». Per il severo timbro delle Scritture, unito a una sincera preoccupazione religiosa, si può accostare (senza sovrapporre) la Guidacci alla quasi coetanea e altrettanto notevole Cristina Campo. Al ’49 risale il suo matrimonio con il sociologo di origine sarda Luca Pinna da cui ebbe tre figli. Diviene insegnante di inglese nelle scuole secondarie, continuando parallelamente la sua attività di traduttrice e cementando la collaborazione con alcuni quotidiani.
I successivi testi poetici – Morte del riccio ( Vallecchi 1954), Giorno dei santi (Scheiwiller 1957), Paglia e polvere (Rebellato 1961) – approfondiscono la natura dicotomica che informa un po’ tutte le sue liriche: il nesso tempo-eterno, la lotta tra amore e morte, il ritorno al primigenio e alla nuda solidità degli elementi, persino il senso del dolore e della malattia (precipuamente in Neurosuite, Neri Pozza 1970), sempre filtrati da una dizione prosastica, comunicativa. Visivamente parlando, infatti, la poesia della Guidacci appare assai moderna e priva d’incrostazioni: i versi lunghissimi, whitmaniani – che non disdegnano talora un impulso civile – si sposano con una visione dell’esistenza prossima a conchiudersi nella più genuina preghiera («Dio mi ha chiamato ad arricchire il mondo / decretandone il semplice strumento: / basta un opaco granello di sabbia / e intorno il mio dolore iridescente!»). Nel ’76 è chiamata a insegnare Letteratura angloamericana all’Università di Macerata e passa poi nell’81 alla Lumsa di Roma.
Dal ’79, intanto, in collaborazione con Aleksandra Kurczab e Brenno Bucciarelli traduce tre opere letterarie di Giovanni Paolo II: Pietra di luce, Il sapore del pane e Giobbe ed altri inediti. Negli anni Ottanta si registrano ben otto sillogi, percorse da un misticismo che abbandona gli inquieti pudori delle prime raccolte per farsi sempre più universale: spiccano L’altare di Isenheim (Rusconi 1980), La Via Crucis dell’umanità (Città di Vita 1984), Il buio e lo splendore (Garzanti 1989) fino al postumo – Margherita morirà a Roma il 19 giugno 1992 – Anelli del tempo (Città di Vita 1993). A cura di Maura Del Serra è uscita lo scorso dicembre un’edizione aggiornata dell’intero corpus lirico, Le poesie (Le Lettere). Sara Lombardi, in un volume monografico dedicato all’autrice fiorentina, ha scritto che «in conformità con la sua formazione cattolica, la poesia per la Guidacci non sarà mai gioco letterario, ma esperienza estremamente seria». Niente di più vero. È questo bisogno di vita che la sua esperienza testimonia con forza. Ed è questa serietà specchiata che rende così audace, così dolcemente eversiva e attuale la lezione di Margherita Guidacci.
Ernest Hemingway... "il sole sorgerà ogni giorno"


Hemingway: un cattolicesimo devoto
Ron Hansen
Lo scrittore e giornalista americano Ernest Hemingway (1899-1961) è cresciuto nella fede congregazionista in un ricco sobborgo di Chicago. Al liceo, il suo talento per la scrittura lo portò a curare il giornale e l’annuario della scuola. Avrebbe dovuto frequentare l’Università dell’Illinois, ma abbandonò gli studi per unirsi al Kansas City Star come giornalista freelance.
Erano gli anni in cui la Grande Guerra infuriava in Europa e Hemingway sentiva che stava perdendo un’occasione, così, a 18 anni, si offrì volontario per guidare un’ambulanza della Croce Rossa in Italia. Fu lì, una notte, in prima linea, che un colpo di mortaio austriaco esplose a poca distanza da Hemingway, ferendolo gravemente quando 227 schegge gli lacerarono le gambe. Inzuppato di sangue e incerto se sarebbe sopravvissuto o meno, il protestante in un paese cattolico si ritrovò a pregare per l’intercessione di “Nostra Signora e vari santi”.
Fondamentale fu il fatto che un prete italiano si imbatté nei soldati feriti che si aggrappavano alla vita e li unse nel l’olio dell’estrema unzione. In Hemingway’s Faith, Mary Claire Kendall osserva che “Hemingway considerava l‘8 luglio 1918 un giorno di rinascita spirituale. Era il giorno in cui aveva guardato in faccia la morte ed era stato ’unto’ e assolto dai suoi peccati”. Da quel momento in poi, si definì cattolico.
Eppure si trattava di un cattolicesimo semplice, devozionale e molto privato, cosa non insolita all’epoca. Un amico negli anni Venti – nota Kendall – riteneva che Hemingway “fosse un cattolico molto devoto. La sua religione derivava principalmente dalle apparizioni della Vergine Maria. Mi disse più volte che se non ci fosse stata la Bibbia, né le leggi ecclesiastiche create dall’uomo, le apparizioni avrebbero dimostrato senza ombra di dubbio che la Chiesa cattolica era la vera Chiesa”.
Circa 40 anni dopo, Hemingway disse in un’intervista col New York Post che “la politica e la religione sono due cose di cui non parlo mai. Se i miei libri non chiariscono come mi sento riguardo a entrambe, allora ho fallito nel lavoro della mia vita”.
Le sue idee politiche di sinistra sono abbastanza facili da individuare nei suoi romanzi (a un certo punto è stato considerato “persona di interesse” dall’FBI), ma l’obiettivo di Hemingway’s Faith è quello di trovare i temi religiosi che sono sotterranei nei suoi libri.
Kendall scrive che The Sun Also Rises è “intriso di cattolicesimo”, notando una scena in cui il ferito di guerra Jake Barnes entra in una cattedrale a Pamplona e dice: “Ero inginocchiato con la fronte sul legno di fronte a me, e pensavo a me stesso mentre pregavo. Mi vergognavo un po’ e mi pentivo di essere un cattolico così cattivo” – aggiungendo che quella cattolica “era una grande religione e desideravo solo potermi sentire religioso e forse lo sarei stato la prossima volta”.
In Addio alle armi, c’è un’importante conversazione sull’amore con un prete cattolico. In Per chi suona la campana, un personaggio centrale di nome Pilar (un cenno questo alla Madonna del Pilar) che dice: “Probabilmente c’è ancora un Dio, anche se lo abbiamo bandito”. In Il vecchio e il mare, il pescatore Santiago, che prende il nome dalla meta di pellegrinaggio spagnola di Santiago de Compostela, molto amata da Hemingway, insegue un marlin che è stato attaccato dagli squali. Santiago afferma di non essere religioso, ma “inizia a pregare un’Ave Maria dopo l’altra, aggiungendo: “Benedetta Vergine, prega per la morte di questo pesce. Per quanto sia meraviglioso”.
Purtroppo, nella narrativa di Hemingway ci sono solo esempi di considerazioni religiose, niente di diretto, probabilmente perché si considerava un “fallito” e non all’altezza della religione. “La sua storia matrimoniale movimentata, credeva erroneamente, gli precludeva la piena comunione con la Chiesa” – scrive Kendall.
Kendall è particolarmente attenta nel fornire prospettive sui matrimoni irregolari di Hemingway. La sua prima moglie, Hadley Richardson, era ricca, non battezzata e aveva otto anni più di lui. Dopo il loro matrimonio civile, lei permise a Pauline Pfeiffer, una giornalista di moda quattro anni più grande di Hemingway e ancora più ricca, di vivere con la coppia, apparentemente ignara dei segni di una relazione amorosa. Poiché il matrimonio di Hemingway con Richardson era stato celebrato al di fuori della Chiesa, l’arcivescovo di Parigi concesse a Hemingway l’annullamento per sposare la Pfeiffer, cattolica, e lo scrittore fu ufficialmente certificato come cattolico.
Ma il suo abbraccio alla fede non durò. Sebbene spesso si rimproverasse per le sue trasgressioni, trovava troppo difficile cambiare. Si lasciò coinvolgere in molteplici relazioni amorose che si conclusero con un altro divorzio e il suo matrimonio con la giornalista di guerra Martha Gellhorn. Anche lei poi divorziò da lui dopo cinque anni a causa del suo bullismo, della sua dipendenza dall’alcol e della sua gelosia. A lei seguì Mary Welsh, alcolizzata e corrispondente di guerra come lui, che divenne la persona che si prese cura di Hemingway negli ultimi 15 anni della sua vita, quando cadde nella paranoia e nella malattia mentale.
Come suo padre, sua sorella e suo fratello, tutti morti suicidi, Hemingway sembrava aver ereditato l’emocromatosi, una malattia genetica causata da un eccesso di ferro nel sangue, che accumula i sintomi del diabete, disturbi della memoria e depressione. Ma si trattava di una diagnosi errata che lo costrinse a sottoporsi a 25 elettroshock. Di questo scrisse al giornalista e romanziere A.E. Hotchner: “Che senso ha rovinarmi la testa e cancellarmi la memoria, che è il mio capitale, e mettermi fuori gioco? È stata una cura brillante, ma abbiamo perso il paziente. È una brutta esperienza, Hotch, terribile”.
La prova dei suoi disturbi psichici è anche il fatto che, nel 1961, gli ci volle “una settimana per comporre un semplice biglietto di congratulazioni al neoeletto presidente John F. Kennedy. Scriveva tra le lacrime, frustrato dal fatto che le parole tardassero così tanto ad arrivare”.
Sabato sera del 1° luglio 1961, Hemingway sembrava di buon umore mentre lui e sua moglie mangiavano in un ristorante cinese. Le sue ultime parole a Mary furono: “Buonanotte, gattina mia”. La domenica mattina presto tirò fuori il suo fucile preferito. “Mary lo trovò in fondo alle scale, accasciato, in un groviglio di sangue”. Non aveva ancora 62 anni.
Ho trovato il libro di Mary Claire Kendall avvincente e ricco di nuove informazioni. L’autrice ha fatto un ottimo lavoro nel setacciare la montagna di materiale su Ernest Hemingway e ha saggiamente fatto riferimento alla ricerca del defunto H.R. Stoneback, “il massimo studioso del cattolicesimo di Hemingway e lui stesso un convertito”.
Il defunto poeta e saggista della Duke University Reynolds Price suggerì che, sebbene non lo sapesse consapevolmente, il tema di tutta la vita di Hemingway era la santità. Hemingway’s Faith dà ampia prova di ciò.


L’avventura di Hemingway, scrittore per vocazione
Ernest Hemingway (21 luglio 1899 – 2 luglio 1961), autore di racconti e libri cult come “Il vecchio e il mare”, “Per chi suona la campana”, “Fiesta” e “Addio alle armi”, è stato tante cose: giornalista, scrittore, cronista di guerra, cacciatore per passione, amante della vita per vocazione… Un uomo che ha vissuto nella perenne ricerca del limite da oltrepassare, sempre proiettato all’avventura di domani, alla narrazione senza fronzoli, ironica e a tratti malinconica, degli eventi che affollano un’esistenza vissuta, appunto, in gran fretta – L’approfondimento sui suoi libri e la sua vita «La fretta. Quella eccitantissima perversione di vita: la necessità di compiere qualcosa in un tempo minore di quanto in realtà ne occorrerebbe».
Capita sempre quando si ha a che fare con i grandi scrittori: per ricercare poetica, intenzioni, volontà e pensiero, è sufficiente cercare tra le loro parole. Ernest Hemingway non fa eccezione. Questa citazione, tratta da Fiesta, dà infatti un parziale ma efficace scorcio di quella che è stata una delle personalità più influenti della letteratura americana, un uomo che ha vissuto nella perenne ricerca del limite da oltrepassare, sempre proiettato all’avventura di domani, alla narrazione senza fronzoli, ironica e a tratti malinconica, degli eventi che affollano un’esistenza vissuta, appunto, in gran fretta.
Hemingway è stato tante cose: giornalista, scrittore, cronista di guerra, cacciatore per passione, amante della vita per vocazione. E, come accade con tutto ciò che si ama troppo, ha dovuto abbandonarla, la vita, con la sua stessa mano.
In Italia, le sue opere sono state tradotte da Fernanda Pivano e pubblicate da Mondadori.
Ernest Miller Hemingway nasce a Oak Park, un sobborgo di Chicago, il 12 luglio del 1899. Suo padre, Clarence Edmonds, è un medico, mentre sua madre, Grace Hall, è una ex aspirante cantante, appassionata di lirica e grande devota. Quella di Oak Park è una società benpensante, repressiva, di gente che tiene molto all’opinione altrui. Una società che non ci mette molto a star stretta al piccolo Ernest.
Anticonformista nato, Hemingway sogna infatti uno stile di vita più autentico, lontano dal mondo civilizzato. Lo trova in Michigan, nella regione dei Grandi Laghi, presso la fattoria dove la sua famiglia si stabilisce ogni estate. È qui che si scopre ben presto innamorato dell’avventura, della pesca e della caccia, passioni che saranno il filo conduttore della sua esistenza e che si ritroveranno spesso presenti nella sua produzione letteraria.
Ernest Hemingway, scrittore per vocazione
«Avere un cuore da bambino non è una vergogna. È un onore. Un uomo deve comportarsi da uomo. Deve sempre combattere, preferibilmente e saggiamente, con le probabilità a suo favore, ma in caso di necessità deve combattere anche contro qualunque probabilità e senza preoccuparsi dell’esito. Deve seguire i propri usi e le proprie leggi tribali, e quando non può, deve accettare la punizione prevista da queste leggi. Ma non gli si deve dire come un rimprovero che ha conservato un cuore da bambino, un’onestà da bambino, una freschezza e una nobiltà da bambino.»
(da Vero all’alba)
Non ci impiegano molto, i suoi insegnanti, a rendersi conto che Ernest ha un talento e un’inclinazione naturale per la letteratura: qui, tra i banchi di scuola, Hemingway scrive i suoi primi racconti; continuerà a farlo per tutta la vita.
Nel 1917 si trasferisce a Kansas City e lavora come cronista per il quotidiano Kansas City Star: la sua penna comincia ad affinarsi. La scrittura giornalistica è decisamente nelle sue corde: uno stile diretto, veloce, affilato, che non necessita di termini antiquati, stili ricercati e contenuti prolissi per raggiungere l’obiettivo di farsi leggere. Più semplice è, meglio è, diventa presto il suo motto. Semplicità di scrittura che, tuttavia, non è semplicità di pensiero: l’arte, per Hemingway, è non a caso quella di saper riprodurre concetti complicati attraverso un linguaggio semplice, ma non banale.
Gli anni della guerra
L’eco del primo conflitto mondiale in Europa ha raggiunto gli Stati Uniti, e con l’ingresso del paese in guerra Hemingway decide di arruolarsi. Scartato per un problema alla vista, viene assegnato ai reparti della croce rossa e inviato in Italia, in quello che sarà solo il primo dei suoi molti viaggi in giro per l’Europa. È proprio qui che, nella degenza in un ospedale militare a seguito di una ferita riportata nel tentativo di salvare un commilitone, conosce il suo primo amore, solo in parte corrisposto, il quale più avanti ispirerà una delle sue opere più note: Addio alle armi.
Addio alle armi (1929)
«Questo si faceva. Si moriva. Non si sapeva di cosa si trattasse. Non si aveva mai il tempo di imparare. Si veniva gettati dentro e si sentivano le regole e la prima volta che vi acchiappavano in fallo vi uccidevano.»
Libri su Milano Hemingway
Ambientato in Italia, a cavallo tra l’inizio e la fine della battaglia di Caporetto, Addio alle armi narra le vicende di un soldato americano, Frederic Henry, che svolge servizio di soccorso sui campi di battaglia e si innamora di un’infermiera durante la degenza in ospedale a seguito di una ferita. La storia d’amore è direttamente legata a quella della battaglia con un tragico epilogo che evidenzia la crudeltà della guerra e l’ineluttabilità dello scorrere del tempo.
La “generazione perduta”
Al rientro in patria, Hemingway viene assunto dal quotidiano Toronto Star e conosce quella che sarà la sua prima moglie, Hadley Richardson. È stata proprio lei a suggerire al marito di farsi assegnare dal Toronto Star il ruolo di corrispondente europeo: il quotidiano accetta e i due partono alla volta di Parigi.
Qui Hemingway conosce la scrittrice Gertrude Stein, la quale a sua volta lo presenta ad autori espatriati del calibro di Francis Scott Fitzgerald, James Joyce ed Ezra Pound. È qui che inizia la vera carriera letteraria dell’autore, che diventerà un figura chiave di quel gruppo di artisti rivoluzionari chiamati da Stein “la generazione perduta”.
La collaborazione con il Toronto Star prosegue liscia, proprio come i viaggi in Europa. Milano, Roma, Costantinopoli, Spagna: ogni luogo che Hemingway visita si trasforma in una storia, che diventerà poi un racconto.
«Nel modo in cui ti guadagni la vita, qualunque esso sia, in questo sta il tuo talento.»
(Da Le nevi del Kilimangiaro)
Ne i 49 racconti si possono trovare tutti gli aspetti della vita di Hemingway, una sintesi delle sue passioni e del suo stile; gli argomenti sono i più disparati, dalla boxe alle avventure di pesca, dalle storie di guerra agli amori, perduti o vissuti. E ogni racconto racchiude in sé un’esperienza di vita vissuta in prima persona, una sorta di cronaca di un’esistenza ricca d’esperienze al limite e drammi insuperabili. Lo stile è narrativo, scevro di artifici letterari o retorici, diretto e colmo di dialoghi che rappresentano lo specchio della vita dello scrittore.
L’amore per la Spagna
Il 1923 è poi un anno importante nella vita di Hemingway. Incontra infatti due piccoli editori americani, Bill Bird e Robert McAlmon, disposti a pubblicare i suoi lavori. Inizia quindi a scrivere quelli che diventeranno alcuni dei suoi racconti più famosi: Gatto sotto la pioggia, il mio vecchio e Fuori stagione.
Nello stesso anno, in giugno, si reca per la prima volta in Spagna, paese che diventerà presto lo scenario di alcuni dei suoi testi migliori. Lì assiste alla sua prima corrida importante e si cimenta nelle novilladas, ovvero le corride per principianti.
Lo scrittore rimane così entusiasta del viaggio che decide di tornare in Spagna il mese successivo, a Pamplona, per la festa di San Firmino. La conoscenza dei toreri più famosi ha lasciato il segno: in ottobre, Ernest e Hadley hanno il loro primo figlio, che chiamano John Hadley Nicanor, in omaggio a uno dei matador del momento.
Dall’esperienza spagnola Hemingway trae ispirazione per il fortunato romanzo Il sole sorgerà ancora, meglio conosciuto come Fiesta.
Fiesta (1926)
«È facilissimo reagire con freddezza alle cose durante il giorno, ma di notte è tutto un altro discorso.” “Non ha senso che per il solo fatto che faccia buio si debbano vedere le cose in maniera diversa da quando c’è luce. No, accidenti, non ha senso!” “Entrai in camera mia e mi sdraiai sul letto.»
fiesta
È la storia della vacanza a Pamplona, durante la festa di San Firmino, di un gruppo di amici che vivono a Parigi, a fare da cornice all’opera. Durante il periodo di Fiesta in terra spagnola si intrecciano così gli amori appassionati e disattesi dei vari protagonisti. I toni sono scanzonati, cinici, così diretti e crudi da far scalpore nella società del periodo. Il quadro che ne deriva è quello di una profonda disillusione, a tratti malinconica ma sempre oggettiva – un amore che il protagonista, proprio come Hemingway pochi anni prima, riconosce di dover lasciar andare.
L’incontro con Pauline Pfeiffer
Dopo l’uscita di Fiesta, Hemingway si innamora di una giornalista di Vogue, Pauline Pfeiffer, con cui inizia una relazione coinvolgendo sua moglie Hadley. Questa situazione sentimentale verrà poi raccontata in Festa mobile e nel romanzo postumo Il giardino dell’Eden. Sposata infine Pauline, i due fanno rientro in Florida, dove verrà pubblicato nel 1929 Addio alle armi. Il successo del libro è tale da consacrare ufficialmente Hemingway a letterato di fama internazionale.
Poco prima della pubblicazione, però, Hemingway subisce un colpo durissimo: suo padre si è sparato in testa, durante un attacco di depressione dovuto al diabete e a diversi problemi finanziari. Ancora non lo sa, ma anni dopo la stessa sorte toccherà a Leicester, fratello minore di Hemingway, che rimarrà talmente ossessionato dalla vista del padre morto da suicidarsi nello stesso modo. La tragedia, purtroppo, è dietro l’angolo.
L’alcol
«Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo.»
Dopo la morte del padre, Hemingway è insofferente nei confronti di tutto, in particolare della vita familiare che gli sta sempre più stretta. Mentre Pauline è in attesa del secondo figlio, Hemingway è sempre più un habitué di bar e ristoranti, inizia a bere troppo e a condurre una vita fatta di vizi e sregolatezze. Porta avanti anche una relazione extraconiugale con Jane Mason, che sarà d’ispirazione per il racconto La breve vita felice di Francis Macomber.
Si consolida, intanto, la “leggenda” di Hemingway: l’autore si atteggia da vecchio saggio, si fa chiamare “Papa” e vuole essere dipinto come uomo d’azione, grande eroe di guerra e allo stesso tempo artista un po’ maudit, ma dallo stile limpido ed espressivo.
La terza moglie
Nel 1936 scoppia il moto franchista in Spagna e la North American Newspaper Alliance contatta Hemingway perché invii servizi dalla penisola iberica sulla guerra civile. Hemingway riparte per la Spagna, e lavora anche ad alcuni documentari propagandistici a sostegno dei repubblicani spagnoli.
In Europa, comunque, non va da solo, bensì in compagnia della scrittrice Martha Gellhorn. Non ci metterà molto, Ernest, a divorziare da Pauline e a sposarsi nuovamente. Con lei si sposta a Cuba, a L’Avana, dove scrive Per chi suona la campana, che esce nell’ottobre del 1940. Il libro vince il Premio Pulitzer e, nell’arco di due anni, diventa il più grande bestseller americano fino ad allora, dopo Via col vento. Per dieci anni, Hemingway non scriverà altri romanzi.
Per chi suona la campana (1940)
«Preoccuparsi è dannoso come aver paura; serve solo a far le cose più difficili.»
Per chi suona la campana Ernest Hemingway
Il romanzo è ambientato nel bel mezzo della guerra civile spagnola. Tratta della crudeltà della guerra, del senso del dovere contrapposto alla nascita di un nuovo amore cui è difficile rinunciare e del sacrificio necessario perché la speranza abbia possibilità di sopravvivere. Le tematiche principali della storia sono la morte, compagna sempre presente nella vita di un soldato, e il suicidio, un gesto estremo ma accettato per la salvezza di molti. Nell’opera è presente una critica feroce all’ideologia fascista, in netta contrapposizione con quella che era la visione politica di Ezra Pound, all’epoca amico di Hemingway.
Gli ultimi anni
Dopo anni passati in viaggio tra l’Estremo Oriente e l’Europa, nelle vesti di giornalista, intervallati dai soggiorni cubani trascorsi a bordo della Pilar, Hemingway partecipa nel 1944 allo sbarco in Normandia. Anche stavolta, è in compagnia di una nuova donna, che sposerà a breve: la giornalista Mary Welsh.
Le condizioni fisiche e mentali dello scrittore sono compromesse da una lunga serie di incidenti e da un impressionante consumo di alcol. Di regola, Hemingway inizia a bere appena sveglio, anche prima dell’alba, e continua fino alla cena. Lo stile di vita sopra le righe incide negativamente sulla vena creativa dello scrittore, che fatica sempre di più a trovare la concentrazione.
Non prima, però, di aver scritto forse la sua opera più famosa e la più consacrata, che gli varrà nientemeno che il premio Nobel per la letteratura nel 1954: Il vecchio e il mare.
Il vecchio e il mare (1952)
«Non lo disse ad alta voce perché sapeva che a dirle, le cose belle non succedono.»
Pubblicato per la prima volta nel 1952 sulla rivista LIFE e vincitore del premio Pulitzer e del premio Nobel nel 1954, Il vecchio e il mare racconta della lotta di Santiago, pescatore cubano ormai in là con gli anni, con un imponente Marlyn, il pesce più grande con cui avesse mai combattuto. Lo stile è scarno, il ritmo narrativo è serrato, incatenato a periodi brevi e cadenzati, che portano il lettore a immergersi nello scontro e prendere di volta in volta le parti dei contendenti. Ricorre anche in questo caso la tematica del tempo, quello scorrere incessante che avvicina il pescatore alla fine delle sue avventure in mare, e della morte, a cui Santiago e la preda cercano di resistere.
La morte
«Morire è una cosa molto semplice. Ho guardato la morte e lo so davvero. Se avessi dovuto morire sarebbe stato molto facile. Proprio la cosa più facile che abbia mai fatto… e come è meglio morire nel periodo felice della giovinezza non ancora disillusa, andarsene in un bagliore di luce, che avere il corpo consunto e vecchio e le illusioni disperse.»
Dopo il Nobel, Hemingway torna a viaggiare e lavorare, continuando però a soffrire di depressioni nervose sempre più gravi, oltre che di disturbi derivanti da pressione alta e malattie al fegato. Nel 1960 viene ricoverato in una clinica del Minnesota, dove riceve trattamenti con l’elettroshock.
Con fatica porta avanti la stesura di un libro sulla Parigi della sua giovinezza, che i suoi curatori intitoleranno poi Festa mobile. Ad aprile 1961, Mary sventa un primo tentativo di suicidio. Da un po’ di tempo ripete ai medici che, non riuscendo più a scrivere, non ha più motivo di vivere e intende farla finita.
Il 2 luglio 1961 Mary Welsh sente uno sparo al pianterreno. Trova Ernest a terra, ucciso da un colpo di fucile da caccia alla testa. Aveva 61 anni. Si dice che le sue ultime parole siano state rivolte alla moglie, alla quale sussurra con dolcezza: “Goodnight, Kitten“.
Gilbert Keith Chesterton...profeta gioioso della fede

Gilbert Chesterton un faro nel cammino di fede
Il 28 dicembre 2024 Papa Francesco nel Pensiero del giorno trasmesso in onda dalla BBC ha parlato di gentilezza, umiltà e gratitudine e quindi ha citato G.K. Chesterton — non era la prima volta — questo grande scrittore britannico, ha detto, molto stimato dal poeta argentino Borges, il quale nel finale della sua Autobiografia ci ricorda saggiamente di prendere i fatti della vita con gratitudine e non con scontatezza.
In due parole il Papa ha colto l’essenza dell’opera del poeta inglese, il grande nemico appunto della scontatezza. Una parola inusuale ma che dice e mette in guardia da quello che forse è il pericolo peggiore per l’uomo di ogni tempo e latitudine, quell’atteggiamento di sentirsi “in credito” nei confronti della vita e impedisce così di aprirsi allo stupore e, infine, alla gratitudine. Proprio nel finale della sua Autobiografia, che uscì postuma nel 1936 dopo la morte dell’autore, Chesterton conclude affermando che «L’esistenza è ancora una cosa molto strana e stupefacente per me e le do il benvenuto come se fosse uno straniero (…). Sento di essere stato approvato nel mio desiderio di capire il miracolo di essere vivi (...). Ho detto che questa religione un po’ grossolana e primitiva della gratitudine non mi ha preservato dall’ingratitudine, dal peggiore dei peccati». Un’affermazione che chiude il cerchio visto che all’inizio del libro aveva dichiarato: «Questo fu il mio primo problema, quello di indurre gli uomini a capire la meraviglia e lo splendore dell’essere vivi».
Non a caso il suo miglior romanzo è intitolato Manalive (in italiano: Le avventure di un uomo vivo) in cui il protagonista, Innocent Smith, cioè l’uomo comune colto nella sua innocenza, attraversa il mondo di chi lo accoglie con scontatezza e, con il suo candore eccentrico e con azioni che appaiono scandalose, getta lo scompiglio rivelando che si tratta di un mondo già morto, infilzato come una farfalla dall’entomologo le cui spille sono le abitudini, le convenzioni, le rigidità mentali. Da questo rigor mortis Innocent e Gilbert, uomini vivi, sono venuti a scuotere gli uomini, con leggerezza, allegria, humour e umiltà (tra loro fratelli) e un grande gusto per il paradosso.
Chi ha colto tutta la portata della rivoluzione chestertoniana è appunto Borges, come ha sottolineato il Papa, il quale riflettendo sull’essenza della poesia dice che essa consiste nel saper cogliere le cose della vita in quanto “strane”. Cioè libere dalla scontatezza e splendenti nel sole della gratuità e della libertà. La poesia come gratitudine di fronte a un dono. Questo combacia con il “benvenuto” che Chesterton dà all’esistenza “come fosse uno straniero”. Spesso solo lo straniero, che viene a inquietarci nel nostro torpore, apprezza quelle bellezze che noi “del luogo” abbiamo sotto gli occhi e quindi non vediamo più.
Eppure di quella bellezza ne abbiamo nostalgia, cerchiamo una casa per il nostro desiderio. Per chiudere questa lunga rassegna che nel 150esimo anniversario dalla nascita abbiamo voluto dedicargli, forse è allora giusto citare questi due versi composti in occasione del Natale, quando lo Straniero è venuto a visitare il nostro piccolo, meraviglioso, mondo: «Un bambino in una misera stalla, / con le bestie a scaldarlo ruminando; / solo là, dove Lui fu senza un tetto, / tu ed io siamo a casa».

Dio si fa carico del male a favore di tutti gli uomini
Platania, Marzia Curatore, Leonardi, Enrico Fonte
Nella sofferenza di Dio stesso entrato nella Storia, nella carne e nel sangue, uomo tra gli uomini, è riassunta potentemente tutta l'opera del male; nella vittoria finale del Cristo risorto il male del mondo è misteriosamente sconfitto.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2690142
Davanti alla realtà irrevocabile del male (irrevocabile perché liberamente scelta dall'uomo creato libero, cui Dio ha affidato la Sua Creazione) la scelta di Dio è stata quella di assumerlo Egli stesso, di farsene carico a favore di tutti gli uomini. Questa è la salvezza: il ricapitolarsi in Cristo di tutta la creazione affinché attraverso l'obbedienza perfetta essa fosse condotta ad una nuova perfezione, che non rinnega né tralascia il male occorso, ma lo assume e lo attraversa, lo capovolge trasformandolo nel suo contrario. Nella sofferenza di Dio stesso entrato nella Storia, nella carne e nel sangue, uomo tra gli uomini, è riassunta potentemente tutta l'opera del male; nella vittoria finale del Cristo risorto il male del mondo è misteriosamente sconfitto.
Nessuna sofferenza e nessuna imperfezione è lasciata fuori da questo supremo mistero; nessuna teoria o visione profetica ha mai potuto offrire ciò che il cristianesimo annuncia. Il cristianesimo non si illude di cancellare il male dando agli uomini delle istruzioni: se la loro stessa natura è stata deviata, come potranno seguirle?
Esso non si oppone al male con un muro di consigli e di prescrizioni: gli ha invece spalancato le porte, ha lasciato che mordesse la carne stessa di Dio, lo ha lasciato aggredire la consistenza stessa dell'Essere, e poi con un improvviso e subitaneo rovesciamento ben degno di una tale guerra ha trasformato la sconfitta stessa in vittoria, trionfando definitivamente. E' incredibile che una simile avventura sia sentita dagli uomini come qualcosa di obsoleto e noioso
Quando il mondo si commosse e il sole oscillò nel cielo, non fu al momento della crocifissione ma al grido dall'alto della croce: il grido che confessò che Dio era abbandonato da Dio. Ed ora lasciate che i rivoluzionari scelgano un credo fra tutti i credi e un dio fra tutti gli dei del mondo, pesando con la massima cura tutti gli dei dal ritorno inevitabile e dall'inalterabile potere. Essi non ne troveranno un altro che sia stato in rivolta anche lui. Anzi (il tema si fa sempre più difficile per essere trattato in termini umani) lasciate che gli atei stessi si scelgano un dio. Essi non troveranno che una divinità che abbia manifestato il suo isolamento; non troveranno che una religione in cui Dio sia apparso per un istante ateo. (GKC, Ortodossia, pag. 189)
Il significato che Cristo rivela è il significato della storia. La morte di Cristo si pone come l’evento centrale e determinante della storia cosmica che inizia con la Creazione e ha il suo primo drammatico evento nella Caduta. La Caduta rende ragione della morte e della sofferenza incancellabili dalla storia, così come della debolezza umana, debolezza morale quanto intellettuale. La Redenzione svela che esse sono conseguenze di un atto libero e perciò irrevocabile. L'opera della Redenzione è il libero atto di Dio fatto uomo che sconfigge la morte a favore degli uomini, non abolendola, ma attraversandola. Dio stesso assume la umana debolezza su di sé; morte e sofferenza raggiungono il loro culmine sublime nella sofferenza e morte in croce del Dio fatto uomo; e in virtù di questo rovesciamento dell'immenso creatore nella piccola creatura, anche la morte e la sofferenza stessa sono rovesciate nel loro contrario. Non sono abolite, ma rovesciate. Cristo è quel centro di gravità che opera l'inaudito rovesciamento
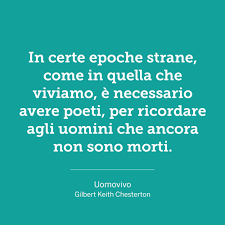
G.K. Chesterton: 150 anni dopo è un Uomo Vivo
Gulisano Paolo
Il 29 maggio del 1874 nasceva a Londra Gilbert Keith Chesterton, geniale autore di saggi, biografie, romanzi e poemi. Fu uno dei grandi interpreti del genere Mystery, con il personaggio ineguagliabile del prete detective, ma fu anche giornalista di razza, protagonista assoluto della scena culturale inglese della prima metà del Novecento.
Sono passati centocinquant’anni dalla sua nascita, ma Chesterton è più attuale che mai, con la sua difesa della ragionevolezza, con quell’uso magistrale del paradosso che sempre lo caratterizzò. Un paradosso mai fine sè stesso, non un gioco intellettuale, ma un metodo per risvegliare la mente e la coscienza.
Chesterton difese la bellezza della Fede, dell’annuncio della Salvezza che è una persona: Gesù Cristo. E lo fece con passione, con decisione, con simpatia, perfino. Morto a soli sessantadue anni nel 1936, fu veramente un “Uomo Vivo” – come dice il titolo di un suo celebre romanzo. Un cristiano controcorrente. E per questo dopo tanti anni è ancora attuale: perché il conflitto tra la Chiesa e il Mondo sta assumendo – negli ultimi tempi – dimensioni drammatiche.
I primi anni
Quando Chesterton nacque, Londra era la più grande, popolosa e importante città del mondo: il cuore e la mente della civiltà Occidentale e dell’ordine da lei stabilito.
L’adolescenza di Chesterton corrisponde agli anni disperati e crepuscolari del simbolismo e del decadentismo. L’opera di Chesterton è una sorta di medicina per l’anima, anzi, più precisamente può essere definita un antidoto. Lo stesso scrittore aveva in realtà usato la metafora dell’antidoto per indicare l’effetto sul mondo della santità: il santo ha lo scopo di essere segno di contraddizione e di restituire sanità mentale a un mondo impazzito.
Ancora ogni generazione cerca per istinto il suo santo – aveva detto –, ed egli è non ciò che la gente vuole, ma piuttosto colui del quale la gente ha bisogno… Da ciò il paradosso della storia che ciascuna generazione è convertita dal santo che la contraddice maggiormente.
Serenità e speranza
Il modo con cui Chesterton riuscì a contraddire la generazione del suo tempo è stato quello dell’essere felice. Una felicità autentica, che per essere tale non prescinde affatto dal dolore, dalla fatica e dalle lacrime.
La lettura di Chesterton, in sigla GKC, sia che si tratti dei romanzi che dei saggi, lascia sempre nel lettore una grande serenità e un sentimento di speranza che scaturisce non certo da una visione della vita irenistica e mondanamente ottimistica, che è in realtà quanto di più lontano dal pensiero di Chesterton, che denuncia dettagliatamente tutte le aberrazioni della modernità, ma dalla cristiana, virile fortezza dell’esperienza religiosa.
La proposta di Chesterton è quella di prendere sul serio la realtà nella sua integrità, a cominciare dalla realtà interiore dell’uomo e di adoperare fiduciosamente l’intelletto – ovvero il buon senso-nella sua originale sanità, purificato da ogni incrostazione ideologica.
Una fede viva
Raramente capita di leggere delle pagine in cui si parla di fede, di conversione, di dottrina, tanto chiare e incisive quanto prive di ogni eccesso sentimentalistico e moralistico. Ciò deriva dall’attenta lettura della realtà di Chesterton, il quale sa che la conseguenza più deleteria della scristianizzazione non è stato il pur gravissimo smarrimento etico, ma lo smarrimento della ragione, sintetizzabile in questo suo giudizio: «Il mondo moderno ha subìto un tracollo mentale, molto più consistente del tracollo morale».
Di fronte a questo scenario Chesterton sceglie il cattolicesimo e afferma che esistono almeno diecimila ragioni per giustificare questa scelta, tutte valide e fondatissime ma riconducibili a un’unica ragione: che il cattolicesimo è vero, la responsabilità e il compito della Chiesa consistono dunque in questo: nel coraggio di credere, in primo luogo, e quindi di segnalare le strade che conducono al nulla o alla distruzione, a un muro cieco o a un pregiudizio. «La Chiesa – dice Chesterton – difende l’umanità dai suoi peggiori nemici, quei mostri antichi, divoratori orribili che sono i vecchi errori».
Il successo di padre Brown
L’opera critica di Chesterton – i libri su Dickens, Browing, Stevenson, Blake e il pittore Watts – non è meno incantevole che penetrante; i suoi romanzi, scritti all’inizio del secolo, uniscono il mistico al fantastico, ma la sua fama attuale si deve soprattutto a quelle che si potrebbero chiamare le “Gesta di Padre Brown”.
Chesterton non era un filosofo, o un teologo, ma portava i lettori alla riflessione attraverso le sue storie. E tra le storie che più ci tenne a raccontare c’erano i gialli, i polizieschi. Dei racconti polizieschi difese le ragioni in un suo saggio, The Defendant (Il difensore):
Non è vero che il volgo preferisce la letteratura mediocre alle opere di gran pregio, né che ama i racconti polizieschi perché sono letteratura di infimo grado. (..) Bisogna riconoscere che numerosi racconti polizieschi traboccano di crimini eccezionali, proprio come un dramma di Shakespeare. (..) Non solo il racconto poliziesco è una forma d’arte perfettamente legittima, ma presenta certi vantaggi ben definiti e reali come strumento del benessere pubblico.
E ancora: «Il primo pregio fondamentale del racconto poliziesco consiste nel fatto che rappresenta il più antico, nonché l’unico genere di letteratura popolare in cui sia espressa una qualche consapevolezza della poesia della vita moderna».
E del genere poliziesco
Chi è l’investigatore? L’investigatore è il moderno eroe che vive la sua Iliade nei meandri delle strade della città. Era inevitabile che sorgesse una letteratura popolare che tenesse conto delle possibilità romantiche offerte dalla città moderna. I racconti polizieschi possono essere sobri e confortanti come le ballate di Robin Hood.
Il romanzo poliziesco sottrae all’oblio il fatto che la civiltà stessa è la più sensazionale delle trasgressioni e la più romantica delle sommosse. «Trattando delle vigili sentinelle che difendono gli avamposti della società, esso tende a rammentarci che viviamo in un accampamento militare, in conflitto con un mondo caotico, e che i malfattori, figli del caos, non sono altro che traditori entro le mura della città».
Per Chesterton il romanzo poliziesco ci offre uno spaccato realistico della vita umana, e si basa sul fatto che «la moralità è il più oscuro e ardito dei complotti».
Scrivere per convertirsi
Gran parte della sua fama mondiale venne a Gilbert Keith Chesterton proprio da uno di questi personaggi, inizialmente solo una delle diverse figure di investigatore a cui pensava. Si trattava di un piccolo prete dalla faccia tonda, umile, dimesso, ma dalla mente pronta, straordinariamente acuta, in grado di gareggiare con i più abili poliziotti e delinquenti non in astuzia, ma in intelligenza.
Un prete cattolico, personaggio che appare per la prima volta in un racconto del 1910, diversi anni prima quindi della sua conversione. Chesterton per primo fu stupito del successo di questo personaggio, e si trovò quasi obbligato a dargli continuità.
Imparò ad amare e ad apprezzare il Cattolicesimo prima che nei suoi contenuti dottrinari, per quelle qualità di umiltà, semplicità e intelligenza che pose nel personaggio del prete investigatore.
In Padre Brown non c’è mai compiacimento dei propri successi: c’è il dolore per tutto il male che c’è nel mondo, un dolore sereno mitigato dalle tre virtù cardinali che egli incarna con semplicità: la fede, che non viene mai meno e che egli comunica e trasmette con naturalezza; la speranza, che anima la sua attività di prete e investigatore, con l’intenzione di salvare il peccatore, se non di impedire il peccato; la carità, ovvero l’amore, la capacità di offrire il perdono di Dio, il desiderio di vedere non la morte (o la punizione) del colpevole, ma la sua conversione.
La Distribust League
Tra le varie attività cui GKC si dedicò – diceva che diffidava di chiunque si occupasse di una cosa sola – ci fu anche l’economia e la politica.
Nel 1925 decise di rialzare dalla polvere la vecchia bandiera del giornalismo coraggioso che era stata levata in alto da suo fratello Cecil, e insieme a Belloc, Padre McNabb e altri amici fondò un nuovo settimanale da battaglia. Dopo diverse discussioni, si scelse un nome piuttosto singolare per la nuova testata: “G.K’s Weekly”, ovvero “il settimanale di GK”, le iniziali di Gilbert Keith; la decisione impegnava direttamente e personalmente l’autorevolezza e la responsabilità del suo direttore, Chesterton, ma rappresentava le idee di un gruppo destinato a raccogliere moltissimi consensi. Tale gruppo, un anno dopo, fondò un movimento politico, la Distributist League, la Lega Distributista.
Il Distributismo – si proponeva un ritorno alle forme di civiltà e ai principi basilari della società popolare medievale che trovavano la loro estrinsecazione nelle gilde e nei terreni comuni, oltre che in un rigoglioso localismo, e cioè un ritorno del popolo a una vita autonoma, alla diretta amministrazione dei propri interessi, affidati negli Stati moderni al controllo degli apparati statali o delle oligarchie economiche. Il motto coniato da Chesterton per il movimento fu: «La libertà attraverso la distribuzione della proprietà».
Un progetto utopico
Circoli distributisti vennero aperti in numerose città di Inghilterra e anche in Scozia, presso l’Università di Glasgow, trovando subito un notevole riscontro tra gli studenti. Il Distributismo possedeva tutte le caratteristiche per suscitare l’interesse di chi viveva in una fase di depressione economica, di delusione seguita a una guerra che ci si era illusi sarebbe stata l’ultima e aveva invece lasciato tante ferite aperte.
Era un movimento fuori degli schemi partitici, dei quali Belloc aveva direttamente sperimentato tutta l’incoerenza e la corruzione, che si proponeva di combattere i mali della modernità affidandosi non a modelli non più proponibili, ma riscoprendo le strutture sociali ed economiche di un concretissimo Medioevo, rilette alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa. Propugnando la teoria economica del «piccolo è bello», il Distributismo era non solo anti-imperialista e localista, ma riprendeva anche i temi della difesa della terra e del ritorno ad essa.
«La Chiesa ringiovanisce mentre il mondo invecchia», Così aveva scritto Chesterton in un suo saggio, constatando che il Cristianesimo è una pazzia che sana mentre tutto il mondo impazzisce. Ciò che rende sempre giovane e attraente la Fede è il fatto che Cristo ci ha dato un modo più ragionevole di vivere, più lucido ed equilibrato nei suoi giudizi, più sano nei suoi istinti, più lieto e sereno di fronte al destino e alla morte.
La morte
Nel giugno del 1936 Chesterton si ammalò gravemente, e morì.
Appresa la notizia della scomparsa del grande scrittore, papa Pio XI mandò, per mezzo del Segretario di Stato Cardinale Eugenio Pacelli, un telegramma di cordoglio, in cui si piangeva la perdita di «un devoto figlio della Santa Chiesa, difensore ricco di doni della Fede cattolica. Era la seconda volta nella storia che un pontefice attribuiva a un inglese la qualifica di “difensore della fede”.
Forse la Segreteria di Stato non si era accorta dell’ironico accostamento, che avrebbe fatto esplodere Gilbert in una delle sue proverbiali risate: l’altro inglese era stato Enrico VIII, l’uomo che aveva inferto alla Chiesa in Inghilterra la più grave e profonda ferita. Fu l’ultimo paradosso di GKC.
Ingeborg Bachmann..."non conosco mondo migliore"

Ingeborg Bachmann, ancora
Federico Ferrari
Ho guardato per anni le fotografie di Ingeborg Bachmann. Credo che vi ricercassi un’entrata secondaria per penetrare nel labirinto della sua opera. Le ripetute letture non erano, infatti, riuscite a rendermi intellegibile la complessità della sua opera e della sua persona. Era come se, di decennio in decennio, il segreto contenuto nelle sue frasi, nei suoi versi e nelle sue fotografie si allontanasse da dove mi trovavo. Poco importava che il mio “luogo” mutasse inevitabilmente con il passare degli anni, mentre la sua opera risultava essere ormai compiuta da quel 17 ottobre del 1973, in cui la scrittrice austriaca, nella sua amata Roma, dopo lunga agonia, lasciava questo mondo.
In fondo, la sua scrittura, così asciutta, talvolta spigolosa, a volte un po’ impacciata, ma sempre al di là di ogni messaggio codificato, di ogni banale scrittura a tema, mi portava a fare esperienza di un mondo instabile eppur solidamente resistente a ogni astrazione. Mostrava, col suo fraseggio intricato, quanto inutile fosse cercare di afferrare tra le grinfie del concetto quel che sfugge da ogni parte fluendo verso il nulla: l’esperienza stessa del reale.
La vita – la vita che Bachmann consumava senza risparmiarsi, bruciandola nella passione (una passione che la rendeva, inesorabilmente, indifesa) – scivolava, spostandosi sempre altrove, in una sorta di non-luogo o di spazio utopico al quale era rimandato o demandato il senso dell’esistenza. La sua scrittura era una partitura sui cui righi si inscriveva un’arte della fuga, con tutti i suoi slanci in avanti e i suoi punti d’arresto, le sue apoteosi e le sue catastrofi. Proprio come nei suoi ritratti, in cui si alternano sorrisi radiosi a sguardi funerei, i suoi libri oscillavano e si dipanavano, tra interruzioni e silenzi, per tutta l’ampiezza della sua opera da Il tempo dilazionato a Non conosco mondo migliore, da Il trentesimo anno sino a Malina, da Luogo eventuale a Letteratura come utopia.
Questa impossibilità di fissare un insieme eterogneo di testi, a volte incompiuti, dentro a una gabbia interpretativa o a un’immagine esemplare, non si presentava, però, solo come un’esperienza in sé straniante, se non angosciante, come potrebbe sembrare, ma piuttosto come un’infinita attesa o rinvio a un ancora, a un istante sempre ancora a venire, in cui il senso – dell’opera? di una vita? (quale vita? la sua? la nostra?) – si prolungava, si dilazionava, si prorogava indefinitamente, più che essere rinviato sine die a causa della sua assenza.
C’era come una linea messianica, di profonda e fiduciosa attesa, che si rivelava e nascondeva, si rivelava nascondendosi, tra le pagine di Bachmann. Una linea sottile, mai davvero esplicitata ma nemmeno mai occultata del tutto. Il suo era, ancor prima di un messianismo etico (incentrato sulla questione della giustizia), un messianismo sensibile, inscritto nel suo corpo, nella sua inesausta richiesta di felicità come senso che si dà in e per tutti i sensi. Un messianismo come attesa e pegno di felicità dei corpi e dei sensi.
Ecco, se, oggi, a cinquant’anni dalla sua morte, mi chiedessero cosa animasse la scrittura di Bachmann direi la ricerca infinita di una felicità reale o di una realtà felice. Il suo problema non era, come molti sembrano ancora credere, quello dell’invenzione di una lingua. O meglio se esisteva il problema di una lingua, di un inevitabile lavoro sul linguaggio, era solo per trovare parole che fossero capaci di porsi all’altezza del reale, di una realtà che sola poteva far accedere al sogno di felicità, alla necessità di felicità che ogni corpo porta dentro di sé.
Bachmann, proprio grazie alla sua estenuante ricerca sul linguaggio, all’attenzione indirizzata verso il ritmo interno alla lingua, fingendo mimeticamente di adattarvisi, poneva fuori gioco ogni sperimentalismo neoavanguardista di quegli anni. Il fine della scrittura, infatti, non era, per lei, la lingua ma la realtà. Il linguaggio veniva concepito “solamente” come la scala wittgensteiniana che, una volta utilizzata per raggiungere la realtà, può essere gettata. Certo, poteva essere necessario, talvolta, anzi sempre, riprendere la scala e nuovamente arrampicarsi fino a nuove altitudini o discendere verso nuove profondità della realtà, poiché la realtà non è un’entità immobile, non è l’Essere, che una volta afferrato resta uguale a se stesso per sempre. La realtà è, più semplicemente e più radicalmente, un coacervo, mutevole e inafferrabile, di percezioni e sentimenti, spesso confusi tra loro e senza fissa dimora. Da qui, l’idea di una letteratura come utopia, come ricerca senza fine del luogo utopico della realtà. La letteratura era, per lei, esperienza ossimorica di una realtà che oscilla tra il qui dei nostri corpi e l’utopia di una speranza di felicità a venire e grazie alla quale la realtà assume un senso. La letteratura come luogo utopico del reale.
Scrivere, in fondo, per Bachmann, significava dare una possibilità ulteriore a quel desiderio o a quella speranza di reale felicità che ogni essere umano, se non ogni essere vivente, porta in sé.
Come tutti coloro i cui occhi sono velati di tristezza, anche Ingeborg Bachmann era abitata da una sorta di forza indisgiuntiva degli opposti: si dava in lei tristezza perché aveva conosciuto la realtà della felicità e si dava in lei esperienza della felicità perché aveva provato sulla propria pelle, e fino in fondo, la disperante caduta e l’abbandono. La scrittura era un modo di lasciare traccia di questa oscillazione inevitabile, di questo alternarsi di dolore e gioia, di solitudine e condivisione, di scrittura e realtà. Una forma di accogliente saluto alla vita, alla sua dismisura.
Così, ritornando a sfogliare le sue fotografie, l’iconografia dell’autrice, là dove la scrittura diventa tangente alla singolarità assoluta di un corpo, e guardando i suoi occhi, lungo tutti questi anni, mi è parso di intravvedere la nuda realtà delle sue parole, intrise di un coraggio disperato e di una cieca fiducia nell’avvenire. Detto altrimenti – ma in fondo non si tratta che di questo: dire altrimenti – ho compreso la sua mai spenta attesa dell’altro, la sua volontà di esporsi a un desiderio che strazia e rende felici, la sua passione per il semplice esistere, per le cose, per i volti e per tutto quello che la luminosità del mondo mostra.
Chiudendo un suo testo del 1955, la ventinovenne Bachmann, quasi in una sorta di autoprofezia, in cui la parola e lo sguardo convergono per aprirsi al reale e al tempo che non smette di venire, scrive “ho udito che al mondo c’è più tempo che intelletto, ma anche che gli occhi ci sono dati per vedere”. Vedere coi propri occhi, vedere negli occhi degli altri. Ancora e ancora. Sembra poco, ma forse è tutto.

Chi cade ha ali. Una lettura di Ingeborg Bachmann.
Giannina Longobardi
La guida, che ho scelto per questo intervento che ha come temi l’amore e la violenza è Ingeborg Bachmann. Il titolo è un verso tratto dalla sua poesia Il gioco è finito, che apre la raccolta Invocazione all’Orsa Maggiore[1]. E’ un omaggio a chi è caduto nel gioco dell’amore: chi ci ha provato, è caduto, ma aveva ali, e le ha usate: ha provato a volare.
Le amiche di Diotima mi hanno segnalato che nel suo Donne in relazione.[2] Milagros Rivera Garretas intitola il III capitolo: Io sono una donna maltrattata, compie così un passo provocatorio che ci costringe a guardare la nostra istintiva presa di distanza dalle donne che si fanno maltrattare e apre lo spazio di una relazione politica. Assume come soggetti, non come vittime insipienti, le donne che stanno in una relazione d’amore pericolosa.
E’ una mossa politica della quale anch’io sento nella necessità, per questo, in questo Grande Seminario che affronta il tema della violenza, ho sentito l’esigenza di introdurre anche il tema dell’amore. Ho scelto Ingeborg Bachmann, come guida, come profeta, un’esperta di cose d’amore. Esperta della guerra d’amore e uccisa dalle ferite riportate, ma fino all’ultimo convinta del fatto che chi non è aperto alla speranza, perde l’umano. E chi non spera e chi non vive e chi non ama e chi non spera … per me non è un essere umano.[3] Così afferma in Verrà un giorno, l’ultima videointervista, spiegando il senso della poesia La Boemia è sul mare, la poesia cui tiene di più e sulla quale torneremo alla fine, perché si può considerarla il suo testamento spirituale.
Azzardo qualificarla profeta, perché dai corsi di Antonietta Potente sull’Apocalisse e sul profeta Ezechiele, che ho seguito in questi ultimi anni, ho ritenuto che profeta è colui che sente, intimamente, nella sua esistenza, nel suo corpo, attraverso tutti i suoi sensi, la tragedia del suo tempo, l’essere noi perduti, addormentati, avvolti dalle tenebre, schiavi della bestia e cerca di risvegliare da questo sonno e invita alla lotta tenendo aperta la speranza.[4] La visone utopica non prefigura il mondo che verrà, non rinvia al futuro la realizzazione del regno, ma permette che il mondo del presente non si chiuda in una serie di dati di fatto senza senso.
Anche per la mia guida la parola vera sboccia solo in colei che mantiene viva la sua fede.
Schiavo del mondo, tu sei gravato di catene,
ma quel ch’è vero nel muro apre le crepe.
Vegli e nel buio vai scrutando intorno,
a ignota via d’uscita tu sei volto[5]
La fede che spinge a cercare l’apertura, la via d’uscita sconosciuta, non ha per lei alcun fondamento, non poggia né su Dio, né su alcun soggetto storico – né la classe operaia, né le donne-, è piuttosto un’esigenza spirituale e vitale e in questo senso è necessaria, e profondamente radicata nell’interiorità.
Talvolta mi è stato chiesto perché ho un’idea oppure una visione di un paese utopico, di un mondo utopico nel quale tutto sarà buono e nel quale tutti saremo buoni. Rispondere a questa domanda può essere paradossale, visto che siamo confrontati continuamente con le nefandezze della quotidianità. Ciò che possediamo è nulla, si è ricchi se si possiede qualcosa, che vale di più di ogni bene materiale. Ed io non credo a questo materialismo, a questa società di massa, a questo capitalismo, a questa mostruosità d’oggi, a questo arricchirsi di gente che non ha alcun diritto di arricchirsi sulla nostra pelle. Io credo davvero in qualcosa e questo qualcosa lo chiamo: «Verrà un giorno». E chissà, verrà, forse non verrà perché, sì, ce l’hanno sempre distrutto. Da migliaia di anni hanno continuato a distruggerlo. Non verrà, eppure ci credo, perché se non posso crederci allora non posso neanche più scrivere.[6]
Nel racconto Simultaneo, che apre la raccolta Tre sentieri su lago, la protagonista, un’esperta traduttrice simultanea, che conosce perfettamente più lingue, al momento di lasciare l’albergo di Maratea nel quale ha trascorso una brevissima vacanza con un uomo quasi sconosciuto, prima del congedo, apre a caso il volume della Bibbia che fa parte dell’arredamento della stanza e punta il dito. Mima quindi un atto divinatorio per cercare in una parola l’appiglio per la giornata. La frase designata dice: il miracolo, come sempre è il risultato della fede e d’una fede audace. Cercando di scomporla e di tradurla scoppia in pianto. La frase non le risulta traducibile in nessuna lingua sebbene fosse convinta di sapere il significato di ciascuna di quelle parole e come andavano usate e tuttavia non sapeva di quale sostanza quella frase fosse fatta in realtà. [7] Nessun miracolo quindi le accade e la breve storia di un incontro si chiude senza alcuna conseguenza.
Ma chi è stata Ingeborg Bachmann?
Molte di voi conosceranno già Ingeborg Bachmann direttamente attraverso la lettura della sua prosa, (Malina; Il caso Franza; il Libro del deserto; Luogo eventuale e le raccolte di racconti: Il trentesimo anno; Tre sentieri per il lago, i radiodrammi tra cui Il buon Dio di Manhattan) o delle poesie (Tempo dilazionato; Invocazione all’Orsa Maggiore) altre di voi forse solo attraverso le parole di Wanda Tommasi.[8] o di Chiara Zamboni[9] che hanno parlato di lei proprio qui, nei grandi Seminari di Diotima di alcuni anni fa.
Nata nel 1926 a Klagenfurt, laureata in filosofia con una tesi contro Heidegger[10] giovanissima entrò a far parte del gruppo 47 di cui facevano parte scrittori austriaci e tedeschi impegnati a rinnovare la letteratura e a fare i conti con il passato nazista, che veniva rapidamente rimosso in un clima di riarmo e guerra fredda. Di questo gruppo facevano parte tra gli altri Heinrich Boll, Hans Magnus Enzensberger, Gunter Grass; Peter Handke… Lì, fu subito riconosciuta come una grande poeta. Era una delle pochissime donne che partecipava attivamente al gruppo e che vi svolgeva un ruolo di rilievo.
Dal ‘53 visse molto in Italia, dapprima a Ischia, e a Napoli, per poi stabilirsi definitivamente a Roma, dopo più o meno lunghi periodi di residenza a Parigi, a Zurigo, a Berlino e frequenti viaggi all’estero. A Roma morì a 47 anni per le conseguenze d’incidentali bruciature. Il letto nel quale si era addormentata con la sigaretta accesa prese fuoco. Una morte accidentale, ma in qualche modo annunciata: non moriamo di malattia – né d’incidenti o di avvenimenti apparentemente casuali, potremmo aggiungere – ma di ciò che ci è stato fatto: questo era quello che si proponeva di mostrare nel ciclo narrativo che aveva intrapreso dell’ultimo periodo della sua vita, e che è rimasto incompiuto: Cause di Morte.
Vivere ardendo e non sentire il male. Questo verso di Gaspara Stampa si trova messo a epigrafe a più di una poesia e la citazione ritorna più volte in vari altri luoghi. E’in qualche modo il motto sul suo vessillo. Anche nelle ultime pagine di Malina, prima della fine dell’Io amante nella crepa del muro, ricorrono altre immagini di fuoco e di bruciature. Mentre prepara l’ultimo caffè, si costringe all’attenzione perché potrebbe distrattamente prendere fuoco.[11] Ancora poche pagine prima sente come una camicia di Nesso che la brucia il vestito che le è stato chiesto di indossare[12].
E noi dopo di ciò che le è accaduto non possiamo leggere senza brividi queste frasi e pensare alla terribile realizzazione della metafora, a questo passaggio dall’immagine al corpo, alla vita.
Ingeborg Bachmann sceglie la sua genealogia femminile di riferimento in donne che sono state grandi e sfortunate amanti, e le sceglie sia tra figure storiche che tra le eroine della letteratura.
In un’intervista[13] del 1971, e siamo nella fioritura della prima rivolta femminista all’intervistatrice, che nota perplessa che l’eroina di Malina svolge un ruolo femminile tradizionale, l’autrice risponde Per me non si pone il problema del ruolo della donna ma del fenomeno dell’amore: come si ama. E spiega le ragioni del fallimento dell’incontro amoroso Questa donna ama in modo così straordinario che dall’altra parte nulla può corrisponderle. Per lui lei è un episodio nella sua vita: per lei, lui è colui che trasforma il mondo che lo fa bello. E di fronte al femminismo di cui coglie soprattutto l’aspetto rivendicativo e paritario, aggiunge Forse per lei è molto strano che proprio una donna che ha sempre guadagnato i suoi soldi, che si è guadagnata da studiare, che ha sempre vissuto da sola, dica che non le importa niente di tutta l’emancipazione.
In effetti, né l’emancipazione che lei si era da subito guadagnata, né un vivo senso della differenza che certo non le manca, bastano a risolvere la questione della relazione tra i sessi, e a mettere nel mondo l’amore. E dichiara dunque, che ciò che la interessa è come si ama, anzi come le donne amano, alcune, non tutte. Nella stessa intervista prosegue, infatti, così:
Non so se mi sia riuscito di mostrare il genio dell’amore. So soltanto che i pochi grandi esempi sono così straordinari che si deve dire che indubbiamente esistono delle persone che, là dove gli altri hanno un piccolo talento occasionale, hanno ricevuto un dono; non lo si acquisisce, per questo è qualche cosa che brucia.
L’amore è una creazione femminile, ed ha una qualità estatica – mette fuori di sé e fuori dalla vita ordinaria, dai normali commerci del mondo. Ha un effetto vivificante, unificante dell’anima, produce una concentrazione di senso di fronte alla quale tutti gli oggetti morti del mondo si annullano. Prendiamo in prestito dalla lettura che Judith Butler fa del frammento giovanile di Hegel sull’amore questa definizione bellissima: l’amore è sentire ciò che nell’altro è vivente.[14] Per Hegel giovane, nell’amore si verifica l’incontro di due soggetti uguali, pari, senza sottomissione e senza dominio, nell’amore vi è pura soggettività che è vita.
La protagonista femminile del romanzo Malina dice che l’amore per Ivan è felicità dell’oggi che vuole eternarsi. L’amore introduce nell’esistenza un centro di tale intensità da far deperire le preoccupazioni e le occupazioni quotidiane – in questo caso quelle di una scrittrice che dovrebbe rispondere alla posta, fissare appuntamenti, rilasciare interviste. L’amore provoca una dislocazione dell’Io da se stesso che lei sente come guarigione, anzi come un’iniezione di realtà. Che significa che il mondo ordinario è fasullo e che quella che l’amore genera è l’unica vita vera, l’unica vita veramente viva.
L’amore pone gli amanti così in alto, come al 57° piano di un albergo di Manhattan, che di lì, da quella posizione, la vita ordinaria di chi lavora, compra, vende, si affaccenda e si affatica, appare piccola, insignificante, ridicola. Mi riferisco al suo dramma radiofonico: Il Buon Dio di Manhattan. E’ un dramma noir paradossale, tutto giocato sul filo dell’ironia, una di quelle commedie che potrebbero, anche fare piangere. Il Buon Dio di Manhattan è un giustiziere che si serve degli scoiattoli di Hyde Park come di spie, messaggeri e agenti, che denuncia e condanna il lato sovversivo dell’amore, decidendo che per il buon ordine del mondo, è giusto mettere un ordigno e fare saltare in aria gli amanti. Sì volare devono, volare in aria, senza lasciare traccia, perché niente e nessuno può avvicinarsi troppo a loro. Sono come gli elementi rari che vengono trovati qua e là, quelle materie di follia, con forza radiante ed incendiaria, che disgregano tutto e mettono in discussione il mondo. [15] E ancora, è sempre il Buon Dio che parla: Credo che l’amore stia dal lato oscuro del mondo, più pernicioso di tutte le eresie. Credo che dove sorge l’amore si formi un vortice come prima del primo giorno della creazione [16].
La colpa degli amanti è quella di chi non sa fare un uso ragionevole dell’amore[17], di chi non possiede la ragionevolezza di coloro che, dopo l’ardore iniziale. hanno fatto dell’amore un’impresa di medicinali contro la solitudine, una forma di cameratismo e una comunione di interessi economici.[18]
In questo dramma Ingeborg Bachmann cita indirettamente, e mette in scena, l’utopia contenuta in L’uomo senza qualità di Musil dove due amanti, lì una coppia di fratello e sorella, gemelli attuano il passaggio di confine, per inaugurare la controera e anch’essi falliscono. L’amore come stato di eccezione non può durare e non salda la scissione del mondo.[19] Di Musil Ingeborg Bachmann condivide l’idea che il mondo in cui viviamo è un mondo scisso: da una parte interiorità, senso, coscienza e sogno, dall’altra funzionalità, utilitarismo, frasi fatte e tanta violenza[20]. Se alla più alta ragione si congiungesse una veemente emotività si produrrebbe una bomba atomica spirituale, capace di produrre un mondo nuovo.
L’amore è creazione femminile. Lo è fin dall’inizio, è lei che si sporge verso di lui, che spera di incontrare la vita.
L’iniziativa è di lei: uno scambio di sguardi, un sorriso, l’intuizione di una verità della carne[21], e la decisione di passare all’azione, la determinazione a coinvolgere immediatamente nella relazione l’oggetto del desiderio, a non lasciare sfuggire l’occasione che si offre. Momento delicato che potrebbe non ripresentarsi più[22]. E’ lei dunque che si compromette e che si offre ad uno sconosciuto. Non posso incontrare la bellezza senza avere voglia di sedurla[23].
Leggiamo in Malina dell’incontro con Ivan: E’ bene che io abbia afferrato in un lampo e senza complimenti e senza presentazioni sia andata con Ivan. Questo avvenimento …ha bisogno di un’estrema accelerazione perché possa realizzarsi, già tre frasi sarebbero state troppe.
E’ il germinare di questa che è la potenza unica al mondo perché appunto il mondo è malato e non vuole che venga su questa forza salutare.[24]
I segreti d’alcova con Ivan non vengono rivelati, conosciamo invece quelli di Jennifer in Il buon Dio di Manhattan: Jennifer si offre a lui totalmente, e senza alcuna riserva e attraverso questo mettersi nelle sue mani, in totale abbandono, cerca di trattenerlo e di sgelare il lago gelato che è nel suo cuore.[25]
O amore, che le nostre scorze,
rompesti, gettandole via, il nostro scudo,
la difesa del tempo e la ruggine brunita degli anni![26]
L’amore può essere agente di trasformazione solo se si consente a lasciare che la scorza di protezione dell’io si rompa. Solo così dalle proprie ceneri mescolate nasce la coppia amorosa che ha saputo eternare la felicità dell’unione.
L’amore ha un trionfo e la morte ne ha uno,
il tempo e il tempo che segue.
Noi non ne abbiamo.
Solo tramontare intorno a noi di stelle. Riflesso e silenzio.
Ma il canto sulla polvere dopo,
alto si leverà si di noi.[27]
Sembra che Jennifer abbia vinto e sia riuscita a coinvolgere completamente Jan, ma la disparità tra i due amanti riemerge anche nella tragedia finale. Quando la bomba scoppia nella stanza degli amanti solo lei muore, perché lui ha lasciato la stanza, per un momento…
In Malina la relazione con Ivan fallisce invece perché l’incontro erotico non riesce a trasformarsi in storia d’amore. Ivan non vuole sentimenti. La donna amante sa che amore è una parola impronunciabile, se lei la dicesse Ivan fuggirebbe subito. Non posso dire a Ivan tu sei la gioia, tu sei vita. Ci sono tra loro, nota lei, solo poche frasi, né l’uno né l’altra sanno la storia dell’altro. Ivan non vuole sapere.
Ivan è un uomo dolce ma inafferrabile, di lei e del suo abnorme investimento non vuole farsi carico: Non posso respirare dove tu mi metti .
L’Io che ama Ivan, del quale Ivan avverte la paura, non può raccontare la sua storia. La storia di questo Io, e quella di Franza e la realtà della ferita della città di Berlino, vengono rivelate solo attraverso una prosa onirica e delirante.
Nel ciclo Cause di morte – Malìna, Il caso Franza, Il Libro del deserto – e anche in Luogo eventuale, il discorso pronunciato a Berlino, quando è invitata a ritirare il premio Buchner, Ingeborg Bachmann sceglie di dire il reale attraverso una percezione allucinata: l’incubo, il sogno permettono di esprimere una verità altrimenti indicibile. Non è l’io razionale a prendere la parola, ma l’io ferito, smarrito, distrutto dal dolore: solo in questo io stravolto la verità può rivelarsi.
Ma la notte e da soli nascono i monologhi erratici che rimangono, perché l’uomo è un essere oscuro, è padrone di sé solo nelle tenebre e di giorno ritorna alla schiavitù.[28]
Padrone di sé solo nelle tenebre affermazione paradossale da parte di un io assalito e tormentato da immagini orrorifiche, che accoglie la verità che in esse gradualmente si svela, dove la storia personale, di chi ha sperimentato la violenza su di sé, inerme, affidato, s’intreccia con la densità della storia collettiva, con il rinnovarsi, in un tempo senza fine, della guerra e della violenza. Padroni di sé nelle tenebre non perché in esse ci venga dato il potere di controllare la nostra esistenza o di salvaguardare la vita, ma padroni dell’unica padronanza possibile che è la vicinanza al vero. Schiavi nel giorno, perché nella luce ritorniamo nel mondo ordinario e ordinato, che pretende di essere l’unico mondo reale e possibile, dove ragionevolezza e adattamento, ci inducono a consentire, a confermare e a condividere la menzogna attraverso la quale si instaura il dominio del grande animale (SW) o della bestia, per usare un termine apocalittico che compare nelle sue poesie.
Allora è meglio sragionare, essere folli o tacere. Davanti alla morte, all’orrore, nessuna immagine, meglio scegliere il silenzio.
Due strofe dalla poesia A Voi, parole [29], dedicata a Nelly Sachs, l’amica, la poetessa, con venerazione:
La parola / non farà/ che tirarsi dietro altre parole, /la frase altre frasi./ Così il mondo intende,
definitivamente / imporsi, esser già detto. Non lo dite (…)
non sussurrate nulla, /nulla, dico, all’orecchio supremo,/ che per la morte nulla/ ti venga in mente:/lascia stare, seguimi,/né mite né amara,/non consolatrice/né significativamente/ sconsolante,/ma nemmeno priva di significato-E soprattutto niente immagini/tessute nella polvere, vuoto rotolare/ di sillabe, parole di morte./ Nemmeno una,/ o parole.
Così Ingeborg Bachmann invitata a Berlino nel 1964 a ritirare il premio Buchner, dalla posizione d’autorità e di onore che l’assegnazione del premio le attribuisce, proferisce parole che compongono una descrizione demenziale della città divisa. E gli ascoltatori ne furono irritati: perché parlare proprio di Berlino[30]? Berlino ovest risuona dall’interno di una clinica psichiatrica, gli aerei che riforniscono la città isolata rombano spaventosamente, le suppellettili tremano, le campane di tutte le chiese suonano, le strade si sollevano di 45 gradi, la gente assale i supermercati e lascia sulle scale mobili tutta la merce che ha preso dagli scaffali…quelli che fuggono dall’est vengono interrogati. Sono passati tre anni da quando la città è divisa dal muro: ciò che si mostra è conseguente a qualche cosa che è già avvenuto prima, è un accidente che ritorna.
Alla lettura del suo testo l’autrice premette un breve discorso che spiega perché ha scelto di parlare di Berlino e rappresentare la sua realtà, come essa potrebbe apparire ad una mente stravolta dalla follia[31]. (…) La follia che era nei singoli è uscita all’esterno e imbocca la via del ritorno in situazioni che ci sono divenute familiari nei lasciti della nostra epoca. La divisione della città è una malattia, è una ferita chirurgica. Dire ciò che è impone però di attenersi alla malattia, a una sequenza di variabili immagini di malattia la quale a propria volta produce malattia. Questo obbligo può costringere qualcuno a camminare a testa in giù, perché sia possibile testimoniare di un luogo di cui si potrebbero facilmente riferire centinaia di cose, ma di cui è difficile venire a capo. La sua esposizione è perfettamente adeguata a lui stesso, mai perfettamente adeguata alla cosa, Ma esporre esige radicalizzazione, è un atto obbligato.[32] In questo discorso l’autrice segue le tracce del personaggio principale del romanzo di Buchner, Lenz, un uomo impazzito che, a testa all’ingiù segue la crepa che si è aperta nel mondo, cercando la consequenzialità, la ragione per cui questa crepa si è prodotta e scuote il capo alle spiegazioni che gli vengono proposte. Ingeborg Bachmann afferma: La consequenzialità, il conseguente è quasi sempre qualche cosa di terribile, mentre il liberante, il vivibile viene a noi inconseguentemente.[33]
Anche nel ciclo Cause di morte, il grande manuale progettato per illustrare le cause di morte delle donne, l’autrice vuole mostrare il conseguente: anche la malattia è un conseguente: moriamo infatti di ciò che ci viene fatto. Veniamo, quindi, ad altre pagine visionarie e deliranti nelle quali si svela una guerra tra i sessi le cui origini si perdono nella notte dei tempi. In questa guerra, nella violenza e nella volontà di dominio degli uomini sulle donne, si ritrova la radice di ogni altra forma di violenza sul vivente, su ogni altro essere e su ogni altro popolo. Negli incubi notturni del romanzo Malina e nel delirio di Franza approdata al deserto, si mescolano storie e figure che appartengono all’esperienza personale, sempre trasfigurata, con immagini di violenza e profanazioni che appartengono alla storia collettiva. Scene di deportazioni, e di camere a gas s’intrecciano a scene d’imprigionamenti di figlie disobbedienti, a unioni imposte, all’incesto con il padre, all’aborto obbligato, all’elettroshock nella clinica psichiatrica, alla violenza carnale, all’assassinio. Nella guerra tra i sessi anche lei, come lui, è traboccante di odio, ma impotente a realizzare la sua propria furia omicida. Quando una donna dice a un uomo, ti strozzo, si tratta di una metafora, perché non ha la forza di farlo. la sua rabbia si rivolge quindi contro se stessa: ogni suicidio è un omicidio spostato… L’odio che non trova espressione diviene una tossina mortale, provoca un avvelenamento.
In questa rabbiosa e disperata impotenza va ricercata l’origine delle malattie di cui soffrono le donne. Sembra che muoiano di malattia, dietro la malattia – o dietro all’incidente – c’è un assassinio, ci sono delitti per i quali nessuno sarà chiamato in tribunale.
Negli incubi del romanzo Malina l’assassino ha il volto del padre, o del padre e della madre insieme, una madre che è una cagna adorante, sottomessa, che sopporta il tradimento ed è complice, consenziente al peggio. Si tratta di un grande padre storico, impersonale, che recita il peggiore arbitrio del potere patriarcale e anche dell’aguzzino nazista. L’origine del fascismo è nel rapporto intimo, nel più privato della relazione tra uomo e donna.
Nella storia personale dell’io ferito l’assassino reale non è però il padre, ma, quasi sempre, l’amante più anziano che manipola la donna più giovane e approfitta del suo amore e della sua fiducia. No, non era mio padre, era l’uomo al quale avevo creduto come se fosse mio padre.
La violenza che questo amante mortifero esercita deriva dal suo non saper stare come soggetto di fronte ad un altro soggetto che, pur nell’abbandono, rimane un mistero inesauribile. Allora il vivente dell’altro che si è offerto nell’incontro amoroso viene ridotto ad oggetto, profanato, diviene caso clinico per il marito psicanalista di Franza, diviene oggetto di dissezione letteraria da parte dello scrittore amante.
.. e lei era stata derubata, rapinata di tutte le frasi dette in settecento notti e settecento giorni, frasi buttate là e frasi importanti, giudizi e vestiti, lei in pigiama, lei in bicicletta, lei a un concerto, dov’era la sua vita, era lì. .. perché lui aveva messo sulla carta le loro settecento notti e anche i settecento giorni e le ore di ebbrezza e li aveva squartati, sì si dice squartati, è così che si dice: una volta l’aveva sentito dire, lui l’aveva sbudellata, come un macellaio, di lei aveva fatto salsiccia e arrosto e tutto il resto, lei era macellata nelle 386 pagine di un libro… macellata, bollita e affumicata , come si fa con un porco …[34]
La profanazione da parte dell’amante, che possiede e consuma oggettivando è analoga alla profanazione del segreto delle tombe dei faraoni. Estratti dalla profondità della terra dove li avevano nascosti per preservarli, vengono esposti, disfatti tutti gli involucri protettivi, nella sala delle mummie del museo archeologico del Cairo. Non riuscivo nemmeno a vomitare, sebbene non desiderassi altro che dare a quei porci, a quei profanatori di cadaveri, almeno un segno di disgusto. Un gruppo di turisti arriva e scatta fotografie, discute sulla qualità della pellicola. Era il nostro spirito che lì governava. E la vergogna non ci sopravviveva. Si sono fatti calare in sepolcri così profondi e segreti per sopravvivere[35]
E l’oggettivazione, l’uccisione dello spirito vivente, si opera sempre attraverso un medium tecnico o scientifico: la cartella clinica, le frasi annotate sul diario che registra il materiale per la scrittura, la macchina fotografica, e oggi potremmo aggiungerci i filmati e i ricatti su Facebook.
Quando vengono distrutti la fiducia, il patto dell’intimità, l’onore allora: ciò che non si può più riproporre è quell’orgia di sentimenti fasulli con cui la cultura ha costruito la storia d’amore. inferiorità dei bianchi: hanno dei sentimenti simili a stracci variopinti, un costume di carnevale fatto di, non voglio star qui ad elencarli, visto che sono noti, gelosia, calcolo, tattica, idolatria, umiliazione, tutto strombazzato come amore, cambiamento e rinuncia, qualcosa di assolutamente invivibile…[36]
Ciò che rimane e che guarisce nell’esperienza del deserto è la riduzione dell’io alla vita elementare, la soddisfazione di bisogni essenziali alla sopravvivenza: la buona acqua del Nilo piena di moscerini e di batteri, un piatto di pane e fagioli condiviso da sei mani, il contatto e le carezze di corpi sconosciuti.
Smetterla con i sentimentalismi per recuperare un sentire profondo, basilare, corporeo. Che è di tutti. Abbandonare un Io che chiede qualche cosa per sé.
Nelle ultime pagine di Malina, prima che l’Io femminile amante si estingua, questo personaggio misterioso, che è la figura del suo Io superiore secondo quanto l’autrice ha spiegato, promette, all’io che sta per sparire, un guadagno che deriverebbe dalla sua non azione: l’uscita dalla guerra che è dentro di lei, la scomparsa di nemici immaginari e la fine di vane richieste di riconoscimento.
Il carattere assoluto – estatico come lei lo dice – dell’investimento amoroso da parte dell’io femminile non può trovare risposta adeguata da parte di un uomo, che si trova di fronte ad una domanda per lui incomprensibile. Né lei vede lui, né lui vede lei.
M. – Mai ti ha visto uno dei tuoi nemici, questo non puoi dimenticarlo, e mai visto uno di loro.
Lei – Non ci credo. Ne ho visto uno anche lui ha visto me, non bene, direi.
M. – Ma che strane pretese. Vuoi essere vista bene? Magari anche dai tuoi amici? Nel tuo posto giusto non potrai volere più niente: la sarai talmente te stessa che abbandonerai il tuo Io: sarà il primo posto in cui il mondo venga guarito da qualcuno. Continui a riempirti la bocca con questo Io?Ancora lo nomini? Ma addormentalo un po’! [37]
L’autrice si riprometteva di raccontare, nel seguito del manuale, che cosa sarebbe diventato Malina, una volta depurato della sua parte delirante, ma non ha potuto farlo.[38] Sarebbe rimasto, come era, uno che accetta il mondo così com’è, senza pretendere di mutarlo, o sarebbe divenuto in qualche modo erede anche della speranza che ci possa essere tra i sessi e nell’umanità, non solo guerra, violenza e dominio, ma anche pace ed armonia? Il sogno che uomini e donne possano esprimere la poesia e bontà, propri, in modo diverso, a ciascuno dei due sessi, e la riconciliazione tra di loro e con la terra, che abbiamo incontrato nei frammenti di favola felice, Verrà un giorno, nel primo capitolo di Malina, era destinato a rimanere murato per sempre nella crepa del muro?
La risposta a questa domanda la dobbiamo cercare altrove. Un Io che trova la pace, trasfigurato dopo tante prove e peripezie dolorose, lo ritroviamo infatti nella poesia La Boemia é sul mare che, insieme al testo dell’intervista Verrà un giorno. Conservazioni romane[39], è divenuto il suo testamento spirituale. Il titolo riprende la speranza utopica in un mondo felice, che l’Io amante del romanzo Malina esprimeva nel libro bellissimo per Ivan, e l’autrice legge le poesie alle quali tiene di più, una delle quali sbocciata tardivamente, nel periodo nel quale era passata alla prosa perché sentiva che non c’era nulla nell’aria e continuare a scrivere poesie sarebbe stato solo un fatto di mestiere. Una di queste è appunto La Boemia è sul mare.
Di essa dice: È scritta per tutti, da qualcuno che non esiste. [40]
Questo qualcuno che non esiste cui la poesia dà la parola è l’io che emerge, trasformato dopo la scomparsa dell’io infelicemente amante. E’ un io che ha affrontato la distruzione, che ha percorso fino in fondo la sua passione, che è disceso agli inferi, e che, dopo aver deposto la pena d’amore, dopo aver toccato il fondo, ha raggiunto l’impersonalità, ha perso identificazione e confini, è uno qualunque, che non vuole più niente per sé. E’ un io però che continua a sognare una terra promessa, accogliente per tutti, per tutti i profughi e gli irregolari che ancora sanno mantenere viva la speranza.
Prima di leggerla, come fa l’autrice nel film intervista, qualche indicazione in più che renda più comprensibile questa poesia bellissima, ma densa di richiami letterari[41]. Lo farò seguendo quanto l’autrice spiega in Verrà un giorno.
Dice:. E oggi sono felice di averla scritta… Ed è la poesia che difenderò sempre. È rivolta a tutti gli uomini perché si tratta del paese della loro speranza, che non raggiungeranno mai e tuttavia non devono smettere di sperare, altrimenti non possono vivere. E questa poesia mi rende molto felice, non perché l’ho scritta io, non sono stata io, deve essere stato un altro. Per me rappresenta un dono e io devo soltanto consegnarlo a tutti coloro che non smettono di credere nella loro terra promessa, in quel paese che non raggiungeranno. Sì, non lo raggiungeranno, ma essi non smetteranno di sperare.
È la poesia del mio ritorno a casa, non di un ritorno geografico, ma del mio ritorno spirituale, per questo l’ho chiamata La Boemia è sul mare. Mi era stato chiesto – e mi sono sentita naturalmente onorata – ma ho rifiutato – di scrivere qualcosa – come rappresentante della letteratura tedesca – per l’anno shakespeariano a Stratford on Avon. Io ho risposto: No, non posso. Poi mi è venuto in mente qualcosa, soltanto una singola frase di Shakespeare, vale a dire «la Boemia è sul mare». Sappiamo che ci fu una vivace polemica fra Shakespeare e un suo contemporaneo fra i più intelligenti, Jonson, che gli aveva rinfacciato di essere incolto, un cattivo poeta, di non sapere nemmeno che la Boemia non è sul mare. Quando sono andata a Praga, ho capito che Shakespeare aveva ragione: la Boemia è sul mare. (….) Per questo, per me, tutto finisce lì, … Shakespeare ha ragione, la Boemia è sul mare. È un’Utopia, dunque un paese che non esiste affatto, perché la Boemia non è, naturalmente, sul mare e questo lo sappiamo. Eppure è sul mare. Ecco cosa ci tocca davvero, noi speriamo in un paese e questo paese non esiste ancora e questo paese è la Boemia e questo paese è sul mare. Vale a dire è qualcosa di incompatibile. Non per me, perché io ci credo. E io ci credo tanto, per me rappresenta la speranza e l’unico paese che esiste. E la Boemia per me non significa che sono boema, ma tutti, noi tutti siamo boemi e noi tutti speriamo in questo mare e in questo paese. E chi non spera e chi non vive e chi non ama e chi non spera in questo paese per me non è un essere umano. [42]..
LA BOEMIA È SUL MARE
Se qui sono verdi le case, in una casa entro ancora.
Se qui sono integri i ponti, cammino su suolo sicuro.
Se in ogni tempo pena d’amore è perduta, qui contenta la perdo.
Se non sono io, è un altro ed è un io come me.
Se qui una parola sino a me confina, lascio che confini.
Se la Boemia ancora è sul mare nei mari io credo di
nuovo.
E se ancora nel mare io credo io spero nella terra.
Se sono io, lo è un altro ed è a me uguale
Più nulla per me voglio. Io voglio naufragare.
Al fondo, sì, sino al mare, lì la Boemia ritrovo.
Sul fondo sospinta, sereno è il risveglio.
Ora so dal profondo e più perduta non sono.
Venite boemi voi tutti, gente del mare, puttane dei
porti e navi
disancorate. Non volete essere boemi, illiri, veronesi, e- veneziani voi tutti.
Le commedie recitate che son fatte per ridere
e inducono al pianto e cento e più volte sbagliate,
come me che tanto ho sbagliato e prove mai ho
superato
sì, l’una e l’altra volta le ho superate.
Come la Boemia le ha superate e un bellissimo giorno
il mare le fu donato e adesso è sul mare.
Io confino ancora con una parola e con una terra
diversa,
io confino, anche se poco, sempre più con tutto,
un boemo, un errante, che nulla ha, nulla trattiene,
capace ancora soltanto di vedere dal mare, che è controverso, la terra
della mia Elezione.[43]
[1] Vedi Ingeborg Bachmann Il gioco è finito in Invocazione all’Orsa Maggiore, a cura di Luigi Reitani, Milano SE 1994, p. 13.
[2] Maria Milagros Rivera Garretas Donne in relazione La rivoluzione del femminismo, trad. di Clara Jourdan, Napoli, Liguori ed. 2007, pp.24 sgg.
[3] Ingeborg Bachmann Verrà un giorno. Conversazioni romane, a cura di Judith Kasper, trad. Francesco Malone Genova – Milano, Marietti, ed. 2009, p.89.
[4] Dormiamo, infatti, dormiamo per paura di dover percepire il mondo intorno a noi. Vedi Ingeborg Bachmann Letteratura come utopia, Lezioni di Francoforte, trad. Vanda Perretta, Milano, Adelphi ed. 1993, p.30.
[5] Quel ch’è vero in Invocazione all’orsa maggiore, cit. p.83.
[6] Da Verrà un giorno, cit. p.71.
[7] Ingeborg Bachmann Simultaneo in Tre sentieri per il lago e altri racconti, trad. Amina Pandolfi, Milano Adelphi ed. 1980, p.44.
[8] Vedi Wanda Tommasi La scrittura del deserto, in Diotima, La Magica forza del negativo, Napoli, Liguori, 2005, pp. 163 sgg. e Soglia in Diotima Immaginazione e politica. La rischiosa vicinanza fra reale e irreale, Napoli, Liguori, 2009, pp. 67 sgg.
[9] Vedi Chiara Zamboni Quando il reale si crepa, in La magica forza del negativo, cit. p.99 sgg.
[10] Vedi Giorgio Agamben in In cerca di frasi vere., Introduzione di Giorgio Agamben, Colloqui ed interviste a cura di Christine Koschel e Inge von Weidenbaum, Bari, Laterza 1989.
[11] Ingeborg Bachmann, Malina trad., Maria Grazia Mannucci, Milano, Adelphi ed. 1973, p.294.
[12] Ivi p.283.
[13] Intervista del 5 maggio 1971 ad Ilse Heim in Ingeborg Bachmann in In cerca di frasi vere., cit., p 180- 181.
[14] Judith Butler Sentire ciò che nell’altro è vivente. L’amore nel giovane Hegel, a cura di Mariafilomena Anzalone, Napoli-Salerno, Orthotes ed, 2014.
[15] Ingeborg Bachmann Il buon Dio di Manhattan un negozio di sogni Le cicale, a cura di Cinzia Romani, Milano, Adelphi 1991. cit, p. 176.
[16] Ivi p.172.
[17] Ivi p 142.
[18] Ivi p.172.
[19] Dove la coppia fratello e sorella rappresenta la congiunzione di ragione e sentimento. Vedi Ingeborg Bachmann Il dicibile e l’indicibile. Saggi Radiofonici, trad. Barbara Agnese, Milano, Adelphi ed. 1998, pp. 30 sgg.
[20] Letteratura come utopia, cit. p.30.
[21] Vedi il racconto Un Wildermuth in Ingeborg Bachmann Il Trentesimo anno, trad. Magda Olivetti, Milano Adelphi. 1985.
[22] Vedi nel racconto Tre sentieri per il lago in Tre sentieri per il lago, cit., soltanto che le cose vere non succedono mai o succedono troppo tardi, pp.229-230.
[23] Malina, cit., p.245.
[24] Ivi , p. 35
[25] Il buon Dio cit, p.167.
[26] Da Canti lungo la fuga in Invocazione All’Orsa Maggiore, cit., p.133.
[27] Da Canti lungo la fuga, cit., p.137.
[28] In In cerca di frasi vere, cit , pp.127-128.
[29] A voi, parole, in Ingeborg Bachmann Poesie, a cura di Maria Teresa Mndalari , Parma Guanda ed. 1978, p.153.
[30] Berlino –simbolo di minacciosa disarmonia di Christine Koschel e Inge Von Weidenbaum, p.75, in Ingeborg Bachmann Luogo Eventuale, trad. Bruna Bianchi, Milano , SE ed, 1992.
[31] Luogo Eventuale, cit., p 69.
[32] Ivi, p.71.
[33] Ivi.
[34] Qui in realtà si tratta dell’ amante più giovane, aspirante scrittore, di una grande attrice, della quale profitta per fare carriera Requiem per Fanni Goldmann in Ingeborg Bachmann Il caso Franza, trad. Magda Olivetti, Milano, Adelphi ed, 1988 cit. p.187.
[35] Ingeborg Bachmann Libro del deserto, trad. Anna Pensa, Napoli, Cronopio ed. 1999, p.27.
[36] Ivi, p12
[37] Malina cit., p276
[38] Nell’intervista dell’aprile 1971 a Toni Kienlechner, l’autrice definisce il libro Malina una overture e afferma che nel seguito : Malina ci racconterà che cosa gli ha lasciato l’altra parte del suo personaggio, l’Io, vedi In cerca di frasi vere, cit., p.161.
[39] Pochi mesi prima di morire – nel giugno 1973, sarebbe morta nell’ottobre – Ingeborg Bachmann accetta di girare un film intervista che le è stato proposto da Gerda Haller una giovane donna austriaca alla sua prima prova. Insieme scelgono le parti di Roma da inquadrare e quali presenze umane debbano comparire insieme a lei: il compositore Hans Werner Henze, e l’amica governante Maria Teofili. Henze è omosessuale, e la relazione con lui, profonda e produttiva, è durata decenni, mentre tutte le altre storie d’amore burrascose sono finite. Henze è il vero fratello, quello che per la prima volta l’ha portata in Italia e con il quale ha convissuto a Napoli e a Ischia. Per lui l’autrice ha scritto alcuni libretti d’opera e lui ha messo in musica alcune sue poesie. Il testo dell’intervista rilasciata a Gerda Heller corredato da alcune foto delle inquadrature è stato pubblicato in italiano in un libretto intitolato Ingeborg Bachmann Verrà un giorno. Conversazioni romane trad. Francesco Maione, Milano Marietti ed. 2009.
[40] Ivi p. 88.
[41] Richiami soprattutto a W. Shakespeare: non solo il titolo che allude alla polemica nata dopo la pubblicazione della commedia Racconto d’inverno, ma anche pene d’amor perdute è il titolo di un’altra commedia di Shakespeare, e così i veronesi e i veneziani, invocati, sono personaggi di altre tragedie shakespeariane come Giulietta e Romeo e del Mercante di Venezia.
[42] Verrà un giorno, cit., pp.89-90.
[43] Ivi, p.72-75. BÒHMEN LIEGT AM MEER.
Sind hierorts Hauser grùn, tret ich noch in ein Haus./ Sind hier die Brùcken heil, geh ich auf gutem Grund. / Ist Liebesmùh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern./ Bin ich’s nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich./ Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich’s grenzen./ Liegt Bòhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder./ Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land./ Bin ich’s, so ist’s ein jeder, der ist soviel wie ich./ Ich will nichts mehr fùr mich. Ich will zugrunde gehn,/ Zugrund – das heisst zum Meer, dort find ich Bòhmen wieder./Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf. / Von Grund auf weifi ich jetzt, und ich bin unverloren/ Kommt her, ihr Bòhmen alle, Seefahrer, Hafenhurrn und Schiffe/ unverankert. Wollt ihr nicht bòhmisch sein, Illyrer,Veroneser,/ und Venezianer alle. Spielt die Komòdien, die lachen/ Machen Und die zum Weinen sind. Und irrt euch hundertmal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand, / doch hab ich sic bestanden, ein um das andre Mal. / Wie Bòhmen sie bestand und eines schònen Tag ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt./ Und grenz noch an ein Wort und an ein andres Land, ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr, ein Bòhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts halt, begabt nur noch, vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen.
Fratel Arturo Paoli..."Camminando s'apre cammino"
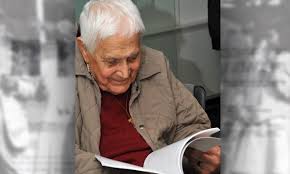
Caro fratel Arturo
Mariano Borgognoni
A 10 ANNI DALLA MORTE DI ARTURO PAOLI
Sono ormai due anni dall’ultima volta che ho portato un fiore sulla tua tomba, in fondo al tratturo che conduce al minuscolo cimitero di San Martino in Vignale. Con esso ho voluto recarti i saluti della comunità dei nostri lettori che hanno goduto della tua presenza di mezzo secolo nella vita della rivista; il primo articolo sul numero 17 del 1967! Come sai Rocca ha voluto e vorrebbe continuare ad essere una sorta di bussola per orientare pensieri e cammini evangelici in questo mondo e in questa società che, da quando te ne sei andato, non ha certo frenato l’erosione di quei valori umani e cristiani per i quali non hai mai cessato di combattere con parole, opere e senza omissioni. Col tuo linguaggio che arrivava dritto alla testa e al cuore di quelli che ti ascoltavano per convinzione o per contrapposizione. Anche tu non le hai mandate a dire, nemmeno alla tua Chiesa, alle sue fragilità, ai suoi tradimenti. Infine sei stato fortunato ad incontrare Francesco, un papa che ha saputo riconoscere la tua testimonianza, quella di Mazzolari, quella di Milani. Speriamo che questo cammino tra i feriti della Chiesa e del mondo possa continuare. Speriamo. Tu ricordalo all’Amico.
Caro Arturo, rammento con nostalgia (non è una malattia quando non impedisce ma aiuta a guardare al futuro) i momenti d’incontro, a Spello, in Cittadella, a Trevi, a casa mia o di qualche amico comune, la tua straordinaria capacità di fare spazio, di dire le parole essenziali, soprattutto di ascoltare e raccontare storie di vita e di volti, esperienze di accoglienza, di fraternità, di solidarietà, di lotta per rendere il mondo più giusto e la Chiesa più cristiana. Sempre contemplazione e strada, contemplattivi, come amate dire voi della famiglia di frere Charles. Non due modi di essere cristiani ma sur la route dell’unità di preghiera e impegno sociale, di adorazione e lavoro manuale e intellettuale costante, di sequela del Signore e fedeltà alla terra. Servire il tempo senza esserne asserviti. Seguire il Signore servendo i più poveri. Tu l’hai fatto con gioia e senza risparmio da piccolo fratello, ad ogni latitudine, da Lucca al deserto, all’Argentina, al Venezuela, al Brasile, a tanti luoghi del nostro Paese, nel lungo percorso della tua vita centenaria spesa fino all’ultimo. E spesa sin dall’inizio collaborando da giovane prete lucchese con il Comitato di liberazione nazionale, contribuendo, con altri confratelli, a salvare la vita a centinaia di ebrei. Con emozione ho scorso il tuo nome scritto sul muro d’onore al Giardino dei Giusti dello Yad Vaschem a Gerusalemme. Ti ho visto felice e sorridente quando, avendo onorato l’Italia, svergognata dalle leggi razziali del fascismo, il 25 aprile 2006, ricevesti dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la Medaglia d’oro al valore civile.
L’ultima tua rubrica rocchigiana, dal 2009 al 2013, si denominava “amorizzare il mondo”, sentivi molto tua questa espressione di Teilhard de Chardin, amouriser le monde, un proposito evangelico ma per te anche un progetto politico nel senso alto che la politica può avere se si propone di essere “la più alta forma di carità” (Paolo VI). Sappiamo quante repliche della storia smentiscono questa utopia eppure il messaggio che ci hai lasciato è il dovere e la passione della perseveranza, la pazienza dell’attesa nel senso di farci carico delle nostre responsabilità e di saper aspettare che i frutti maturino. Il compito è quello che hai detto in un titolo di Rocca: schiodare Cristo dalla croce. Riscoprirne la divinità nell’umanità, organizzare la speranza a partire dal far diventare testata d’angolo la pietra scartata. Mettere lì la punta del compasso per disegnare una circonferenza sociale che ci renda più giusti e quindi più felici.
Caro Arturo come non vedere che questo è un cammino difficile, le guerre di ieri e di oggi, le nuove potentissime gerarchie sociali che mettono insieme tecnologie, soldi e politica come avevi ben intuito mettendoci in guardia, sulla scorta del tuo amato Levinas, da disumanizzanti derive tecnocratiche che nascondono i volti sotto una coltre di cifre inappellabili e sacre, le disuguaglianze crescenti nel nome di una libertà senza vincoli etici e sociali, la demolizione progressiva di ciò che è comune nel conformismo dell’individuo-massa, ci parlano di una ybris quasi invincibile negli umani ; eppure tu continui a indicarci l’Amico (eri davvero un mistico con gli occhi aperti) come pienezza di umanità secondo il sogno di Dio. Un’alternativa alle logiche oppressive, distruttive, ingiuste; gabbie d’oro piene di solitudine e tristezza, anche per coloro che le costruiscono. Ricordo che una volta sulle colline di Spello parlammo, perché eri un uomo di profonda curiosità culturale, della rilettura del mito di Ulisse da parte di Adorno e Horkheimer: quest’uomo dominante che, affinché si potesse resistere al canto delle sirene, non solo rende sordi i suoi servi ma è costretto lui stesso a farsi legare. In ogni caso e malgrado tutto ti immaginerei adesso, nella fragilità del tuo corpo, a far risuonare in modo potente la tua voce profetica che, ad un tempo, denuncia la profondità del male, personale e sociale e annuncia la possibilità e l’urgenza di costruire soggetti e percorsi di liberazione.
Ancora oggi ci diresti di mantenerci aperti allo “spirito buono”, come lo chiamava Sorella Maria, (ricordi? L’amica del padre di tutti gli “eretici” ancora confinato nella damnatio memoriae: Buonaiuti), che ci aiuti a cogliere nella nostra lingua, nella nostra cultura, nel nostro contesto vitale i segni dei tempi, a liberare le relazioni umane dallo sfruttamento, dalla sopraffazione, dalla volontà di potenza e di possesso e ci impegni a riaprire cammini di fraternità. In fondo l’umanità non ha mai abbandonato, con mille errori e tragedie, il sogno di una cosa. Per i cristiani vivere qui e ora almeno uno scampolo della logica del Regno, nell’attesa della sua venuta che restituisca anche agli sventurati di ogni tempo dignità e pienezza. Lo sappiamo, caro fratel Arturo che, anche dentro i luoghi, perfino i migliori, della vita cristiana e laica è complicato vivere la concordia nella diversità, la capacità di ascolto reciproco e di risanamento delle ferite: spesso anzi corruptio optimi pessima (non c’è niente di peggio che la corruzione del meglio). Per questo abbiamo bisogno di donne e uomini che, come te, abbiano la forza mite e tenace di ridirci ogni volta che è possibile percorrere un’altra strada. Che è possibile essere insieme anime aperte, persino grandi, e piccoli fratelli, piccole sorelle, seminatori di futuro.

Il Vangelo secondo fratel Arturo
Massimiliano Castellani
Che sia un giorno di quiete, nella tempesta quotidiana dalla quale tutti noi proviamo a sopravvivere, lo si capisce salendo i tornanti, incorniciati dal verde argentato degli uliveti, che da Lucca conducono a Pieve Santo Stefano. È qui, nella chiesa con annessa canonica messagli a disposizione dall’arcivescovo Italo Castellani, che dopo mezzo secolo, passato ad attraversare il deserto e in soccorso degli ultimi, è voluto tornare fratel Arturo Paoli. Ad aprire la porta della casa è Paola, mamma di due figli e «Vado a preparare il pranzo». Seduta al lungo tavolo, accanto a colui che sembra un magnifico ulivo nodoso e secolare – fratel Arturo domani compie 100 anni –, sta Benedetta, universitaria alle prese con la tesi sul cantautorato di Carmen Consoli e un impiego da commessa al supermercato per sbarcare il lunario. Benedetta è una dei giovani degli "incontri del martedì", quelli dedicati alla lettura e al commento del Vangelo guidati dal sacerdote e piccolo fratello della Congregazione fondata da Charles de Foucauld. Fratel Arturo finisce di leggere con voce attoriale una lettera appena recapitata: «È dello psicanalista Luigi Zoja… Anche io, sa, scrivo solo lettere di mio pugno», poi alza lo sguardo e ci tiene a precisare: «L’idea di un gruppo che si ritrovasse a leggere e a commentare il Vangelo me l’ha data un libro geniale, La prima generazione incredula di don Armando Matteo. Trovo che sia un approccio assolutamente straordinario per loro…». "Loro" sono i ragazzi, proprio come quelli che qui in questo momento sono alle prese con il Vangelo di Matteo. Si incontrano alla sera dopo la scuola o il lavoro e vanno avanti fino a notte fonda, quando fratel Arturo si ritira nella sua cameretta per salutare il nuovo giorno. «Alle 4 sono sul mio letto che aspetto l’aurora, senza di me il sole non se la sente mica di sorgere», sorride divertito e si fa scuro solo quando il ricordo lo riporta a quelle «brevi ore di un pomeriggio d’inverno del 1920», quando a Lucca, in piazza San Michele, vide le "camicie nere" fasciste sparare e uccidere due uomini che assistevano a un comizio socialista. Un trauma, come la morte della giovane amata e poi quella della madre che lo condussero al sacerdozio, «anche se non riuscivo a pensarmi parroco». È diventato un prete spesso "scomodo", che ha cercato di conciliare impegno politico e testimonianza di fede concreta. Dinanzi alla banalità del male, rispose con l’impegno totale, adempiendo alla richiesta dell’allora arcivescovo di Lucca, Antonio Torrini, che a lui e altri tre giovani sacerdoti disse: «Dedicatevi a tutti i perseguitati della terra». In quel periodo della seconda guerra, che definisce «straordinario», riuscì a mettere in salvo centinaia di ebrei, pagando con il carcere. Il 6 agosto, giorno in cui venne liberato da un anonimo tenente tedesco, ancora oggi lo commemora con una Messa. Nella sua memoria sono scolpiti i nomi dei tanti salvati che ne hanno fatto un "Giusto fra le nazioni", a cominciare dallo scrittore ebreo e tedesco, Ludwig Greve, che della scampata deportazione racconta nel libro dedicato a fratel Arturo, Un amico a Lucca. Ricordi d’infanzia e d’esilio. «Ludwig veniva da Cuneo, dopo che suo padre e la sorella erano spariti nel nulla… Appena arrivato, a muso duro mi disse: "Non crederà mica di convertirmi?". Tre giorni dopo, vivendo assieme a noi, rideva di quello che aveva detto. Si salvò vestendosi da prete. Le sue figlie, che ha fatto battezzare in Germania, quando passano per l’Italia non mancano mai di venirmi a trovare». E anche oggi è giorno di visite. Dal Brasile sono atterrati tre amici, parte di quelle comunità di base che fratel Paoli contribuì a creare tra i campesinos e gli affamati dell’America Latina, «dove ho visto realizzato il Concilio Vaticano II. Qui da noi invece, molto spesso li abbiamo dimenticati... Laggiù è ancora accesa la scintilla della sana "ribellione" cristiana. E quella l’ho toccata con mano nelle favelas brasiliane, nel popolo d’Argentina e del Venezuela». Parla come ha vissuto, condividendo speranze e drammi, come quelli dei desaparecidos argentini e subendo anche lui la violenza dei generali che lo cacciarono. «Oggi la forza rivoluzionaria positiva di quei popoli, vorrei ritrovarla nei nostri giovani, ma si sono spenti…». Fissa negli occhi Benedetta che prova a difendersi e a difendere la sua generazione: «Ma Arturo, anche questo modo diverso di vivere il Vangelo con leggerezza e al tempo stesso in maniera estremamente profonda, come ci hai insegnato tu, per noi rappresenta già una piccola rivoluzione…». Fratel Arturo annuisce. Comprende le ragioni dei giovani di un Occidente svuotato e annichilito, e mostra un piccolo libro. "L’anno scorso ho scritto questo pamphlet, La rinascita dell’Italia, in cui denuncio il fatto che non si può tacere delle gravi responsabilità della politica, delle ruberie compiute dai dragoni di una classe dirigente che pare non tenga in nessun conto la povertà crescente del nostro popolo. La deriva politica però, è lo specchio di quella morale... Non si sono mai viste, come oggi, tante "unioni" così frettolose e che altrettanto velocemente poi si sciolgono. L’incapacità di amare è il grande male dell’uomo».Ragionamenti "scomodi" anche per chi potrebbe pensare che la sua "rivoluzione" sia un po’ relativista e a buon mercato. Si rifà all’insegnamento di Teilhard de Chardin, fratel Arturo. «Dobbiamo "amorizzare" il mondo», dice mentre accarezza l’immaginetta del suo Charles de Foucauld («il 1° dicembre - ricorda - è il giorno della sua morte»), in cui sta scritta la massima: «Jamais avoir peur», mai dobbiamo avere paura. «Già, non dobbiamo temere neppure il "vuoto"». Fratel Arturo lentamente si alza e chiede con permesso se può andare a riposarsi un po’ nella sua stanza. Riappare dopo una mezz’ora e confessa: «Ho imparato da Beethoven che durante la giornata è necessario fare delle piccole soste di sonno... Il mio tempo è pieno di letture. Testi religiosi certo, ma anche tanta letteratura, a cominciare dai miei amati sudamericani, a cominciare da Jorge Amado. Il fatto di scrivere (Aragno ha appena ripubblicato il suo Dialogo della libertà e di venire considerato un intellettuale all’inizio è stato un ostacolo per entrare nella Congregazione dei Piccoli Fratelli. Da loro ho appreso tanto e più vado avanti e più mi convinco che il cristianesimo va ricercato nell’opera del contadino. Come dice il mio amico Ivo, piccolo fratello nella comunità di Spello: "Degno di Cristo, è chi affonda le mani tutti i giorni nella terra madre"». Nell’orto fuori dalla canonica, le mani nella terra le affonda Camillo, 84 anni - uno degli "ex ragazzi" di fratel Arturo - assieme al giovane Valentin, il figlio di Paola che dice raggiante: «Coltivano di tutto, in casa abbiamo pomodori grandi come cocomeri». Benedetta apparecchia la tavola, Paola serve la pasta. Sono tutte volontarie, come «quell’angelo della Piera che appare e scompare, in silenzio», dice fratel Arturo che non ha mai voluto una perpetua «perché anche la migliore con il tempo diventa un triste sottoprete. Molto meglio affidarsi alla Provvidenza». È quella che spinge tanti a salire fin quassù in questa oasi di San Martino in Vignale, per parlare e ascoltare la sua voce che incanta con le omelie della domenica. «Per me sono una ferita aperta. Dopo ogni omelia fatico a riprendermi. E non è perché ora porto un secolo sulle mie povere spalle, ma accade da quando il Cristo, il mio Amico, ha cominciato a parlarmi. E tutto questo è iniziato tanto tempo fa…».
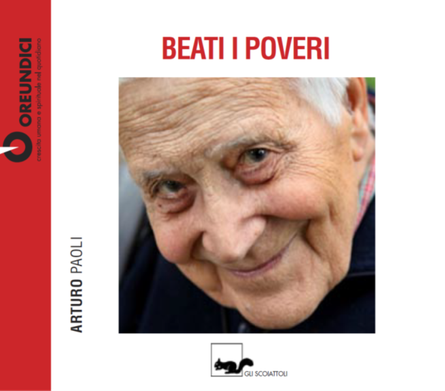
Uno scritto giovanile racconta il salvataggio degli ebrei
Arturo Paoli
Nel settembre 1943 gli oblati di Lucca vennero a conoscere il signor Giorgio Nissim di Pisa, delegato della Delasem (Delegazione per l’assistenza degli emigranti ebrei), il quale li pregò di aiutarlo nella sua attività a favore dei correligionari perseguitati dalle leggi razziali. Con la benedizione e l’incoraggiamento di monsignor arcivescovo, che mise a disposizione anche dei mezzi pecuniari, subito gli Oblati iniziarono la loro opera di assistenza. Un primo gruppo di 18 persone furono portate da Livorno, delle quali 5 furono ricoverate presso l’Istituto dei Poveri Vecchi (Monte San Quirico) e 13 furono avviate a Formentale, in una casa che l’animo caritatevole dei padri Certosini aveva messo a disposizione, dopo che tutte furono ristorate presso le suore di santa Dorotea e le suore Barbantini. Un secondo gruppo di 30 persone, composto in più parte di donne anziane e ammalate o deboli, furono ricoverate presso le suore di Santa Zita, presso le quali furono poi collocate anche altre donne.Molte altre famiglie furono sistemate in case private, sia in città come in campagna, approfittando in molti casi dell’ospitalità dei parroci, che occultavano nelle proprie canoniche questi perseguitati fino a che non fosse stato trovato un rifugio maggiormente sicuro. Il contatto e il collegamento dei parroci con gli Oblati, per questa opera di ospitalità e di assistenza, passò sopra ogni pericolo e ogni difficoltà, mostrando praticamente la grandezza della carità cristiana. La casa degli Oblati restò sempre per tutti gli israeliti di passaggio a Lucca come punto di ritrovo, di conforto e di smistamento. Da un calcolo sommario degli israeliti che sono passati per Lucca, il loro numero non deve essere inferiore agli 800.Permanentemente trovarono asilo nella casa degli Oblati tre giovani israeliti, che altrove non potevano trovare posto perché più compromettenti. Rimase anche nella casa il signor Nissim, che fu sempre in stretto collegamento con gli Oblati sia quando si recava a Genova, Firenze, Pisa, Livorno o altre minori località, per prendervi le persone che maggiormente si trovavano in pericolo, come per la distribuzione dei fondi che aveva prelevato a Genova, coi quali nella città e provincia gli Oblati e il signor Nissim davano sussidi a tutti gli israeliti bisognosi. Ma non solo un sussidio mensile o altra assistenza in denaro veniva dato agli israeliti, ma pure venivano riforniti di indumenti e di generi alimentari, come di carte annonarie quando era possibile esserne riforniti e di tessere di riconoscimento sotto altro nome. Era infatti nella casa degli Oblati che il detto signor Nissim aveva impiantato un ufficio per la preparazione dei documenti necessari all’occultamento, con tutta l’attrezzatura di timbri e stampati procurati clandestinamente ed era un sacerdote degli Oblati che lo aiutava nel delicato lavoro.Degli israeliti occultati dagli Oblati nessuno è stato catturato dai tedeschi, nonostante che qualcuno abbia corso serio pericolo nei rastrellamenti degli ultimi giorni di dominazione, sia in città come nella campagna. Fatti degni di particolare menzione sono: 1) L’assistenza prestata a una giovane signora estera, che vicina a essere madre fu ricoverata presso le suore Barbantini, le quali poco tempo innanzi avevano corso serio pericolo in una minuziosa perquisizione fatta loro nei locali della clinica. Quella signora poté dare alla luce una bambina e non fu denunciata all’ufficio anagrafe; 2) l’assistenza a una signora scesa con il figlio dai monti di Cuneo, dove si era rifugiata fuggendo dalla Francia, e che arrivò gravemente ferita a una spalla e a un braccio per uno scontro tra partigiani e soldati tedeschi, e fu necessario sottoporla per due volte ad atto chirurgico. Anche le suore Mantellate e Passioniste, con l’obbedienza di monsignor arcivescovo accolsero israeliti nei loro monasteri e furono generose di assistenza morale e materiale. Né può essere dimenticata l’assistenza prestata dai medici Enea Melosi, Frediano Francesconi, professor Tronci ostetrico, in ogni caso ad essi presentato, come non può essere dimenticata l’assistenza prestata dalla baronessa Elza di Sardagna agli israeliti, la quale si tenne in contatto con gli Oblati fino a che non fu uccisa dalle Ss tedesche. Dal mese di gennaio 1944 si raccoglieva periodicamente a Lucca nella casa degli Oblati del Volto Santo il Comitato di liberazione nazionale, che teneva le sue adunanze nei locali della casa. Questo è avvenuto fino a pochi giorni avanti la liberazione della città, perché a causa di lettere anonime intercettate alludenti a tali adunanze e facenti i nomi delle persone più in vista che vi prendevano parte, fu conveniente interrompere le adunanze stesse anche perché i membri del Comitato, essendo ricercati, si erano messi in salvo in luoghi sicuri, mentre l’opera dei sacerdoti Oblati veniva in dette lettere classificata come contraria alla repubblica fascista e all’esercito tedesco. Ma la casa degli Oblati restò ancora come luogo di ritrovo ai membri del Comitato e come punto di arrivo e di partenza per le notizie interessanti la liberazione della città. Trovarono inoltre asilo nella nostra casa 22 giovani, in maggior parte membri di bande di patrioti, scesi in città dietro ordini del Comitato, per prepararsi all’azione, qualora ce ne fosse stato bisogno, nella liberazione della città.
Padre Giovanni Vannucci..la libertà del Vangelo
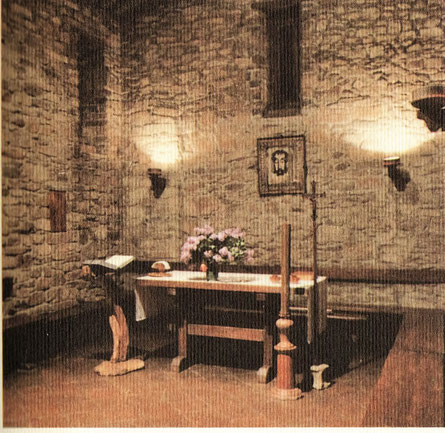
Il sogno di padre Giovanni si può leggere ancora oggi sulla soglia delle Stinche: «In questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e, libero da costrizioni, potesse raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace, di riflessione per ogni viandante che vi giunge, un posto dove l’ideale diventa realtà e dove la gioia è il frutto spontaneo»

Una tenda vi basti a riparo
dalle bufere e Dio ritorni vagabondo
a camminare sulle strade
a cantare con voi i salmi del deserto
Giovanni Vannucci

Aprirsi all'abbraccio divino
“Tra noi e Cristo c’è uno spazio di silenzio. E allora dobbiamo andare a lui profumandoci di silenzio. Immergendoci in questo silenzio raggiungere Cristo attraverso questo spazio di deserto, di silenzio, di solitudine, che non è terreno: è uno spazio di anima”. (G.V.)
Di fronte al diluvio universale di questa epoca, diluvio di parole e di immagini, è necessario costruirsi un’arca di silenzio per incontrare se stessi, e, nella profondità di sé, aprirsi all’abbraccio divino.
“Il silenzio è quello spazio in cui il divino non è più invocato, ma presente nel cuore”. La preghiera è l’attività specifica dell’uomo che cerca di comprendere il silenzio, che è aldilà delle cose, dell’uomo, delle parole, dei riti, delle formulazioni dottrinali, e che conferisce un senso e un valore al tutto.
In questo senso la preghiera costituisce l’attività più vera e incisiva dell’uomo. "Sentitevi, al mattino e alla sera, nell’ora da voi scelta, come creature che salgono verso lo Spirito con atto di perfetto culto. Fate tacere tutte le voci che vengono dalla terra e dal sangue; e compiendo l’atto di totale offerta di voi allo Spirito vi sentirete invasi lentamente da una forza nuova che darà calore e alimento a tutta la vostra vitalità, anche a quella fisica. Insistendo in questo esercizio, lentamente ma infallibilmente, raggiungerete la pacificazione di voi stessi. Rientrando nell’esistenza, guarderete le creature con i sensi purificati, avrete nuove capacità mentali, il vostro giudizio sulle realtà terrene sarà più esatto e più preciso, perché le osserverete dal punto di vista dell’eternità. Sentirete, ad esempio, come la vostra parte irascibile viene gradatamente riordinata, troverete l’elemento positivo di tutte le vostre passioni, e soprattutto incomincerete ad apprendere cosa significa amare”
(Fraternità di Romena, Perché pregare?, Anno XIV n°3/2010)

Padre Giovanni Vannucci
«Vi siete ricordati di aprire il pollaio?». Sono queste le ultime parole di padre Giovanni Vannucci, la mattina del 18 giugno 1984, mentre lo stanno caricando sull’ambulanza a seguito del devastante infarto che lo porterà alla morte. Sembra la frase di una mente confusa, invece sono le parole che forse più di altre rappresentano la vita, il pensiero e la fede di quest’uomo coltissimo (docente di ebraico e Sacra scrittura, lettore assiduo e onnivoro: la sua biblioteca conteneva più di 12 mila volumi) approdato con il tempo alla semplicità dei santi.
Con le sue scelte spesso controcorrente e che gli attirarono severi giudizi da parte dell’allora Chiesa istituzionale, precorse di quasi un ventennio lo spirito del Concilio. Uomo della Parola e del silenzio, animo mistico eppure immerso nella vita quotidiana, sacerdote aperto all’incontro con ogni uomo e donna di qualsiasi estrazione, provenienza o credo religioso, a padre Giovanni per anni non fu perdonata la grande libertà di pensiero e di azione che gli aveva donato il Vangelo.
Nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, secondogenito di una famiglia numerosa, Vannucci decide di entrare, nel 1926, nel convento fiorentino dei Sette Santi Fondatori (Servi di Maria). Dopo gli studi e la professione solenne – il 13 ottobre 1936 –, si dedica all’insegnamento dell’esegesi biblica e della lingua ebraica per dieci anni. Nello stesso periodo frequenta il Pontificio Istituto Biblico e l’Ateneo pontificio «Angelicum».
I lunghi studi non lo allontanano però dalla vita concreta. Anzi, in là con gli anni amerà dire ai novizi: «Voi potete conoscere a memoria tutti i manuali di pedagogia, di filosofia e di morale, e magari poi non riuscite a trattare concretamente con gli uomini che vengono a chiedervi un aiuto, un consiglio. Potete avere un bagaglio di nozioni teoriche immense, ma che diventano assolutamente inutili se in voi manca l’attenzione, l’apertura totale alla vita, al mistero dell’esistenza». Per lui, infatti, conoscenza e cultura hanno un unico scopo: aprirsi all’amore. «Bisogna conoscere per amare di più», suole ripetere. Negli studi e nell’insegnamento manterrà sempre «l’animo del cercatore di Dio – scrive Massimo Orlandi nel bel volume Giovanni Vannucci custode della luce, edizioni di Romena –, poco interessato alle speculazioni e alle teologie cerebrali e invece immerso nella Parola, per svelarne il senso simbolico e liberarne la luce». Uno stile che preoccupa non poco i suoi superiori che gli negheranno più volte il permesso di avviare forme comunitarie innovative e originali.
Nella ricerca di risposte per il suo animo inquieto, bisognoso di «verità e vita», padre Giovanni approda a Campello, nelle colline umbre. Si tratta di un eremo fondato vent’anni prima da sorella Maria, che vi abita insieme ad altre donne. «Maria – scrive ancora Massimo Orlandi – ha scelto la via dell’eremo non per creare un nuovo Ordine ma, al contrario, per liberare la sua esperienza di religiosa dai limiti imposti da strutture e barriere confessionali».
La libertà che respira in questi luoghi sarà decisiva per Vannucci che qui si sente «nascere una seconda volta». «L’eremo – confiderà riferendosi a Campello – è stato uno dei doni più grandi che il Signore mi ha concesso, la terra dove il sogno e la missione del monachesimo trovano un compimento che aiuta a sperare e a vivere». Qui padre Giovanni sperimenta l’ecumenismo «della base», quello semplice, concreto, che lo porterà a dire, avanti con gli anni: «Le religioni sono come i raggi di una ruota: tutti portano verso il centro». A Campello abita, infatti, anche una sorella anglicana e si mantengono contatti con fratelli protestanti e di altre confessioni. Siamo nel 1948, e l’apertura di Maria non può ancora essere compresa: vive pertanto una condizione di emarginazione all’interno della Chiesa, che però non la spegne. Da quelle colline lei tiene rapporti con personaggi del calibro di Gandhi e Albert Schweitzer: «L’eremo ci tiene in comunione con i santi, con i grandi, con i poveri e i derelitti, con le stelle, con i fiori, con l’universo. È come una scala dalla terra verso il cielo» scrive. Lo stile appreso a Campello segnerà padre Giovanni per la vita.
Nel frattempo la situazione di Vannucci a Roma si fa sempre più delicata. «Il suo spirito libero e innovatore, l’attenzione profonda ai miti di tutte le religioni – ricorda ancora Orlandi – lo pongono, per le autorità ecclesiastiche, nella zona d’ombra che si avvicina all’eresia».
In questo periodo padre Giovanni scriverà: «Soffriamo perché vediamo che tutta la nostra attività non incide nella storia degli uomini. C’è troppa separazione tra monaci e popolo». Mosso da questa convinzione, decide di abbracciare l’esperienza della neonata comunità di Nomadelfia. Fondata da don Zeno Saltini, quest’ultima è socialmente strutturata per poter vivere concretamente il Vangelo: non esiste proprietà privata né denaro e vi è un’apertura totale delle famiglie all’accoglienza di figli in affido. Nel 1950, con altri sei confratelli, Vannucci decide così di trasferirsi in Maremma, dove la comunità ha aperto una sede. «Non è una defezione – appunterà in quel periodo – ma è il portare alle sue estreme conseguenze la nostra vocazione iniziale. Nomadelfia costituisce un esempio vivente di un perfetto accordo della vita umana col Vangelo e del cristiano con la storia del tempo nel quale vive».
Anche questa esperienza, però, è destinata in breve a concludersi. Nell’estate del 1951 il Sant’Uffizio obbliga i religiosi a rientrare «sotto l’obbedienza dei superiori». Una ferita profonda, ma che non domerà lo spirito di Vannucci.
Rielaborato il dolore, dopo qualche anno è di nuovo in campo. Chiede infatti ai superiori di poter avviare una nuova forma di vita comunitaria: una fraternità dedita alla preghiera e al lavoro, ma aperta all’accoglienza. La scelta ricade sull’eremo di San Pietro alle Stinche, nel Chianti, dove padre Giovanni può ritirarsi, complice anche l’ormai mutato clima ecclesiale post-conciliare (siamo nel 1967).
Padre Giovanni trascorrerà alle Stinche il resto della vita. Si rifiuterà sempre di scrivere una regola per la sua comunità: quello che propone è uno stile di vita. L’eremo, nel suo progetto, non è una via di fuga, ma un luogo in cui posare il capo, scaricare i pesi troppo gravosi, riempirsi gli occhi, la mente e il cuore di bellezza, e ripartire. Chi arriva non deve giustificare la sua presenza, ma solo condividere la semplicità della vita dei fratelli. È la libertà dei figli di Dio.
Card Martini..Profeta del novecento

All'alba ti cercherò
Signore, provoca anche noi!
Passa in mezzo a noi, dovunque siamo,
sia che ci troviamo tra la folla,
sia che ci troviamo nel luogo della preghiera,
sia che ci troviamo nelle realtà della vita quotidiana!
Fa' che non ci sia differenza tra l'una e l'altra,
che non abbiamo a rinnegare nella vita quotidiana
colui che sul monte vogliamo conoscere.
Fa' che ci sia unità tra i diversi momenti della nostra esistenza!
Signore, attraverso la contemplazione di te che risvegliandoti dal sonno e risorto dalla morte mi dai fiducia,
sciogli, ti prego, i miei timori, le mie paure, le mie indecisioni,
i miei blocchi nelle scelte importanti, nelle amicizie, nel perdono, nei rapporti con gli altri,
negli atti di coraggio per manifestare la mia fede.
Sciogli i miei blocchi, Signore!
Card Martini

Signore, Tu sei la mia lampada,
Ti prego, Signore
di rischiarare la mia lampada che è la
preghiera:
preghiera che fa fatica ad accendersi,
che non è splendente come vorrei.
Ti chiedo Signore di rischiararla
e però vorrei con più audacia,
fare mie le parole di Davide: tu sei la mia lampada.
Non voglio quindi preoccuparmi troppo
della mia preghiera nella certezza che tu sei
la mia lampada, il sole dalla mia vita.
Donaci, o Signore Dio nostro, di capire il mistero della preghiera.
Donami di coltivare la terra con umiltà e
semplicità di cuore, a imitazione della Vergine Maria.

Donaci, Signore,
una vera, nuova e più approfondita
conoscenza di te.
Anche attraverso le parole
che non comprendiamo,
fa' che possiamo intuire con l'affetto del cuore
il mistero tuo che è al di là di ogni comprendere.
Fa' che l'esercizio di pazienza della mente,
il percorso spinoso dell'intelligenza
sia il segno di una verità
che non è raggiunta semplicemente
coi canoni della ragione umana,
ma è al di là di tutto
e, proprio per questo, è la luce senza confini,
mistero inaccessibile e insieme nutritivo
per l'esistenza dell'uomo,
per i suoi drammi e le sue apparenti assurdità.
Donaci di conoscere te, di conoscere noi stessi,
di conoscere le sofferenze dell'umanità,
di conoscere le difficoltà
nelle quali si dibattono molti cuori
e di ritornare a una sempre nuova
e più vera esperienza di te. Amen.

Carlo Maria Martini: Chiesa e postmodernità
Francesco Cosentino
Lo scorso 31 agosto è stato celebrato l’ anniversario della morte del cardinale Carlo Maria Martini. Una memoria che non si spegne, ma continua ad ardere nel cuore della Chiesa proprio come il fuoco di quella Parola di Dio di cui egli fu instancabile studioso, maestro e annunciatore. Sarebbe naturalmente impossibile racchiudere in poche parole la ricchezza di un profilo e di una spiritualità, che hanno fortemente segnato la Chiesa e il cattolicesimo italiani.
Affascinato dalla Parola di Dio, vero faro della sua esistenza sacerdotale ed episcopale, egli fu una figura sobria e austera, un comunicatore semplice ma mai banale, e soprattutto un uomo capace di leggere e interpretare la vita, i problemi e gli aspetti della società con un discernimento intelligente, aperto, sereno e lungimirante. Per lui, la fede era il grande rischio della vita e non una passiva consolazione, e ciò lo rese affascinante ed empatico anche agli occhi di molti non credenti, toccati dal suo stile e dalla sua visione.
Vorrei soffermarmi, però, su un tema che mi sembra particolarmente attuale, trattato dal cardinale Martini in un articolo pubblicato da Avvenire il 27 luglio 2008 dal titolo “Quale cristianesimo nel mondo postmoderno”.
Martini cerca di spostare il baricentro del giudizio dominante dell’ambito ecclesiale e teologico che, purtroppo, ancora oggi, appare piuttosto risentito nei confronti del mondo moderno, facendo emergere tutta la nostra difficoltà a far pace con la perdita di spazio e di rilevanza della fede.
Emergono talvolta da più parti, infatti, alcuni rigurgiti polemici, rigidi moralismi, valutazioni negative, atteggiamenti rancorosi e lamentosi e un’apologetica che il grande teologo francese de Lubac definirebbe aggressiva e difensiva.
Secondo Martini, invece, ci troviamo in un momento di crisi della fede e in mondo pieno di problemi e di sfide, ma, tuttavia, «non vi è mai stato nella storia della Chiesa un periodo così felice come il nostro». Infatti, continua il cardinale, «la nostra Chiesa conosce la sua più grande diffusione geografica e culturale e si trova sostanzialmente unita nella fede, con l’eccezione dei tradizionalisti di Lefebvre».
Non solo: «Nella storia della teologia non vi è mai stato un periodo più ricco di quest’ultimo. Persino nel IV secolo, il periodo dei grandi Padri della Cappadocia della Chiesa orientale e dei grandi Padri della Chiesa occidentale, come san Girolamo, sant’Ambrogio e sant’Agostino, non vi era un’altrettanto grande fioritura teologica. È sufficiente ricordare i nomi di Henri de Lubac e Jean Daniélou, di Yves Congar, Hugo e Karl Rahner, di Hans Urs von Balthasar e del suo maestro Erich Przywara, di Oscar Cullmann, Martin Dibelius, Rudolf Bultmann, Karl Barth e dei grandi teologi americani come Reinhold Niebuhr, per non parlare dei teologi della liberazione (qualunque sia il giudizio che possiamo dare di loro)».
Partendo da questa visione positiva, ci si può inoltrare nel complesso tempo postmoderno senza indulgere alla rassegnazione lamentosa o al risentimento.
Al cardinale non sfugge la problematicità della visione postmoderna della vita e della società, che si configura come una mentalità di opposizione nei confronti del modo in cui abbiamo concepito il mondo fino ad ora e che promuove un’istintiva preferenza per i sentimenti, per le emozioni e per l’attimo presente, invece che per i grandi progetti e ideali.
Naturalmente, in questo clima si fanno strada il rifiuto o un certo giudizio negativo nei confronti della morale, un sentimento anti-istituzionale che penalizza anche la Chiesa, nonché ciò che Martini chiama «il rifiuto del senso del peccato e della redenzione».
Questi aspetti potrebbero facilmente gettare lo spirito del cristiano nello scoraggiamento oppure orientarlo verso un atteggiamento ostile e controversista. Al contrario, nello spirito ignaziano che gli era proprio, il cardinale Martini afferma che occorre un vero discernimento spirituale, capace di osservare la realtà con gli occhi di Dio e di cogliere perciò il grano buono nel mezzo della zizzania.
A ben guardare – afferma sorprendentemente – «forse questa situazione è migliore di quella che esisteva prima. Perché il cristianesimo ha la possibilità di mostrare meglio il suo carattere di sfida, di oggettività, di realismo, di esercizio della vera libertà, di religione legata alla vita del corpo e non solo della mente. In un mondo come quello in cui viviamo oggi, il mistero di un Dio non disponibile e sempre sorprendente acquista maggiore bellezza; la fede compresa come un rischio diventa più attraente. Il cristianesimo appare più bello, più vicino alla gente, più vero».
La lettura è degna di attenta riflessione. La crisi di un certo cristianesimo sociologico, la perdita di rilevanza pubblica della Chiesa e la riduzione del suo potere sociale, così come la mentalità “liquida” che presiede le visioni e l’agire dei nostri contemporanei non rappresentano un “luogo” totalmente negativo per la fede cristiana; al contrario, la crisi diventa e può essere un’occasione per riscoprire un cristianesimo nuovo, che non si instaura più per un influsso sociale o per tradizione culturale, ma si situa nel cuore della gente grazie alla freschezza e alla novità del Vangelo, e diventa attrattiva per il fatto di mostrarsi come una sfida, un rischio, una possibilità di realizzare una vita umana qualitativamente differente.
Insomma, la crisi di un cristianesimo tradizionale e sociologico potrebbe indurre alla riscoperta di una fede viva, fondata sulla Parola, radicata nell’esperienza spirituale e, certamente, più consapevole, più responsabile e più adulta.
Non è superfluo ricordare che Benedetto XVI ebbe a fare la stessa analisi parlando ai cattolici di Germania nel 2011, ricordando loro che «in un certo senso, la storia viene in aiuto alla Chiesa attraverso le diverse epoche di secolarizzazione, che hanno contribuito in modo essenziale alla sua purificazione e riforma interiore… Liberata dai fardelli e dai privilegi materiali e politici, la Chiesa può dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo intero, può essere veramente aperta al mondo». Anni addietro, l’allora professor Ratzinger aveva già parlato di una “Chiesa minoranza”.
In tale direzione, Martini esorta il lettore citando san Paolo: «Esamina tutto con discernimento; conserva ciò che è vero; astieniti dal male» (1Ts 5,21-22). In questo esercizio, il cardinale afferma che, nel tempo postmoderno, la fede è una vera e propria sfida, per affrontare la quale servono quattro attitudini, che vale la pena non solo di enumerare, ma anche di meditare citando le sue stesse parole:
«Non essere sorpreso dalla diversità. Non avere paura di ciò che è diverso o nuovo, ma consideralo come un dono di Dio. Prova ad essere capace di ascoltare cose molto diverse da quelle che normalmente pensi, ma senza giudicare immediatamente chi parla. Cerca di capire che cosa ti viene detto e gli argomenti fondamentali presentati. I giovani sono molto sensibili a un atteggiamento di ascolto senza giudizi. Questa attitudine dà loro il coraggio di parlare»;
«Corri dei rischi. La fede è il grande rischio della vita. “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà” (Mt 16,25)»;
«Sii amico dei poveri. Metti i poveri al centro della tua vita, perché essi sono gli amici di Gesù che ha fatto di se stesso uno di loro»;
«Alimentati con il Vangelo. Come Gesù ci dice nel suo discorso sul pane della vita: “Perché il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo” (GV 6,33)».
Si tratta di un vero e proprio programma spirituale e pastorale, che non si preoccupa degli spazi da occupare e dei trionfi sociali da raggiungere, ma di sviluppare una spiritualità capace di generare luce nel mondo e di aprire strade al Vangelo; per dar vita a queste quattro attitudini, infatti, Martini propone quattro esercizi: la lectio divina perché è la Parola di Dio che nutre la vita e apre all’incontro con Dio; l’autocontrollo, perché saziare tutti i desideri senza discernimento può portare alla noia e alla sazietà; il silenzio, perché «dobbiamo allontanarci dall’insana schiavitù del rumore e delle chiacchiere senza fine, e trovare ogni giorno almeno mezz’ora di silenzio e mezza giornata ogni settimana per pensare a noi stessi, per riflettere e pregare»; infine, l’umiltà, cioè «non credere che spetti a noi risolvere i grandi problemi dei nostri tempi. Lascia spazio allo Spirito Santo che lavora meglio di noi e più profondamente. Non cercare di soffocare lo Spirito negli altri, è lo Spirito che soffia. Piuttosto, sii pronto a cogliere le sue manifestazioni più sottili».
Anche in un tempo difficile, indifferente e per certi versi ostile alla fede e alla Chiesa, Dio continua a bussare. Tante persone, anche inconsapevolmente, sono inquietate da domande diverse e dal desiderio di vincere il grigiore della routine e la staticità delle abitudini. Il Vangelo continua in qualche modo a suscitare stupore e la figura di Gesù crea ancora scompiglio. Ciò che manca, forse, è un cristianesimo, una Chiesa e dei cristiani capaci di quello sguardo e di quelle attitudini, che il cardinal Martini ha voluto ricordarci.
Non è un caso se questo invito, oggi, in una nuova stagione ecclesiale ricca di sorprese, ci viene proposto da papa Francesco. Proprio il pontefice ha affermato: «la nostra missione di battezzati, di sacerdoti, di consacrati, non è determinata particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano, ma dalla capacità che si ha di generare e suscitare cambiamento, stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù, in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze… Penso che la preoccupazione sorge quando noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter essere significativi solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con la capacità che abbiamo di “lievitare” lì dove ci troviamo e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare apparentemente benefici tangibili o immediati. Perché essere cristiano non è aderire a una dottrina, né a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro, un incontro con Gesù Cristo».
Su questa strada, tracciata profeticamente da Carlo Maria Martini, siamo ancora in cammino.

Card. Martini: il silenzio che apre all’ascolto e sfocia nel dialogo
Marco Vergottini, teologo, a lungo collaboratore dell’allora arcivescovo di Milano, segnala i punti di contatto nella figura e nel pensiero dell’attuale pontefice e del biblista che fu sulla cattedra di Ambrogio dal 1979 al 2002
“La passione per l’evangelo, la parresia, l’invito a uno stile di Chiesa sinodale, la lotta per la giustizia e il perdono, l’attenzione ai poveri”: sono questi i tratti che avvicinano - oltre ovviamente alla scuola ignaziana - due gesuiti come Jorge Mario Bergoglio e Carlo Maria Martini. Così come non mancano le differenze: nel “temperamento”, nella formazione e nel “curriculum ecclesiastico”. È Marco Vergottini, teologo, a lungo collaboratore dell’allora arcivescovo di Milano, a segnalare i punti di contatto nella figura e nel pensiero dell’attuale pontefice e del biblista che fu sulla cattedra di Ambrogio dal 1979 al 2002. Di Martini si ricorda il terzo anniversario della scomparsa, avvenuta il 31 agosto 2012: in tale occasione ha visto la luce il volume “Martini e noi”, curato da Vergottini, con 111 testimonianze di “cardinali, vescovi, intellettuali, teologi, giornalisti e soprattutto uomini e donne che sono stati segnati dal rapporto con le sue parole, con i suoi scritti, con la sua persona”.
In dialogo con il suo tempo. Al termine del lungo lavoro attorno al volume, Vergottini riconosce che alcuni tra coloro che raccontano della personale conoscenza col card. Martini, “hanno scoperto o impresso una nuova direzione alla propria vita proprio nell’incontro con lui, nell’ascolto del suo magistero episcopale a Milano durato 22 anni, continuato dalle cattedre di Gerusalemme e Gallarate”. Gli scritti presentati in “Martini e noi” e raggruppati per capitoli, delineano del resto una sorta di indice della biografia martiniana: il credente e la vita spirituale; il biblista e Gerusalemme; il vescovo e la sua Chiesa; l’uomo del dialogo ecumenico e interreligioso; il pastore e le forme della comunicazione; l’intellettuale e la polis. Vergottini, che ha alle spalle diversi studi sul porporato, puntualizza: “Se Martini ha potuto sorprendere la Chiesa di Milano per l’insistenza con cui ha richiamato il primato della dimensione contemplativa, pure egli ha ricercato con intensità, curiosità e audacia - da taluni ritenuta quasi spericolata - di entrare in dialogo con le donne e gli uomini di oggi per incalzarli a riflettere sul senso dell’esistenza e sollecitarli all’incontro con il Padre di tutti, riscuotendo interesse e attenzione nel mondo laico, come nessun’altra personalità del mondo cattolico”.
Silenzio che genera ascolto. Tra le firme del volume, edito da Piemme, figurano il cardinale Ravasi, il priore di Bose Enzo Bianchi, il patriarca ecumenico Bartolomeo I. E poi Cacciari, Cazzullo, De Bortoli, Giorello, Lerner, Mancuso… Tanti gli amici del lungo periodo milanese di Martini. Tra questi proprio Ravasi, nominato da Martini nel 1989 prefetto della prestigiosa Biblioteca Ambrosiana. Nel suo scritto, Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, sottolinea soprattutto un aspetto del cardinale di origine piemontese: “Il silenzio autentico genera l’ascolto che, a sua volta, crea il dialogo. È stato un po’ questo il programma personale ed ecclesiale di Martini che ha sempre alonato le sue parole di silenzio contemplativo, rendendole così incisive ed efficaci e perciò feconde per l’incontro con l’Altro divino e l’altro umano”. Ma “il suo non era solo un silenzio ‘ascetico’, capace cioè di purificare la parola dalla verbosità, dall’enfasi e dalla prevaricazione; era anche un silenzio ‘mistico’ e appassionato perché edificava la comunione attraverso l’ascolto attento della parola dell’altro. Non per nulla i primi interventi ecclesiali pubblici del cardinale erano stati un appello alla vita contemplativa e all’ascolto della Parola sacra”. Il card. Ravasi aggiunge: “Martini nel suo lungo ministero pastorale ha saputo costantemente scendere dal monte del silenzio contemplativo per incrociare le persone in un silenzio di ascolto fraterno che sbocciava nell’incontro, nel confronto, nel dialogo ove identità e differenza si componevano in armonia”.
“Ecclesiastico senza tattiche”. Sull’ascolto torna il biblista Enzo Bianchi, secondo il quale l’aspetto “più impressionante del suo essere uomo, cristiano, vescovo della Parola, emergeva dalla sua grande capacità di ascolto: dialogare con lui era sperimentare di persona cosa sia un orecchio attento e un cuore accogliente, cosa significhi pensare e pregare prima di formulare una risposta… Era da questo ascolto attento, della Parola e dell’interlocutore, che ho visto nascere nel cardinale Martini la capacità di gesti profetici, la sollecitudine per la Chiesa e per la sua unità, la vicinanza ai poveri, il farsi prossimo ai lontani, il dialogo con i non credenti. In lui coglievo una delle rare figure di ecclesiastici senza tattiche, né strategie, né calcoli di governo, ma quella vita di Cristo e in Cristo che aveva posto come chiave di lettura dell’esistenza di ogni battezzato e del suo ministero pastorale”.
Il poeta contadino Giuseppe Guarisco..vero discepolo della Divina Sapienza
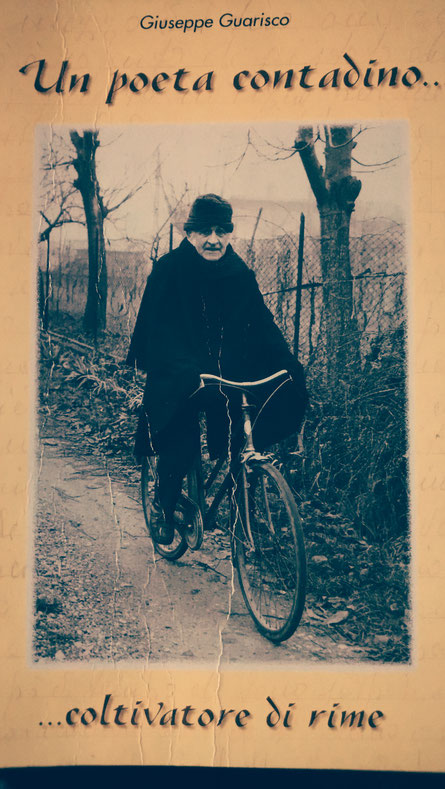
La mia vita
Cenni biografici
Un giorno lontano, 10 maggio 1914, venivo alla luce di questo mondo in una piccola e vecchia casa in contrada Bregadina, a Viadana di Calvisano. Prima di me c’erano già sei fratelli: tre maschi e tre femmine. Là i primi vagìti in una famiglia povera. Le membra strette con larghe fasce.
Raggiunti i due anni la mia famiglia si è trasferita nella cascina “Vaschina sera”. Una cascina senza comodità, con un po’ di terra. Qui ho iniziato le prime fatiche fisiche.
Dopo di me sono nati altri due fratelli: una famiglia di undici componenti. Il lavoro era campi e stalla.
A sei anni ho cominciato la prima elementare. Al mattino mi alzavo presto: prima aiutavo in stalla, alle ore sei andavo a servire la Messa e poi a scuola. La terza elementare l’ho ripetuta tre volte: capivo poco! Naturalmente c’eran solo tre anni di scuola.
Il lavoro della campagna era massacrante. La mietitura del grano si faceva a mano. A otto anni tagliavo il frumento con la falce. Avevo le gambe sanguinanti per i mozziconi degli steli tagliati che pungevano.
La terra veniva lavorata con l’aratro tirato dai buoi. D’estate, per evitare il tormento dei tafani sui bovini, si partiva alle quattro del mattino. La colazione veniva consumata nel campo, seduti per terra.
Vi era la stagione dei “bachi” (“caalér”). Ci si arrampicava sulle piante dei gelsi per procurare la foglia per i bachi da seta.
D’inverno andavamo sulle piante per tagliare la legna con l’accetta.
Il lavoro della campagna camminava di paripasso con gli impegni in parrocchia. Ancora da ragazzo il curato don Pietro Marini mi affidava tanti impegni: catechista, delegato della gioventù di Azione Cattolica e più tardi degli uomini.
A diciotto anni sempre don Pietro ha insistito perché accompagnassi le funzioni in chiesa con l’armonium. Senza andare a scuola di musica mi sono arrangiato da solo… ma che fatica! In principio con brani semplici, poi con canti a più voci. Tante volte sudavo… e sbagliavo! Ma bisognava andare avanti.
Veniva il momento della filodrammatica. A fatica abbiamo messo in moto una compagnia teatrale. C’ero sempre dentro: prima attore, poi suggeritore. A un certo punto, come hobby e passione, mi son messo a scrivere delle farse e delle commedie in dialetto.
Mi sono sempre piaciute anche le poesie. Mi sembrava di avere una vena poetica. Ma poi tante volte mi inceppavo! Venivano a proposito certe parole, ma non ne conoscevo il significato. Comunque ne ho scritte tante, specialmente per gli sposalizi e in altre circostanze. Quando ci riuscivo era per me una grande soddisfazione. Mi è sempre piaciuto l’umorismo! Mi faceva dimenticare il peggio.
Poi venne il momento di partire sotto le armi. A vent’anni partii per il militare. Prima a Cremona, poi a Milano nel terzo Reggimento Artiglieria Celere. Diciotto mesi di servizio. Fui congedato nel 1936.
A casa ripresi tutte le mie attività. Aiutavo nei campi, in stalla, in chiesa e su richiesta anche in Comune a Calvisano come Consigliere. Le convocazioni erano lunghe, con discussioni animate. Tornavo la sera tardi o di notte in bicicletta.
Nel 1937, in gennaio, mi è morta la mamma, Ferrari Giacomina. Il gran lutto ha gettato uno sconforto nella famiglia, specie per il papà Damasceno. Aveva settant’anni. Uomo già logorato dal lavoro dei campi, ha tirato avanti ancora tre anni, cupo e silenzioso.
Nel 1939, avevo accennato al papà che desideravo sposarmi: lui fece una smorfia! Era il primo anno che andavo a morose dalla signorina Ferrari Luigia (Gina). Il papà non era contrario al matrimonio, ma vi erano difficoltà economiche.
Poi nel 1940 fu colpito da un altro dispiacere: con lo scoppio della seconda guerra mondiale, io fui richiamato alle armi l’11 giugno 1940. Ho prestato servizio a Rocca D’Anfo, poi a Sonico in Val Camonica e infine a Sesana di Trieste. Il giorno 23 giugno mi giunse improvviso un telegramma per la morte del papà. Un altro grave lutto.
Nel 1942, comunque, mi feci dare la licenza di un mese per sposarmi. In tempo di guerra era un rischio sposarsi.
Il primo bacio alla mia sposa l’ho dato sul treno, in viaggio di nozze il 5 ottobre 1942.
Nel 1943 il 7 settembre, con l’armistizio, è stata la tragedia. Preso prigioniero dai Tedeschi, mi portarono in Polonia e poi in Germania, sempre fra i reticolati, col tormento della fame, dei pidocchi e del freddo.
Il distacco più amaro fu quello di lasciare la giovane sposa per un viaggio ignoto: qui si apre il mio Diario di prigionia. Un calvario durato 22 mesi.
Al ritorno dalla prigionia ho ripreso il mio lavoro nei campi con pochi “piò” di terra e qualche capo di bestiame: una vita molto stentata.
Tribolando ho formato la mia famiglia. I figli nati sono sei, viventi quattro. Non sono mancati problemi di malanni: parecchie volte c’era il dottore per casa. Io avevo poca salute, perché invalido di guerra. Formare e crescere una famiglia con poca salute e tanto lavoro era preoccupante. Confidavo nella Provvidenza e superavo i momenti difficili con coraggio e col mio carattere sempre di buon umore.
Mentre tribolavo, mantenevo la vena di scrivere farse, commedie e poesie. L’arte dell’umorismo è stata per me un valido aiuto nell’approssimarsi della vecchiaia.
A un certo punto non gliela facevo più a lavorare la terra per l’invalidità fisica. Ho trovato lavoro, come invalido, presso l’industria. Ho lavorato a Brescia, poi a Carpenedolo e infine a Calvisano. Sempre un lavoro serrato fino a 63 anni.
Pensionato con la minima ho continuato stentatamente la mia vita in famiglia e in parrocchia.
Nei miei 85 anni di vita, di cui 57 di matrimonio, voglio ringraziare innanzitutto il Signore che mi ha custodito nei momenti di prova e anche mia moglie Gina che mi ha sempre accompagnato con coraggio, serenità e con le sue instancabili preghiere.
Adesso sono in attesa del giorno finale per entrare in una nuova vita!
Viadana 10 maggio 1999 Gepi

Giuseppe guarisco il poeta contadino
"vero discepolo della divina sapienza"
“Figlio mio custodisci le mie parole e fa’ tesoro dei miei precetti.
Osserva i miei precetti e vivrai; il mio insegnamento
sia come la pupilla dei tuoi occhi (Prov. 7,1-2).
Queste esortazioni che la Sapienza rivolge a chi desidera orientare positivamente la propria vita, possono ritenersi la chiave di lettura delle poesie amorevolmente raccolte per esser date alla stampa con la presente pubblicazione.
Per due motivi o sotto due prospettive convergenti:
da un lato vi si presenta l’esperienza di una persona che, attraverso le vicende della vita affrontate con fede e fiducia, ha saputo legare quelle dolorose e liete con il filo della Provvidenza di Dio “che tutto coordina per il bene di coloro che lo amano”.
E dall’altro vi si scorge come il padre affida ai figli come testamento spirituale, una testimonianza di vita serena e laboriosa, fiduciosa pur nella prova, e come i figli l’accolgono con animo riconoscente, perché vi vedono non tanto una esercitazione letteraria, quanto le pagine di vita scritte giorno per giorno, animate dalla preghiera e illuminate dalla Parola di Dio, per essere offerte con amore a chi, nel susseguirsi dei giorni, lega gioie e dolori per il bene dei suoi figli.
Pur non conoscendo l’autore, scorrendo le sue poesie ora in italiano ora in dialetto, mi sono fatto un’ottima impressione di un uomo saggio, vero discepolo della Divina Sapienza.
Non mi resta perciò che augurare ai figli e nipoti, agli amici e ai conoscenti, di saper fare tesoro della bella testimonianza di fede e di amore che il “poeta-contadino” ha voluto affidare alle poesie amorosamente raccolte nella presente pubblicazione.
Brescia 8 marzo 1999 Vigilio Mario Olmi V. A.
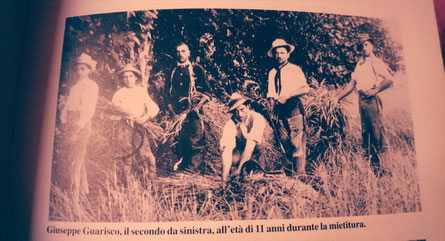
LA POESIA DI GIUSEPPE GUARISCO
(detto Gepi)
"Vera poesia, poesia religiosa, perché la vita è vissuta e vista sotto la luce di Dio, come è ovvio per chi ha scoperto il senso religioso del vivere"
Quella che oggi è Viadana frazione di Calvisano con più di 1250 abitanti, tutti occupati in diverse attività, fino a qualche decina di anni fa non era altro che cascine e piccole contrade sparse nella campagna a nord del territorio di Calvisano. Per secoli la popolazione si era dedicata alla coltivazione dei campi e della pastorizia.
Da sempre a Viadana la gente ha formato una Comunità, per la presenza costante di un sacerdote Il Curato di Viadana, che celebrava e raccoglieva la popolazione nella chiesa dedicata all’Annunciazione. Nella prima metà del secolo scorso il Curato era anche il maestro di scuola dei ragazzi di 1° e 2° elementare maschile.
La scuola, a Viadana, esiste fin dal 1839 per i maschi e dal 1846 anche per le femmine. Nei primi anni del ‘900 venne istituita la classe 3° elementare a Calvisano e nelle frazioni. Al termine dell’obbligo scolastico, non pochi genitori chiedevano alle maestre di far ripetere ai loro figlioli la classe 3°, perchè i loro piccoli potessero frequentare ancora la scuola, ma soprattutto perché i ragazzi e le fanciulle potessero imparare di più, dal momento che le classi 4° e 5° elementare non erano statali ma parrocchiali, funzionanti a Calvisano, presso le Madri Canossiane, e quindi piuttosto lontane dalle abitazioni.
Giuseppe Guarisco scrive di aver ripetuto tre volte la classe 3° perché capiva poco!, in realtà, per i motivi espressi sopra.
La scuola costituiva per i ragazzi una parte del loro impegno e dovere quotidiano. Negli altri momenti della giornata e nei giorni liberi di scuola, dovevano dedicarsi alle faccende domestiche o al lavoro in stalla, nei campi e nei pascoli. Un altro dovere fondamentale era la frequenza al catechismo e alla messa domenicale. Famiglia, scuola, chiesa erano strettamente unite e solidali nella educazione dei fanciulli.
Giuseppe Guarisco, nella sua poesia, esprime quel tipo di educazione e di formazione. Esalta e rimpiange nei suoi versi i valori che non sono solo del tempo passato, ma perenni: la bellezza della natura, francescamente sentita, ma anche, spesse volte, crudelmente sperimentata: tu sei benefica e pur crudele; il bene che l’uomo può compiere con l’aiuto di Dio, il male che compie per la sua fragilità e che deve espiare; l’amore, il più nobile dei sentimenti dell’uomo, ma che oggi giorno viene spesso profanato.
Nei suoi componimenti troviamo temi costanti e comuni a tutti i poeti antichi e moderni: il tempo che fugge, la morte che sovrasta, i dolci doni della natura, le piccole, ma significative gioie della vita. Tutto è visto con l’occhio dell’adulto che sa per esperienza, sovente dolorosa, la ragione del vivere, ma che ha conservato nell’anima la voce semplice del contadino.
Può sembrare, ad una prima lettura, di avere davanti una poesia popolare e naïf. Ed è vero: sono poesie per la maggior parte occasionali, scritte per varie ricorrenze religiose e civili, che la comunità di Viadana ha celebrato e ricordato. Ma le emozioni, i sentimenti, i pensieri trascendono il momento, vanno al di là del luogo e del tempo, si dilatano nel tempo e nello spazio.
In realtà, le poesie qui riportate esprimono l’esperienza di una vita intessuta di dolori e di fatica. Vi è la visione ottimistica e serena donata a Giuseppe Guarisco dalla fede e dalla pratica religiosa; ma vi è anche la consapevolezza del male e della cattiveria umana, che si è manifestata nella guerra, nella deportazione, nella prigionia nei lager. Vi è la vita di ogni giorno bella e triste nello stesso tempo, ove l’esperienza del dolore (fisico, morale, spirituale) supera l’esperienza della gioia.
E’ vera poesia, poesia religiosa, perché la vita è vissuta e vista sotto la luce di Dio, come è ovvio per chi ha scoperto il senso religioso del vivere.
Viene qui pubblicato un piccolo canzoniere, che vuol essere diario umano e spirituale. Poesia che esprime il vissuto dell’autore che rivive e reinterpreta sentimenti, emozioni, immagini proprie delle persone che vissero e ricordano un mondo ormai perduto, un mondo contadino ormai inesistente.
Affiorano dalla memoria i ricordi indelebili di chi in quel mondo è nato e a lungo è vissuto. Talvolta si nota una accorata elegia del paesaggio che è mutato troppo in fretta. E’ poesia che racconta un paese, con un pizzico di rimpianto per i valori purtroppo perduti. Ma non è rimpianto per le fatiche, per i dolori, per le preoccupazioni presenti nella civiltà contadina: chi rimpiange la vecchia civiltà contadina non l’ha mai conosciuta da vicino.
Quello era un mondo in cui vi era una diffusa povertà, sopportata con diffusa rassegnazione. La terra era l’unica fonte per il sostentamento degli uomini e degli animali. Viene alla memoria la figura di don Pietro che, all’approssimarsi dei temporali, correva a suonare le campane, per allontanare la nuvolaglia e a portarsi sulla soglia della chiesa con la reliquia della Santa Croce per scacciare con una benedizione la sventura che sovrastava.
Specie nei componimenti in dialetto (e soprattutto nelle commedie che meriterebbero di essere pubblicate) è raffigurato il mondo contadino, particolarmente quello calvisanese, o meglio viadanese.
E’ poesia intesa come gioco, lusus, come divertimento, affrontato con serietà di impegno e di intenti. Non c’è pretesa, ma gusto del poetare, desiderio non solo di dire parole, ma soprattutto di esprimere cose.
Virginio Prandini

AMORE
Fate silenzio, labbra, sì tacete!
Non cantate amor che non sapete!
Volete profanare questo grande verbo
ch’è tanto saporoso, ma per voi acerbo?
Oh! Esseri umani, miseri, che fate?
Amor non conoscete e tanto lo cantate!
Gridando fra le “musa” con espressivi gesti,
a volte forsennati, a volte pii e mesti,
che i cantautori esprimono ignari del valore
che in sè racchiude quel verbo ch’è amore.
Sol tu, o pia Madre, che il Figlio amasti tanto
puoi dir cos’è amore parlando dal tuo canto.
Sol tu, o Madre Santa, che prona alla croce
vedi il divin Figlio tra spasimo atroce,
ch’è fisso con tre chiodi, il volto insanguinato,
ci indica l’amor su un legno inchiodato.
Il Figlio tuo guardati, amor senza confini
ed i peccati sconta dei miseri tapini,
con testa bassa e umile, Lui, ch’è Redentore
e il mondo va altero seppur è peccatore.
Giuseppe Guarisco

LA VITA
Nasce un bimbo, una luce s’accende
sul lungo cammino la vita ascende.
Dapprima è bella, tutto un trastullo!
E corre e cresce quel caro fanciullo.
Tra il buono e il bello ancora non pensa
che di dolori la vita è pur densa.
E su quel sentiero il mondo nasconde
trappole, inganni e lui si confonde.
Cammina evitando fastidi e noie.
Infatti gli arridon fortune e gioie!
Diventa adulto e con l’occasioni
fa intemperanze a profusioni!
Con tanti abusi di ogni sorte
s’ammala e quasi è vicino alla morte!
L’imperdonabile mal lo colpisce
tutto il suo mondo, d’un tratto, fallisce!
Aveva una luce a mo’ di chi crede:
ma è torturato e perde la fede.
Cammina sull’orlo per disperarsi,
ma poi ci ripensa vorrebbe rifarsi!
Perché se si spegne quel poco di luce
resto al buio e chi mi conduce?
La sofferenza su di me veglia
tormentata la carne, ma l’alma risveglia.
Il mondo, il mio corpo mi hanno tradito.
Signore, Signore, or son pentito!
Lo so, lo sento che io qui soffro:
ma tutto, Signore, tutto ti offro!
Perché, purtroppo, lo devo scontare
il mal che ho fatto, il mio peccare!
Ti rendo grazie per questa tua prova,
tu mi regali una vita ch’è nuova!
Al fin quella luce prima accesa
ancor sarà viva dopo l’ascesa.
E con la morte questa mia vita
io credo, Signore, non è qui finita!
Ma sfocia gloriosa, eterna, lassù
ove tutti quei mali, non ci sono più.
Giuseppe Guarisco

Il MARE
O mare! Quanto sei bello, grande, immenso!
Su di te scivolano uomini di ogni sorte!
Ma sotto, nelle viscere del tuo denso,
quanti, quanti sono gli spettri di morte!
Per questo a te volgo lo sguardo... e penso!
L’ ACQUA
Tu non hai vita e vita pur dai
immensa regina della natura.
C’è chi ti guarda, chi ti trascura
e c’è chi perfin offenderti sa.
Chi ti conosce e ti comprende
creatura, sorella mia?
Fors’il viandante su quella via
che arso e stanco si dissetò?
Oppure quel volgo, che sotto il sole,
è massacrato dal suo lavoro
ed ha trovato grande ristoro
nel chiaro vivido tuo zampil?
O forse l’uomo - il lussurioso -
che nei bagordi s’è dimenato
e refrigerio ha poi ritrovato
nella semplice tua bontà?
Quell’altro che stava nuotando
in quella spiaggia, in quel momento,
che si beava tutto contento
nel tuo dolce e lieto cullar?
Oh!… Nessuno ti dice grazie!
Ma che cattivi e senza cuore!
Eppure sanno che tutto muore
e non c’è vita senza di te!
Ah!... Quei frutti sì ubertosi
che dalla terra hanno succhiato!
Tu sei stata che hai mandato
alle radici il provvid’ umor.
Se pur semplice sei a guardarti
non ti conosce nemmen chi ti usa:
in un arcano tu sei rinchiusa
sol ti conosce il Creator.
Tu sei in terra, in cielo, in mare;
tu cambi forma, colore, aspetto
e a noi parli del tuo diletto
col tuo inno, le tue virtù.
Sei tu ancora che muovi la ruota
e al mondo dai energia.
E se di notte, su quella via,
le luci brillan, ancora sei tu.
Calma ten’vai, senza stancarti;
vispa gorgheggi nel lieto ruscello,
muovi, lambisci il ramoscello
che si diverte al tuo passar.
Quando ti tocca il sole cocente,
allora ti cangi e nùgol diventi
e poi ti plasman i provvidi venti
fin che di nuovo ritorni quaggiù.
A volte lenta, quasi graziosa,
scendi benefica dal tuo cielo
a rinverdire del prato lo stelo
e dissetare gli arsi terren.
Quando in alto ti trovi nel verno
lui ti trastulla e dice con vanto:
“Va’ sulla terra e stendi un manto
che pareggiabil un altro non v’è”.
A volte scendi, invece, furiosa
e se dal gelo tu sei toccata
allora in chicchi sei trasformata
e flagellando ci porti squallor!
Tu sei benefica e pur crudele;
diventi cattiva, cieca e dura:
perché tormenti la bella natura
che ebbe la vita pel tuo poter?
Ah!... Purtroppo quando t’impenni
e forsennata spingi la onda,
fin che all’urto cede la sponda,
allora pietade alcuna non v’è!
Come pagliuzze tutto trascini,
produci panico, grida e morte!
Eppure non meno ivi è la sorte
ove presenza tua non c’è!
Oh!…Bell’acqua, scusami tanto!
Or t’ho capito, sì finalmente!
Tu non hai colpa, sei innocente
e sei guidata dall’Autor!
Quando, fuorviata, meni una strage
è un richiamo del Creatore
che porge la prova al peccatore
perché elevi la mente al ciel!
Tu nella neve sei la purezza,
nella tempesta sei il peccato,
che strugge quanto Dio ci ha dato
e poi ritorni tutto a lavar!
Tu nel diluvio fosti lavacro
e nel mar Rosso liberatrice
poi nel Giordano, il Vangelo dice,
hai battezzato il Cristo Gesù!
Sorella acqua!
Giuseppe Guarisco
La parola chiave del lettore:
Siete occhi che guardano e che sognano!
Continuate a sognare, a inquietarvi, a immaginare parole e visioni che ci aiutino a leggere il mistero della vita umana e orientino le nostre società verso la bellezza e la fraternità universale.
Aiutateci ad aprire la nostra immaginazione perché essa superi gli angusti confini dell’io, e si apra alla realtà tutta intera, nella pluralità delle sue sfaccettature: così sarà disponibile ad aprirsi anche al mistero santo di Dio. Andate avanti, senza stancarvi, con creatività e coraggio!
Papa Francesco


































