E Dio fece fiorire la voce delle donne
La rosa necessaria
Ciò che canta in me è il canto dell'eternità. Ciò che è entrato in me non può piú morire.
Adriana Zarri

Rinascere nella Speranza

Allo stesso modo in cui il sole illumina i grandi cedri ed i fiorucci da niente come se ciascuno fosse unico al mondo, così nostro Signore si occupa di ciascun'anima con tanto amore, quasi fosse la sola ad esistere; e come nella natura le stagioni tutte sono regolate in modo da far sbocciare nel giorno stabilito la pratolina più umile, cosi tutto risponde al bene di ciascun'anima.
Santa Teresina del Bambin Gesù
“La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna”
La sensibilità attuale del mondo esige che siano restituite alla donna la dignità e il valore intrinseco di cui l’ha dotata il Creatore. I tanti esempi di vita mettono in evidenza alcuni elementi che delineano quella femminilità così necessaria nella Chiesa e nel mondo: la forza per affrontare le difficoltà, la capacità di concretezza, una naturale disposizione a essere propositive per ciò che è più bello e umano, secondo il piano di Dio, e una visione lungimirante del mondo e della storia — profetica — che le ha rese seminatrici di speranza e costruttrici di futuro.
Papa Francesco
Donare le Tue radici nel mio cuore...missione di ogni giorno

Chi ti descriverà luce divina che procedi immutata e immutabile dal mio sguardo redento?
Tono del mio essere
Non sia mai che io tolga la lanterna
Emanata dai fiori e ogni grazia
Alda Merini
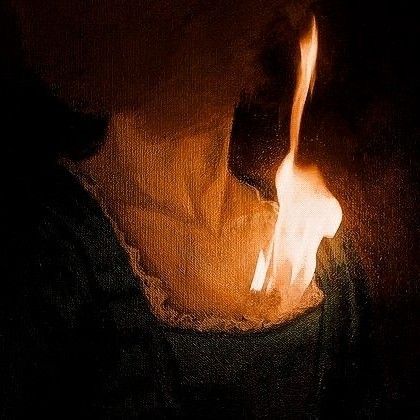
“Io non sono né missionaria, né laica. Sono totalmente consacrata a Dio e ai poveri. Nella mia vita non c’è rinuncia, non c’è sacrificio. La mia è pura felicità. Non c’è che una tristezza al mondo: quella di non amare. La vita è sperare sempre, sperare contro ogni speranza, buttarsi alle spalle le nostre miserie, non guardare alle miserie degli altri, credere che Dio c’è e che lui è un Dio d’amore."

In mezzo a questi poveri è la mia vita: per qualcuno significativa, per altri solo interrogativa, per altri ancora forse insignificante; né io pretendo che tutti l'avvertano nel suo valore religioso. E' una presenza più che una testimonianza. Ma mi domando se la presenza non sia la testimonianza più preziosa. Perché la presenza di uomo di fede è la presenza di Dio nel mondo: la presenza di Cristo che cammina nel passo di tutti i suoi fedeli.
Adriana Zarri

Speranza è Parola in azione, Missione
Tra la passività, per estrema che sia, e l’azione, tra l’indifferenza che confina con l’annichilimento della persona umana e la piena attualizzazione della sua finalità. […] Un ponte […] anche al di sopra del tempo perché, giungendo ad annullarlo trasportandoci, quasi, dalla sponda del passato al futuro, essa opera, già in questa vita, una specie di resurrezione. La speranza è esempio di creatura che cresce e si sviluppa magicamente, pur nell’indigenza e nello stento, perché non spera nulla, si alimenta della propria incertezza: la speranza creatrice, quella che estrae la sua stessa forza dal vuoto […] che crea stando sospesa […] la speranza liberata dell’infinità senza termine che abbraccia e attraversa l’intera estensione delle epoche rigenera i cuori.
Maria Zambrano

Vivere d'Amore
Santa Teresa del Bambin Gesù
Vivere d'amore, quaggiù, è un darsi smisurato, senza chieder salario; senza far conti io mi dò, sicura come sono che quando s'ama non si fanno calcoli.
Io ho dato tutto al Cuore divino che trabocca di tenerezza!
Non ho più nulla e la mia sola ricchezza è vivere d'amore.
Vivere d'amore è sbandire ogni tema, ogni ricordo dei passati errori. Non vedo nemmeno l'impronta d'uno dei peccati, ciascuno è svanito nel fuoco divino.
Fiamma sacra, dolcissima fornace, del tuo focolare io fo la mia stanza.
E qui a mio piacere canto, Gesù, e vivo d'amore!
Vivere d'amore è custodire nel vaso mortale di sé un tesoro.
Mio Benamato! debolissima io sono! E tutt'altro che un angelo del cielo.
Ma se cado a ogni passo tu mi raggiungi, di volta in volta mi sollevi, mi avvolgi nel tuo abbraccio e mi dai la tua grazia.
Io vivo d'amore!
Vivere d'amore è un navigare incessante, seminando nei cuori la gioia e la pace.
Pilota amato! M'incita la carità, perché ti vedo in tutte le anime mie sorelle.
La carità, ecco la sola mia stella; alla sua luce vogo diritta; e sulla vela è scritto il mio motto: Vivere d'amore!
Vivere d'amore, quando assopito è Gesù, è il riposo sui flutti in tempesta; ah non temere, Gesù, che ti svegli, io aspetto in pace l'approdo dei Cieli.
Presto la fede squarcerà il suo velo, la mia speranza sarà d'un giorno solo: la carità gonfia e sospinge la mia vela.
Ed io vivo d'amore!
Vivere d'amore, o mio Divino Maestro, è supplicarti di spandere i tuoi raggi nell'anima eletta e santa del sacerdote ch'egli sia più che un celeste serafino.
Proteggi la tua Chiesa immortale, te ne scongiuro ad ogni attimo.
Io, figlia sua, m'immolo per lei e vivo d'amore!
Vivere d'amore è asciugarTi il volto ed ottenere perdono ai peccatori: che rientrino nella Tua grazia, o Dio di amore, e sempre benedicano il tuo nome!
Ogni bestemmia mi rintocca nel cuore; e per cancellarla ridico ogni giorno: T'amo e t'adoro, o Nome sacro! e vivo d'amore.
Vivere d'amore è imitare Maria Maddalena che bagna di pianti e di preziose essenze i Tuoi Piedi Divini, e li bacia rapita, li asciuga coi lunghi capelli, poi con santa audacia levandosi, anche il dolce Tuo Volto cosparge d'aroma...
Per me, quell'olezzo che innalzo al Tuo Volto è il mio amore.
Vivere d'amore, che strana pazzia!
Mi dice il mondo: smettila di cantare! e bada a non sprecare i tuoi aromi, la tua vita, impiegali utilmente! Ma amarTi, Gesù, che feconda perdita! Ogni mio aroma è Tuo, per sempre.
E voglio cantare, lasciando il mondo: Io muoio d'amore!
Morir d'amore è il ben dolce martirio di cui vorrei soffrire.
Cherubini, accordate i liuti, ché il mio esilio, lo sento, sta per finire...
Dardo di fuoco, consumami senza tregua, e feriscimi il cuore in questo triste soggiorno. Divino Gesù, avvera il mio sogno, morir d'amore!
Morir d'amore, ecco la mia speranza: quando vedrò spezzati i miei lacci, Dio sarà la mia gran ricompensa: non voglio altri beni.
Son tutta presa del Suo Amore, e venga, dunque, a stringermi a Sé per sempre.
Ecco il mio cielo, il mio destino: Vivere d'amore!

“Scrostaci, o Dio, la triste polvere dell’abitudine, della stanchezza e del disincanto; dacci la gioia di svegliarci, ogni mattino, con occhi stupiti per vedere gli inediti colori di quel mattino, unico e diverso da ogni altro.”
Adriana Zarri
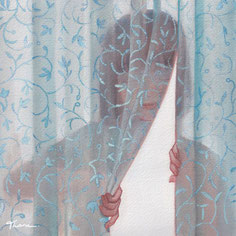
"Cercavo"
Anita Prati
Cercavo silenzi
di boschi e montagne,
di sguardi profondi,
di vento sul mare.
Cercavo passi
che riportano a casa,
che tracciano strade,
che camminano insieme.
Cercavo luce
a rischiarare la notte –
bagliori di fiamma,
tremolio di candele.
Cercavo acqua
che disseta la sete,
rinfresca la pelle,
inonda i pensieri.
Cercavo pane
per spezzare fatiche,
sostenere gli affanni,
carezzare il dolore.
Cercavo vino
per danzare la festa,
per cantare la vita,
liberare la gioia.
Cercavo parole
da riporre in silenzio
fra le pieghe del cuore –
parole da ascoltare,
parole da parlare,
parole da intrecciare
con legami d’amore.
Cercavo –
ho sempre cercato –
e Tu, ogni volta,
mi hai sempre trovato

“Ogni giorno tenere”
Mariangela Gualtieri
Ogni giorno tenere
un po’ di fame.
Dare alla terra un sorso d’acqua
un ossicino una foglia
– lei prende e centuplica e scatena –
guardare bene una faccia
nutrire un animale, almeno uno.
Guardare spesso il cielo.
Leggere una poesia sola.
Dire grazie.
Abitare un silenzio
con il corpo pregare – coi passi con le braccia.
A questo aggiungere la tua legge grande.
E può bastare.
Il canto del Creato...nelle voci poetiche femminili
Al termine del mese dedicato al Creato e in occasione del 4 ottobre San Francesco d'Assisi dedichiamo questo prezioso angolo al respiro della nostra terra attraverso voci poetiche femminili

Io sono verticale
Sylvia Plath
( poetessa americana)
Io sono verticale ma preferirei essere orizzontale.
Non sono un albero con radici nel suolo
succhiante minerali e amore materno
così da poter brillare di foglie a ogni marzo,
né sono la beltà di un’aiuola
ultradipinta che susciti grida di meraviglia,
senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali.
Confronto a me, un albero è immortale
e la cima di un fiore, non alta, ma più clamorosa:
dell’uno la lunga vita, dell’altra mi manca l’audacia.
Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle,
alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi.
Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso.
A volte io penso che mentre dormo
forse assomiglio a loro nel modo più perfetto –
con i miei pensieri andati in nebbia.
Stare sdraiata è per me più naturale.
Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio,
un giorno finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me.

Un giardino d’ottobre
Christina Rossetti
( poetessa inglese)
Nel mio giardino d’autunno ero solita
Piangere tra le mie rose sparse;
Ahimè per quell’ultimo bocciolo di rosa che si schiude
Al languido sole e alla pioggia dell’Autunno
Quando tutto il mondo è al tramonto!
Che non ha sentito il dolce fascino di giugno,
Né ha sentito l’usignolo cantare.
Astri dal fiore largo, nella passeggiata del mio giardino,
Siete più rozzi delle rose:
Più bella, più cara è la rosa che si schiude,
Con un profumo tenue, pungente, sopra il suo gambo,
La più piccola e l’ultima che i venti freddi scoraggiano;
È una rosa, anche se la più piccola e l’ultima di tutte,
Una rosa per me anche se in autunno.

Il cuore innumerevole
Anne de Noailles
Morire nell’ardente fumea dell’estate,
Quando odoroso, pendulo e greve come un grappolo,
Il cuore, al mormorio dell’aria dondolando,
Si sgrana in dolorosa e dolce voluttà.
Morire al fresco tocco di foglie sulle mani,
Unendo gli occhi agli occhi verdi dei boschi in fiore,
Fondersi all’universo antico e nato or ora,
Accogliendone in sé nel contempo ogni età.
Andar via senza fretta con la fine del giorno;
Trafitta dalle frecce del crepuscolo d’oro,
Avvertire che l’anima dolcemente ritorna
Alla terra profonda e all’immortale amore.
Andar via per gustare nel suo grembo il mistero
Di essere l’erba, l’acqua, la canicola e il grano,
Assopirsi tra i solchi verdeggianti del piano.

Natura è tutto ciò che vediamo
Emily Dickinson
( poetessa inglese)
Natura è tutto ciò che noi vediamo:
il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo,
l’eclissi, il calabrone.
O meglio, la natura è il paradiso.
Natura è tutto ciò che noi udiamo:
il bobolink, il mare, il tuono, il grillo.
O meglio, la natura è armonia.
Natura è tutto quello che sappiamo
senza avere la capacità di dirlo,
tanto impotente è la nostra sapienza
a confronto della sua semplicità.
L’erba ha così poche occupazioni
un mondo di semplice verde
con solo farfalle su cui meditare
e api da ospitare
non ha da fare altro che cullarsi
tutto il giorno ai suoni melodiosi
che le brezze portano leggere
e accogliere in grembo la luce
e inchinarsi ad ogni cosa
e infilare le gocce di rugiada
come perle, per tutta la notte
e diventare così raffinata
che una duchessa invano attenderebbe
da lei un invito, un saluto, un’attenzione.
E quando muore, non fa che trapassare
in odori divini
come umili spezie addormentate
o nardi che si spengono
per poi finire in supremi fienili
e sognare tutti i giorni.
L’erba ha così poche occupazioni
mi piacerebbe tanto essere fieno.

"Sulla terra”
Forough Farrokhzad
( poetessa persiana )
“Io non ho mai desiderato
essere una stella del firmamento
celeste, o come spirito eletto
silente sorella degli angeli.
Mai distaccata dalla terra,
mai amica del cielo.
Qui, sulla terra,
sono uno stelo di pianta
che vive nutrita dal vento,
dal sole e dall’acqua.
Carica di desiderio e dolore
rimango qui, sulla terra,
accolgo l’elogio delle stelle
e la carezza dei venti.
Guardo dalla mia piccola finestra:
non fatta d’eterno, nient’altro
che l’eco di un canto sono.
E solamente l’eco di un canto
cerco nel gemito d’amore
più puro ancora
del silenzio del dolore.
Un nido non cerco
nella stilla di rugiada
posata sul giglio del mio corpo.
Sulle pareti della mia casa,
della mia vita, i passanti
lasciano tracce di ricordi,
con nere penne d’amore:
un cuore trafitto da una freccia,
una candela consumata,
pallidi segni taciturni
su confuse e folli missive.
Per ogni bocca che mi ha baciata
è nata una stella, nella notte
che scendeva sul fiume dei ricordi.
Perché mai desiderare le stelle?
Questo è il mio canto,
più deliziata, più felice
non fui mai come ora
prima d’ora, mai come ora…”.
Rocce e pietre
Yvette Christianse
( poetessa africana )
Il fuoco brucia, il fumo inizio
e fine. Noi fissiamo - quegli alberi -
ci teniamo forti. Sappiamo
perchè il corpo duole - il vento
è un vecchio vandalo in questa valle.
Il fumo sale. Le ceneri si ammucchiano.
Eppure, aspettiamo- la speranza ha un senso.
Dovessi danzare, sarebbe
tra quelli ali sulle onde.
Mi tufferei come gabbiano e
neppure più le ceneri rimarrebbero.
Allora, certo, il vento imparerebbe un altro canto.

Io ero un uccello
Alda Merini
(poetessa italiana)
Io ero un uccello
dal bianco ventre gentile,
qualcuno mi ha tagliato la gola
per riderci sopra,
non so.
Io ero un albatro grande
e volteggiavo sui mari.
Qualcuno ha fermato il mio viaggio,
senza nessuna carità di suono.
Ma anche distesa per terra
io canto ora per te
le mie canzoni d’amore.
La parola chiave del lettore:
Siete occhi che guardano e che sognano!
Continuate a sognare, a inquietarvi, a immaginare parole e visioni che ci aiutino a leggere il mistero della vita umana e orientino le nostre società verso la bellezza e la fraternità universale.
Aiutateci ad aprire la nostra immaginazione perché essa superi gli angusti confini dell’io, e si apra alla realtà tutta intera, nella pluralità delle sue sfaccettature: così sarà disponibile ad aprirsi anche al mistero santo di Dio. Andate avanti, senza stancarvi, con creatività e coraggio!
Papa Francesco
