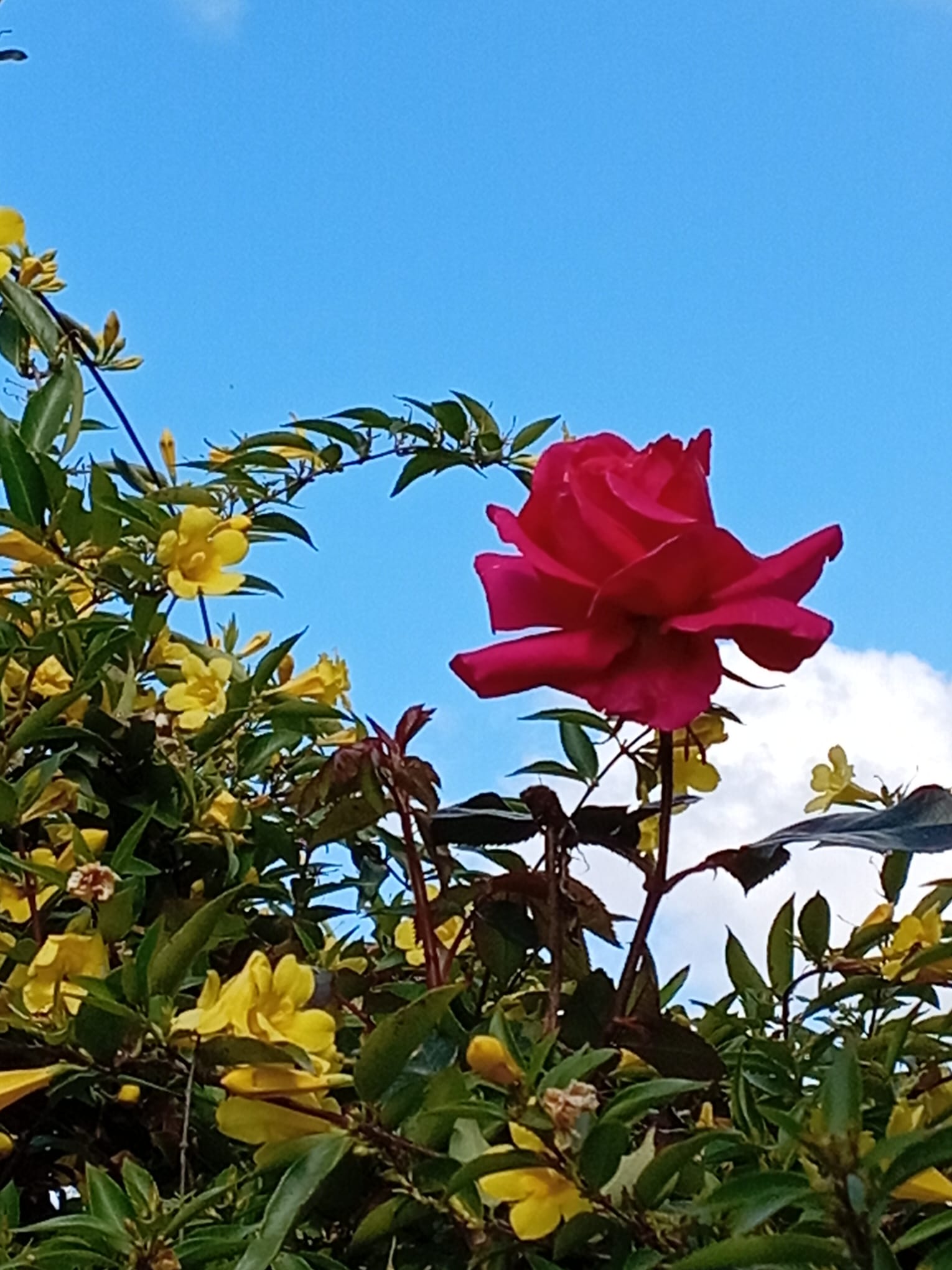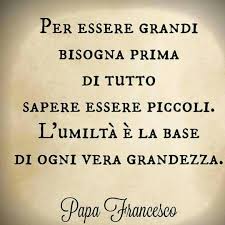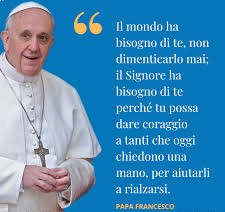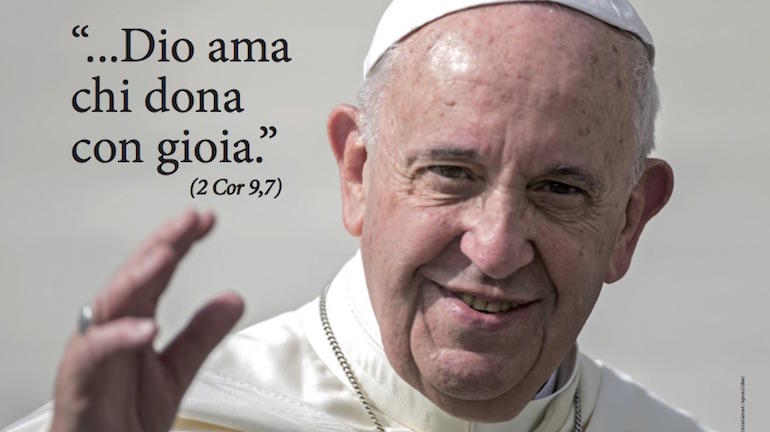Papi al servizio del popolo di Dio!

Papa Leone XIV

"È molto significativo che papa Leone abbia voluto presentarsi dicendo di essere «figlio di sant’Agostino», cioè come frate agostiniano, membro dell’Ordo Sancti Augustini, abbreviato O.S.A., sigla che se si legge senza badare ai punti diventa un imperativo che dà coraggio. Cosa significa essere agostiniano? Significa avere un modo di vivere il cristianesimo improntato alla spiritualità di sant’Agostino, così come essere francescani significa seguire la spiritualità di Francesco d’Assisi, benedettini quella di san Benedetto e così via per tutti i numerosi ordini religiosi maschili e femminili. Ma qual è la specifica spiritualità dell’ordine agostiniano? La risposta ci proviene dallo stesso motto del nuovo Papa scelto quando venne ordinato vescovo: «In illo uno unum», espressione di Agostino che alla lettera significa: «Una sola cosa in lui solo», laddove questo lui è Cristo e la sola cosa è la comunità dei fratelli. Il che indica che lo specifico della spiritualità agostiniana è l’essere pervasa da una forte tensione orizzontale per promuovere la vita comunitaria e l’amicizia, e al contempo da un’ancora maggiore tensione verticale perché questa unità avviene tendendo tutti insieme verso Cristo, «in lui solo». Il che è la perfetta sintesi del cristianesimo, che è fratellanza ma prima ancora figliolanza, che è caritas ma prima ancora imitatio Christi."
Vito Mancuso

APPELLO
"Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre. Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato: «Non ucciderai» (Es 20,13) e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile, da rispettare e da custodire. Rinnovo l’appello al cessate-il-fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale. Invito tutti ad unirsi alla mia accorata preghiera, affinché sorga presto un’alba di pace e di giustizia."
Papa Leone XIV
Messaggio del Santo Padre Leone XIV
111ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2025

Dipinto "Parabola del ricco Epulone", 1550
autore Ponte Jacopo Detto Jacopo Bassano
GIUBILEO DEI CATECHISTI
SANTA MESSA
OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Piazza San Pietro
XXVI domenica del Tempo Ordinario, 28 settembre 2025
Cari fratelli e sorelle,
Le parole di Gesù ci comunicano come Dio guarda il mondo, in ogni tempo e in ogni luogo. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato (Lc 16,19-31), i suoi occhi osservano un povero e un ricco, chi muore di fame e chi si ingozza davanti a lui; vedono le vesti eleganti dell’uno e le piaghe dell’altro leccate dai cani (cfr Lc 16,19-21). Ma non solo: il Signore guarda il cuore degli uomini e, attraverso i suoi occhi, noi riconosciamo un indigente e un indifferente. Lazzaro viene dimenticato da chi gli sta di fronte, appena oltre la porta di casa, eppure Dio gli è vicino e ricorda il suo nome. L’uomo che vive nell’abbondanza, invece, è senza nome, perché perde sé stesso, dimenticandosi del prossimo. È disperso nei pensieri del suo cuore, pieno di cose e vuoto d’amore. I suoi beni non lo rendono buono.
Il racconto che Cristo ci consegna è, purtroppo, molto attuale. Alle porte dell’opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento. Attraverso i secoli, nulla sembra essere cambiato: quanti Lazzaro muoiono davanti all’ingordigia che scorda la giustizia, al profitto che calpesta la carità, alla ricchezza cieca davanti al dolore dei miseri! Eppure il Vangelo assicura che le sofferenze di Lazzaro hanno un termine. Finiscono i suoi dolori come finiscono i bagordi del ricco, e Dio fa giustizia verso entrambi: «Il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto» (v. 22). Senza stancarsi, la Chiesa annuncia questa parola del Signore, affinché converta i nostri cuori.
Carissimi, per una singolare coincidenza, questo stesso brano evangelico è stato proclamato proprio durante il Giubileo dei Catechisti nell’Anno Santo della Misericordia. Rivolgendosi ai pellegrini venuti a Roma per quella circostanza, Papa Francesco evidenziò che Dio redime il mondo da ogni male, dando la sua vita per la nostra salvezza. La sua azione è inizio della nostra missione, perché ci invita a donare noi stessi per il bene di tutti. Diceva il Papa ai catechisti: «Questo centro attorno al quale tutto ruota, questo cuore pulsante che dà vita a tutto è l’annuncio pasquale, il primo annuncio: il Signore Gesù è risorto, il Signore Gesù ti ama, per te ha dato la sua vita; risorto e vivo, ti sta accanto e ti attende ogni giorno» (Omelia, 25 settembre 2016). Queste parole ci fanno riflettere sul dialogo tra l’uomo ricco e Abramo, che abbiamo ascoltato nel Vangelo: si tratta di una supplica che il ricco rivolge per salvare i suoi fratelli e che diventa per noi una sfida.
Parlando con Abramo, infatti, egli esclama: «Se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno» (Lc 16,30). Così risponde Abramo: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31). Ebbene, uno è risorto dai morti: Gesù Cristo. Le parole della Scrittura, allora, non ci vogliono deludere o scoraggiare, ma destano la nostra coscienza. Ascoltare Mosè e i Profeti significa fare memoria dei comandamenti e delle promesse di Dio, la cui provvidenza non abbandona mai nessuno. Il Vangelo ci annuncia che la vita di tutti può cambiare, perché Cristo è risorto dai morti. Questo evento è la verità che ci salva: perciò va conosciuta e annunciata, ma non basta. Va amata: è quest’amore che ci porta a comprendere il Vangelo, perché ci trasforma aprendo il cuore alla parola di Dio e al volto del prossimo.
A questo proposito, voi catechisti siete quei discepoli di Gesù, che ne diventano testimoni: il nome del ministero che svolgete viene dal verbo greco katēchein, che significa istruire a viva voce, far risuonare. Ciò vuol dire che il catechista è persona di parola, una parola che pronuncia con la propria vita. Perciò i primi catechisti sono i nostri genitori, coloro che ci hanno parlato per primi e ci hanno insegnato a parlare. Come abbiamo imparato la nostra lingua madre, così l’annuncio della fede non può essere delegato ad altri, ma accade lì dove viviamo. Anzitutto nelle nostre case, attorno alla tavola: quando c’è una voce, un gesto, un volto che porta a Cristo, la famiglia sperimenta la bellezza del Vangelo.
Tutti siamo stati educati a credere mediante la testimonianza di chi ha creduto prima di noi. Da bambini e da ragazzi, da giovani, poi da adulti e anche da anziani, i catechisti ci accompagnano nella fede condividendo un cammino costante, come avete fatto voi in questi giorni, nel pellegrinaggio giubilare. Questa dinamica coinvolge tutta la Chiesa: infatti, mentre il Popolo di Dio genera uomini e donne alla fede, «cresce la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr Lc 2,19.51), sia con la intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità» (Cost. dogm. Dei Verbum, 8). In tale comunione, il Catechismo è lo “strumento di viaggio” che ci ripara dall’individualismo e dalle discordie, perché attesta la fede di tutta la Chiesa cattolica. Ogni fedele collabora alla sua opera pastorale ascoltando le domande, condividendo le prove, servendo il desiderio di giustizia e di verità che abita la coscienza umana.
È così che i catechisti in-segnano, cioè lasciano un segno interiore: quando educhiamo alla fede, non diamo un ammaestramento, ma poniamo nel cuore la parola di vita, affinché porti frutti di vita buona. Al diacono Deogratias, che gli chiedeva come essere un buon catechista, sant’Agostino rispose: «Esponi ogni cosa in modo che chi ti ascolta ascoltando creda, credendo speri e sperando ami» (De catechizandis rudibus, 4, 8).
Cari fratelli e sorelle, facciamo nostro questo invito! Ricordiamoci che nessuno dà quello che non ha. Se il ricco del Vangelo avesse avuto carità per Lazzaro, avrebbe fatto del bene, oltre che al povero, anche a sé stesso. Se quell’uomo senza nome avesse avuto fede, Dio lo avrebbe salvato da ogni tormento: è stato l’attaccamento alle ricchezze mondane a togliergli la speranza del bene vero ed eterno. Quando anche noi siamo tentati dall’ingordigia e dall’indifferenza, i molti Lazzaro di oggi ci ricordano la parola di Gesù, diventando per noi una catechesi ancora più efficace in questo Giubileo, che è per tutti tempo di conversione e di perdono, di impegno per la giustizia e di ricerca sincera della pace.

UDIENZA GIUBILARE
CATECHESI DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Piazza San Pietro
Sabato, 27 settembre 2025
Catechesi. 5. Sperare è intuire. Ambrogio di Milano
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
Il Giubileo ci rende pellegrini di speranza, perché intuiamo un grande bisogno di rinnovamento che riguarda noi e tutta la terra.
Ho appena detto “intuiamo”: questo verbo – intuire – descrive un movimento dello spirito, una intelligenza del cuore che Gesù ha riscontrato soprattutto nei piccoli, cioè nelle persone di animo umile. Spesso, infatti, le persone dotte intuiscono poco, perché presumono di conoscere. È bello, invece, avere ancora spazio nella mente e nel cuore, perché Dio si possa rivelare. Quanta speranza quando sorgono nuove intuizioni nel popolo di Dio!
Gesù esulta di questo, è pieno di gioia, perché si accorge che i piccoli intuiscono. Hanno il sensus fidei, che è come un “sesto senso” delle persone semplici per le cose di Dio. Dio è semplice e si rivela ai semplici. Per questo c’è un’infallibilità del popolo di Dio nel credere, della quale l’infallibilità del Papa è espressione e servizio (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 12; Commissione Teologica Internazionale, Il sensus fidei nella vita della Chiesa, 30-40).
Vorrei ricordare un momento nella storia della Chiesa, che mostra come la speranza possa venire dalla capacità del popolo di intuire. Nel quarto secolo, a Milano, la Chiesa era lacerata da grandi conflitti e l’elezione del nuovo vescovo si stava trasformando in un vero e proprio tumulto. Intervenne l’autorità civile, il governatore Ambrogio, che con una grande capacità di ascolto e mediazione portò tranquillità. Il racconto dice che allora una voce di bambino si alzò a gridare: “Ambrogio vescovo!”. E così anche tutto il popolo chiese: “Ambrogio vescovo!”.
Ambrogio non era nemmeno battezzato, era soltanto un catecumeno, cioè si preparava al Battesimo. Il popolo però intuisce qualcosa di profondo di quest’uomo e lo elegge. Così la Chiesa ha avuto uno dei suoi vescovi più grandi, e un dottore della Chiesa.
Ambrogio prima non vuole, persino fugge. Poi comprende che quella è una chiamata di Dio, allora si lascia battezzare e ordinare vescovo. E diventa cristiano facendo il vescovo! Vedete che grande regalo fatto dai piccoli alla Chiesa? Anche oggi questa è una grazia da chiedere: diventare cristiani mentre si vive la chiamata ricevuta! Sei mamma, sei papà? Diventa cristiano come mamma e papà. Sei un imprenditore, un operaio, un insegnante, un prete, una religiosa? Diventa cristiano sulla tua strada. Il popolo ha questo “fiuto”: capisce se stiamo diventando cristiani o no. E ci può correggere, ci può indicare la direzione di Gesù.
Sant’Ambrogio, negli anni, ha poi restituito molto al suo popolo. Ad esempio, ha inventato nuovi modi di cantare salmi e inni, di celebrare, di predicare. Lui stesso sapeva intuire, e così la speranza si è moltiplicata. Agostino fu convertito dalla sua predicazione e fu da lui battezzato. Intuire è un modo di sperare, non dimentichiamolo!
Anche così Dio fa andare avanti la sua Chiesa, mostrandole nuove strade. Intuire è il fiuto dei piccoli per il Regno che viene. Che il Giubileo ci aiuti a diventare piccoli secondo il Vangelo per intuire e per servire i sogni di Dio!

DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV
AL COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DE "LA CIVILTÀ CATTOLICA"
Sala del Concistoro
Giovedì, 25 settembre 2025
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi!
Buongiorno e grazie per la pazienza!
A pochi mesi dall’inizio del Pontificato, sono contento di accogliere voi, membri del Collegio degli scrittori e collaboratori della rivista “La Civiltà Cattolica”. Saluto il Preposito Generale, che gentilmente ci accompagna in questa udienza.
Questo incontro si svolge nel 175° anniversario della fondazione de “La Civiltà Cattolica”. Colgo dunque l’occasione per ringraziare tutti voi per il servizio così fedele e generoso che per tanti anni avete prestato alla Sede Apostolica. Il vostro lavoro ha contribuito – e continua a farlo – a rendere la Chiesa presente nel mondo della cultura, in sintonia con gli insegnamenti del Papa e con gli orientamenti della Santa Sede.
Qualcuno ha definito la vostra rivista “una finestra sul mondo”, apprezzandone l’apertura, e davvero una sua caratteristica è quella di sapersi accostare all’attualità senza temere di affrontarne le sfide e le contraddizioni.
Potremmo individuare tre aree significative del vostro operato su cui soffermarci: educare le persone a un impegno intelligente e fattivo nel mondo, farsi voce degli ultimi, essere annunciatori di speranza.
Circa il primo aspetto, ciò che scrivete può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo, valutandone potenzialità e debolezze, nella ricerca di quei “segni dei tempi” alla cui attenzione ci ha richiamato il Concilio Vaticano II (cfr Cost. past. Gaudium et spes, 4). E ciò li metterà in grado di dare apporti validi, anche a livello politico, su temi fondamentali come l’equità sociale, la famiglia, l’istruzione, le nuove sfide tecnologiche, la pace. Con i vostri articoli, voi potete offrire a chi legge strumenti ermeneutici e criteri d’azione utili, perché ognuno possa contribuire alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno, nella verità e nella libertà. Come diceva San Giovanni Paolo II, il «ruolo della Chiesa, che voi siete chiamati ad amplificare e diffondere, è quello di proclamare il vangelo della carità e della pace, promuovendo la giustizia, lo spirito di fraternità e la consapevolezza del destino comune degli uomini, premesse indispensabili per la costruzione dell'autentica pace tra i popoli» (Discorso alla comunità della rivista “La Civiltà Cattolica”, 22 aprile 1999, 4).
Questo ci porta al secondo punto: farsi voce dei più poveri e degli esclusi. Papa Francesco ha scritto che, nell’annuncio del Vangelo, «c’è un segno che non deve mai mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 195). Farsi voce dei piccoli è dunque un aspetto fondamentale della vita e della missione di ogni cristiano. Esso richiede prima di tutto una grande e umile capacità di ascoltare, di stare vicino a chi soffre, per riconoscere nel suo grido silenzioso quello del Crocifisso che dice: «Ho sete» (Gv 19,28). Solo così è possibile farsi eco fedele e profetica della voce di chi è nel bisogno, spezzando ogni cerchio di isolamento, di solitudine e di sordità.
E veniamo al terzo punto: essere messaggeri di speranza. Si tratta di opporsi all’indifferentismo di chi rimane insensibile agli altri e al loro legittimo bisogno di futuro, come pure di vincere la delusione di chi non crede più nella possibilità di intraprendere nuove vie, ma soprattutto di ricordare e annunciare che per noi la speranza ultima è Cristo, nostra via (cfr Gv 14,6). In Lui e con Lui, sul nostro cammino non ci sono più vicoli ciechi, né realtà che, per quanto dure e complicate, possano fermarci e impedirci di amare con fiducia Dio e i fratelli. Come ha scritto Benedetto XVI, al di là di successi e fallimenti, io so che «la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell’Amore» (Lett. enc. Spe salvi, 35), e perciò trovo ancora e sempre il coraggio di operare e di proseguire (cfr ibid.). È un messaggio importante questo, specialmente in un mondo sempre più ripiegato su sé stesso.
Carissimi, concludendo vorrei ancora ricordare le parole che Papa Francesco vi ha indirizzato, poco prima di lasciarci, in occasione dell’inizio ufficiale del vostro “giubileo di fondazione”: «Vi incoraggio – scriveva – a proseguire nel vostro lavoro con gioia, mediante il buon giornalismo, che non aderisce ad altro schieramento se non a quello del Vangelo, ascoltando tutte le voci e incarnando quella docile mitezza che fa bene al cuore» (Messaggio al direttore de “La Civiltà Cattolica” nel 175° di pubblicazione, 17 marzo 2025: “L’Osservatore Romano”, 2 aprile 2025, p. 5).
E in un’altra occasione disse, riferendosi al nome del vostro periodico: «Una rivista è davvero “cattolica” solo se possiede lo sguardo di Cristo sul mondo, e se lo trasmette e lo testimonia» (Discorso alla comunità de “La civiltà cattolica”, 9 febbraio 2017). Ecco la vostra missione: cogliere lo sguardo di Cristo sul mondo, coltivarlo, comunicarlo, testimoniarlo.
Condividendo appieno le parole del mio compianto Predecessore, di nuovo vi ringrazio, vi assicuro il mio ricordo nella preghiera e vi benedico di cuore. Grazie!

La Giustizia: dedizione piena e comune per il bene di ogni individuo
Giubileo degli operatori di giustizia
20 settembre 2025
Il Papa: condizioni disumane per tanti popoli, uno Stato senza giustizia non è uno Stato
Leone XIV incontra in piazza san Pietro i partecipanti al Giubileo degli operatori di giustizia e lancia un forte appello a mettere la giustizia alla base della società, per promuovere il bene comune e tutelare i più deboli in un mondo colpito da tensioni, violenze e disuguaglianze. Quando si esercita la giustizia, sottolinea, “ci si pone al servizio delle persone, del popolo e dello Stato, in una dedizione piena e costante”. Il male non va “soltanto sanzionato, ma riparato”
Isabella H. de Carvalho
La realtà di “tanti Paesi e popoli” è che “hanno ‘fame e sete di giustizia’, perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili”. “All’attuale panorama internazionale andrebbero dunque applicate” le “sentenze permanente valide” di Sant’Agostino, ovvero come “lo Stato, in cui non si ha la giustizia, non è uno Stato”. È un forte appello a esercitare la giustizia a servizio dei più deboli, mettendo al centro la dignità e il diritto delle persone, in un mondo in cui troppi soffrono per discriminazioni e disuguaglianze, quello che Leone XIV rivolge agli operatori di giustizia in occasione del giubileo a loro dedicato, oggi, 20 settembre. L'evento inizia con un breve saluto dell'arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e il Papa viene accolto da una grande folla in piazza San Pietro, composta da magistrati, avvocati, rappresentati di associazioni e università e tanti altri da tutto il mondo che lavorano nel “vasto campo della giustizia”. Il Pontefice poi rivolge il suo discorso a tutti i presenti e auspica che le parole “impegnative” del santo che ha ispirato la famiglia religiosa a cui appartiene, scritte nell’opera De civitate Dei, possano essere una guida per creare società più eque: “Senza la giustizia non si può amministrare lo Stato; è impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia” e “la giustizia infatti è la virtù che distribuisce a ciascuno il suo. Dunque non è giustizia dell’uomo quella che sottrae l’uomo stesso al Dio vero”.
La giustizia, infatti, è chiamata a svolgere una funzione superiore nell’umana convivenza, che non può essere ridotta alla nuda applicazione della legge o all’operato dei giudici, né limitarsi agli aspetti procedurali.
La giustizia, strumento-cardine per il bene comune
Il Pontefice sottolinea che la giustizia è “indispensabile sia per l’ordinato sviluppo della società sia come virtù cardinale che ispira e orienta la coscienza di ogni uomo e donna”. Chiarisce che “il desiderio profondo del giusto” presente nel cuore di in ogni persona, “è lo strumento-cardine per edificare il bene comune in ogni società umana”. La giustizia, continua, è innanzitutto una virtù, ovvero “un atteggiamento fermo e stabile” che ordina la condotta “secondo la ragione e la fede”.
La giustizia dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l’armonia che promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene comune, obiettivo che si rende garante di un ordine a tutela del debole, di colui che chiede giustizia perché vittima di oppressione, escluso o ignorato.
“Nella giustizia, infatti, si coniugano la dignità della persona, il suo rapporto con l’altro e la dimensione della comunità fatta di convivenza, strutture e regole comuni”, quindi “una circolarità della relazione sociale che pone al centro il valore di ogni essere umano”, afferma Leone XIV. La giustizia deve garantire questo equilibrio “di fronte alle diverse forme di conflitto che possono sorgere nell’agire individuale, o nella perdita di senso comune che può coinvolgere anche gli apparati e le strutture”.
Mettersi al servizio delle persone e dello Stato
Papa Leone XIV spiega poi che “attraverso i valori posti alla base del vivere sociale, la giustizia assume il suo ruolo centrale per la convivenza delle persone e delle comunità umane” e riconosce che a sollecitare chi lavora in questo campo oggi “è proprio la ricerca o il recupero dei valori dimenticati nella convivenza, la loro cura e il loro rispetto”. Il Pontefice afferma come questo è “un processo utile e doveroso” davanti a “comportamenti e strategie che mostrano disprezzo per la vita umana sin dal suo primo manifestarsi, che negano diritti basilari per l’esistenza personale e non rispettano la coscienza da cui scaturiscono le libertà”. Infatti insiste che per operare la giustizia bisogna “pensare sempre alla luce della verità e della sapienza”, “interpretare la legge andando in profondità”, e “cogliere il senso intimo della verità”. “Tendere verso la giustizia, quindi, richiede di poterla amare come una realtà a cui si può giungere solo se si coniugano l’attenzione costante, il radicale disinteresse e un assiduo discernimento”, prosegue il Papa.
Quando si esercita la giustizia, infatti, ci si pone al servizio delle persone, del popolo e dello Stato, in una dedizione piena e costante. La grandezza della giustizia non diminuisce quando la si esercita nelle cose piccole, ma emerge sempre quando è applicata con fedeltà al diritto e al rispetto per la persona in qualunque parte del mondo si trovi.
Vera uguaglianza per combattere discriminazioni
Per rendere concreta questa giustizia, Leone XIV evidenzia, deve tendere “verso gli altri” in modo che a “ciascuno è reso quanto gli è dovuto, fino a raggiungere l’uguaglianza nella dignità e nelle opportunità fra gli esseri umani”. Il Papa riconosce che “l’effettiva uguaglianza non è quella formale di fronte alla legge” dato che “pur essendo una condizione indispensabile per il corretto esercizio della giustizia, non elimina il fatto che vi sono crescenti discriminazioni che hanno come primo effetto proprio il mancato accesso alla giustizia”. E chiama invece a promuovere società in cui la dignità di ogni individuo può essere valorizzata:
Vera uguaglianza, invece, è la possibilità data a tutti di realizzare le proprie aspirazioni e di vedere i diritti inerenti alla propria dignità garantiti da un sistema di valori comuni e condivisi, capaci di ispirare norme e leggi su cui fondare il funzionamento delle istituzioni.
L’importanza di riparare il male
Il Pontefice poi invita a guardare alla “giustizia evangelica” perché “non distoglie da quella umana, ma la interroga e ridisegna: la provoca ad andare sempre oltre, perché la spinge verso la ricerca della riconciliazione”. Citando vari episodi del Vangelo come la “vedova che induce il giudice a ritrovare il senso del giusto”, l’operaio pagato all’ultima ora, o ancora la parabola del figlio prodigo, Leone XIV evidenzia “la forza del perdono che è propria del comandamento dell’amore” ed emerge “come elemento costitutivo di una giustizia capace di coniugare il soprannaturale all’umano”.
Il male, infatti, non va soltanto sanzionato, ma riparato, e a tale scopo è necessario uno sguardo profondo verso il bene delle persone e il bene comune. Compito arduo, ma non impossibile per chi, cosciente di svolgere un servizio più esigente di altri, si impegna a tenere una condotta di vita irreprensibile.
Cercare una giustizia più grande
Riprendendo infine la beatitudine “beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati”, tratta dal Vangelo di Matteo, il Papa spiega che Gesù ha voluto “esprimere la tensione spirituale a cui è necessario essere aperti, non solo per ottenere una vera giustizia, ma soprattutto per ricercarla da parte di quanti la devono realizzare nelle diverse situazioni storiche”.
Avere “fame e sete” di giustizia equivale a essere consapevoli che essa esige lo sforzo personale per interpretare la legge nella misura più umana possibile, ma soprattutto chiede di tendere a una “sazietà” che può trovare compimento solo in una giustizia più grande, trascendente le situazioni particolari.
Giubileo degli Operatori di Giustizia: riprendere il senso alto e nobile del diritto
20 settembre 2025
Nella Lectio Magistralis tenuta in piazza San Pietro, monsignor Juan Ignacio Arrieta, segretario del Dicastero per i Testi Legislativi esorta l’intera classe forense a diffidare dal “pericolo del formalismo”, rispettando la dignità dei singoli e lasciandosi guidare dalla verità “oggettiva del caso concreto”. Ad introdurla, monsignor Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione che sottolinea l'importanza di promuovere le esigenze di persona, società e creato
Edoardo Giribaldi
Gli “eccessi” immortalati dal dottor Azzeccagarbugli nei Promessi Sposi diventano per la classe forense lo stimolo a riscoprire “il senso alto e nobile” della propria missione. In quest’ottica, il Giubileo degli Operatori di Giustizia rappresenta l’occasione per riorientare la bussola verso colui che è la fonte stessa della giustizia: Dio, “che ha ordinato ogni cosa in modo giusto”. La sua verità, “umile”, “paziente” ma anche “profondamente testarda, sapendo di prevalere sempre in superiore istanza”, rifugge il “pericolo del formalismo”, rispetta la dignità del singolo e conduce a un giudizio oggettivo “del caso concreto”. Sono questi alcuni dei temi trattati da monsignor Juan Ignacio Arrieta, segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, nella Lectio Magistralis pronunciata questa mattina, 19 settembre, in piazza San Pietro, nell’ambito degli eventi dell’Anno Santo dedicati agli operatori di giustizia. Per la prima volta nella storia dei Giubilei, essi raccolgono oltre 15mila partecipanti – giudici, magistrati, associazioni, università ed enti governativi – provenienti da circa 100 Paesi.
Giustizia sostanziale e relazionale
La riflessione del presule parte da un postulato comune a ogni credente: “la giustizia sta in Dio”. Essa possiede una duplice dimensione: “sostanziale”, come attributo della divina essenza che ha creato ogni cosa in modo retto e ordinato, e “relazionale”, che riguarda i rapporti tra gli uomini nella società. Apparentemente inconciliabili, queste due prospettive si rivelano in realtà complementari e inscindibili. “In fondo – ha spiegato il presule – è stato Dio a ordinare ogni cosa in modo giusto, e la giustizia degli uomini non può fare altro che reintegrare l’ordine da lui stabilito”.
L'intuizione di sant'Agostino
Sant’Agostino, ricordato dal vescovo, dedicò una parte della sua predicazione alla nozione di giustizia come imago Dei. Nel concreto, si impegnò “con assiduità nel ruolo di giudice”, arrivando a lamentarsi del tempo e delle energie che tale compito gli richiedeva. Per il santo di Ippona, la giustizia era “partecipazione alla Verità” e al tempo stesso impegno “per ricomporre l’ordine prestabilito da Dio”. Un’intuizione che unisce la dimensione sostanziale e quella relazionale: “essendo noi immagine" divina, "dobbiamo realizzare la giustizia che portiamo scritta nel cuore”.
La giustizia di Gesù
Secondo Arrieta, la giustizia assume così un’accezione “quasi sacra”, che trova piena realizzazione nella figura di Cristo. Alcuni episodi evangelici lo testimoniano: il pagamento delle tasse prescritte, pur non essendone tenuto “in tutta giustizia” come Figlio di Dio, ma affrontato “per evitare lo scandalo”; la denuncia della prassi che consentiva di liberarsi dagli obblighi familiari attraverso l’elemosina; , l'avere affermato "che il nuovo ordine della Grazia che stava per essere istaurato, respinge il ripudio, tollerato inizialmente a causa della profonda ferita lasciata dal peccato nella natura umana". In queste occasioni Gesù, come “fonte di autorità”, denuncia il “pericolo del formalismo”, corregge interpretazioni distorte della legge e ne restituisce il senso autentico. Con la sua croce, “salda la dimensione eterna dell’ingiustizia degli uomini nella storia”.
Operatori di giustizia, strumenti di speranza
Oggi, duemila anni dopo, gli operatori di giustizia sono chiamati a servire la dignità delle persone, occupandosi delle loro “più imperative necessità” e ponendosi – con le “differenze dovute”, ma al pari, ad esempio, di medici e sacerdoti – come “strumento di speranza”. È un compito gravoso, talvolta segnato da divisioni e dalla sensazione di “impotenza”. Gli stessi ordinamenti, osserva il presule, sembrano a volte “aver rinunciato alla verità oggettiva, prediligendo la sicurezza geometrica delle norme”. Il diritto canonico, mantenendosi “ai margini delle correnti positivistiche”, offre invece la possibilità di evitare che i singoli casi si perdano “nella boscaglia del sistema legale”, staccandosi da una “mera lettura” dei testi.
La verità, umile e testarda
Chi amministra la giustizia è “personalmente vincolato a criteri più elevati di verità”, cercando sempre – come ricordava il giurista Giuseppe Capograssi – la “certezza sostanziale del diritto, che risiede nella sostanza interiore dei principi della legge”. La verità, in questo senso, è “umile e paziente”, ma anche ostinata. La sua applicazione dovrebbe essere “rapida” e imparziale: “anche chi non potrà ripagare le energie spese, nelle cause d’ufficio o di povertà, ha diritto di essere assistito con uguale attenzione e professionalità”.
La legge naturale
Il segretario del Dicastero per i Testi Legislativi ha quindi richiamato le parole di Leone XIV ai parlamentari in occasione del Giubileo dei Governanti, secondo il quale “la legge naturale, universalmente valida al di là e al di sopra di altre convinzioni di carattere più opinabile, costituisce la bussola con cui orientarsi nel legiferare e nell'agire”. Riprendendo Cicerone (De re publica), il Pontefice ricordava come essa sia “diritta ragione, conforme a natura, universale, costante ed eterna, la quale con i suoi ordini invita al dovere, con i suoi divieti distoglie dal male. A questa legge non è lecito fare alcuna modifica né sottrarre qualche parte, né è possibile abolirla del tutto".
Il ricordo del magistrato Livatino
Il Giubileo degli Operatori di Giustizia coincide, domenica, con il 35.mo anniversario dell’uccisione del magistrato Rosario Livatino, assassinato a 33 anni il 21 settembre 1990 lungo la strada tra Caltanissetta e Agrigento, in Sicilia. Beatificato il 9 maggio 2021, al processo di canonizzazione testimoniò anche uno dei suoi assassini, pentito e convertito grazie al suo esempio. Livatino firmava i propri scritti professionali con l’acronimo S.T.D., “Sub tutela Dei”, formula che alcune cancellerie medievali usavano per porre gli atti “sotto gli auspici di Dio”. Per lui, diritto e fede erano realtà “'continuamente interdipendenti fra loro, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte armonioso, a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispensabile”.
L'arduo compito di decidere
Agli operatori del diritto spetta quindi uno dei compiti più ardui: “decidere”. Arrieta ha concluso citando lo stesso Livatino: “quando moriremo, nessuno ci chiederà quanto siamo stati credenti, ma credibili”. Un richiamo a un impegno concreto che renda visibile, anche nell’esercizio della professione giuridica, la coerenza delle convinzioni cristiane.
Il saluto di Fisichella
Ad introdurre la Lectio, prima dell'udienza con il Papa, monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, che ha dato il benvenuto alla variegata assemblea “unita dall’amore per la giustizia”. Il presule ha ricordato la pagina biblica del libro del Levitico nella quale vengono date delle “prescrizioni” giuridiche per la celebrazione del giubileo che fanno “leva sul condono del debito e la possibilità di riscatto dei beni perché la terra appartiene a Dio”. “Questo Giubileo possa essere anche per tutti voi un richiamo all’importanza del diritto che sa cogliere in profondità le esigenze della persona, della società e del creato - ha detto Fisichella - perché inserito in quel diritto naturale impresso nella creazione che supera i confini delle nazioni e dei popoli”.

LEONE XIV
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 17 settembre 2025
Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. III. La Pasqua di Gesù. 7. La morte. «Un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto» (Gv 19,40-41)
Cari fratelli e sorelle,
nel nostro cammino di catechesi su Gesù nostra speranza, oggi contempliamo il mistero del Sabato Santo. Il Figlio di Dio giace nel sepolcro. Ma questa sua “assenza” non è un vuoto: è attesa, pienezza trattenuta, promessa custodita nel buio. È il giorno del grande silenzio, in cui il cielo sembra muto e la terra immobile, ma è proprio lì che si compie il mistero più profondo della fede cristiana. È un silenzio gravido di senso, come il grembo di una madre che custodisce il figlio non ancora nato, ma già vivo.
Il corpo di Gesù, calato dalla croce, viene fasciato con cura, come si fa con ciò che è prezioso. L’evangelista Giovanni ci dice che fu sepolto in un giardino, dentro «un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto» (Gv 19,41). Nulla è lasciato al caso. Quel giardino richiama l’Eden perduto, il luogo in cui Dio e l’uomo erano uniti. E quel sepolcro mai usato parla di qualcosa che deve ancora accadere: è una soglia, non un termine. All’inizio della creazione Dio aveva piantato un giardino, ora anche la nuova creazione prende avvio in un giardino: con una tomba chiusa che, presto, si aprirà.
Il Sabato Santo è anche un giorno di riposo. Secondo la Legge ebraica, nel settimo giorno non si deve lavorare: infatti, dopo sei giorni di creazione, Dio si riposò (cfr Gen 2,2). Ora anche il Figlio, dopo aver completato la sua opera di salvezza, riposa. Non perché è stanco, ma perché ha terminato il suo lavoro. Non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c’è più nulla da aggiungere. Questo riposo è il sigillo dell’opera compiuta, è la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine. È un riposo pieno della presenza nascosta del Signore.
Noi facciamo fatica a fermarci e a riposare. Viviamo come se la vita non fosse mai abbastanza. Corriamo per produrre, per dimostrare, per non perdere terreno. Ma il Vangelo ci insegna che saperci fermare è un gesto di fiducia che dobbiamo imparare a compiere. Il Sabato Santo ci invita a scoprire che la vita non dipende sempre da ciò che facciamo, ma anche da come sappiamo congedarci da quanto abbiamo potuto fare.
Nel sepolcro, Gesù, la Parola vivente del Padre, tace. Ma è proprio in quel silenzio che la vita nuova inizia a fermentare. Come un seme nella terra, come il buio prima dell’alba. Dio non ha paura del tempo che passa, perché è Signore anche dell’attesa. Così, anche il nostro tempo “inutile”, quello delle pause, dei vuoti, dei momenti sterili, può diventare grembo di risurrezione. Ogni silenzio accolto può essere la premessa di una Parola nuova. Ogni tempo sospeso può diventare tempo di grazia, se lo offriamo a Dio.
Gesù, sepolto nella terra, è il volto mite di un Dio che non occupa tutto lo spazio. È il Dio che lascia fare, che attende, che si ritira per lasciare a noi la libertà. È il Dio che si fida, anche quando tutto sembra finito. E noi, in quel sabato sospeso, impariamo che non dobbiamo avere fretta di risorgere: prima occorre restare, accogliere il silenzio, lasciarci abbracciare dal limite. A volte cerchiamo risposte rapide, soluzioni immediate. Ma Dio lavora nel profondo, nel tempo lento della fiducia. Il sabato della sepoltura diventa così il grembo da cui può sgorgare la forza di una luce invincibile, quella della Pasqua.
Cari amici, la speranza cristiana non nasce nel rumore, ma nel silenzio di un’attesa abitata dall’amore. Non è figlia dell’euforia, ma dell’abbandono fiducioso. Ce lo insegna la Vergine Maria: lei incarna questa attesa, questa fiducia, questa speranza. Quando ci sembra che tutto sia fermo, che la vita sia una strada interrotta, ricordiamoci del Sabato Santo. Anche nel sepolcro, Dio sta preparando la sorpresa più grande. E se sappiamo accogliere con gratitudine quello che è stato, scopriremo che, proprio nella piccolezza e nel silenzio, Dio ama trasfigurare la realtà, facendo nuove tutte le cose con la fedeltà del suo amore. La vera gioia nasce dall’attesa abitata, dalla fede paziente, dalla speranza che quanto è vissuto nell’amore, certo, risorgerà a vita eterna.

GIUBILEO DELLA CONSOLAZIONE
VEGLIA DI PREGHIERA
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE LEONE XIV
Basilica di San Pietro
Lunedì, 15 settembre 2025
«Consolate, consolate il mio popolo» (Is 40,1). È questo l’invito del profeta Isaia, che oggi giunge in modo impegnativo anche a noi: ci chiama a condividere la consolazione di Dio con tanti fratelli e sorelle che vivono situazioni di debolezza, di tristezza, di dolore. Per quanti sono nel pianto, nella disperazione, nella malattia e nel lutto risuona chiaro e forte l’annuncio profetico della volontà del Signore di porre termine alla sofferenza e cambiarla in gioia. In questo senso, vorrei ringraziare di nuovo le due persone che hanno dato la loro testimonianza. Si può trasformare tutto il dolore con la grazia di Gesù Cristo. Grazie! Questa Parola compassionevole, fattasi carne in Cristo, è il buon samaritano di cui ci ha parlato il Vangelo: è Lui che lenisce le nostre ferite, è Lui che si prende cura di noi. Nel momento del buio, anche contro ogni evidenza, Dio non ci lascia soli; anzi, proprio in questi frangenti siamo chiamati più che mai a sperare nella sua vicinanza di Salvatore che non abbandona mai.
Cerchiamo chi ci consoli e spesso non lo troviamo. Talvolta ci diventa persino insopportabile la voce di quanti, con sincerità, intendono partecipare al nostro dolore. È vero, ci sono situazioni in cui le parole non servono e diventano quasi superflue. In questi momenti rimangono, forse, solo le lacrime del pianto, se pure queste non si sono esaurite. Papa Francesco ricordava le lacrime di Maria Maddalena, disorientata e sola, presso il sepolcro vuoto di Gesù. «Piange semplicemente – diceva –. Vedete, alle volte nella nostra vita gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. C’è un momento nella nostra vita in cui solo le lacrime ci preparano a vedere Gesù. E quale è il messaggio di questa donna? “Ho visto il Signore”». [1]
Care sorelle e cari fratelli, le lacrime sono un linguaggio, che esprime sentimenti profondi del cuore ferito. Le lacrime sono un grido muto che implora compassione e conforto. Ma prima ancora sono liberazione e purificazione degli occhi, del sentire, del pensare. Non bisogna vergognarsi di piangere; è un modo per esprimere la nostra tristezza e il bisogno di un mondo nuovo; è un linguaggio che parla della nostra umanità debole e messa alla prova, ma chiamata alla gioia.
Dove c’è il dolore sorge inevitabile l’interrogativo: perché tutto questo male? Da dove proviene? Perché è dovuto capitare proprio a me? Nelle sue Confessioni, Sant’Agostino scrive: «Cercavo l’origine del male … qual è la sua radice, quale il suo seme?... Se Dio che è buono ha creato buone tutte le cose, allora da dove ha origine il male?... Tali erano i pensieri che io manipolavo nel mio misero cuore … Tuttavia, salda e stabile rimaneva nel mio cuore la fede nella Chiesa cattolica del suo Cristo, nostro Signore e Salvatore; fede che non intendevo abbandonare, benché su molti punti fosse vaga e fluttuante» (VII, 5).
Il passaggio dalle domande alla fede è quello a cui ci educa la Sacra Scrittura. Vi sono infatti domande che ci ripiegano su noi stessi e ci dividono interiormente e dalla realtà. Vi sono pensieri da cui non può nascere nulla. Se ci isolano e ci disperano, umiliano anche l’intelligenza. Meglio, come nei Salmi, che la domanda sia protesta, lamento, invocazione di quella giustizia e di quella pace che Dio ci ha promesso. Allora gettiamo un ponte verso il cielo, anche quando sembra muto. Nella Chiesa cerchiamo il cielo aperto, che è Gesù, il ponte di Dio verso di noi. Esiste una consolazione che allora ci raggiunge, quando “salda e stabile” rimane quella fede che ci pare “vaga e fluttuante” come una barca nella tempesta.
Dove c’è il male, là dobbiamo ricercare il conforto e la consolazione che lo vincono e non gli danno tregua. Nella Chiesa significa: mai da soli. Poggiare il capo su una spalla che ti consola, che piange con te e ti dà forza, è una medicina di cui nessuno può privarsi perché è il segno dell’amore. Dove profondo è il dolore, ancora più forte dev’essere la speranza che nasce dalla comunione. E questa speranza non delude.
Le testimonianze che abbiamo ascoltato trasmettono questa certezza: che il dolore non deve generare violenza; che la violenza non è l’ultima parola, perché viene vinta dall’amore che sa perdonare. Quale liberazione più grande possiamo sperare di raggiungere, se non quella che proviene dal perdono, che per grazia può aprire il cuore nonostante abbia subito ogni sorta di brutalità? La violenza patita non può essere cancellata, ma il perdono concesso a quanti l’hanno generata è un’anticipazione sulla terra del Regno di Dio, è il frutto della sua azione che pone termine al male e stabilisce la giustizia. La redenzione è misericordia e può rendere migliore il nostro futuro, mentre ancora attendiamo il ritorno del Signore. Lui solo asciugherà ogni lacrima e aprirà il libro della storia consentendoci di leggere le pagine che oggi non possiamo giustificare né comprendere (cfr Ap 5).
Anche a voi, fratelli e sorelle che avete subito l’ingiustizia e la violenza dell’abuso, Maria ripete oggi: “Io sono tua madre”. E il Signore, nel segreto del cuore, vi dice: “Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia”. Nessuno può togliere questo dono personale offerto a ciascuno. E la Chiesa, di cui alcuni membri purtroppo vi hanno ferito, oggi si inginocchia insieme a voi davanti alla Madre. Che tutti possiamo imparare da lei a custodire i più piccoli e fragili con tenerezza! Che impariamo ad ascoltare le vostre ferite, a camminare insieme. Che possiamo ricevere da Maria Addolorata la forza di riconoscere che la vita non è definita solo dal male patito, ma dall’amore di Dio che mai ci abbandona e che guida tutta la Chiesa.
Le parole di San Paolo, poi, ci suggeriscono che, quando si riceve consolazione da Dio, allora si diventa capaci di offrire consolazione anche agli altri: «Egli – scrive l’Apostolo – ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio» (2Cor 1,4). I segreti del nostro cuore non sono nascosti a Dio: non dobbiamo impedirgli di consolarci, illudendoci che possiamo contare solo sulle nostre forze.
Sorelle e fratelli, al termine di questa Veglia vi verrà offerto un piccolo dono: l’Agnus Dei. È un segno che potremo portare nelle nostre case per ricordare che il mistero di Gesù, della sua morte e risurrezione è la vittoria del bene sul male. Lui è l’Agnello che dona lo Spirito Santo Consolatore, il quale non ci lascia mai, ci conforta nelle necessità e ci fortifica con la sua grazia (cfr At 15,31).
Quanti amiamo e ci sono stati strappati da sorella morte non vanno perduti e non spariscono nel nulla. La loro vita appartiene al Signore che, come Buon Pastore, li abbraccia e li tiene stretti a sé, e ce li restituirà un giorno perché possiamo godere una felicità eterna e condivisa.
Carissimi, come c’è il dolore personale, così, anche ai nostri giorni, esiste il dolore collettivo di intere popolazioni che, schiacciate dal peso della violenza, della fame e della guerra, implorano pace. È un grido immenso, che impegna noi a pregare e agire, perché cessi ogni violenza e chi soffre possa ritrovare serenità; e impegna prima di tutto Dio, il cui cuore freme di compassione, a venire nel suo Regno. La vera consolazione che dobbiamo essere capaci di trasmettere è quella di mostrare che la pace è possibile, e che germoglia in ognuno di noi se non la soffochiamo. I responsabili delle Nazioni ascoltino in modo particolare il grido di tanti bambini innocenti, per garantire loro un futuro che li protegga e li consoli.
In mezzo a tanta prepotenza, ne siamo certi, Dio non farà mancare cuori e mani che portano aiuto e consolazione, operatori di pace capaci di rincuorare coloro che sono nel dolore e nella tristezza. E insieme, come Gesù ci ha insegnato, invocheremo con più verità: “Venga il tuo Regno!”.
________________________________________
[1] Francesco, Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae (2 aprile 2013).

DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV
AI PARTECIPANTI AL CAPITOLO GENERALE DELL'ORDINE DI SANT'AGOSTINO
Pontificio Istituto Patristico "Augustinianum"
Lunedì, 15 settembre 2025
Sono felice di essere qui con voi in occasione del vostro Capitolo Generale. Posso dire di sentirmi a casa e di partecipare interiormente anch’io, in spirito di condivisione spirituale, a quanto state vivendo in questi giorni. Ringrazio il Priore Generale che ha terminato il suo servizio e saluto il nuovo Priore appena eletto: per questo compito così impegnativo ci vuole la preghiera di tutti noi, non dimentichiamolo!
Il Capitolo Generale è una preziosa occasione per pregare insieme e riflettere sul dono ricevuto, sull’attualità del carisma e anche sulle sfide e le problematiche che interpellano la comunità. Mentre si portano avanti le diverse attività, celebrare il Capitolo significa mettersi in ascolto dello Spirito, in un certo senso in analogia con quanto diceva il nostro padre Agostino richiamando l’importanza dell’interiorità nel cammino della fede: «Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita nell’uomo interiore» (De vera religione, 39, 72).
D’altra parte, l’interiorità non è una fuga dalle nostre responsabilità personali e comunitarie, dalla missione che il Signore ci ha affidato nella Chiesa e nel mondo, dalle domande e dai problemi urgenti. Si rientra in sé stessi per poi uscire in modo ancora più motivato ed entusiasta nella missione. Rientrare in noi stessi rinnova lo slancio spirituale e pastorale: si ritorna alla sorgente della vita religiosa e della consacrazione, per poter offrire luce a coloro che il Signore pone sul nostro cammino. Si riscopre la relazione con il Signore e con i fratelli della propria famiglia religiosa, perché da questa comunione d’amore possiamo trarre ispirazione e affrontare meglio le questioni della vita comunitaria e le sfide apostoliche.
In tale contesto, dopo un’ampia e condivisa riflessione che avete portato avanti in questi anni, vi state soffermando su alcune tematiche che vorrei brevemente richiamare.
Anzitutto, un tema fondamentale: le vocazioni e la formazione iniziale. Mi piace ricordare quell’esortazione di Sant’Agostino: «Amate ciò che sarete» (Discorso 216, 8). Trovo che sia un’indicazione preziosa, soprattutto per non cadere nell’errore di immaginare la formazione religiosa come un insieme di regole da osservare o di cose da fare o, ancora, come un abito già confezionato da indossare passivamente. Al centro di tutto, invece, c’è l’amore. La vocazione cristiana, e quella religiosa in particolare, nasce solo quando si avverte l’attrazione di qualcosa di grande, di un amore che possa nutrire e saziare il cuore. Perciò la nostra prima preoccupazione dovrebbe essere quella di aiutare, specialmente i giovani, a intravedere la bellezza della chiamata e ad amare ciò che, abbracciando la vocazione, potranno diventare. La vocazione e la formazione non sono realtà prestabilite: sono un’avventura spirituale che coinvolge tutta la storia di una persona, e si tratta anzitutto di un’avventura d’amore con Dio.
L’amore, che, come sappiamo, Agostino ha messo al centro della sua ricerca spirituale, è un criterio fondamentale anche per la dimensione dello studio teologico e della formazione intellettuale. Nella conoscenza di Dio non è mai possibile arrivare a Lui con la nostra sola ragione e con una serie di informazioni teoriche, ma si tratta anzitutto di lasciarsi stupire dalla sua grandezza, di interrogare noi stessi e il senso delle cose che accadono per rintracciarvi le orme del Creatore, e soprattutto di amarlo e di farlo amare. A coloro che studiano, Agostino suggerisce generosità e umiltà, che nascono appunto dall’amore: la generosità di comunicare agli altri le proprie ricerche, perché ciò vada a vantaggio della loro fede; l’umiltà per non cadere nella vanagloria di chi cerca la scienza per sé stessa, sentendosi superiore agli altri per il fatto di possederla.
Al contempo, il dono ineffabile della carità divina è ciò a cui dobbiamo guardare se vogliamo vivere al meglio anche la vita comunitaria e l’attività apostolica, mettendo in comune i nostri beni materiali, come pure quelli umani e spirituali. Ricordiamoci di quanto è efficace ciò che è scritto nella nostra Regola: «Come siete nutriti da una sola dispensa, così vestitevi da un solo guardaroba» (Regola, 30). Restiamo fedeli alla povertà evangelica e facciamo in modo che diventi criterio per vivere tutto ciò che siamo e che abbiamo, compresi i mezzi e le strutture, al servizio della nostra missione apostolica.
Infine, non dimentichiamoci della nostra vocazione missionaria. A partire dalla prima missione nel 1533, gli Agostiniani hanno annunciato il Vangelo in tante parti del mondo con passione e generosità, prendendosi cura delle comunità cristiane locali, dedicandosi all’educazione e all’insegnamento, spendendosi per i poveri e realizzando opere sociali e caritative. Questo spirito missionario non deve spegnersi, perché anche oggi ce n’è molto bisogno. Vi esorto a ravvivarlo, ricordando che la missione evangelizzatrice a cui tutti siamo chiamati esige la testimonianza di una gioia umile e semplice, la disponibilità al servizio, la condivisione della vita del popolo a cui siamo inviati.
Carissimi, vi auguro di proseguire i lavori del Capitolo nella gioia fraterna e con il cuore disposto ad accogliere i suggerimenti dello Spirito. Prego per voi, perché la carità del Signore ispiri i vostri pensieri e le vostre azioni, rendendovi apostoli e testimoni del Vangelo nel mondo. Intercedano la Vergine Maria e Sant’Agostino, e vi accompagni la benedizione apostolica.

"RENDIAMO IL MONDO UN POSTO MIGLIORE"
COMMEMORAZIONE DEI MARTIRI E TESTIMONI DELLA FEDE DEL XXI SECOLO
OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Basilica di San Paolo fuori le mura
14 settembre 2025
Fratelli e sorelle,
«Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6,14). Le parole dell’apostolo Paolo, presso la cui tomba siamo riuniti, ci introducono alla commemorazione dei martiri e dei testimoni della fede del XXI secolo, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce.
Ai piedi della Croce di Cristo, nostra salvezza, descritta come la “speranza dei cristiani” e la “gloria dei martiri” (cfr Vespro della Liturgia bizantina per la Festa dell’Esaltazione della Croce), saluto i Rappresentanti delle Chiese Ortodosse, delle Antiche Chiese Orientali, delle Comunioni cristiane e delle Organizzazioni ecumeniche, che ringrazio per aver accettato il mio invito a questa celebrazione. A tutti voi qui presenti rivolgo il mio abbraccio di pace!
Siamo convinti che la martyria fino alla morte è «la comunione più vera che ci sia con Cristo che effonde il suo sangue e, in questo sacrificio, fa diventare vicini coloro che un tempo erano lontani (cfr Ef 2,13)» (Lett. enc. Ut unum sint, 84). Anche oggi possiamo affermare con Giovanni Paolo II che, laddove l’odio sembrava permeare ogni aspetto della vita, questi audaci servitori del Vangelo e martiri della fede hanno dimostrato in modo evidente che «l’amore è più forte della morte» (Commemorazione dei Testimoni della fede nel XX secolo, 7 maggio 2000).
Ricordiamo questi nostri fratelli e sorelle con lo sguardo rivolto al Crocifisso. Con la sua croce Gesù ci ha manifestato il vero volto di Dio, la sua infinita compassione per l’umanità; ha preso su di sé l’odio e la violenza del mondo, per condividere la sorte di tutti coloro che sono umiliati e oppressi: «Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori» (Is 53,4).
Tanti fratelli e sorelle, anche oggi, a causa della loro testimonianza di fede in situazioni difficili e contesti ostili, portano la stessa croce del Signore: come Lui sono perseguitati, condannati, uccisi. Di essi Gesù dice: «Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,10-11). Sono donne e uomini, religiose e religiosi, laici e sacerdoti, che pagano con la vita la fedeltà al Vangelo, l’impegno per la giustizia, la lotta per la libertà religiosa laddove è ancora violata, la solidarietà con i più poveri. Secondo i criteri del mondo essi sono stati “sconfitti”. In realtà, come ci dice il Libro della Sapienza: «Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena d’immortalità» (Sap 3,4).
Fratelli e sorelle, nel corso dell’Anno giubilare, celebriamo la speranza di questi coraggiosi testimoni della fede. È una speranza piena d’immortalità, perché il loro martirio continua a diffondere il Vangelo in un mondo segnato dall’odio, dalla violenza e dalla guerra; è una speranza piena d’immortalità, perché, pur essendo stati uccisi nel corpo, nessuno potrà spegnere la loro voce o cancellare l’amore che hanno donato; è una speranza piena d’immortalità, perché la loro testimonianza rimane come profezia della vittoria del bene sul male.
Sì, la loro è una speranza disarmata. Hanno testimoniato la fede senza mai usare le armi della forza e della violenza, ma abbracciando la debole e mite forza del Vangelo, secondo le parole dell’apostolo Paolo: «Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. […] Infatti quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,9-10).
Penso alla forza evangelica di Suor Dorothy Stang, impegnata per i senza terra in Amazzonia: a chi si apprestava a ucciderla chiedendole un’arma, lei mostrò la Bibbia rispondendo: “Ecco la mia unica arma”. Penso a Padre Ragheed Ganni, prete caldeo di Mosul in Iraq, che ha rinunciato a combattere per testimoniare come si comporta un vero cristiano. Penso a fratel Francis Tofi, anglicano e membro della Melanesian Brotherhood, che ha dato la vita per la pace nelle Isole Salomone. Gli esempi sarebbero tanti, perché purtroppo, nonostante la fine delle grandi dittature del Novecento, ancora oggi non è finita la persecuzione dei cristiani, anzi, in alcune parti del mondo è aumentata.
Questi audaci servitori del Vangelo e martiri della fede, «costituiscono come un grande affresco dell’umanità cristiana […]. Un affresco del vangelo delle Beatitudini, vissuto sino allo spargimento del sangue» (S. Giovanni Paolo II, Commemorazione dei Testimoni della fede nel XX secolo, 7 maggio 2000).
Cari fratelli e sorelle, non possiamo, non vogliamo dimenticare. Vogliamo ricordare. Lo facciamo, certi che, come nei primi secoli, anche nel terzo millennio «il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani» (Tertulliano). Vogliamo preservare la memoria insieme ai nostri fratelli e sorelle delle altre Chiese e Comunioni cristiane. Desidero quindi ribadire l’impegno della Chiesa Cattolica a custodire la memoria dei testimoni della fede di tutte le tradizioni cristiane. La Commissione per i Nuovi Martiri, presso il Dicastero per le Cause dei Santi, adempie a tale compito, collaborando con il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.
Come riconoscevamo durante il recente Sinodo, l’ecumenismo del sangue unisce i «cristiani di appartenenze diverse che insieme danno la vita per la fede in Gesù Cristo. La testimonianza del loro martirio è più eloquente di ogni parola: l’unità viene dalla Croce del Signore» (XVI Assemblea sinodale, Documento finale, n. 23). Possa il sangue di tanti testimoni avvicinare il giorno beato in cui berremo allo stesso calice di salvezza!
Carissimi, un bambino pakistano, Abish Masih, ucciso in un attentato contro la Chiesa cattolica, aveva scritto sul proprio quaderno: «Making the world a better place», «rendere il mondo un posto migliore». Il sogno di questo bambino ci sproni a testimoniare con coraggio la nostra fede, per essere insieme lievito di un’umanità pacifica e fraterna.

PAPA LEONE XIV
ANGELUS
Piazza San Pietro
Domenica, 14 settembre 2025
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Oggi la Chiesa celebra la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, in cui ricorda il ritrovamento del legno della Croce da parte di Sant’Elena, a Gerusalemme, nel IV secolo, e la restituzione della preziosa Reliquia alla Città santa, ad opera dell’Imperatore Eraclio.
Ma cosa vuol dire per noi, oggi, celebrare questa Festa? Ci aiuta a comprenderlo il Vangelo che la liturgia ci propone (cfr Gv 3,13-17). La scena si svolge di notte: Nicodemo, uno dei capi dei Giudei, persona retta e dalla mente aperta (cfr Gv 7,50-51), viene a incontrare Gesù. Ha bisogno di luce, di guida: cerca Dio e chiede aiuto al Maestro di Nazaret, perché in Lui riconosce un profeta, un uomo che compie segni straordinari.
Il Signore lo accoglie, lo ascolta, e alla fine gli rivela che il Figlio dell’uomo dev’essere innalzato, «perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 3,15), e aggiunge: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (cfr v. 16). Nicodemo, che forse al momento non comprende appieno il senso di queste parole, lo potrà fare certamente quando, dopo la crocifissione, aiuterà a seppellire il corpo del Salvatore (cfr Gv 19,39): capirà che Dio, per redimere gli uomini, si è fatto uomo ed è morto sulla croce.
Gesù parla di questo a Nicodemo, richiamando un episodio dell’Antico Testamento (cfr Nm 21,4-9), quando nel deserto gli Israeliti, assaliti da serpenti velenosi, si salvavano guardando il serpente di bronzo che Mosè, obbedendo al comando di Dio, aveva fatto e posto sopra un’asta.
Dio ci ha salvati mostrandosi a noi, offrendosi come nostro compagno, maestro, medico, amico, fino a farsi per noi Pane spezzato nell’Eucaristia. E per compiere quest’opera si è servito di uno degli strumenti di morte più crudeli che l’uomo abbia mai inventato: la croce.
Per questo oggi noi ne celebriamo l’“esaltazione”: per l’amore immenso con cui Dio, abbracciandola per la nostra salvezza, l’ha trasformata da mezzo di morte a strumento di vita, insegnandoci che niente può separarci da Lui (cfr Rm 8,35-39) e che la sua carità è più grande del nostro stesso peccato (cfr Francesco, Catechesi, 30 marzo 2016).
Chiediamo allora, per intercessione di Maria, la Madre presente al Calvario vicino al suo Figlio, che anche in noi si radichi e cresca il suo amore che salva, e che anche noi sappiamo donarci gli uni agli altri, come Lui si è donato tutto a tutti.

VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE LEONE XIV
IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL PROGETTO
“GESTI DELL’ACCOGLIENZA”
ALLA LISTA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELL’UNESCO
[Lampedusa, venerdì 12 settembre 2025]
Cari fratelli e sorelle riuniti a Lampedusa!
“O’scià!”. Il soffio, il respiro: questo vi augurate, salutandovi nel vostro dialetto. E così vi salutò nel 2013 il nostro amato Papa Francesco quando venne tra voi: fu il suo primo viaggio. Sapete che nella lingua della Bibbia il soffio, il respiro sono ciò che noi traduciamo “lo spirito”. E così, nel salutarci – oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona –, come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo, il soffio di Dio.
I frutti dello Spirito, cari amici, sono abbondanti fra di voi. Mi ricordate ciò che scrisse l’apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica: voi avete «accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti» (1Ts 1,6-7). La posizione geografica di Lampedusa e Linosa, infatti, da sempre fa di voi una porta d’Europa. Negli ultimi decenni, ciò ha richiesto alla vostra comunità un enorme impegno di accoglienza, che dal cuore del Mediterraneo vi ha portati nel cuore della Chiesa, «tanto che – dice ancora San Paolo – non abbiamo bisogno di parlarne» (1Ts 1,8), perché la vostra fede e la vostra carità sono ormai note a tutti. È un patrimonio immateriale, ma reale.
Il mio “grazie”, che è il “grazie” di tutta la Chiesa per la vostra testimonianza, prolunga e rinnova quello di Papa Francesco. “Grazie” alle associazioni, ai volontari, ai sindaci e alle amministrazioni che nel tempo si sono succeduti; “grazie” ai sacerdoti, ai medici, alle forze di sicurezza e a tutti coloro che, spesso invisibilmente, hanno mostrato e mostrano il sorriso e l’attenzione di un volto umano a persone sopravvissute nel loro viaggio disperato di speranza.
Voi siete un baluardo di quell’umanità che le ragioni gridate, le paure ataviche e i provvedimenti ingiusti tendono a incrinare. Non c’è giustizia senza compassione, non c’è legittimità senza ascolto del dolore altrui. Tante vittime – e fra loro quante madri, e quanti bambini! – dalle profondità del Mare nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Parecchi fratelli e sorelle migranti sono stati sepolti a Lampedusa, e riposano nella terra come semi da cui vuole germogliare un mondo nuovo. Non mancano, grazie a Dio, migliaia di volti e di nomi di persone che vivono oggi una vita migliore e non dimenticheranno mai la vostra carità. Molti di loro sono diventati a loro volta operatori di giustizia e di pace, perché il bene è contagioso.
Sorelle e fratelli, il soffio dello Spirito non venga a mancarvi mai! È vero, col passare degli anni può subentrare la stanchezza. Come in una corsa, può mancare il fiato. Le fatiche tendono a mettere in questione ciò che si è fatto e, a volte, anche a dividerci. Bisogna reagire insieme, stando uniti e aprendoci di nuovo al respiro di Dio. Tutto il bene che avete fatto potrebbe sembrare come gocce nel mare. Non è così, è molto di più!
La globalizzazione dell’indifferenza, che Papa Francesco denunciò proprio a partire da Lampedusa, sembra oggi essersi mutata in una globalizzazione dell’impotenza. Davanti all’ingiustizia e al dolore innocente siamo più consapevoli, ma rischiamo di stare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia niente da fare. Cosa posso fare io, davanti a mali così grandi? La globalizzazione dell’impotenza è figlia di una menzogna: che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori. Allora sembra che noi non possiamo nulla. Invece no: la storia è devastata dai prepotenti, ma è salvata dagli umili, dai giusti, dai martiri, nei quali il bene risplende e l’autentica umanità resiste e si rinnova.
Come alla globalizzazione dell’indifferenza Papa Francesco oppose la cultura dell’incontro, così vorrei che oggi, insieme, iniziassimo a opporre alla globalizzazione dell’impotenza una cultura della riconciliazione. Riconciliarsi è un modo particolare di incontrarsi. Oggi dobbiamo incontrarci curando le nostre ferite, perdonandoci il male che abbiamo fatto e anche quello che non abbiamo fatto, ma di cui portiamo gli effetti. Tanta paura, tanti pregiudizi, grandi muri anche invisibili ci sono tra noi e tra i nostri popoli, come conseguenze di una storia ferita. Il male si trasmette da una generazione all’altra, da una comunità all’altra. Ma anche il bene si trasmette e sa essere più forte! Per praticarlo, per rimetterlo in circolo, dobbiamo diventare esperti di riconciliazione. Bisogna riparare ciò che è infranto, trattare con delicatezza le memorie che sanguinano, avvicinarci gli uni agli altri con pazienza, immedesimarci nella storia e nel dolore altrui, riconoscere che abbiamo gli stessi sogni, le stesse speranze. Non esistono nemici: esistono solo fratelli e sorelle. È la cultura della riconciliazione. Servono gesti di riconciliazione e politiche di riconciliazione.
Cari fratelli e sorelle, andiamo avanti insieme su questa strada di incontro e di riconciliazione. Così si moltiplicheranno le isole di pace, diventeranno piloni di ponti, affinché la pace possa raggiungere tutti i popoli e tutte le creature. In questo orizzonte di speranza e di impegno, per l’intercessione di Maria Stella del Mare vi benedico e con tanto affetto vi saluto. O’scià! E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. Amen.

LEONE XIV
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 10 settembre 2025
Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. III. La Pasqua di Gesù. 6. La morte. «Gesù, dando un forte grido, spirò» (Mc 15,37)
Cari fratelli e sorelle,
buongiorno e grazie per la vostra presenza, una bella testimonianza!
Oggi contempliamo il vertice della vita di Gesù in questo mondo: la sua morte in croce. I Vangeli attestano un particolare molto prezioso, che merita di essere contemplato con l’intelligenza della fede. Sulla croce, Gesù non muore in silenzio. Non si spegne lentamente, come una luce che si consuma, ma lascia la vita con un grido: «Gesù, dando un forte grido, spirò» (Mc 15,37). Quel grido racchiude tutto: dolore, abbandono, fede, offerta. Non è solo la voce di un corpo che cede, ma il segno ultimo di una vita che si consegna.
Il grido di Gesù è preceduto da una domanda, una delle più laceranti che possano essere pronunciate: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». È il primo verso del Salmo 22, ma sulle labbra di Gesù assume un peso unico. Il Figlio, che ha sempre vissuto in intima comunione con il Padre, sperimenta ora il silenzio, l’assenza, l’abisso. Non si tratta di una crisi di fede, ma dell’ultima tappa di un amore che si dona fino in fondo. Il grido di Gesù non è disperazione, ma sincerità, verità portata al limite, fiducia che resiste anche quando tutto tace.
In quel momento, il cielo si oscura e il velo del tempio si squarcia (cfr Mc 15,33.38). È come se il creato stesso partecipasse a quel dolore, e insieme rivelasse qualcosa di nuovo: Dio non abita più dietro un velo, il suo volto è ora pienamente visibile nel Crocifisso. È lì, in quell’uomo straziato, che si manifesta l’amore più grande. È lì che possiamo riconoscere un Dio che non resta distante, ma attraversa fino in fondo il nostro dolore.
Il centurione, un pagano, lo capisce. Non perché ha ascoltato un discorso, ma perché ha visto morire Gesù in quel modo: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15,39). È la prima professione di fede dopo la morte di Gesù. È il frutto di un grido che non si è disperso nel vento, ma ha toccato un cuore. A volte, ciò che non riusciamo a dire a parole lo esprimiamo con la voce. Quando il cuore è pieno, grida. E questo non è sempre un segno di debolezza, può essere un atto profondo di umanità.
Noi siamo abituati a pensare al grido come a qualcosa di scomposto, da reprimere. Il Vangelo conferisce al nostro grido un valore immenso, ricordandoci che può essere invocazione, protesta, desiderio, consegna. Addirittura, può essere la forma estrema della preghiera, quando non ci restano più parole. In quel grido, Gesù ha messo tutto ciò che gli restava: tutto il suo amore, tutta la sua speranza.
Sì, perché anche questo c’è, nel gridare: una speranza che non si rassegna. Si grida quando si crede che qualcuno possa ancora ascoltare. Si grida non per disperazione, ma per desiderio. Gesù non ha gridato contro il Padre, ma verso di Lui. Anche nel silenzio, era convinto che il Padre era lì. E così ci ha mostrato che la nostra speranza può gridare, persino quando tutto sembra perduto.
Gridare diventa allora un gesto spirituale. Non è solo il primo atto della nostra nascita – quando veniamo al mondo piangendo –: è anche un modo per restare vivi. Si grida quando si soffre, ma pure quando si ama, si chiama, si invoca. Gridare è dire che ci siamo, che non vogliamo spegnerci nel silenzio, che abbiamo ancora qualcosa da offrire.
Nel viaggio della vita, ci sono momenti in cui trattenere tutto dentro può consumarci lentamente. Gesù ci insegna a non avere paura del grido, purché sia sincero, umile, orientato al Padre. Un grido non è mai inutile, se nasce dall’amore. E non è mai ignorato, se è consegnato a Dio. È una via per non cedere al cinismo, per continuare a credere che un altro mondo è possibile.
Cari fratelli e sorelle, impariamo anche questo dal Signore Gesù: impariamo il grido della speranza quando giunge l’ora della prova estrema. Non per ferire, ma per affidarci. Non per urlare contro qualcuno, ma per aprire il cuore. Se il nostro grido sarà vero, potrà essere la soglia di una nuova luce, di una nuova nascita. Come per Gesù: quando tutto sembrava finito, in realtà la salvezza stava per iniziare. Se manifestata con la fiducia e la libertà dei figli di Dio, la voce sofferta della nostra umanità, unita alla voce di Cristo, può diventare sorgente di speranza per noi e per chi ci sta accanto.

UDIENZA GIUBILARE
CATECHESI DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Sperare è scavare.
Elena imperatrice
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Benvenuti a tutti voi pellegrini, giunti a Roma da tanti luoghi diversi. In questa città ricca di storia noi possiamo venire confermati nella fede, nella carità e nella speranza. Oggi ci soffermeremo su un particolare aspetto della speranza.
Vorrei cominciare con un ricordo: da bambini, mettere le mani nella terra aveva un fascino speciale. Lo ricordiamo, e forse ancora lo osserviamo: ci fa bene osservare il gioco dei bambini! Scavare nella terra, rompere la crosta dura del mondo e vedere che cosa c’è sotto…
Quello che Gesù descrive nella parabola del tesoro nel campo (cfr Mt 13,44) non è più un gioco da bambini, eppure la gioia della sorpresa è la stessa. E il Signore ci dice: così è il Regno di Dio. Anzi: così si trova il Regno di Dio. La speranza si riaccende quando scaviamo e rompiamo la crosta della realtà, andiamo al di sotto della superficie.
Oggi vorrei ricordare con voi che, appena avuta la libertà di vivere da cristiani pubblicamente, i discepoli di Gesù cominciarono a scavare, in particolare nei luoghi della sua passione, morte e risurrezione. La Tradizione d’Oriente e d’Occidente ricorda Flavia Giulia Elena, madre dell’imperatore Costantino, come l’anima di quelle ricerche. Una donna che cerca. Una donna che scava. Il tesoro che accende la speranza è infatti la vita di Gesù: bisogna mettersi sulle sue tracce.
Quante altre cose avrebbe potuto fare un’imperatrice! Quali luoghi nobili avrebbe potuto preferire alla periferica Gerusalemme. Quanti piaceri e onori di corte. Anche noi, sorelle e fratelli, ci possiamo adagiare nelle posizioni raggiunte e nelle ricchezze, più o meno grandi, che ci danno sicurezza. Si perde così la gioia che avevamo da bambini, quel desiderio di scavare e di inventare che rende nuovo ogni giorno. “Inventare” – sapete – in latino significa “trovare”. La grande “invenzione” di Elena fu il ritrovamento della Santa Croce. Ecco il tesoro nascosto per cui vendere tutto! La Croce di Gesù è la scoperta più grande della vita, il valore che modifica tutti i valori.
Elena poté capirlo, forse, perché aveva portato a lungo la propria croce. Non era nata a corte: si dice che fosse una locandiera di umili origini, di cui il futuro imperatore Costanzo si innamorò. La sposò, ma per calcoli di potere non esitò poi a ripudiarla allontanandola per anni dal figlio Costantino. Divenuto imperatore, Costantino stesso le procurò non pochi dolori e delusioni, ma Elena fu sempre sé stessa: una donna in ricerca. Aveva deciso di diventare cristiana e praticò sempre la carità, non dimenticando mai gli umili da cui lei stessa proveniva.
Tanta dignità e fedeltà alla coscienza, cari fratelli e sorelle, cambiano il mondo anche oggi: avvicinano al tesoro, come il lavoro dell’agricoltore. Coltivare il proprio cuore richiede fatica. È il più grande lavoro. Ma scavando si trova, abbassandosi ci si avvicina sempre di più a quel Signore che spogliò sé stesso per farsi come noi. La sua Croce è sotto la crosta della nostra terra.
Possiamo camminare orgogliosi, calpestando distrattamente il tesoro che è sotto i nostri piedi. Se invece diventiamo come bambini, conosceremo un altro Regno, un’altra forza. Dio è sempre sotto di noi, per sollevarci in alto.
SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DEI BEATI:
- PIER GIORGIO FRASSATI
- CARLO ACUTIS
OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Piazza San Pietro
XXIII Domenica del tempo Ordinario, 7 settembre 2025
Parole a braccio prima della Santa Messa con il Rito delle Canonizzazioni
Buongiorno a tutti! Buona domenica e benvenuti! Grazie!
Fratelli e sorelle, oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo! E prima di cominciare la solenne celebrazione della Canonizzazione, volevo dire un saluto e una parola a tutti voi, perché, se da una parte la celebrazione è molto solenne, è anche un giorno di molta gioia! E volevo salutare soprattutto tanti giovani, ragazzi, che sono venuti per questa santa Messa! Veramente una benedizione del Signore: trovarci insieme con tutti voi che siete venuti da diversi Paesi. È veramente un dono di fede che vogliamo condividere.
Dopo la Santa Messa, se potete avere un po’ di pazienza, spero di venire e salutare voi in Piazza. E allora, se adesso siete lontani, speriamo almeno di poterci salutare…
Saluto i familiari dei due Beati quasi Santi, le Delegazioni ufficiali, tanti Vescovi e sacerdoti che sono venuti. Un applauso per tutti loro, grazie anche a voi per essere qui! Religiosi e religiose, l’Azione Cattolica!
Ci prepariamo per questa celebrazione liturgica con la preghiera, con il cuore aperto, volendo ricevere veramente questa grazia del Signore. E sentiamo tutti nel cuore la stessa cosa che Pier Giorgio e Carlo hanno vissuto: questo amore per Gesù Cristo, soprattutto nell’Eucaristia, ma anche nei poveri, nei fratelli e nelle sorelle. Anche tutti voi, tutti noi, siamo chiamati ad essere santi. Dio vi benedica! Buona celebrazione! Grazie per essere qui!
* * *
Cari fratelli e sorelle,
nella prima Lettura abbiamo sentito una domanda: «[Signore,] chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?» (Sap 9,17). L’abbiamo sentita dopo che due giovani Beati, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, sono stati proclamati Santi, e ciò è provvidenziale. Questa domanda, infatti, nel Libro della Sapienza, è attribuita proprio a un giovane come loro: il re Salomone. Egli, alla morte di Davide, suo padre, si era reso conto di disporre di tante cose: il potere, la ricchezza, la salute, la giovinezza, la bellezza, il regno. Ma proprio questa grande abbondanza di mezzi gli aveva fatto sorgere nel cuore una domanda: “Cosa devo fare perché nulla vada perduto?”. E aveva capito che l’unica via per trovare una risposta era quella di chiedere a Dio un dono ancora più grande: la sua Sapienza, per conoscere i suoi progetti e aderirvi fedelmente. Si era reso conto, infatti, che solo così ogni cosa avrebbe trovato il suo posto nel grande disegno del Signore. Sì, perché il rischio più grande della vita è quello di sprecarla al di fuori del progetto di Dio.
Anche Gesù, nel Vangelo, ci parla di un progetto a cui aderire fino in fondo. Dice: «Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo» (Lc 14,27); e ancora: «Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo» (v. 33). Ci chiama, cioè, a buttarci senza esitazioni nell’avventura che Lui ci propone, con l’intelligenza e la forza che vengono dal suo Spirito e che possiamo accogliere nella misura in cui ci spogliamo di noi stessi, delle cose e delle idee a cui siamo attaccati, per metterci in ascolto della sua parola.
Tanti giovani, nel corso dei secoli, hanno dovuto affrontare questo bivio nella vita. Pensiamo a San Francesco d’Assisi: come Salomone, anche lui era giovane e ricco, assetato di gloria e di fama. Per questo era partito per la guerra, sperando di essere investito “cavaliere” e di coprirsi di onori. Ma Gesù gli era apparso lungo il cammino e lo aveva fatto riflettere su ciò che stava facendo. Rientrato in sé, aveva rivolto a Dio una semplice domanda: «Signore, che vuoi che io faccia?». [1] E da lì, tornando sui suoi passi, aveva cominciato a scrivere una storia diversa: la meravigliosa storia di santità che tutti conosciamo, spogliandosi di tutto per seguire il Signore (cfr Lc 14,33), vivendo in povertà e preferendo all’oro, all’argento e alle stoffe preziose di suo padre l’amore per i fratelli, specialmente i più deboli e i più piccoli.
E quanti altri santi e sante potremmo ricordare! A volte noi li raffiguriamo come grandi personaggi, dimenticando che per loro tutto è cominciato quando, ancora giovani, hanno risposto “sì” a Dio e si sono donati a Lui pienamente, senza tenere nulla per sé. Sant’Agostino racconta, in proposito, che, nel «nodo tortuoso e aggrovigliato» della sua vita, una voce, nel profondo, gli diceva: «Voglio te». [2] E così Dio gli ha dato una nuova direzione, una nuova strada, una nuova logica, in cui nulla della sua esistenza è andato perduto.
In questa cornice, oggi guardiamo a San Pier Giorgio Frassati e a San Carlo Acutis: un giovane dell’inizio del Novecento e un adolescente dei nostri giorni, tutti e due innamorati di Gesù e pronti a donare tutto per Lui.
Pier Giorgio ha incontrato il Signore attraverso la scuola e i gruppi ecclesiali – l’Azione Cattolica, le Conferenze di San Vincenzo, la FUCI, il Terz’Ordine domenicano – e lo ha testimoniato con la sua gioia di vivere e di essere cristiano nella preghiera, nell’amicizia, nella carità. Al punto che, a forza di vederlo girare per le strade di Torino con carretti pieni di aiuti per i poveri, gli amici lo avevano ribattezzato “Frassati Impresa Trasporti”! Anche oggi, la vita di Pier Giorgio rappresenta una luce per la spiritualità laicale. Per lui la fede non è stata una devozione privata: spinto dalla forza del Vangelo e dall’appartenenza alle associazioni ecclesiali, si è impegnato generosamente nella società, ha dato il suo contributo alla vita politica, si è speso con ardore al servizio dei poveri.
Carlo, da parte sua, ha incontrato Gesù in famiglia, grazie ai suoi genitori, Andrea e Antonia – presenti qui oggi con i due fratelli, Francesca e Michele – e poi a scuola, anche lui, e soprattutto nei Sacramenti, celebrati nella comunità parrocchiale. È cresciuto, così, integrando naturalmente nelle sue giornate di bambino e di ragazzo preghiera, sport, studio e carità.
Entrambi, Pier Giorgio e Carlo, hanno coltivato l’amore per Dio e per i fratelli attraverso mezzi semplici, alla portata di tutti: la santa Messa quotidiana, la preghiera, specialmente l’Adorazione eucaristica. Carlo diceva: «Davanti al sole ci si abbronza. Davanti all’Eucaristia si diventa santi!», e ancora: «La tristezza è lo sguardo rivolto verso sé stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. La conversione non è altro che spostare lo sguardo dal basso verso l’Alto, basta un semplice movimento degli occhi». Un’altra cosa essenziale per loro era la Confessione frequente. Carlo ha scritto: «L’unica cosa che dobbiamo temere veramente è il peccato»; e si meravigliava perché – sono sempre parole sue – «gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo e non si preoccupano della bellezza della propria anima». Tutti e due, infine, avevano una grande devozione per i Santi e per la Vergine Maria, e praticavano generosamente la carità. Pier Giorgio diceva: «Intorno ai poveri e agli ammalati io vedo una luce che noi non abbiamo». [3] Chiamava la carità “il fondamento della nostra religione” e, come Carlo, la esercitava soprattutto attraverso piccoli gesti concreti, spesso nascosti, vivendo quella che Papa Francesco ha chiamato «la santità “della porta accanto”» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7).
Perfino quando la malattia li ha colpiti e ha stroncato le loro giovani vite, nemmeno questo li ha fermati e ha impedito loro di amare, di offrirsi a Dio, di benedirlo e di pregarlo per sé e per tutti. Un giorno Pier Giorgio disse: «Il giorno della morte sarà il più bel giorno della mia vita»; [4] e sull’ultima foto, che lo ritrae mentre scala una montagna della Val di Lanzo, col volto rivolto alla meta, aveva scritto: «Verso l’alto». [5] Del resto, ancora più giovane, Carlo amava dire che il Cielo ci aspetta da sempre, e che amare il domani è dare oggi il meglio del nostro frutto.
Carissimi, i santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l’alto e a farne un capolavoro. Ci incoraggiano con le loro parole: “Non io, ma Dio”, diceva Carlo. E Pier Giorgio: “Se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine”. Questa è la formula semplice, ma vincente, della loro santità. Ed è pure la testimonianza che siamo chiamati a seguire, per gustare la vita fino in fondo e andare incontro al Signore nella festa del Cielo.
[1] Leggenda dei tre compagni, cap. II: Fonti Francescane, 1401.
[2] Confessiones, II, 10, 18.
[3] Nicola Gori, Al prezzo della vita: “L’Osservatore romano”, 11 febbraio 2021.
[4] Irene Funghi, I giovani assieme a Frassati: un compagno nei nostri cammini tortuosi: “Avvenire”, 2 agosto 2025.
[5] Ibid.

MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ
PAPA LEONE XIV
PER LA X GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LA CURA DEL CREATO 2025
1° settembre 2025
Semi di Pace e di Speranza
Cari fratelli e sorelle!
Il tema di questa Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, scelto dal nostro amato Papa Francesco, è “Semi di Pace e di Speranza”. Nel 10° anniversario dell’istituzione della Giornata, avvenuta in concomitanza con la pubblicazione dell’Enciclica Laudato si’, ci troviamo nel vivo del Giubileo, “pellegrini di Speranza”. E proprio in questo contesto il tema acquista il suo pieno significato.
Molte volte Gesù, nella sua predicazione, usa l’immagine del seme per parlare del Regno di Dio, e alla vigilia della Passione la applica a sé stesso, paragonandosi al chicco di grano, che per dare frutto deve morire (cfr Gv 12,24). Il seme si consegna interamente alla terra e lì, con la forza dirompente del suo dono, la vita germoglia, anche nei luoghi più impensati, in una sorprendente capacità di generare futuro. Pensiamo, ad esempio, ai fiori che crescono ai bordi delle strade: nessuno li ha piantati, eppure crescono grazie a semi finiti lì quasi per caso e riescono a decorare il grigio dell’asfalto e persino a intaccarne la dura superficie.
Dunque, in Cristo siamo semi. Non solo, ma “semi di Pace e di Speranza”. Come dice il profeta Isaia, lo Spirito di Dio è in grado di trasformare il deserto, arido e riarso, in un giardino, luogo di riposo e serenità: «In noi sarà infuso uno spirito dall’alto; allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri» (Is 32,15-18).
Queste parole profetiche, che dal 1° settembre al 4 ottobre accompagneranno l’iniziativa ecumenica del “Tempo del Creato”, affermano con forza che, insieme alla preghiera, sono necessarie la volontà e le azioni concrete che rendono percepibile questa “carezza di Dio” sul mondo (cfr Laudato si’, 84).La giustizia e il diritto, infatti, sembrano rimediare all’inospitalità del deserto. Si tratta di un annuncio di straordinaria attualità. In diverse parti del mondo è ormai evidente che la nostra terra sta cadendo in rovina. Ovunque l’ingiustizia, la violazione del diritto internazionale e dei diritti dei popoli, le diseguaglianze e l’avidità da cui scaturiscono producono deforestazione, inquinamento, perdita di biodiversità. Aumentano in intensità e frequenza fenomeni naturali estremi causati dal cambiamento climatico indotto da attività antropiche (cfr Esort. ap. Laudate Deum, 5), senza considerare gli effetti a medio e lungo termine della devastazione umana ed ecologica portata dai conflitti armati.
Sembra che manchi ancora la consapevolezza che distruggere la natura non colpisce tutti nello stesso modo: calpestare la giustizia e la pace significa colpire maggiormente i più poveri, gli emarginati, gli esclusi. È emblematica in tale ambito la sofferenza delle comunità indigene.
E non basta: la natura stessa talvolta diventa strumento di scambio, un bene da negoziare per ottenere vantaggi economici o politici. In queste dinamiche, il creato viene trasformato in un campo di battaglia per il controllo delle risorse vitali, come testimoniano le zone agricole e le foreste divenute pericolose a causa delle mine, la politica della “terra bruciata” [1], i conflitti che scoppiano attorno alle fonti d’acqua, la distribuzione iniqua delle materie prime, penalizzando le popolazioni più deboli e minando la stessa stabilità sociale.
Queste diverse ferite sono dovute al peccato. Di certo non è questo ciò che aveva in mente Dio quando affidò la Terra all’uomo creato a sua immagine (Gen 1,24-29). La Bibbia non promuove «il dominio dispotico dell’essere umano sul creato» (Laudato si’, 200). Anzi, è «importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a “coltivare e custodire” il giardino del mondo (cfr Gen 2,15). Mentre “coltivare” significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura» (ivi, 67).
La giustizia ambientale – implicitamente annunciata dai profeti – non può più essere considerata un concetto astratto o un obiettivo lontano. Essa rappresenta una necessità urgente, che va oltre la semplice tutela dell’ambiente. Si tratta, in realtà, di una questione di giustizia sociale, economica e antropologica. Per i credenti, in più, è un’esigenza teologica, che per i cristiani ha il volto di Gesù Cristo, nel quale tutto è stato creato e redento. In un mondo dove i più fragili sono i primi a subire gli effetti devastanti del cambiamento climatico, della deforestazione, e dell’inquinamento, la cura del creato diventa una questione di fede e di umanità.
È ormai davvero il tempo di far seguire alle parole i fatti. «Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (ivi, 217). Lavorando con dedizione e con tenerezza si possono far germogliare molti semi di giustizia, contribuendo così alla pace e alla speranza. Ci vogliono talvolta anni prima che l’albero dia i suoi primi frutti, anni che coinvolgono un intero ecosistema nella continuità, nella fedeltà, nella collaborazione e nell’amore, soprattutto se quest’amore diventa specchio dell’Amore oblativo di Dio.
Tra le iniziative della Chiesa che sono come semi gettati in questo campo, desidero ricordare il progetto “Borgo Laudato Si’”, che Papa Francesco ci ha lasciato in eredità a Castel Gandolfo, come seme che può portare frutti di giustizia e di pace. Si tratta di un progetto di educazione all’ecologia integrale che vuole essere un esempio di come si può vivere, lavorare e fare comunità applicando i principi dell’Enciclica Laudato si’.
Prego l’Onnipotente di mandarci in abbondanza il suo «spirito dall’alto» (Is 32,15), affinché questi semi e altri simili portino abbondanti frutti di pace e di speranza.
L’Enciclica Laudato si’ ha accompagnato la Chiesa Cattolica e molte persone di buona volontà per dieci anni: essa continui ad ispirarci e l’ecologia integrale sia sempre più scelta e condivisa come rotta da seguire. Così si moltiplicheranno i semi di speranza, da “custodire e coltivare” con la grazia della nostra grande e indefettibile Speranza, Cristo Risorto. Nel suo nome invio a tutti voi la mia benedizione.
Dal Vaticano, 30 giugno 2025, Memoria dei Santi Protomartiri della Chiesa Romana
LEONE PP. XIV
___________________________________
[1] Cfr Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Terra e cibo, LEV 2015, 51-53.

SANTA MESSA PER L’INIZIO DEL CAPITOLO GENERALE DELL’ORDINE DI SANT’AGOSTINO
OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio (Roma)
Lunedì, 1° settembre 2025
[Miei cari fratelli e sorelle,
Padre Alejandro Moral, Priore Generale, fratelli nell’episcopato, Luis and Wilder, e tutti voi, miei fratelli agostiniani, fratelli e sorelle qui presenti. Prima di iniziare l’omelia formale che è stata preparata, desidero solo salutarvi tutti. E per quelli di voi che capiscono l’inglese ma non capiscono l’italiano: pregate per ricevere il dono dello Spirito Santo! E forse, durante questo breve momento di riflessione sulla Parola di Dio e su ciò che il Signore chiede a tutti voi, a voi che state per iniziare questo Capitolo Generale Ordinario, vi sarà dato non necessariamente il dono di comprendere o parlare tutte le lingue, ma il dono di ascoltare, il dono di essere umili e il dono di promuovere l’unità, all’interno dell’Ordine e attraverso l’Ordine, in tutta la Chiesa e nel mondo].
Celebriamo questa Eucaristia all’inizio del Capitolo Generale, momento di grazia per l’Ordine Agostiniano e momento di grazia per tutta la Chiesa.
In questa Santa Messa votiva dello Spirito Santo, chiediamo che sia Lui, per il quale l’amore di Cristo abita nei nostri cuori (cfr Rm 5,5), a guidare giorno per giorno il vostro lavoro.
Un antico autore, parlando della Pentecoste (cfr At 2,1-11), la descrive come un «sopravvento abbondante e irresistibile dello Spirito» (Didimo il cieco, De Trinitate, 6, 8: PG 39, 533). Chiediamo al Signore che sia così anche per voi: che il suo Spirito abbia il sopravvento su ogni logica umana, in modo “abbondante e irresistibile”, perché veramente la Terza Persona divina divenga la protagonista dei giorni a venire.
Lo Spirito Santo parla, oggi come nel passato. Lo fa nei “penetralia cordis” e attraverso i fratelli e le circostanze della vita. Per questo è importante che il clima del Capitolo, in armonia con la tradizione secolare della Chiesa, sia un clima di ascolto, ascolto di Dio, ascolto degli altri.
Meditando sulla Pentecoste, il nostro Padre Sant’Agostino, rispondendo alla domanda provocatoria di chi chiedeva perché, oggi, non si ripeta, come un giorno a Gerusalemme, il segno straordinario della “glossolalia”, fa una riflessione che penso possa tornarvi molto utile nel mandato che state per compiere. Agostino dice: «In un primo momento ciascun fedele […] parlò tutte le lingue […]. Ora l’insieme dei credenti parla in tutte le lingue. Perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla» (Sermo 269, 1).
Carissimi, qui, insieme, voi siete membra del Corpo di Cristo, che parla tutte le lingue. Se non tutte quelle del mondo, certamente tutte quelle che Dio sa necessarie al compimento del bene che, nella sua provvidente sapienza, vi affida.
Vivete, perciò, questi giorni in uno sforzo sincero di comunicare e di comprendere, e fatelo come risposta generosa al dono grande e unico, di luce e di grazia, che il Padre dei Cieli vi fa convocandovi qui, proprio voi, per il bene di tutti.
E veniamo a un secondo punto: fate tutto questo con umiltà. Sant’Agostino, commentando la varietà dei modi in cui lo Spirito Santo, nei secoli, si è effuso sul mondo, legge tale molteplicità come un invito per noi a farci piccoli di fronte alla libertà e all’imperscrutabilità dell’agire di Dio (ivi, 2). Nessuno pensi di avere da sé tutte le risposte. Ciascuno condivida con apertura ciò che ha. Tutti accolgano con fede ciò che il Signore ispira, nella consapevolezza che «quanto il cielo sovrasta la terra» (Is 55,9) tanto le sue vie sovrastano le nostre vie e i suoi pensieri i nostri pensieri. Solo così lo Spirito potrà “insegnare” e “ricordare” ciò che Gesù ha detto (cfr Gv 14,26), incidendolo nei vostri cuori perché da essi se ne diffonda l’eco nell’unicità e irripetibilità di ogni battito.
C’è però ancora un punto di riflessione che vorrei sottolineare di ciò che la Liturgia della Parola oggi ci propone: il valore dell’unità.
Nella prima Lettura San Paolo, parlando della comunità di Corinto, ne fa una descrizione che si può applicare facilmente al vostro Capitolo. Anche qui, infatti «a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune» (1Cor 12,7), anche qui «tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole» (v. 11) e anche di voi si può dire che «come […] il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo» (v. 12).
L’unità sia un oggetto irrinunciabile dei vostri sforzi, ma non solo: sia anche il criterio di verifica del vostro agire e lavorare insieme, perché ciò che unisce è da Lui, ma ciò che divide non può esserlo.
In proposito, ci viene anche qui in aiuto Sant’Agostino che, sempre commentando il miracolo di Pentecoste, osserva: «Come allora le diverse lingue che un uomo poteva parlare erano il segno della presenza dello Spirito Santo, così ora è l’amore per l’unità […] il segno della sua presenza (ivi, 3). E poi continua: «Come infatti gli uomini spirituali godono dell’unità, quelli carnali cercano sempre i contrasti» (ibid.). Si chiede perciò: «Quale forza maggiore della pietà che l’amore per l’unità?» e conclude: «Avrete lo Spirito Santo quando acconsentirete che il vostro cuore aderisca all’unità attraverso una carità sincera» (ibid.).
Ascolto, umiltà e unità, ecco tre suggerimenti, spero utili, che la liturgia vi dona per questi prossimi giorni.
L’invito è a farli vostri, rinnovando la preghiera che abbiamo rivolto al Signore all’inizio di questa Celebrazione: «Lo Spirito Paraclito, che procede da te, o Padre, illumini le nostre menti e, secondo la promessa del tuo Figlio, ci guidi a tutta la verità» (cfr Messale Romano, S. Messa votiva dello Spirito Santo, B, Colletta).

LEONE XIV
UDIENZA GENERALE
Aula Paolo VI
Mercoledì, 27 agosto 2025
Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. III. La Pasqua di Gesù. 4. La consegna. «Chi cercate?» (Gv 18,4)
Cari fratelli e sorelle,
oggi ci soffermiamo su una scena che segna l’inizio della passione di Gesù: il momento del suo arresto nell’orto degli Ulivi. L’evangelista Giovanni, con la sua consueta profondità, non ci presenta un Gesù spaventato, che fugge o si nasconde. Al contrario, ci mostra un uomo libero, che si fa avanti e prende la parola, affrontando a viso aperto l’ora in cui si può manifestare la luce dell’amore più grande.
«Gesù, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: “Chi cercate?”» (Gv 18,4). Gesù sa. Tuttavia, decide di non indietreggiare. Si consegna. Non per debolezza, ma per amore. Un amore così pieno, così maturo, da non temere il rifiuto. Gesù non viene preso: si lascia prendere. Non è vittima di un arresto, ma autore di un dono. In questo gesto si incarna una speranza di salvezza per la nostra umanità: sapere che, anche nell’ora più buia, si può restare liberi di amare fino in fondo.
Quando Gesù risponde «sono io», i soldati cadono a terra. Si tratta di un passaggio misterioso, dal momento che questa espressione, nella rivelazione biblica, richiama il nome stesso di Dio: «Io sono». Gesù rivela che la presenza di Dio si manifesta proprio dove l’umanità sperimenta l’ingiustizia, la paura, la solitudine. Proprio lì, la luce vera è disposta a brillare senza timore di essere sopraffatta dall’avanzare delle tenebre.
Nel cuore della notte, quando tutto sembra crollare, Gesù mostra che la speranza cristiana non è evasione, ma decisione. Questo atteggiamento è il frutto di una preghiera profonda in cui non si chiede a Dio di essere risparmiati dalla sofferenza, ma di avere la forza di perseverare nell’amore, consapevoli che la vita liberamente offerta per amore non ci può essere tolta da nessuno.
«Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano» (Gv 18,8). Nel momento del suo arresto, Gesù non si preoccupa di salvare sé stesso: desidera soltanto che i suoi amici possano andarsene liberi. Questo dimostra che il suo sacrificio è un vero atto d’amore. Gesù si lascia prendere e imprigionare dalle guardie solo per poter lasciare in libertà i suoi discepoli.
Gesù ha vissuto ogni giorno della sua vita come preparazione a quest’ora drammatica e sublime. Per questo, quando essa arriva, ha la forza di non cercare una via di fuga. Il suo cuore sa bene che perdere la vita per amore non è un fallimento, ma possiede una misteriosa fecondità. Come il chicco di grano che proprio cadendo a terra non rimane solo, ma muore e diventa fruttuoso.
Anche Gesù prova turbamento di fronte a un cammino che sembra condurre solo alla morte e alla fine. Ma è ugualmente persuaso che solo una vita perduta per amore, alla fine, si ritrova. In questo consiste la vera speranza: non nel cercare di evitare il dolore, ma nel credere che, anche nel cuore delle sofferenze più ingiuste, si nasconde il germe di una vita nuova.
E noi? Quante volte difendiamo la nostra vita, i nostri progetti, le nostre sicurezze, senza accorgerci che, così facendo, restiamo soli. La logica del Vangelo è diversa: solo ciò che si dona fiorisce, solo l’amore che diventa gratuito può riportare fiducia anche là dove tutto sembra perduto.
Il Vangelo di Marco ci racconta anche di un giovane che, quando Gesù viene arrestato, scappa via nudo (Mc 14,51). È un’immagine enigmatica, ma profondamente evocativa. Anche noi, nel tentativo di seguire Gesù, viviamo momenti in cui siamo colti alla sprovvista e restiamo spogliati delle nostre certezze. Sono i momenti più difficili, nei quali siamo tentati di abbandonare la via del Vangelo perché l’amore ci sembra un viaggio impossibile. Eppure, sarà proprio un giovane, alla fine del Vangelo, ad annunciare la risurrezione alle donne, non più nudo, ma rivestito di una veste bianca.
Questa è la speranza della nostra fede: i nostri peccati e le nostre esitazioni non impediscono a Dio di perdonarci e di restituirci il desiderio di riprendere la nostra sequela, per renderci capaci di donare la vita per gli altri.
Cari fratelli e sorelle, impariamo anche noi a consegnarci alla volontà buona del Padre, lasciando che la nostra vita sia una risposta al bene ricevuto. Nella vita non serve avere tutto sotto controllo. Basta scegliere ogni giorno di amare con libertà. È questa la vera speranza: sapere che, anche nel buio della prova, l’amore di Dio ci sostiene e fa maturare in noi il frutto della vita eterna.

LEONE XIV
UDIENZA GENERALE
Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. III. La Pasqua di Gesù. 3. Il perdono. «Li amò sino alla fine» (Gv 13,2)
Cari fratelli e sorelle,
oggi ci soffermiamo su uno dei gesti più sconvolgenti e luminosi del Vangelo: il momento in cui Gesù, durante l’ultima cena, porge il boccone a colui che sta per tradirlo. Non è solo un gesto di condivisione, è molto di più: è l’ultimo tentativo dell’amore di non arrendersi.
San Giovanni, con la sua profonda sensibilità spirituale, ci racconta così quell’istante: «Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo […] Gesù, sapendo che era venuta la sua ora […] li amò fino alla fine» (Gv 13,1-2). Amare fino alla fine: ecco la chiave per comprendere il cuore di Cristo. Un amore che non si arresta davanti al rifiuto, alla delusione, neppure all’ingratitudine.
Gesù conosce l’ora, ma non la subisce: la sceglie. È Lui che riconosce il momento in cui il suo amore dovrà passare attraverso la ferita più dolorosa, quella del tradimento. E invece di ritrarsi, di accusare, di difendersi… continua ad amare: lava i piedi, intinge il pane e lo porge.
«È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò» (Gv 13,26). Con questo gesto semplice e umile, Gesù porta avanti e a fondo il suo amore. Non perché ignori ciò che accade, ma proprio perché vede con chiarezza. Ha compreso che la libertà dell’altro, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. Perché sa che il vero perdono non aspetta il pentimento, ma si offre per primo, come dono gratuito, ancor prima di essere accolto.
Giuda, purtroppo, non comprende. Dopo il boccone – dice il Vangelo – «Satana entrò in lui» (v. 27). Questo passaggio ci colpisce: come se il male, fino a quel momento nascosto, si manifestasse dopo che l’amore ha mostrato il suo volto più disarmato. E proprio per questo, fratelli e sorelle, quel boccone è la nostra salvezza: perché ci dice che Dio fa di tutto – proprio tutto – per raggiungerci, anche nell’ora in cui noi lo respingiamo.
È qui che il perdono si rivela in tutta la sua potenza e manifesta il volto concreto della speranza. Non è dimenticanza, non è debolezza. È la capacità di lasciare libero l’altro, pur amandolo fino alla fine. L’amore di Gesù non nega la verità del dolore, ma non permette che il male sia l’ultima parola. Questo è il mistero che Gesù compie per noi, al quale anche noi, a volte, siamo chiamati a partecipare.
Quante relazioni si spezzano, quante storie si complicano, quante parole non dette restano sospese. Eppure, il Vangelo ci mostra che c’è sempre un modo per continuare ad amare, anche quando tutto sembra irrimediabilmente compromesso. Perdonare non significa negare il male, ma impedirgli di generare altro male. Non è dire che non è successo nulla, ma fare tutto il possibile perché non sia il rancore a decidere il futuro.
Quando Giuda esce dalla stanza, «era notte» (v. 30). Ma subito dopo Gesù dice: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato» (v. 31). La notte è ancora lì, ma una luce ha già cominciato a brillare. E brilla perché Cristo rimane fedele fino alla fine, e così il suo amore è più forte dell’odio.
Cari fratelli e sorelle, anche noi viviamo notti dolorose e faticose. Notti dell’anima, notti della delusione, notti in cui qualcuno ci ha ferito o tradito. In quei momenti, la tentazione è chiuderci, proteggerci, restituire il colpo. Ma il Signore ci mostra la speranza che esiste, esiste sempre un’altra via. Ci insegna che si può offrire un boccone anche a chi ci volta le spalle. Che si può rispondere con il silenzio della fiducia. E che si può andare avanti con dignità, senza rinunciare all’amore.
Chiediamo oggi la grazia di saper perdonare, anche quando non ci sentiamo compresi, anche quando ci sentiamo abbandonati. Perché è proprio in quelle ore che l’amore può giungere al suo vertice. Come ci insegna Gesù, amare significa lasciare l’altro libero — anche di tradire — senza mai smettere di credere che persino quella libertà, ferita e smarrita, possa essere strappata all’inganno delle tenebre e riconsegnata alla luce del bene.
Quando la luce del perdono riesce a filtrare tra le crepe più profonde del cuore, capiamo che non è mai inutile. Anche se l’altro non lo accoglie, anche se sembra vano, il perdono libera chi lo dona: scioglie il risentimento, restituisce pace, ci riconsegna a noi stessi.
Gesù, con il gesto semplice del pane offerto, mostra che ogni tradimento può diventare occasione di salvezza, se scelto come spazio per un amore più grande. Non cede al male, ma lo vince con il bene, impedendogli di spegnere ciò che in noi è più vero: la capacità di amare.

PAPA LEONE XIV
ANGELUS
Piazza della Libertà (Castel Gandolfo)
Domenica, 17 agosto 2025
Oggi il Vangelo ci presenta un testo impegnativo (cfr Lc 12,49-53), in cui Gesù, con immagini forti e grande franchezza, dice ai discepoli che la sua missione, e anche quella di chi lo segue, non è tutta “rose e fiori”, ma è “segno di contraddizione” (cfr Lc 2,34).
Così dicendo, il Signore anticipa ciò che dovrà affrontare quando a Gerusalemme sarà osteggiato, arrestato, insultato, percosso, crocifisso; quando il suo messaggio, pur parlando d’amore e di giustizia, sarà rifiutato; quando i capi del popolo reagiranno con ferocia alla sua predicazione. Del resto, tante delle comunità a cui l’evangelista Luca si rivolgeva con i suoi scritti, vivevano la stessa esperienza. Erano, come ci dicono gli Atti degli Apostoli, comunità pacifiche che, pur con i loro limiti, cercavano di vivere al meglio il messaggio di carità del Maestro (cfr At 4,32-33). Eppure subivano persecuzioni.
Tutto questo ci ricorda che non sempre il bene trova, attorno a sé, una risposta positiva. Anzi a volte, proprio perché la sua bellezza infastidisce quelli che non lo accolgono, chi lo compie finisce coll’incontrare dure opposizioni, fino a subire prepotenze e soprusi. Agire nella verità costa, perché nel mondo c’è chi sceglie la menzogna, e perché il diavolo, approfittandone, spesso cerca di ostacolare l’agire dei buoni.
Gesù, però, ci invita, con il suo aiuto, a non arrenderci e a non omologarci a questa mentalità, ma a continuare ad agire per il bene nostro e di tutti, anche di chi ci fa soffrire. Ci invita a non rispondere alla prepotenza con la vendetta, ma a rimanere fedeli alla verità nella carità. I martiri ne danno testimonianza spargendo il sangue per la fede, ma anche noi, in circostanze e con modalità diverse, possiamo imitarli.
Pensiamo, ad esempio, al prezzo che deve pagare un buon genitore, se vuole educare bene i suoi figli, secondo principi sani: prima o poi dovrà saper dire qualche “no”, fare qualche correzione, e questo gli costerà sofferenza. Lo stesso vale per un insegnante che desideri formare correttamente i suoi alunni, per un professionista, un religioso, un politico, che si propongano di svolgere onestamente la loro missione, e per chiunque si sforzi di esercitare con coerenza, secondo gli insegnamenti del Vangelo, le proprie responsabilità.
Sant’Ignazio di Antiochia, in proposito, mentre era in viaggio verso Roma, dove avrebbe subito il martirio, scriveva ai cristiani di questa città: «Non voglio che voi siate accetti agli uomini, ma a Dio» (Lettera ai Romani, 2,1), e aggiungeva: «È bello per me morire in Gesù Cristo più che regnare sino ai confini della terra» (ibid., 6,1).
Fratelli e sorelle, chiediamo insieme a Maria, Regina dei Martiri, di aiutarci ad essere, in ogni circostanza, testimoni fedeli e coraggiosi del suo Figlio, e di sostenere i fratelli e le sorelle che oggi soffrono per la fede.

OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Santuario di Santa Maria della Rotonda (Albano)
XX domenica del Tempo Ordinario, 17 agosto 2025
E' una gioia trovarci insieme a celebrare l’Eucaristia domenicale, che ci regala una gioia ancora più profonda. Se, infatti, è già un dono essere oggi vicini e vincere la distanza guardandoci negli occhi, come veri fratelli e sorelle, un dono più grande è vincere nel Signore la morte. Gesù ha vinto la morte – la domenica è il suo giorno, il giorno della Risurrezione – e noi iniziamo già a vincerla con Lui. È così: ognuno di noi viene in chiesa con qualche stanchezza e paura – a volte più piccole, a volte più grandi – e subito siamo meno soli, siamo insieme e troviamo la Parola e il Corpo di Cristo. Così il nostro cuore riceve una vita che va oltre la morte. È lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, a fare questo fra di noi e in noi, silenziosamente, domenica dopo domenica, giorno dopo giorno.
Ci troviamo in un antico Santuario le cui mura ci abbracciano. Si chiama “Rotonda” e la forma circolare, come a Piazza San Pietro e come in altre chiese antiche e nuove, ci fa sentire accolti nel grembo di Dio. All’esterno la Chiesa, come ogni realtà umana, può apparirci spigolosa. La sua realtà divina, però, si manifesta quando ne varchiamo la soglia e troviamo accoglienza. Allora la nostra povertà, la nostra vulnerabilità e soprattutto i fallimenti per cui possiamo venire disprezzati e giudicati – e a volte noi stessi ci disprezziamo e ci giudichiamo – sono finalmente accolti nella dolce forza di Dio, un amore senza spigoli, un amore incondizionato. Maria, la madre di Gesù, per noi è segno e anticipazione della maternità di Dio. In lei diventiamo una Chiesa madre, che genera e rigenera non in virtù di una potenza mondana, ma con la virtù della carità.
Può forse averci sorpreso, nel Vangelo appena letto, quello che dice Gesù. Noi cerchiamo la pace, ma abbiamo ascoltato: «Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione» (Lc 12,51). E quasi gli risponderemmo: «Ma come, Signore? Anche tu? Abbiamo già troppe divisioni. Non sei proprio tu che hai detto nell’ultima cena: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”?». «Sì – ci potrebbe rispondere il Signore – sono io. Ricordate però che quella sera, la mia ultima sera, aggiunsi subito a proposito della pace: «Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (cfr Gv 14,27).
Cari amici, il mondo ci abitua a scambiare la pace con la comodità, il bene con la tranquillità. Per questo, affinché in mezzo a noi venga la sua pace, lo shalom di Dio, Gesù deve dirci: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12,49). Forse i nostri stessi familiari, come preannuncia il Vangelo, e persino gli amici si divideranno su questo. E qualcuno ci raccomanderà di non rischiare, di risparmiarci, perché importa stare tranquilli e gli altri non meritano di essere amati. Gesù invece si è immerso nella nostra umanità con coraggio. Ecco il «battesimo» di cui parla (v. 50): è il battesimo della croce, un’immersione totale nei rischi che l’amore comporta. E noi quando, come si dice, “facciamo la comunione”, ci alimentiamo di questo suo dono audace. La Messa nutre questa decisione. È la decisione di non vivere più per noi stessi, di portare il fuoco nel mondo. Non il fuoco delle armi, e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri. Questo no. Ma il fuoco dell’amore, che si abbassa e serve, che oppone all’indifferenza la cura e alla prepotenza la mitezza; il fuoco della bontà, che non costa come gli armamenti, ma gratuitamente rinnova il mondo. Può costare incomprensione, scherno, persino persecuzione, ma non c’è pace più grande di avere in sé la sua fiamma.
Per questo oggi vorrei ringraziare, insieme al vostro vescovo Vincenzo, tutti voi, che nella diocesi di Albano vi impegnate a portare il fuoco della carità. E vi incoraggio a non distinguere tra chi assiste e chi è assistito, tra chi sembra dare e chi sembra ricevere, tra chi appare povero e chi sente di offrire tempo, competenze, aiuto. Siamo la Chiesa del Signore, una Chiesa di poveri, tutti preziosi, tutti soggetti, ognuno portatore di una Parola singolare di Dio. Ognuno è un dono per gli altri. Abbattiamo i muri. Ringrazio chi opera in ogni comunità cristiana per facilitare l’incontro fra persone diverse per provenienza, per situazione economica, psichica, affettiva: solo insieme, solo diventando un unico Corpo in cui anche il più fragile partecipa in piena dignità, siamo il Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio. Questo avviene quando il fuoco che Gesù è venuto a portare brucia i pregiudizi, le prudenze e le paure che emarginano ancora chi porta scritta la povertà di Cristo nella propria storia. Non lasciamo fuori il Signore dalle nostre chiese, dalle nostre case e dalla nostra vita. Nei poveri, invece, lasciamolo entrare e allora faremo pace anche con la nostra povertà, quella che temiamo e neghiamo quando cerchiamo a ogni costo tranquillità e sicurezza.
Interceda per noi la Vergine Maria, che si sentì indicare dal santo vecchio Simeone il figlio Gesù come «segno di contraddizione» (Lc 2,34). Siano svelati i pensieri dei nostri cuori, e possa il fuoco dello Spirito Santo renderli non più cuori di pietra, ma cuori di carne.
Santa Maria della Rotonda, prega per noi!

L'Amicizia
"Carissimi, ogni persona desidera naturalmente una vita buona, come i polmoni tendono all’aria, ma quanto è difficile trovarla! Quanto è difficile trovare un’amicizia autentica! Secoli fa, Sant’Agostino ha colto il profondo desiderio del nostro cuore – è il desiderio di ogni cuore umano – anche senza conoscere lo sviluppo tecnologico di oggi. Anche lui è passato attraverso una giovinezza burrascosa: non si è però accontentato, non ha messo a tacere il grido del suo cuore. Agostino cercava la verità, la verità che non illude, la bellezza che non passa. E come l’ha trovata? Come ha trovato un’amicizia sincera, un amore capace di dare speranza? Incontrando chi già lo stava cercando, incontrando Gesù Cristo. Come ha costruito il suo futuro? Seguendo Lui, suo amico da sempre. Ecco le sue parole: «Nessuna amicizia è fedele se non in Cristo. È in Lui solo che essa può essere felice ed eterna» (Contro le due lettere dei pelagiani, I, I, 1); e la vera amicizia è sempre in Gesù Cristo con fiducia, amore e rispetto. «Ama veramente il suo amico colui che nel suo amico ama Dio» (Discorso 336), ci dice Sant’Agostino. L’amicizia con Cristo, che sta alla base delle fede, non è solo un aiuto tra tanti altri per costruire il futuro: è la nostra stella polare. Come scriveva il beato Pier Giorgio Frassati, «vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere, ma vivacchiare» (Lettere, 27 febbraio 1925). Quando le nostre amicizie riflettono questo intenso legame con Gesù, diventano certamente sincere, generose e vere.
Volersi bene in Cristo. Saper vedere Gesù negli altri. L’amicizia può veramente cambiare il mondo. L’amicizia è una strada verso la pace."
Papa Leone XIV

LEONE XIV
UDIENZA GENERALE
Aula Paolo VI
Mercoledì, 13 agosto 2025
Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. III. La Pasqua di Gesù. 2. Il tradimento. «Sono forse io?» (Mc 14,19)
Cari fratelli e sorelle,
proseguiamo il nostro cammino alla scuola del Vangelo, seguendo i passi di Gesù negli ultimi giorni della sua vita. Oggi ci fermiamo su una scena intima, drammatica, ma anche profondamente vera: il momento in cui, durante la cena pasquale, Gesù rivela che uno dei Dodici sta per tradirlo: «In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà» (Mc 14,18).
Parole forti. Gesù non le pronuncia per condannare, ma per mostrare quanto l’amore, quando è vero, non può fare a meno della verità. La stanza al piano superiore, dove poco prima tutto era stato preparato con cura, si riempie all’improvviso di un dolore silenzioso, fatto di domande, di sospetti, di vulnerabilità. È un dolore che conosciamo bene anche noi, quando nelle relazioni più care si insinua l’ombra del tradimento.
Eppure, il modo in cui Gesù parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda. Parla in modo tale che ciascuno possa interrogarsi. Ed è proprio quello che succede. San Marco ci dice: «Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l’altro: “Sono forse io?”» (Mc 14,19).
Cari amici, questa domanda – “Sono forse io?” – è forse tra le più sincere che possiamo rivolgere a noi stessi. Non è la domanda dell’innocente, ma del discepolo che si scopre fragile. Non è il grido del colpevole, ma il sussurro di chi, pur volendo amare, sa di poter ferire. È in questa consapevolezza che inizia il cammino della salvezza.
Gesù non denuncia per umiliare. Dice la verità perché vuole salvare. E per essere salvati bisogna sentire: sentire che si è coinvolti, sentire che si è amati nonostante tutto, sentire che il male è reale ma non ha l’ultima parola. Solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo può accettare anche la ferita del tradimento.
La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione. Il Vangelo non ci insegna a negare il male, ma a riconoscerlo come occasione dolorosa per rinascere.
Gesù, poi, aggiunge una frase che ci inquieta e ci fa pensare: «Guai a quell’uomo, dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!» (Mc 14,21). Sono parole dure, certamente, ma vanno intese bene: non si tratta di una maledizione, è piuttosto un grido di dolore. In greco quel “guai” suona come un lamento, un “ahimè”, un’esclamazione di compassione sincera e profonda.
Noi siamo abituati a giudicare. Dio, invece, accetta di soffrire. Quando vede il male, non si vendica, ma si addolora. E quel “meglio se non fosse mai nato” non è una condanna inflitta a priori, ma una verità che ciascuno di noi può riconoscere: se rinneghiamo l’amore che ci ha generati, se tradendo diventiamo infedeli a noi stessi, allora davvero smarriamo il senso del nostro essere venuti al mondo e ci autoescludiamo dalla salvezza.
Eppure, proprio lì, nel punto più oscuro, la luce non si spegne. Anzi, comincia a brillare. Perché se riconosciamo il nostro limite, se ci lasciamo toccare dal dolore di Cristo, allora possiamo finalmente nascere di nuovo. La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne: quella della misericordia.
Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità. Sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio del tradimento. Ma Gesù continua a fidarsi. Continua a sedersi a tavola con i suoi. Non rinuncia a spezzare il pane anche per chi lo tradirà. Questa è la forza silenziosa di Dio: non abbandona mai il tavolo dell’amore, neppure quando sa che sarà lasciato solo.
Cari fratelli e sorelle, anche noi possiamo chiederci oggi, con sincerità: “Sono forse io?”. Non per sentirci accusati, ma per aprire uno spazio alla verità nel nostro cuore. La salvezza comincia da qui: dalla consapevolezza che potremmo essere noi a spezzare la fiducia in Dio, ma che possiamo anche essere noi a raccoglierla, custodirla, rinnovarla.
In fondo, questa è la speranza: sapere che, anche se noi possiamo fallire, Dio non viene mai meno. Anche se possiamo tradire, Lui non smette di amarci. E se ci lasciamo raggiungere da questo amore – umile, ferito, ma sempre fedele – allora possiamo davvero rinascere. E iniziare a vivere non più da traditori, ma da figli sempre amati.

Prepariamo la Speranza nel nostro cuore!
LEONE XIV
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 6 agosto 2025
Cari fratelli e sorelle,
proseguiamo il nostro cammino giubilare alla scoperta del volto di Cristo, in cui la nostra speranza prende forma e consistenza. Oggi cominciamo a riflettere sul mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Iniziamo meditando una parola che sembra semplice, ma custodisce un segreto prezioso della vita cristiana: preparare.
Nel Vangelo di Marco si racconta che «il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: “Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?”» (Mc 14,12). È una domanda pratica, ma anche carica di attesa. I discepoli intuiscono che sta per avvenire qualcosa di importante, ma non ne conoscono i dettagli. La risposta di Gesù sembra quasi un enigma: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua» (v. 13). I dettagli si fanno simbolici: un uomo che porta una brocca – gesto solitamente femminile in quell’epoca –, una sala al piano superiore già pronta, un padrone di casa sconosciuto. È come se ogni cosa fosse stata predisposta in anticipo. In effetti è proprio così. In questo episodio, il Vangelo ci rivela che l’amore non è frutto del caso, ma di una scelta consapevole. Non si tratta di una semplice reazione, ma di una decisione che richiede preparazione. Gesù non affronta la sua passione per fatalità, ma per fedeltà a un cammino accolto e percorso con libertà e cura. È questo che ci consola: sapere che il dono della sua vita nasce da un’intenzione profonda, non da un impulso improvviso.
Quella “sala al piano superiore già pronta” ci dice che Dio ci precede sempre. Ancor prima che ci rendiamo conto di avere bisogno di accoglienza, il Signore ha già preparato per noi uno spazio dove riconoscerci e sentirci suoi amici. Questo luogo è, in fondo, il nostro cuore: una “stanza” che può sembrare vuota, ma che attende solo di essere riconosciuta, colmata e custodita. La Pasqua, che i discepoli devono preparare, è in realtà già pronta nel cuore di Gesù. È Lui che ha pensato tutto, disposto tutto, deciso tutto. Tuttavia, chiede ai suoi amici di fare la loro parte. Questo ci insegna qualcosa di essenziale per la nostra vita spirituale: la grazia non elimina la nostra libertà, ma la risveglia. Il dono di Dio non annulla la nostra responsabilità, ma la rende feconda.
Anche oggi, come allora, c’è una cena da preparare. Non si tratta solo della liturgia, ma della nostra disponibilità a entrare in un gesto che ci supera. L’Eucaristia non si celebra soltanto sull’altare, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie. Prepararsi a celebrare questo rendimento di grazie non significa fare di più, ma lasciare spazio. Significa togliere ciò che ingombra, abbassare le pretese, smettere di coltivare aspettative irreali. Troppo spesso, infatti, confondiamo i preparativi con le illusioni. Le illusioni ci distraggono, i preparativi ci orientano. Le illusioni cercano un risultato, i preparativi rendono possibile un incontro. L’amore vero – ci ricorda il Vangelo – si dà prima ancora che venga ricambiato. È un dono anticipato. Non si fonda su ciò che riceve, ma su ciò che desidera offrire. È ciò che Gesù ha vissuto con i suoi: mentre loro ancora non capivano, mentre uno stava per tradirlo e un altro per rinnegarlo, Lui preparava per tutti una cena di comunione.
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a “preparare la Pasqua” del Signore. Non solo quella liturgica: anche quella della nostra vita. Ogni gesto di disponibilità, ogni atto gratuito, ogni perdono offerto in anticipo, ogni fatica accolta pazientemente è un modo per preparare un luogo dove Dio può abitare. Possiamo allora chiederci: quali spazi nella mia vita ho bisogno di riordinare perché siano pronti ad accogliere il Signore? Cosa significa per me oggi “preparare”? Forse rinunciare a una pretesa, smettere di aspettare che l’altro cambi, fare il primo passo. Forse ascoltare di più, agire di meno, o imparare a fidarmi di ciò che già è stato predisposto.
Se accogliamo l’invito a preparare il luogo della comunione con Dio e tra di noi, scopriamo di essere circondati da segni, incontri, parole che orientano verso quella sala, spaziosa e già pronta, in cui si celebra incessantemente il mistero di un amore infinito, che ci sostiene e che sempre ci precede. Che il Signore ci conceda di essere umili preparatori della sua presenza. E, in questa disponibilità quotidiana, cresca anche in noi quella fiducia serena che ci permette di affrontare ogni cosa con il cuore libero. Perché dove l’amore è stato preparato, la vita può davvero fiorire.

GIUBILEO DEI GIOVANI
SANTA MESSA
OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Tor Vergata
XVIII domenica del Tempo Ordinario, 3 agosto 2025
Carissimi giovani,
dopo la Veglia vissuta assieme ieri sera, ci ritroviamo oggi per celebrare l'Eucaristia, Sacramento del dono totale di Sé che il Signore ha fatto per noi. Possiamo immaginare di ripercorrere, in questa esperienza, il cammino compiuto la sera di Pasqua dai discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35): prima si allontanavano da Gerusalemme intimoriti e delusi; andavano via convinti che, dopo la morte di Gesù, non ci fosse più niente da aspettarsi, niente in cui sperare. E invece hanno incontrato proprio Lui, lo hanno accolto come compagno di viaggio, lo hanno ascoltato mentre spiegava loro le Scritture, e infine lo hanno riconosciuto allo spezzare del pane. I loro occhi allora si sono aperti e l'annuncio gioioso della Pasqua ha trovato posto nel loro cuore.
La liturgia odierna non ci parla direttamente di questo episodio, ma ci aiuta a riflettere su ciò che in esso si narra: l'incontro con Cristo Risorto che cambia la nostra esistenza, che illumina i nostri affetti, desideri, pensieri.
La prima Lettura, tratta dal Libro del Qoelet, ci invita a prendere contatto, come i due discepoli di cui abbiamo parlato, con l'esperienza del nostro limite, della finitezza delle cose che passano (cfr Qo 1,2;2,21-23); e il Salmo responsoriale, che le fa eco, ci propone l'immagine dell'«erba che germoglia; al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca» (Sal 90,5-6). Sono due richiami forti, forse un po' scioccanti, che però non devono spaventarci, quasi fossero argomenti "tabù", da evitare. La fragilità di cui ci parlano, infatti, è parte della meraviglia che siamo. Pensiamo al simbolo dell'erba: non è bellissimo un prato in fiore? Certo, è delicato, fatto di steli esili, vulnerabili, soggetti a seccarsi, piegarsi, spezzarsi, e però al tempo stesso subito rimpiazzati da altri che spuntano dopo di loro, e di cui generosamente i primi si fanno nutrimento e concime, con il loro consumarsi sul terreno. È così che vive il campo, rinnovandosi continuamente, e anche durante i mesi gelidi dell'inverno, quando tutto sembra tacere, la sua energia freme sotto terra e si prepara ad esplodere, a primavera, in mille colori.
Noi pure, cari amici, siamo fatti così: siamo fatti per questo. Non per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un'esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell'amore. E così aspiriamo continuamente a un "di più" che nessuna realtà creata ci può dare; sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto, che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte ad essa, non inganniamo il nostro cuore, cercando di spegnerla con surrogati inefficaci! Ascoltiamola, piuttosto! Facciamone uno sgabello su cui salire per affacciarci, come bambini, in punta di piedi, alla finestra dell'incontro con Dio. Ci troveremo di fronte a Lui, che ci aspetta, anzi che bussa gentilmente al vetro della nostra anima (cfr Ap 3,20). Ed è bello, anche a vent’anni, spalancargli il cuore, permettergli di entrare, per poi avventurarci con Lui verso gli spazi eterni dell'infinito.
Sant'Agostino, parlando della sua intensa ricerca di Dio, si chiedeva: «Qual è allora l'oggetto della nostra speranza […]? È la terra? No. Qualcosa che deriva dalla terra, come l'oro, l'argento, l'albero, la messe, l'acqua […]? Queste cose piacciono, sono belle queste cose, sono buone queste cose» (Sermo 313/F, 3). E concludeva: «Ricerca chi le ha fatte, egli è la tua speranza» (ibid.). Pensando, poi, al cammino che aveva percorso, pregava dicendo: «Tu [Signore] eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo […]. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai (cfr Sal 33,9; 1Pt 2,3) e ho fame e sete (cfr Mt 5,6; 1Cor 4,11); mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace» (Confessiones, 10, 27).
Sorelle e fratelli, sono parole bellissime, che ricordano quanto Papa Francesco diceva a Lisbona, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, ad altri giovani come voi: «Ognuno è chiamato a confrontarsi con grandi domande che non hanno […] una risposta semplicistica o immediata, ma invitano a compiere un viaggio, a superare sé stessi, ad andare oltre […], a un decollo senza il quale non c’è volo. Non allarmiamoci allora se ci troviamo interiormente assetati, inquieti, incompiuti, desiderosi di senso e di futuro […]. Non siamo malati, siamo vivi!» (Discorso per l'incontro con i Giovani Universitari, 3 agosto 2023).
C'è una domanda importante nel nostro cuore, un bisogno di verità che non possiamo ignorare, che ci porta a chiederci: cos'è veramente la felicità? Qual è il vero gusto della vita? Cosa ci libera dagli stagni del non senso, della noia, della mediocrità?
Nei giorni scorsi avete fatto molte belle esperienze. Vi siete incontrati tra coetanei provenienti da varie parti del mondo, appartenenti a diverse culture. Vi siete scambiati conoscenze, avete condiviso aspettative, avete dialogato con la città attraverso l'arte, la musica, l'informatica, lo sport. Al Circo Massimo, poi, accostandovi al Sacramento della Penitenza, avete ricevuto il perdono di Dio e avete chiesto il suo aiuto per una vita buona.
In tutto questo potete cogliere una risposta importante: la pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo né, come abbiamo sentito nel Vangelo, da ciò che possediamo (cfr Lc 12,13-21). È legata piuttosto a ciò che con gioia sappiamo accogliere e condividere (cfr Mt 10,8-10; Gv 6,1-13). Comprare, ammassare, consumare, non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto, alle «cose di lassù» (Col 3,2), per renderci conto che tutto ha senso, tra le realtà del mondo, solo nella misura in cui serve a unirci a Dio e ai fratelli nella carità, facendo crescere in noi «sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità» (Col 3,12), di perdono (cfr ivi, v. 13), di pace (cfr Gv 14,27), come quelli di Cristo (cfr Fil 2,5). E in questo orizzonte comprenderemo sempre meglio cosa significhi che «la speranza […] non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (cfr Rm 5,5).
Carissimi giovani, la nostra speranza è Gesù. È Lui, come diceva San Giovanni Paolo II, «che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande […], per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e fraterna» (XV Giornata Mondiale della Gioventù, Veglia Di Preghiera, 19 agosto 2000). Teniamoci uniti a Lui, rimaniamo nella sua amicizia, sempre, coltivandola con la preghiera, l’adorazione, la Comunione eucaristica, la Confessione frequente, la carità generosa, come ci hanno insegnato i beati Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis, che presto saranno proclamati Santi. Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo.
Vi affido a Maria, la Vergine della speranza. Con il suo aiuto, tornando nei prossimi giorni ai vostri Paesi, in tutte le parti del mondo, continuate a camminare con gioia sulle orme del Salvatore, e contagiate chiunque incontrate col vostro entusiasmo e con la testimonianza della vostra fede! Buon cammino!

VEGLIA DI PREGHIERA
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE LEONE XIV
Tor Vergata
Sabato, 2 agosto 2025
Santo Padre, sono Dulce María, ho 23 anni e vengo dal Messico. Mi rivolgo a Lei facendomi portavoce di una realtà che viviamo noi giovani in tante parti del mondo. Siamo figli del nostro tempo. Viviamo una cultura che ci appartiene e senza che ce ne accorgiamo ci plasma; è segnata dalla tecnologia soprattutto nel campo dei social network. Ci illudiamo spesso di avere tanti amici e di creare legami di vicinanza mentre sempre più spesso facciamo esperienza di tante forme di solitudine. Siamo vicini e connessi con tante persone eppure, non sono legami veri e duraturi, ma effimeri e spesso illusori.
Santo Padre, ecco la mia domanda: come possiamo trovare un’amicizia sincera e un amore genuino che aprono alla vera speranza? Come la fede può aiutarci a costruire il nostro futuro?
Carissimi giovani, le relazioni umane, le nostre relazioni con altre persone sono indispensabili per ciascuno di noi, a cominciare dal fatto che tutti gli uomini e le donne del mondo nascono figli di qualcuno. La nostra vita inizia grazie a un legame ed è attraverso legami che noi cresciamo. In questo processo, la cultura svolge un ruolo fondamentale: è il codice col quale interpretiamo noi stessi e il mondo. Come un vocabolario, ogni cultura contiene sia parole nobili sia parole volgari, sia valori sia errori, che bisogna imparare a riconoscere. Cercando con passione la verità, noi non solo riceviamo una cultura, ma la trasformiamo attraverso scelte di vita. La verità, infatti, è un legame che unisce le parole alle cose, i nomi ai volti. La menzogna, invece, stacca questi aspetti, generando confusione ed equivoco.
Ora, tra le molte connessioni culturali che caratterizzano la nostra vita, internet e i media sono diventati «una straordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le persone, oltre che di accesso all’informazione e alla conoscenza» (Papa Francesco, Christus vivit, 87). Questi strumenti risultano però ambigui quando sono dominati da logiche commerciali e da interessi che spezzano le nostre relazioni in mille intermittenze. A proposito, Papa Francesco ricordava che talvolta i «meccanismi della comunicazione, della pubblicità e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare soggetti addormentati, dipendenti dal consumo» (Christus vivit, 105). Allora le nostre relazioni diventano confuse, sospese o instabili. Inoltre, come sapete, oggi ci sono algoritmi che ci dicono quello che dobbiamo vedere, quello che dobbiamo pensare, e quali dovrebbero essere i nostri amici. E allora le nostre relazioni diventano confuse, a volte ansiose. È che quando lo strumento domina sull’uomo, l’uomo diventa uno strumento: sì, strumento di mercato, merce a sua volta. Solo relazioni sincere e legami stabili fanno crescere storie di vita buona.
Carissimi, ogni persona desidera naturalmente questa vita buona, come i polmoni tendono all’aria, ma quanto è difficile trovarla! Quanto è difficile trovare un’amicizia autentica! Secoli fa, Sant’Agostino ha colto il profondo desiderio del nostro cuore – è il desiderio di ogni cuore umano – anche senza conoscere lo sviluppo tecnologico di oggi. Anche lui è passato attraverso una giovinezza burrascosa: non si è però accontentato, non ha messo a tacere il grido del suo cuore. Agostino cercava la verità, la verità che non illude, la bellezza che non passa. E come l’ha trovata? Come ha trovato un’amicizia sincera, un amore capace di dare speranza? Incontrando chi già lo stava cercando, incontrando Gesù Cristo. Come ha costruito il suo futuro? Seguendo Lui, suo amico da sempre. Ecco le sue parole: «Nessuna amicizia è fedele se non in Cristo. È in Lui solo che essa può essere felice ed eterna» (Contro le due lettere dei pelagiani, I, I, 1); e la vera amicizia è sempre in Gesù Cristo con fiducia, amore e rispetto. «Ama veramente il suo amico colui che nel suo amico ama Dio» (Discorso 336), ci dice Sant’Agostino. L’amicizia con Cristo, che sta alla base delle fede, non è solo un aiuto tra tanti altri per costruire il futuro: è la nostra stella polare. Come scriveva il beato Pier Giorgio Frassati, «vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere, ma vivacchiare» (Lettere, 27 febbraio 1925). Quando le nostre amicizie riflettono questo intenso legame con Gesù, diventano certamente sincere, generose e vere.
Cari giovani, vogliatevi bene tra di voi! Volersi bene in Cristo. Saper vedere Gesù negli altri. L’amicizia può veramente cambiare il mondo. L’amicizia è una strada verso la pace.
Domanda 2 – Coraggio per scegliere
Santo Padre, mi chiamo Gaia, ho 19 anni e sono italiana. Questa sera tutti noi giovani qui presenti vorremmo parlarLe dei nostri sogni, speranze e dubbi. I nostri anni sono segnati dalle decisioni importanti che siamo chiamati a prendere per orientare la nostra vita futura. Tuttavia, per il clima di incertezza che ci circonda siamo tentati di rimandare e la paura per un futuro sconosciuto ci paralizza. Sappiamo che scegliere equivale a rinunciare a qualcosa e questo ci blocca, nonostante tutto percepiamo che la speranza indica obiettivi raggiungibili anche se segnati dalla precarietà del momento presente.
Santo Padre, le chiediamo: dove troviamo il coraggio per scegliere? Come possiamo essere coraggiosi e vivere l’avventura della libertà viva, compiendo scelte radicali e cariche di significato?
Grazie per questa domanda. La pregunta es ¿cómo encontrar la valentía para escoger? Where can we find the courage to choose and to make wise decisions? La scelta è un atto umano fondamentale. Osservandolo con attenzione, capiamo che non si tratta solo di scegliere qualcosa, ma di scegliere qualcuno. Quando scegliamo, in senso forte, decidiamo chi vogliamo diventare. La scelta per eccellenza, infatti, è la decisione per la nostra vita: quale uomo vuoi essere? Quale donna vuoi essere? Carissimi giovani, a scegliere si impara attraverso le prove della vita, e prima di tutto ricordando che noi siamo stati scelti. Tale memoria va esplorata ed educata. Abbiamo ricevuto la vita gratis, senza sceglierla! All’origine di noi stessi non c’è stata una nostra decisione, ma un amore che ci ha voluti. Nel corso dell’esistenza, si dimostra davvero amico chi ci aiuta a riconoscere e rinnovare questa grazia nelle scelte che siamo chiamati a prendere.
Cari giovani, avete detto bene: “scegliere significa anche rinunciare ad altro, e questo a volte ci blocca”. Per essere liberi, occorre partire dal fondamento stabile, dalla roccia che sostiene i nostri passi. Questa roccia è un amore che ci precede, ci sorprende e ci supera infinitamente: è l’amore di Dio. Perciò davanti a Lui la scelta diventa un giudizio che non toglie alcun bene, ma porta sempre al meglio.
Il coraggio per scegliere viene dall’amore, che Dio ci manifesta in Cristo. È Lui che ci ha amato con tutto sé stesso, salvando il mondo e mostrandoci così che il dono della vita è la via per realizzare la nostra persona. Per questo, l’incontro con Gesù corrisponde alle attese più profonde del nostro cuore, perché Gesù è l’Amore di Dio fatto uomo.
A riguardo, venticinque anni fa, proprio qui dove ci troviamo, San Giovanni Paolo II disse: «è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare» (Veglia di preghiera nella XV Giornata mondiale della Gioventù, 19 agosto 2000). La paura lascia allora spazio alla speranza, perché siamo certi che Dio porta a compimento ciò che inizia.
Riconosciamo la sua fedeltà nelle parole di chi ama davvero, perché è stato davvero amato. “Tu sei la mia vita, Signore”: è ciò che un sacerdote e una consacrata pronunciano pieni di gioia e di libertà. “Tu sei la mia vita, Signore”. “Accolgo te come mia sposa e come mio sposo”: è la frase che trasforma l’amore dell’uomo e della donna in segno efficace dell’amore di Dio nel matrimonio. Ecco scelte radicali, scelte piene di significato: il matrimonio, l’ordine sacro, e la consacrazione religiosa esprimono il dono di sé, libero e liberante, che ci rende davvero felici. E lì troviamo la felicità: quando impariamo a donare noi stessi, a donare la vita per gli altri.
Queste scelte danno senso alla nostra vita, trasformandola a immagine dell’Amore perfetto, che l’ha creata e redenta da ogni male, anche dalla morte. Dico questo stasera pensando a due ragazze, María, ventenne, spagnola, e Pascale, diciottenne, egiziana. Entrambe hanno scelto di venire a Roma per il Giubileo dei Giovani, e la morte le ha colte in questi giorni. Preghiamo insieme per loro; preghiamo anche per i loro familiari, i loro amici e le loro comunità. Gesù Risorto le accolga nella pace e nella gioia del suo Regno. E ancora vorrei chiedere le vostre preghiere per un altro amico, un ragazzo spagnolo, Ignacio Gonzalvez, che è stato ricoverato all’ospedale “Bambino Gesù”: preghiamo per lui, per la sua salute.
Trovate il coraggio di fare le scelte difficili e dire a Gesù: Tu sei la mia vita, Signore”. “Lord, You are my life”. Grazie.
Domanda 3 – Richiamo del bene e valore del silenzio
Santo Padre, mi chiamo Will. Ho 20 anni e vengo dagli stati Uniti. Vorrei farLe una domanda a nome di tanti giovani intorno a noi che desiderano, nei loro cuori, qualcosa di più profondo. Siamo attratti dalla vita interiore anche se a prima vista veniamo giudicati come una generazione superficiale e spensierata. Sentiamo nel profondo di noi stessi il richiamo al bello e al bene come fonte di verità. Il valore del silenzio come in questa Veglia ci affascina, anche se incute in alcuni momenti paura per il senso di vuoto.
Santo Padre, le chiedo: come possiamo incontrare veramente il Signore Risorto nella nostra vita ed essere sicuri della sua presenza anche in mezzo alle difficoltà e incertezze?
Proprio all’inizio del Documento con il quale ha indetto il Giubileo, Papa Francesco scrisse che «nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene» (Spes non confundit, 1). Dire “cuore”, nel linguaggio biblico, significa dire “coscienza”: poiché ogni persona desidera il bene nel suo cuore, da tale sorgente scaturisce la speranza di accoglierlo. Ma che cos’è il “bene”? Per rispondere a questa domanda, occorre un testimone: qualcuno che ci faccia del bene. Più ancora, occorre qualcuno che sia il nostro bene, ascoltando con amore il desiderio che freme nella nostra coscienza. Senza questi testimoni non saremmo nati, né saremmo cresciuti nel bene: come veri amici, essi sostengono il comune desiderio di bene, aiutandoci a realizzarlo nelle scelte di ogni giorno.
Carissimi giovani, l’amico che sempre accompagna la nostra coscienza è Gesù. Volete incontrare veramente il Signore Risorto? Ascoltate la sua parola, che è Vangelo di salvezza! Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano! Servite il povero, testimoniando il bene che vorremmo sempre ricevere dal prossimo! Rimanete uniti con Gesù nell’Eucaristia. Adorate l’Eucarestia, fonte della vita eterna! Studiate, lavorate, amate secondo lo stile di Gesù, il Maestro buono che cammina sempre al nostro fianco.
Ad ogni passo, mentre cerchiamo il bene, chiediamogli: resta con noi, Signore (cfr Lc 24,29)! Resta con noi Signore! Resta con noi, perché senza di Te non possiamo fare quel bene che desideriamo. Tu vuoi il nostro bene; Tu, Signore, sei il nostro bene. Chi ti incontra, desidera che anche altri ii incontrino, perché la tua parola è luce più chiara di ogni stella, che illumina anche la notte più nera. Come amava ripetere Papa Benedetto XVI, chi crede, non è mai solo. Perciò incontriamo veramente Cristo nella Chiesa, cioè nella comunione di coloro che il Signore stesso riunisce attorno a sé per farsi incontro, lungo la storia, ad ogni uomo che sinceramente lo cerca. Quanto ha bisogno il mondo di missionari del Vangelo che siano testimoni di giustizia e di pace! Quanto ha bisogno il futuro di uomini e donne che siano testimoni di speranza! Ecco, carissimi giovani, il compito che il Signore Risorto ci consegna.
Sant’Agostino ha scritto: «L’uomo, una particella del tuo creato, o Dio, vuole lodarti. Sei Tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per Te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in Te. Che io ti cerchi, Signore, invocandoti e ti invochi credendoti» (Confessioni, I). Accostando questa invocazione alle vostre domande, vi affido una preghiera: “Grazie, Gesù, per averci raggiunto: il mio desiderio è quello di rimanere tra i Tuoi amici, perché, abbracciando Te, possa diventare compagno di cammino per chiunque mi incontrerà. Fa’, o Signore, che chi mi incontra, possa incontrare Te, pur attraverso i miei limiti, pur attraverso le mie fragilità”. Attraverso queste parole, il nostro dialogo continuerà ogni volta che guarderemo al Crocifisso: in Lui si incontreranno i nostri cuori. Ogni volta che adoriamo Cristo nell’Eucaristia, i nostri cuori si uniscono in Lui. Perseverate dunque nella fede con gioia e coraggio. E così possiamo dire: grazie Gesù per averci amati; grazie Gesù per averci chiamati. Resta con noi, Signore! Resta con noi!]
Parole a braccio del Santo Padre al termine della Veglia con i Giovani
Vorrei ringraziare il coro, la musica: grazie per accompagnarci! Grazie a tutti voi! Gracias! Mi raccomando: riposatevi un po’. L’appuntamento domani mattina qui per la Santa Messa. Auguri a tutti. Buonanotte!

SALUTO DEL SANTO PADRE LEONE XIV
AGLI INFLUENCER E MISSIONARI DIGITALI
Basilica di San Pietro
Martedì, 29 luglio 2025
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
la pace sia con voi!
Cari fratelli e sorelle, abbiamo cominciato con questo saluto: la pace sia con voi!
E quanto abbiamo bisogno di pace in questo nostro tempo dilaniato dall’inimicizia e dalle guerre. E quanto ci chiama alla testimonianza, oggi, il saluto del Risorto: «Pace a voi!» (Gv 20,19). La pace sia con tutti noi. Nei nostri cuori e nel nostro agire.
Questa è la missione della Chiesa: annunciare al mondo la pace! La pace che viene dal Signore, che ha vinto la morte, che ci porta il perdono di Dio, che ci dona la vita del Padre, che ci indica la via dell’Amore!
1. È la missione che la Chiesa oggi affida anche a voi; che siete qui a Roma per il vostro Giubileo; venuti a rinnovare l'impegno a nutrire di speranza cristiana le reti sociali e gli ambienti digitali. La pace ha bisogno di essere cercata, annunciata, condivisa in ogni luogo; sia nei drammatici luoghi di guerra, sia nei cuori svuotati di chi ha perso il senso dell'esistenza e il gusto dell'interiorità, il gusto della vita spirituale. E oggi, forse più che mai, abbiamo bisogno di discepoli missionari che portino nel mondo il dono del Risorto; che diano voce alla speranza che ci dà Gesù Vivo, fino agli estremi confini della terra (cfr At 1,3-8); che arrivino dovunque ci sia un cuore che aspetta, un cuore che cerca, un cuore che ha bisogno. Sì, fino ai confini della terra, ai confini esistenziali dove non c'è speranza.
[2. In questa missione c'è una seconda sfida: negli spazi digitali, cercate sempre la “carne sofferente di Cristo” in ogni fratello e sorella. Oggi ci troviamo in una cultura nuova, profondamente segnata e costruita con e dalla tecnologia. Sta a noi – sta a voi – far sì che questa cultura rimanga umana.
La scienza e la tecnica influenzano il nostro modo di essere e di stare nel mondo, fino a coinvolgere persino la comprensione di noi stessi, il nostro rapporto con gli altri e il nostro rapporto con Dio. Ma niente che viene dall’uomo e dal suo ingegno deve essere piegato sino a mortificare la dignità dell'altro. La nostra, la vostra missione, è nutrire una cultura di umanesimo cristiano, e di farlo insieme. Questa è per tutti noi la bellezza della "rete".
Di fronte ai cambiamenti culturali, nel corso della storia, la Chiesa non è mai rimasta passiva; ha sempre cercato di illuminare ogni tempo con la luce e la speranza di Cristo, di discernere il bene dal male, quanto di buono nasceva da quanto aveva bisogno di essere cambiato, trasformato, purificato.
Oggi, in una cultura dove la dimensione digitale è presente quasi in ogni cosa, in un tempo in cui la nascita dell'intelligenza artificiale segna una nuova geografia nel vissuto delle persone e per l'intera società, questa è la sfida che dobbiamo raccogliere, riflettendo sulla coerenza della nostra testimonianza, sulla capacità di ascoltare e di parlare; di capire e di essere capiti. Abbiamo il dovere di elaborare insieme un pensiero, di elaborare un linguaggio che, nell’essere figli del nostro tempo, diano voce all’Amore.
Non si tratta semplicemente di generare contenuti, ma di incontrare cuori, di cercare chi soffre e ha bisogno di conoscere il Signore per guarire le proprie ferite, per rialzarsi e trovare un senso, partendo prima di tutto da noi stessi e dalle nostre povertà, lasciando cadere ogni maschera e riconoscendoci per primi bisognosi di Vangelo. E si tratta di farlo insieme.]
[3. E questo ci porta ad un terzo appello, in virtù del quale rivolgo una chiamata a tutti voi: "andate a riparare le reti”. Gesù ha chiamato i suoi primi apostoli mentre erano intenti a riparare le loro reti da pescatori (cfr Mt 4,21-22). Lo chiede anche a noi, anzi ci chiede, oggi, di costruire altre reti: reti di relazioni, reti d'amore, reti di condivisione gratuita, dove l'amicizia sia autentica e profonda. Reti dove si possa ricucire ciò che si è spezzato, dove si possa guarire dalla solitudine, non contando il numero dei follower, ma sperimentando in ogni incontro la grandezza infinita dell’Amore. Reti che danno spazio all’altro più che a sé stessi, dove nessuna "bolla" possa coprire le voci dei più deboli. Reti che liberano, reti che salvano. Reti che ci fanno riscoprire la bellezza di guardarci negli occhi. Reti di verità. Così, ogni storia di bene condiviso sarà il nodo di un'unica, immensa rete: la rete delle reti, la rete di Dio.
Siate allora agenti di comunione, capaci di rompere le logiche della divisione e della polarizzazione; dell’individualismo e dell’egocentrismo. Siate centrati su Cristo, per vincere le logiche del mondo, delle fake news, della frivolezza, con la bellezza e la luce della Verità (cfr Gv 8,31-32).]
E ora, prima di salutarvi con la Benedizione, affidando al Signore la vostra testimonianza, voglio ringraziarvi per quanto di bene avete fatto e fate nelle vostre vite, per i sogni che portate avanti, per il vostro amore al Signore Gesù, per il vostro amore alla Chiesa, per l'aiuto che date a chi soffre, per il vostro cammino nelle strade digitali.

SANTA MESSA PRESSO LA CAPPELLA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI CASTEL GANDOLFO
OMELIA DEL SANTO PADRE LEONE XIV
Martedì, 15 luglio 2025
Cari fratelli e sorelle,
il Vangelo che abbiamo ascoltato ci consegna l’autentico significato cristiano di queste due parole. Fratello e sorella sono nomi di relazione, che ripetiamo spesso nella liturgia come saluto, come segni di prossimità e di affetto. Gesù, il Figlio unigenito di Dio, ne spiega il senso in relazione a sé e al Padre suo, rivelando un legame più forte del sangue perché ci coinvolge tutti, accomunando ogni uomo e ogni donna. Tutti, infatti, siamo davvero fratelli e sorelle di Gesù quando facciamo la volontà di Dio, cioè quando viviamo amandoci gli uni gli altri, come Dio ha amato noi.
Ogni relazione che Dio vive, in sé e per noi, diventa così un dono: quando il suo unico Figlio diventa nostro fratello, il Padre suo diventa Padre nostro e lo Spirito Santo, che unisce il Padre e il Figlio, viene ad abitare nei nostri cuori. L’amore di Dio è tanto grande che Gesù non tiene per sé neanche sua madre, consegnando Maria come madre nostra, nell’ora della croce (cfr Gv 19,27). Solo chi vive di una dedizione così piena può affermare: «chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre» (Mt 12,50). In particolare, queste parole ci fanno capire che Maria diventa madre di Gesù perché ascolta la parola di Dio con amore, la accoglie nel proprio cuore e la vive con fedeltà. Commentando il brano del Vangelo ora ricordato, sant’Agostino ha perciò scritto che «vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo». Difatti, «Maria fu beata, poiché ascoltò la parola di Dio e la mise in pratica» (Sermo 72/A, 7). Il senso della vita di Maria è custodito nella fedeltà alla Parola ricevuta da Dio: il Verbo della vita da lei accolto, portato in grembo e donato al mondo.
Carissimi, di recente è stato celebrato il LXXV anniversario della proclamazione della Vergine fedele, la Virgo fidelis, a Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Proprio da Castel Gandolfo, nel 1949 il mio venerato predecessore Papa Pio XII accolse questa bella proposta del Comando generale dell’Arma. Dopo la tragedia della guerra, in un periodo di ricostruzione morale e materiale, la fedeltà di Maria verso Dio diventava così modello della fedeltà di ogni Carabiniere verso la Patria e il popolo italiano. Questa virtù esprime la dedizione, la purezza, la costanza dell’impegno per il bene comune, che i Carabinieri tutelano garantendo la pubblica sicurezza e difendendo i diritti di tutti, specie di coloro che si trovano in condizioni di pericolo.
Esprimo perciò profonda gratitudine per il nobile e impegnativo servizio che l’Arma rende all’Italia e ai suoi cittadini, oltre che a favore della Santa Sede e dei fedeli che visitano Roma: penso specialmente ai molti pellegrini di quest’anno giubilare.
La devozione alla Vergine fedele rispecchia inoltre il motto dei Carabinieri, Nei secoli fedele, esprimendo il senso del dovere e l’abnegazione di ogni membro dell’Arma, fino al sacrificio di sé. Ringrazio dunque le Autorità presenti, civili e militari, per quello che fate nell’adempimento dei vostri compiti: davanti alle ingiustizie, che feriscono l’ordine sociale, non cedete alla tentazione di pensare che il male possa averla vinta. Specialmente in questo tempo di guerre e di violenza, restate fedeli al vostro giuramento: come servitori dello Stato, rispondete al crimine con la forza della legge e dell’onestà. È così che l’Arma dei Carabinieri, la Benemerita, meriterà sempre la stima del popolo italiano.
In questa Eucaristia, mentre celebriamo la passione, morte e resurrezione del Signore, è giusto e doveroso far memoria dei Carabinieri che hanno dato la vita compiendo il proprio dovere: vi affido come esempio il venerabile Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valore militare, del quale è in corso la causa di beatificazione. In ogni missione, la Virgo fidelis vi accompagni, vegliando amorevole su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e sul vostro lavoro.
Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. II. La vita di Gesù. Le guarigioni. 11. La donna emorroissa e la figlia di Giairo. «Non temere, soltanto abbi fede!» (Mc 5,36)
Mercoledi 25 giugno 2025
Papa Leone XIV
Cari fratelli e sorelle,
anche oggi meditiamo sulle guarigioni di Gesù come segno di speranza. In Lui c’è una forza che anche noi possiamo sperimentare quando entriamo in relazione con la sua Persona.
Una malattia molto diffusa nel nostro tempo è la fatica di vivere: la realtà ci sembra troppo complessa, pesante, difficile da affrontare. E allora ci spegniamo, ci addormentiamo, nell’illusione che al risveglio le cose saranno diverse. Ma la realtà va affrontata, e insieme con Gesù possiamo farlo bene. A volte poi ci sentiamo bloccati dal giudizio di coloro che pretendono di mettere etichette sugli altri.
Mi sembra che queste situazioni possano trovare riscontro in un passo del Vangelo di Marco, dove si intrecciano due storie: quella di una ragazza di dodici anni, che è a letto malata e sta per morire; e quella di una donna, che, proprio da dodici anni, ha perdite di sangue e cerca Gesù per poter guarire (cfr Mc 5,21-43).
Tra queste due figure femminili, l’Evangelista colloca il personaggio del padre della ragazza: egli non rimane in casa a lamentarsi per la malattia della figlia, ma esce e chiede aiuto. Benché sia il capo della sinagoga, non avanza pretese in ragione della sua posizione sociale. Quando c’è da attendere non perde la pazienza e aspetta. E quando vengono a dirgli che sua figlia è morta ed è inutile disturbare il Maestro, lui continua ad avere fede e a sperare.
Il colloquio di questo padre con Gesù è interrotto dalla donna emorroissa, che riesce ad avvicinarsi a Gesù e a toccare il suo mantello (v. 27). Questa donna con grande coraggio ha preso la decisione che cambia la sua vita: tutti continuavano a dirle di rimanere a distanza, di non farsi vedere. L’avevano condannata a rimanere nascosta e isolata. A volte anche noi possiamo essere vittime del giudizio degli altri, che pretendono di metterci addosso un abito che non è il nostro. E allora stiamo male e non riusciamo a venirne fuori.
Quella donna imbocca la via della salvezza quando germoglia in lei la fede che Gesù può guarirla: allora trova la forza di uscire e di andare a cercarlo. Vuole arrivare a toccare almeno la sua veste.
Intorno a Gesù c’era tanta folla, e dunque tante persone lo toccavano, eppure a loro non succede niente. Quando invece questa donna tocca Gesù, viene guarita. Dove sta la differenza? Commentando questo punto del testo, Sant’Agostino dice – a nome di Gesù –: «La folla mi si accalca intorno, ma la fede mi tocca» (Discorso 243, 2, 2). È così: ogni volta che facciamo un atto di fede indirizzato a Gesù, si stabilisce un contatto con Lui e immediatamente esce da Lui la sua grazia. A volte noi non ce ne accorgiamo, ma in modo segreto e reale la grazia ci raggiunge e da dentro pian piano trasforma la vita.
Forse anche oggi tante persone si accostano a Gesù in modo superficiale, senza credere veramente nella sua potenza. Calpestiamo la superficie delle nostre chiese, ma forse il cuore è altrove! Questa donna, silenziosa e anonima, vince le sue paure, toccando il cuore di Gesù con le sue mani considerate impure a causa della malattia. Ed ecco che subito si sente guarita. Gesù le dice: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace» (Mc 5,34).
Nel frattempo, portano a quel padre la notizia che sua figlia è morta. Gesù gli dice: «Non temere, soltanto abbi fede!» (v. 36). Poi va a casa sua e, vedendo che tutti piangono e gridano, dice: «La bambina non è morta, ma dorme» (v. 39). Quindi entra nella camera dove giaceva la bambina, la prende per mano e le dice : «Talità kum», “Fanciulla, alzati!”. La ragazza si alza in piedi e si mette a camminare (cfr vv. 41-42). Quel gesto di Gesù ci mostra che Lui non solo guarisce da ogni malattia, ma risveglia anche dalla morte. Per Dio, che è Vita eterna, la morte del corpo è come un sonno. La morte vera è quella dell’anima: di questa dobbiamo avere paura!
Un ultimo particolare: Gesù, dopo aver risuscitato la bambina, dice ai genitori di darle da mangiare (cfr v. 43). Ecco un altro segno molto concreto della vicinanza di Gesù alla nostra umanità. Ma possiamo intenderlo anche in senso più profondo e domandarci: quando i nostri ragazzi sono in crisi e hanno bisogno di un nutrimento spirituale, sappiamo darglielo? E come possiamo se noi stessi non ci nutriamo del Vangelo?
Cari fratelli e sorelle, nella vita ci sono momenti di delusione e di scoraggiamento, e c’è anche l’esperienza della morte. Impariamo da quella donna, da quel padre: andiamo da Gesù: Lui può guarirci, può farci rinascere. Gesù è la nostra speranza!

Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. II. La vita di Gesù. Le parabole. 9. Bartimeo. «Coraggio! Alzati, ti chiama!» (Mc 10,49)
Papa Leone XIV
Cari fratelli e sorelle,
con questa catechesi vorrei portare il nostro sguardo su un altro aspetto essenziale della vita di Gesù, cioè sulle sue guarigioni. Per questo vi invito a mettere davanti al Cuore di Cristo le vostre parti più doloranti o fragili, quei luoghi della vostra vita dove vi sentite fermi e bloccati. Chiediamo al Signore con fiducia di ascoltare il nostro grido e di guarirci!
Il personaggio che ci accompagna in questa riflessione ci aiuta a capire che non bisogna mai abbandonare la speranza, anche quando ci sentiamo perduti. Si tratta di Bartimeo, un uomo cieco e mendicante, che Gesù incontrò a Gerico (cfr Mc 10,40-52). Il luogo è significativo: Gesù sta andando a Gerusalemme, ma inizia il suo viaggio, per così dire, dagli “inferi” di Gerico, città che sta sotto il livello del mare. Gesù, infatti, con la sua morte, è andato a riprendere quell’Adamo che è caduto in basso e che rappresenta ognuno di noi.
Bartimeo significa “figlio di Timeo”: descrive quell’uomo attraverso una relazione, eppure lui è drammaticamente solo. Questo nome, però, potrebbe anche significare “figlio dell’onore” o “dell’ammirazione”, esattamente al contrario della situazione in cui si trova. [1] E poiché il nome è così importante nella cultura ebraica, vuol dire che Bartimeo non riesce a vivere ciò che è chiamato a essere.
A differenza poi del grande movimento di gente che cammina dietro a Gesù, Bartimeo è fermo. L’Evangelista dice che è seduto lungo la strada, dunque ha bisogno di qualcuno che lo rimetta in piedi e lo aiuti a riprendere il cammino.
Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d’uscita? Bartimeo ci insegna a fare appello alle risorse che ci portiamo dentro e che fanno parte di noi. Lui è un mendicante, sa chiedere, anzi, può gridare! Se desideri veramente qualcosa, fai di tutto per poterlo raggiungere, anche quando gli altri ti rimproverano, ti umiliano e ti dicono di lasciar perdere. Se lo desideri davvero, continua a gridare!
Il grido di Bartimeo, riportato dal Vangelo di Marco – «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» (v. 47) – è diventato una preghiera assai nota nella tradizione orientale, che anche noi possiamo utilizzare: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore».
Bartimeo è cieco, ma paradossalmente vede meglio degli altri e riconosce chi è Gesù! Davanti al suo grido, Gesù si ferma e lo fa chiamare (cfr v. 49), perché non c’è nessun grido che Dio non ascolti, anche quando non siamo consapevoli di rivolgerci a lui (cfr Es 2,23). Sembra strano che, davanti a un uomo cieco, Gesù non vada subito da lui; ma, se ci pensiamo, è il modo per riattivare la vita di Bartimeo: lo spinge a rialzarsi, si fida della sua possibilità di camminare. Quell’uomo può rimettersi in piedi, può risorgere dalle sue situazioni di morte. Ma per fare questo deve compiere un gesto molto significativo: deve buttare via il suo mantello (cfr v. 50)!
Per un mendicante, il mantello è tutto: è la sicurezza, è la casa, è la difesa che lo protegge. Persino la legge tutelava il mantello del mendicante e imponeva di restituirlo alla sera, qualora fosse stato preso in pegno (cfr Es 22,25). Eppure, molte volte, quello che ci blocca sono proprio le nostre apparenti sicurezze, quello che ci siamo messi addosso per difenderci e che invece ci sta impedendo di camminare. Per andare da Gesù e lasciarsi guarire, Bartimeo deve esporsi a Lui in tutta la sua vulnerabilità. Questo è il passaggio fondamentale per ogni cammino di guarigione.
Anche la domanda che Gesù gli pone sembra strana: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» (v. 51). Ma, in realtà, non è scontato che noi vogliamo guarire dalle nostre malattie, a volte preferiamo restare fermi per non assumerci responsabilità. La risposta di Bartimeo è profonda: usa il verbo anablepein, che può significare “vedere di nuovo”, ma che potremmo tradurre anche con “alzare lo sguardo”. Bartimeo, infatti, non vuole solo tornare a vedere, vuole ritrovare anche la sua dignità! Per guardare in alto, occorre rialzare la testa. A volte le persone sono bloccate perché la vita le ha umiliate e desiderano solo ritrovare il proprio valore.
Ciò che salva Bartimeo, e ciascuno di noi, è la fede. Gesù ci guarisce perché possiamo diventare liberi. Egli non invita Bartimeo a seguirlo, ma gli dice di andare, di rimettersi in cammino (cfr v. 52). Marco però conclude il racconto riferendo che Bartimeo prese a seguire Gesù: ha scelto liberamente di seguire colui che è la Via!
Cari fratelli e sorelle, portiamo con fiducia davanti a Gesù le nostre malattie, e anche quelle dei nostri cari, portiamo il dolore di quanti si sentono persi e senza via d’uscita. Gridiamo anche per loro, e siamo certi che il Signore ci ascolterà e si fermerà.
_____________________________________________
[1] È l’interpretazione data anche da Agostino ne Il consenso degli evangelisti, 2, 65, 125: PL 34, 1138.

Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. II. La vita di Gesù. Le parabole. 8. Gli operai nella vigna. «E disse loro: “Andate anche voi nella vigna”» (Mt 20,4). Mercoledi 4 giugno 2025
Papa Leone XIV
Cari fratelli e sorelle,
desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù. Anche in questo caso si tratta di un racconto che nutre la nostra speranza. A volte infatti abbiamo l’impressione di non riuscire a trovare un senso per la nostra vita: ci sentiamo inutili, inadeguati, proprio come degli operai che aspettano sulla piazza del mercato, in attesa che qualcuno li prenda a lavorare. Ma a volte il tempo passa, la vita scorre e non ci sentiamo riconosciuti o apprezzati. Forse non siamo arrivati in tempo, altri si sono presentati prima di noi, oppure le preoccupazioni ci hanno trattenuto altrove.
La metafora della piazza del mercato è molto adatta anche per i nostri tempi, perché il mercato è il luogo degli affari, dove purtroppo si compra e si vende anche l’affetto e la dignità, cercando di guadagnarci qualcosa. E quando non ci si sente apprezzati, riconosciuti, si rischia persino di svendersi al primo offerente. Il Signore ci ricorda invece che la nostra vita vale, e il suo desiderio è di aiutarci a scoprirlo.
Anche nella parabola che oggi commentiamo ci sono degli operai in attesa di qualcuno che li prenda a giornata. Siamo nel capitolo 20 del Vangelo di Matteo e anche qui troviamo un personaggio che ha un comportamento insolito, che stupisce e interroga. È il padrone di una vigna, il quale esce di persona per andare a cercare i suoi operai. Evidentemente vuole stabilire con loro un rapporto personale.
Come dicevo, si tratta di una parabola che dà speranza, perché ci dice che questo padrone esce più volte per andare a cercare chi aspetta di dare un senso alla sua vita. Il padrone esce subito all’alba e poi, ogni tre ore, torna a cercare operai da mandare nella sua vigna. Seguendo questa scansione, dopo essere uscito alle tre del pomeriggio, non ci sarebbe più ragione di uscire ancora, perché la giornata lavorativa terminava alle sei.
Questo padrone instancabile, che vuole a tutti i costi dare valore alla vita di ciascuno di noi, esce invece anche alle cinque. Gli operai che erano rimasti sulla piazza del mercato avevano probabilmente perso ogni speranza. Quella giornata era andata a vuoto. E invece qualcuno ha creduto ancora in loro. Che senso ha prendere degli operai solo per l’ultima ora della giornata di lavoro? Che senso ha andare a lavorare solo per un’ora? Eppure, anche quando ci sembra di poter fare poco nella vita, ne vale sempre la pena. C’è sempre la possibilità di trovare un senso, perché Dio ama la nostra vita.
Ed ecco che l’originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Con i primi operai, quelli che vanno nella vigna all’alba, il padrone si era accordato per un denaro, che era il costo tipico di una giornata di lavoro. Agli altri dice che darà loro quello che è giusto. Ed è proprio qui che la parabola torna a provocarci: che cosa è giusto? Per il padrone della vigna, cioè per Dio, è giusto che ognuno abbia ciò che è necessario per vivere. Lui ha chiamato i lavoratori personalmente, conosce la loro dignità e in base ad essa vuole pagarli. E dà a tutti un denaro.
Il racconto dice che gli operai della prima ora rimangono delusi: non riescono a vedere la bellezza del gesto del padrone, che non è stato ingiusto, ma semplicemente generoso, non ha guardato solo al merito, ma anche al bisogno. Dio vuole dare a tutti il suo Regno, cioè la vita piena, eterna e felice. E così fa Gesù con noi: non fa graduatorie, a chi gli apre il cuore dona tutto Sé stesso.
Alla luce di questa parabola, il cristiano di oggi potrebbe essere preso dalla tentazione di pensare: “Perché cominciare a lavorare subito? Se la remunerazione è la stessa, perché lavorare di più?”. A questi dubbi Sant’Agostino rispondeva così: «Perché dunque ritardi a seguire chi ti chiama, mentre sei sicuro del compenso ma incerto del giorno? Bada di non togliere a te stesso, a causa del tuo differire, ciò ch’egli ti darà in base alla sua promessa». [1]
Vorrei dire, specialmente ai giovani, di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Non rimandare, rimboccati le maniche, perché il Signore è generoso e non sarai deluso! Lavorando nella sua vigna, troverai una risposta a quella domanda profonda che porti dentro di te: che senso ha la mia vita?
Cari fratelli e sorelle, non scoraggiamoci! Anche nei momenti bui della vita, quando il tempo passa senza darci le risposte che cerchiamo, chiediamo al Signore che esca ancora e che ci raggiunga là dove lo stiamo aspettando. Il Signore è generoso e verrà presto!
[1] Discorso 87, 6, 8 .

Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. II. La vita di Gesù. Le parabole. 7. Il samaritano. Passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione (Lc 10,33b). 28 maggio 2025.
Papa Leone XIV
Cari fratelli e sorelle,
continuiamo a meditare su alcune parabole del Vangelo che sono un’occasione per cambiare prospettiva e aprirci alla speranza. La mancanza di speranza, a volte, è dovuta al fatto che ci fissiamo su un certo modo rigido e chiuso di vedere le cose, e le parabole ci aiutano a guardarle da un altro punto di vista.
Oggi vorrei parlarvi di una persona esperta, preparata, un dottore della Legge, che ha bisogno però di cambiare prospettiva, perché è concentrato su sé stesso e non si accorge degli altri (cfr Lc 10,25-37). Egli infatti interroga Gesù sul modo in cui si “eredita” la vita eterna, usando un’espressione che la intende come un diritto inequivocabile. Ma dietro questa domanda si nasconde forse proprio un bisogno di attenzione: l’unica parola su cui chiede spiegazioni a Gesù è il termine “prossimo”, che letteralmente vuol dire colui che è vicino.
Per questo Gesù racconta una parabola che è un cammino per trasformare quella domanda, per passare dal chi mi vuole bene? al chi ha voluto bene? La prima è una domanda immatura, la seconda è la domanda dell’adulto che ha compreso il senso della sua vita. La prima domanda è quella che pronunciamo quando ci mettiamo nell’angolo e aspettiamo, la seconda è quella che ci spinge a metterci in cammino.
La parabola che Gesù racconta ha, infatti, come scenario proprio una strada, ed è una strada difficile e impervia, come la vita. È la strada percorsa da un uomo che scende da Gerusalemme, la città sul monte, a Gerico, la città sotto il livello del mare. È un’immagine che già prelude a ciò che potrebbe succedere: accade infatti che quell’uomo viene assalito, bastonato, derubato e lasciato mezzo morto. È l’esperienza che capita quando le situazioni, le persone, a volte persino quelli di cui ci siamo fidati, ci tolgono tutto e ci lasciano in mezzo alla strada.
La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo. Ci troviamo davanti all’altro, davanti alla sua fragilità e alla sua debolezza e possiamo decidere cosa fare: prendercene cura o fare finta di niente. Un sacerdote e un levita scendono per quella medesima strada. Sono persone che prestano servizio nel Tempio di Gerusalemme, che abitano nello spazio sacro. Eppure, la pratica del culto non porta automaticamente ad essere compassionevoli. Infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità! Prima di essere credenti, siamo chiamati a essere umani.
Possiamo immaginare che, dopo essere rimasti a lungo a Gerusalemme, quel sacerdote e quel levita abbiano fretta di tornare a casa. È proprio la fretta, così presente nella nostra vita, che molte volte ci impedisce di provare compassione. Chi pensa che il proprio viaggio debba avere la priorità, non è disposto a fermarsi per un altro.
Ma ecco che arriva qualcuno che effettivamente è capace di fermarsi: è un samaritano, uno quindi che appartiene a un popolo disprezzato (cfr 2Re 17). Nel suo caso, il testo non precisa la direzione, ma dice solo che era in viaggio. La religiosità qui non c’entra. Questo samaritano si ferma semplicemente perché è un uomo davanti a un altro uomo che ha bisogno di aiuto.
La compassione si esprime attraverso gesti concreti. L’evangelista Luca indugia sulle azioni del samaritano, che noi chiamiamo “buono”, ma che nel testo è semplicemente una persona: il samaritano si fa vicino, perché se vuoi aiutare qualcuno non puoi pensare di tenerti a distanza, ti devi coinvolgere, sporcare, forse contaminare; gli fascia le ferite dopo averle pulite con olio e vino; lo carica sulla sua cavalcatura, cioè se ne fa carico, perché si aiuta veramente se si è disposti a sentire il peso del dolore dell’altro; lo porta in un albergo dove spende dei soldi, “due denari”, più o meno due giornate di lavoro; e si impegna a tornare ed eventualmente a pagare ancora, perché l’altro non è un pacco da consegnare, ma qualcuno di cui prendersi cura.
Cari fratelli e sorelle, quando anche noi saremo capaci di interrompere il nostro viaggio e di avere compassione? Quando avremo capito che quell’uomo ferito lungo la strada rappresenta ognuno di noi. E allora la memoria di tutte le volte in cui Gesù si è fermato per prendersi cura di noi ci renderà più capaci di compassione.
Preghiamo, dunque, affinché possiamo crescere in umanità, così che le nostre relazioni siano più vere e più ricche di compassione. Chiediamo al Cuore di Cristo la grazia di avere sempre di più i suoi stessi sentimenti.

Ciclo di Catechesi – Giubileo 2025. Gesù Cristo nostra speranza. II. La vita di Gesù. Le parabole. 6. Il seminatore. Egli parlò loro di molte cose con parabole (Mt 13,3a). 21 maggio 2025
Papa Leone XIV
Cari fratelli e sorelle,
Sono lieto di accogliervi in questa mia prima Udienza generale. Riprendo oggi il ciclo di catechesi giubilari, sul tema «Gesù Cristo Nostra Speranza», iniziate da Papa Francesco.
Continuiamo oggi a meditare sulle parabole di Gesù, che ci aiutano a ritrovare la speranza, perché ci mostrano come Dio opera nella storia. Oggi vorrei fermarmi su una parabola un po’ particolare, perché si tratta di una specie di introduzione a tutte le parabole. Mi riferisco a quella del seminatore (cfr Mt 13,1-17). In un certo senso, in questo racconto possiamo riconoscere il modo di comunicare di Gesù, che ha tanto da insegnarci per l’annuncio del Vangelo oggi.
Ogni parabola racconta una storia che è presa dalla vita di tutti i giorni, eppure vuole dirci qualcosa in più, ci rimanda a un significato più profondo. La parabola fa nascere in noi delle domande, ci invita a non fermarci all’apparenza. Davanti alla storia che viene raccontata o all’immagine che mi viene consegnata, posso chiedermi: dove sono io in questa storia? Cosa dice questa immagine alla mia vita? Il termine parabola viene infatti dal verbo greco paraballein, che vuol dire gettare innanzi. La parabola mi getta davanti una parola che mi provoca e mi spinge a interrogarmi.
La parabola del seminatore parla proprio della dinamica della parola di Dio e degli effetti che essa produce. Infatti, ogni parola del Vangelo è come un seme che viene gettato nel terreno della nostra vita. Molte volte Gesù utilizza l’immagine del seme, con diversi significati. Nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, la parabola del seminatore introduce una serie di altre piccole parabole, alcune delle quali parlano proprio di ciò che avviene nel terreno: il grano e la zizzania, il granellino di senape, il tesoro nascosto nel campo. Cos’è dunque questo terreno? È il nostro cuore, ma è anche il mondo, la comunità, la Chiesa. La parola di Dio, infatti, feconda e provoca ogni realtà.
All’inizio, vediamo Gesù che esce di casa e intorno a Lui si raduna una grande folla (cfr Mt 13,1). La sua parola affascina e incuriosisce. Tra la gente ci sono ovviamente tante situazioni differenti. La parola di Gesù è per tutti, ma opera in ciascuno in modo diverso. Questo contesto ci permette di capire meglio il senso della parabola.
Un seminatore, alquanto originale, esce a seminare, ma non si preoccupa di dove cade il seme. Getta i semi anche là dove è improbabile che portino frutto: sulla strada, tra i sassi, in mezzo ai rovi. Questo atteggiamento stupisce chi ascolta e induce a domandarsi: come mai?
Noi siamo abituati a calcolare le cose – e a volte è necessario –, ma questo non vale nell’amore! Il modo in cui questo seminatore “sprecone” getta il seme è un’immagine del modo in cui Dio ci ama. È vero infatti che il destino del seme dipende anche dal modo in cui il terreno lo accoglie e dalla situazione in cui si trova, ma anzitutto in questa parabola Gesù ci dice che Dio getta il seme della sua parola su ogni tipo di terreno, cioè in qualunque nostra situazione: a volte siamo più superficiali e distratti, a volte ci lasciamo prendere dall’entusiasmo, a volte siamo oppressi dalle preoccupazioni della vita, ma ci sono anche i momenti in cui siamo disponibili e accoglienti. Dio è fiducioso e spera che prima o poi il seme fiorisca. Egli ci ama così: non aspetta che diventiamo il terreno migliore, ci dona sempre generosamente la sua parola. Forse proprio vedendo che Lui si fida di noi, nascerà in noi il desiderio di essere un terreno migliore. Questa è la speranza, fondata sulla roccia della generosità e della misericordia di Dio.
Raccontando il modo in cui il seme porta frutto, Gesù sta parlando anche della sua vita. Gesù è la Parola, è il Seme. E il seme, per portare frutto, deve morire. Allora, questa parabola ci dice che Dio è pronto a “sprecare” per noi e che Gesù è disposto a morire per trasformare la nostra vita.
Ho in mente quel bellissimo dipinto di Van Gogh: Il seminatore al tramonto. Quell’immagine del seminatore sotto il sole cocente mi parla anche della fatica del contadino. E mi colpisce che, alle spalle del seminatore, Van Gogh ha rappresentato il grano già maturo. Mi sembra proprio un’immagine di speranza: in un modo o nell’altro, il seme ha portato frutto. Non sappiamo bene come, ma è così. Al centro della scena, però, non c’è il seminatore, che sta di lato, ma tutto il dipinto è dominato dall’immagine del sole, forse per ricordarci che è Dio a muovere la storia, anche se talvolta ci sembra assente o distante. È il sole che scalda le zolle della terra e fa maturare il seme.
Cari fratelli e sorelle, in quale situazione della vita oggi la parola di Dio ci sta raggiungendo? Chiediamo al Signore la grazia di accogliere sempre questo seme che è la sua parola. E se ci accorgessimo di non essere un terreno fecondo, non scoraggiamoci, ma chiediamo a Lui di lavorarci ancora per farci diventare un terreno migliore.
La Confederazione dei Canonici Regolari di San Agostino è stata costituita nel 1959, in occasione del 900° anniversario del Sinodo del Laterano IV (1059) e approvata da un breve apostolico del Santo Papa Giovanni XXIII “Caritatis unitas” del 4 maggio 1959.
Ogni Congregazione rimane autonoma, ma quello che ci unisce è la Regola di Sant’Agostino e lo stesso carisma, vissuto nei differenti paesi del mondo intero. Lo scopo della Confederazione è di rinforzare i legami tra le Congregazioni, di scambio di esperienze e di aumentare l’amore fraterno tra i Confratelli.
La Confederazione è presieduta da un Abate Primate, eletto per un solo mandato che dura sei anni. L’Abate Primate non ha giurisdizione sulle diverse Congregazione: è un titolo onorifico dato a un canonico che è segno rappresentativo della nostra unità.
Nove Congregazioni
Attualmente, la Confederazione dei Canonici di Sant’Agostino è composta da nove Congregazioni :
Canonici Regolari del Santissimo Salvatore Lateranense
Canonici Regolari della Congregazione Lateranense Austriaca
Canonici Regolari della Congregazione Svizzera di San Maurizio di Agauno
Canonici Regolari della Congregazione Ospedaliera del Gran San Bernardo
Canonici Regolari della Congregazione di Windesheim
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione
Canonici Regolari di Maria Madre del Redentore
Canonici Regolari della Congregazione dei Fratelli della Vita Commune
Canonici Regolari della Congregazione di San Vittore
Chi sono gli agostiniani, i “frati della carità” dell’ordine a cui appartiene Papa Leone XIV
Robert Francis Prevost è stato a capo dell’ordine degli agostiniani dal 2001 al 2013.
L’americano è il primo papa agostiniano della storia
“Sono un figlio di Sant’Agostino, un agostiniano”: si è presentato così al mondo intero il nuovo Pontefice, Leone XIV, il primo papa agostiniano della storia. È stato priore generale dell’ordine che si ispira a Sant’Agostino di Ippona, uno tra i grandi padri della Chiesa, dal 2001 al 2013. La sua opera più famosa sono le Confessioni, la sua frasi più famosa, così viene tradizionalmente riportata, è “Ama e fa ciò che vuoi”.
L’Ordine di Sant’Agostino è una delle famiglie religiose più antiche della Chiesa. Nasce nel marzo 1244, quando papa Innocenzo IV promuove l’unificazione di diversi gruppi di eremiti già ispirati alla Regola di Sant’Agostino. Non è stato quindi Sant’Agostino di Ippona, a fondare l’ordine ma è a lui e alla sua Regola che si ispira la dottrina degli agostiniani.
Nel 1256 papa Alessandro IV istituisce ufficialmente l’Ordine, fornendogli anche di un’organizzazione centralizzata e riconosciuta. Intorno al 388/389 Sant’Agostino ritornò a Tagaste (oggi Souk Ahras in Algeria) dopo la conversione avvenuta a Milano. Lì iniziò a fare vita comune, nella povertà, nella preghiera e nello studio, insieme ad alcuni compagni. A Ippona divenne presbitero e cominciò la sua vita in comune con alcuni compagni in un monastero da lui fondato. In questo periodo Agostino scrisse la Regola. Tra le indicazioni che si trovano nella Regola troviamo vivere insieme, in comunità, nella condivisione dei beni, nella povertà volontaria e nella ricerca costante della verità attraverso lo studio, la preghiera e il servizio.
Gli Agostiniani conobbero la loro massima espansione a partire dal '500, in coincidenza con la fioritura dell'Umanesimo. Nel'700 invece, quando l'imperatore asburgico Giuseppe II soppresse numerosi monasteri agostiniani e ne sequestrò i beni, l'ordine visse un periodo di decadenza. La rinascita, a partire dalla seconda metà del secolo successivo fu sostenuta come detto da papa Leone XIII.
Tratto distintivo dell’Ordine è l’equilibrio tra vita comunitaria, studio e missione, che si rispecchia nel motto “Charitas et Scientia” (Carità e conoscenza).
La devozione a Maria e la dedizione agli studi sono tra le caratteristiche degli Agostiniani. L'approfondimento della filosofia e la teologia sono la loro «eredità» culturale, assieme all'attività missionaria ed educativa. Tra le figure più celebri appartenute all'ordine c'è Martin Lutero, che prima dello strappo con la Chiesa di Roma fu frate agostiniano. Anche Gregor Mendel, abate nato in Boemia, considerato il padre della genetica moderna, apparteneva all'ordine.
Gi agostiniani: “Uno di noi, sarà pontificato di pace”
Non riesce a trattenere la gioia fra' Cristian Melcangi, sacrista della basilica di Sant'Agostino a Roma. La notizia del nuovo Papa Leone XIV, agostiniano, ha colto di sorpresa l'ordine, generando un clima di felicità doppia: perché la Chiesa ha una nuova guida e perché questa guida viene dall'ordine di Sant'Agostino. "Non ce lo aspettavamo, è un motivo di gioia per noi - dice con voce ancora rotta dall'emozione Melcangi - Credo sarà un pontificato di pace”.

La scelta. Il giglio e il cuore trafitto sul libro: cosa significa lo stemma di Leone XIV
Il giglio per la purezza, il cuore a ricordo della conversione di sant'Agostino
Papa Leone XIV ha scelto il suo stemma papale. In realtà si tratta della conferma - almeno nella iconografia dello scudo - dello stessa che il cardinale Robert Francis Prevost aveva scelto come stemma episcopale. A cambiare è solo la parte esterna, dove al posto del galero vescovile compare la mitra papale. Inoltre compaiono le chiavi del Regno.
Nello scudo papale lo spazio è diviso diagonalmente in due settori. In alto a sinistra sullo sfondo di colore azzurro è raffigurato un giglio bianco.
Questo simbolo è associato alla purezza e alla verginità e richiama la figura della Madonna. Nell’altra parte in basso allo scudo su sfondo chiaro è rappresentata una immagine che ricorda lo stemma degli agostiniani: un cuore trafitto da una freccia posto sopra un libro.
È il ricordo della conversione di sant’Agostino che ricorda come la Parola di Dio gli abbia trafitto il cuore portandolo alla conversione. Come il suo predecessore, anche Leone XIV ha deciso di mantenere il motto episcopale: “In Illo uno unum” (Nell’unico Cristo siamo uno) tratto dall’Esposizione sul Salmo 127 di sant’Agostino.
fonte:Avvenire

Dopo i giorni del dolore e della gioia corriamo ad annunciare il Vangelo
Maurizio Patriciello
«Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze... ». Nessuno è escluso dal banchetto. Milioni di occhi di uomini, donne, bambini guardavano, giovedì sera, verso il balcone da dove ti saresti affacciato. Una strana, incomprensibile, allegra frenesia aleggiava nell’aria. Non ti conoscevamo e già ti amavamo. Non sapevamo ancora con quale nome avremmo dovuto chiamarti e già ti sentivamo nostro. Una domanda sembrava riecheggiare tra le persone in attesa: «Chi cercate?» Domanda facile alla quale ci siamo accorti di non saper rispondere adeguatamente. Perché vi accalcate? Perché avete invaso Roma? Perché in ogni angolo del mondo ve ne state incollati alla televisione, al computer, al telefonino?
Sei apparso. Un boato. Una vera esplosione di gioia. Tu, Leone, meglio di chiunque, sai di chi ha davvero bisogno la gente. È Gesù che cerca. È dell’acqua che zampilla dalla sorgente del suo costato che ha sete. Tu – mica ti offendi se un povero prete osa dirti queste cose? – tu, come tutti noi mortali, sei solo un pretesto, lo specchio da fissare per poterlo meglio vedere. «Dove abiti?» gli chiesero, due millenni orsono, Andrea e Giovanni. «Venite e vedete» rispose. Andarono, si fermarono da lui, chiacchierarono, forse mangiarono qualcosa insieme. Un’esperienza da augurare a tutti. Erano le quattro del pomeriggio, un’ora che rimarrà scolpita nei loro cuori. E, senza indugiare, divennero missionari, corsero da Pietro e gli raccontarono, inciampando sulle parole, di aver incontrato il Messia; poi lo condussero da lui. Un incontro memorabile che cambiò le loro vite.
Proprio come il tuo predecessore, eri emozionato, l’altra sera, fratello Papa. Ci hai donato la pace, ci hai incitato a non avere paura, a non stancarci di costruire i ponti per accorciare le distanze tra i popoli. Hai, poi, voluto ricordare a te stesso e a noi le parole del Battista: «Lui deve crescere io diminuire». La stessa convinzione di Madre Teresa di Calcutta: «Io sono solo una matita nelle mani di Dio», e di suor Lucia di Fatima: «Io sono solo una scopa». Dopo aver spazzato la casa, la scopa scompare, viene riposta nel ripostiglio, non in salotto. Tutti concordi e con le idee chiare, i santi. Siamo uomini, abbiamo bisogno di toccare, di vedere, di essere accarezzati, di essere guidati, per evitare di cadere nelle trappole camuffate lungo le strade della vita. Andiamo alla ricerca di esperti, di padri spirituali, di maestri e testimoni innamorati di Dio, disinteressati, liberi. Abbiamo bisogno di essere perdonati, compresi, incoraggiati, confermati nella fede. Abbiamo bisogno di te, papa Leone. E tu hai bisogno di noi per essere Chiesa, Corpo di Cristo, Popolo di Dio.
Ci hai chiesto di camminare insieme. “Ut unum sint” pregò Gesù. Che siano una sola cosa. Perché il mondo creda, occorre che i cristiani siano uniti, si vogliano bene, sappiano rinunciare all’orgoglio vanitoso e sciocco che li imprigiona, soprattutto quando si ammanta di falsa spiritualità. Umiltà è la virtù della quale, in ogni tempo, necessitano i credenti. Umiltà che si fa gratitudine, perché tutto ci è stato dato in dono. All’unità, un vero cristiano deve essere disposto a sacrificare tutto, anche le sue idee. Non sempre accade. Non sempre è accaduto. E chi ne ha pagato il prezzo è la Sposa di Cristo, il cui abito, tante volte, è stato macchiato di fango, scandalizzando i piccoli.
Extra omnes. Tacciano i profeti di sventura. Chi ha smarrito la speranza non ha diritto alla parola, il pessimismo è mortalmente contagioso. Risuona, in questi giorni, l’invito di Gesù: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro». La missione alla quale sei stato chiamato, caro padre Leone, farebbe tremare i polsi finanche ai santi e agli scaltri. Lo Spirito Santo ti ha scelto. I fratelli cardinali sono stati solo strumenti – consapevoli, inconsapevoli? – per poterti donare alla Chiesa e al mondo. “Seguimi” ti ha detto, ancora una volta, il Maestro. E tu, come sempre, non hai opposto resistenza. Uniche condizioni per ascendere degnamente alla Cattedra di Pietro: amarlo senza misura, senza calcoli, senza recriminare, senza mai cedere alla rassegnazione, ma lasciandoti guidare dallo Spirito Santo che rovescia i potenti dai troni, innalza gli umili, trasforma il deserto in giardino e i peccatori in santi. «Fate quello che vi dirà», ci disse Maria. «Fate quello che vi dirà» ci ripeti tu. L’umanità ha bisogno di Cristo e della Chiesa che custodisce e annuncia la Parola, consacra il Pane di vita eterna e allarga le braccia ai più poveri tra i poveri.
Georges Bernanos: «La Chiesa dispone della gioia, di tutta la parte di gioia riservata a questo triste mondo. Quello che avete fatto contro di essa, l’avete fatto contro la gioia». Nessuno osi derubare i nostri fratelli e sorelle in umanità di questo immenso dono che è la Chiesa. Nostro dovere è renderla più bella, più luminosa, più accogliente, più attraente, più caritatevole, più santa. Una sposa sempre giovane, perennemente innamorata del suo sposo, a servizio degli uomini. Chiniamo il capo, allora, apriamo il cuore, chiediamo perdono, convertiamoci. Dopo i giorni del dolore per la morte di Francesco e della gioia per il dono di Leone, mettiamoci in cammino. La messe è sempre più grande, tempo per la noia e per le chiacchiere non ne abbiamo. Con la nostra stessa vita corriamo ad annunciare il Vangelo della Vita. È il regalo più bello che possiamo fare a noi stessi, a Dio, al Papa, all’umanità.
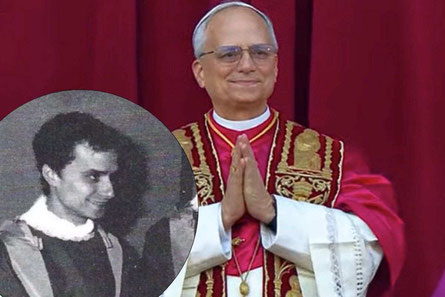
Leone XIV ai giovani: la Chiesa ha tanto bisogno di vocazioni, non abbiate paura!
Nel primo Regina Coeli come vescovo di Roma, che cade nella Domenica del Buon Pastore, il Papa invita a pregare soprattutto per chi è chiamato alla vita sacerdotale e religiosa e che si possa guardare a "modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli". Rilancia l'esortazione del suo predecessore Francesco nel messaggio per la Giornata odierna: accogliere e accompagnare le nuove generazioni. Poi il grazie alle bande musicali che celebrano il loro Giubileo
di Antonella Palermo
È festa. Piazza San Pietro è piena di entusiasmo: pellegrini, turisti, il popolo di Roma di ogni età si riversano laddove il mondo tre giorni fa ha udito l'annuncio del nuovo Papa che oggi ripete quell'affaccio dalla loggia centrale della Basilica e pronuncia, con gioia, il suo primo Regina Coeli. L'affetto espresso dal Successore di Pietro è grande ed esplicito e si indirizza anche alle centinaia di persone riunite nella capitale per il Giubileo delle Bande musicali e degli Spettacoli popolari. È tutto un mosaico di colori con una musica itinerante che già nelle ore precedenti il mezzogiorno si è riversata su via della Conciliazione dopo la Messa celebrata in piazza Cavour. Una coreografia incredibilmente indovinata che ha contagiato di bellezza e letizia. L'impressione è quella di un tessuto geografico multiculturale in cui si intrecciano le piazze di migliaia di borghi, dove viva è la fede popolare e i legami di comunità resistono all'individualismo.
È Cristo che guida la Chiesa
È la Domenica del Buon Pastore, quella in cui la liturgia proclama sempre il Vangelo di Giovanni al capitolo 10, in cui Gesù, come ricorda Leone XIV all'inizio della catechesi, "si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita". Una coincidenza, quella di poter cominciare il servizio come vescovo di Roma proprio in questa ricorrenza, che il Pontefice accoglie come un dono. La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che si celebra oggi, è motivo di ulteriore giubilo e preghiera. Come ha fatto nell'omelia della Messa con i cardinali, all'indomani dell'elezione, lo sguardo a cui il Papa rimanda è a Cristo:
È Lui che guida la Chiesa con il suo Santo Spirito.
I giovani trovino accoglienza e modelli credibili
Leone XIV cita Papa San Gregorio Magno e una sua omelia in cui si evidenzia la corrispondenza del popolo di Dio 'all'amore di chi le ama'. La preghiera del Papa agostiniano, che mai si dissocia da quella del popolo di Dio, è per le vocazioni, "specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa".
La Chiesa ne ha tanto bisogno! Ed è importante che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli.
La richiesta di pastori secondo il "cuore di Dio"
Leone XIV non può che rimandare al Messaggio di Papa Francesco incentrato sull'accoglienza e l'accompagnamento dei giovani. Ed è uno spirito di unità quello con cui si leva dal neoeletto Pontefice l'invocazione a Dio per questa giornata. Ne traspare non tanto un'attenzione ai numeri, quanto un desiderio che la vigna del Signore sia animata da autentici discepoli e discepole:
Chiediamo al Padre celeste di essere gli uni per gli altri, ciascuno in base al proprio stato, pastori “secondo il suo cuore”, capaci di aiutarci a vicenda a camminare nell’amore e nella verità. La Vergine Maria, la cui vita fu tutta una risposta alla chiamata del Signore, ci accompagni sempre nella sequela di Gesù.
Papa Francesco il seminatore di Speranza
"La speranza cristiana non è negazione del dolore, è celebrazione dell’amore di Cristo Risorto che è sempre con noi"
Papa Francesco
Di seguito il link della Santa Sede per trovare documenti, discorsi, encicliche e altri scritti di Papa Francesco
https://www.vatican.va/content/francesco/it.html
In evidenza
Alcune Esortazioni apostoliche
Le Encicliche di Papa Francesco

Il papa in un mondo smarrito
Pierluigi Mele
Il lutto, per la morte improvvisa di papa Francesco, ha attraversato le popolazioni di tutti i continenti. Un fenomeno globale come pochi nella storia contemporanea: solo la morte di papa Wojtila regge il paragone. Ed è una ulteriore dimostrazione di quanto la figura del pontefice romano sia, per la sua missione, una figura universale.
Ogni papa esplicita la sua missione secondo i tempi e il carisma particolare della sua personalità.
In papa Francesco si univano, in una originale sintesi, il carisma di due santi geniali della storia della cristianità: quello di Francesco d’Assisi e di Ignacio de Loyola. Del povero di Assisi ha attualizzato l’attenzione ai dimenticati della storia, e di Ignacio ha attualizzato il carisma del discernimento nella Chiesa e nella società. Per la “maggior gloria di Dio” il discepolo di Ignacio analizza il tempo in cui vive e cerca di sviluppare percorsi di umanizzazione nella storia: la gloria di Dio è l’uomo vivente, come afferma Sant’Ireneo di Lione padre della Chiesa del II secolo. Ora, come ha affermato il vaticanista Marco Politi, Francesco ha afferrato «le paure e le fragilità di centinaia di milioni di uomini e donne di qualsiasi fede e orientamento».
In un mondo smarrito e impaurito, in papa Francesco c’era un invito forte all’umanità a una profonda “conversione”, a un cambiamento radicale di mentalità. I profeti sono dentro la corrente “calda” della storia umana. Sono anticipatori di futuro, di pienezza dell’umanità.
In questo senso, come ci insegna il filosofo tedesco Ernst Bloch, la speranza è nettamente superiore alla paura: è “sogno in avanti”, è “sogno a occhi aperti”. Nel senso, cioè, dell’anticipazione di ciò che non è ancora dato. Ma nulla va dato per scontato, la «speranza è costitutivamente esposta all’incertezza e alla delusione»[1]. La speranza per Bloch è «[…] fattore energetico, mobilitante, entusiasmo fattivo, nell’attesa fervente dell’adempimento»[2]. Insomma, in questo dinamismo della storia umana, la “corrente calda” della profezia ci invita a una incessante lotta di liberazione.
Papa Francesco era inserito in questa “corrente calda”. Il suo magistero aveva una visione alternativa alla “cosmologia” della dominazione: la sua era una “cosmologia” della fraternità della Madre Terra, la nostra Casa Comune. La “cosmologia” della Fraternità Universale era il sogno di Francesco di Roma sulla scia di Francesco d’Assisi e del suo amico teologo francescano Leonardo Boff. È l’alternativa al neoliberismo, al pensiero unico, che ha pervaso l’intero pianeta.
Infatti, il neoliberalismo e il capitalismo, che si reggono sulla competizione e sullo sfruttamento delle risorse della natura, hanno determinato un contrattacco della terra. La specie umana ha fatto una guerra alla natura e la terra ha reagito. Questa è la dinamica secondo Leonardo Boff, uno dei” padri” ispiratori della enciclica Laudato si’.
Meno acqua, più calore, diminuzione della biodiversità sono il risultato del sistema dello sfruttamento: così le riserve della terra sono finite. E se non ci sforziamo di diminuire il nostro consumo, la terra continuerà a reagire. Insomma, la sua ecologia integrale, quella del Magistero di Papa Francesco, può ancora ispirare un percorso nuovo per la politica e l’economia planetaria del prossimo futuro. Appunto la politica è la grande arte per la costruzione della “Casa Comune”. Ma, crto, la politica va ripensata nella logica della “Fraternità Umana”.
Nella Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco ci sono lunghe riflessioni sull’economia e sulla politica. Mette in risalto che: «La politica non deve sottomettersi all’economia e non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia» (n. 177). Fa una franca critica al mercato: «Il mercato da solo non risolve tutto come vogliono farci credere nel dogma della fede neoliberista; si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse ricette per qualsiasi sfida che si presenta; il neoliberismo si auto-riproduce come l’unico cammino per risolvere i problemi sociali» (n. 168). E ancora: «La globalizzazione ci ha resi più vicini ma non più fratelli” (n. 12). Essa “crea solo soci ma non fratelli» (n.101).
Così si esplicita la nuova politica o, se volete, la politica autentica: «Il nuovo paradigma della fraternità e dell’amore sociale si dispiega nell’amore nella sua realizzazione pubblica, nella cura dei più fragili, nella cultura dell’incontro e del dialogo, nella politica come tenerezza e gentilezza»[3]. Dal Papa viene un chiaro invito a compiere la rivoluzione della tenerezza.
L’analisi splendida che Papa Francesco svolge nella Fratelli tutti della figura del buon Samaritano è davvero una grande sfida alla politica contemporanea. Scrive al riguardo Leonardo Boff: Mediante la parabola del buon Samaritano, Francesco compie un’analisi rigorosa dei vari personaggi che entrano in scena e li applica all’economia politica, culminando nella domanda: «Con chi ti identifichi, con i feriti per strada, con il sacerdote, il levita o con il forestiero, il samaritano, disprezzato dagli ebrei’? Questa domanda è cruda, diretta e decisiva. A chi di loro assomigli?» (n. 64). Il buon Samaritano si fa modello di amore sociale e politico (n.66)»[4].
Ecco la misura per valutare la bontà della politica, in questo tempo di “cambio di paradigma”, si applica anche qui: «Con chi ti identifichi?». La politica deve ascoltare il grido di dolore degli ultimi, e sappiamo quanto la cattiva politica e la cattiva economia (quella del turbo-capitalismo) hanno devastato i più fragili impoverendo anche la classe media. Così nuove povertà ci sono affacciate nella nostra società. Creando smarrimento e rabbia.
Ecco un esempio luminoso di politica impregnata di fraternità evangelica, capace di diventare amore politico. Non è utopia questa. Nella storia del cattolicesimo politico italiano c’è chi ha percorso questa strada. Mi riferisco a Giorgio La Pira, indimenticabile “Sindaco Santo” di Firenze. Ai tempi della Guerra Fredda è stato un uomo del dialogo, costruttore di ponti tra le religioni, attentissimo alle questioni sociali.
Scriveva, durante una crisi economica che aveva colpito la sua città: «Non posso essere indifferente […] che i miei fratelli siano costretti a vivere in un regime economico che contraddice la loro natura di uomini. O se i miei fratelli sono costretti a vivere in un regime giuridico e politico che viola i loro fondamentali diritti umani […]. Posso restare inerte di fronte alle disuguaglianze? […] Se facessi così, non negherei quella paternità divina e quella fraternità umana che confesso con le labbra? […] Devo intervenire perché la fraternità, alla quale io credo, sia trascritta nelle istituzioni sociali, diventi fraternità di fatto»[5]. «Bisogna unire le città per unire le nazioni, per unire il mondo»[6].
Un altro esempio richiamato dal Papa è quello di Charles de Foucauld, “piccolo fratello di Gesù”: nel deserto del Nord Africa, insieme alla popolazione musulmana, egli voleva essere «definitivamente il fratello universale» (n. 287). Charles de Foucauld è stato, non va dimenticato, l’ispiratore del grande studioso francese dell’Islam, Luis Massignon. Nella sua esperienza umana e spirituale, Massignon è stato il precursore del dialogo tra Islam e Cristianesimo; senza di lui il dialogo abramitico con l’Islam non sarebbe mai cominciato. Anche lui è un fratello universale.
Ho richiamato questa corrente calda del cattolicesimo contemporaneo, a cui appartiene Papa Francesco. Una corrente che ha suscitato nel Novecento il Concilio vaticano II, che ha segnato una svolta per la Chiesa cattolica. Si potrebbe, allora, dire che tutto il magistero di Francesco è un’autentica declinazione del verbo del Concilio.
Papa Francesco è stato l’uomo dell’ascolto dei poveri e degli ultimi e per questo è diventato fratello di tutti, fratello universale. «Che Dio ispiri questo sogno in ognuno di noi. Amen» (Fratelli tutti n. 288).

"Papa Francesco non è un nome,
ma un progetto della Chiesa e del mondo"
Leonardo Boff
Ogni punto di vista è la visione da un punto, ho affermato una volta. Il mio punto di vista su Papa Francesco è quello di un latinoamericano. Lo stesso Papa Francesco si è presentato come «colui che viene dalla fine del mondo», cioè dall’Argentina, dall’estremo Sud del mondo. Questo fatto non è privo di rilevanza, poiché ci offre una lettura diversa da quella di altri, da altri punti di vista.
La scelta del nome Francisco, senza precedenti, non è casuale. Francesco d’Assisi rappresenta un altro progetto di Chiesa la cui centralità risiedeva nel Gesù storico, povero, amico dei disprezzati e umiliati, come i lebbrosi con i quali andò a vivere. Questa è la prospettiva adottata da Bergoglio quando è stato eletto Papa. Vuole una Chiesa povera per i poveri. Di conseguenza, si spoglia dei paramenti onorari, tradizione degli imperatori romani, ben rappresentata dalla mozzetta, quella mantellina bianca ornata di gioielli, simbolo del potere assoluto degli imperatori e incorporata nei paramenti papali. Lui la rifiuta e la dà alla segretaria come souvenir. Indossa un semplice mantello bianco con la croce di ferro che sempre usava. Visse nella più grande semplicità (il Papa non indossa Prada) e, senza cerimonie, infranse i riti per poter essere vicino ai fedeli. Ciò sicuramente ha scandalizzato molti esponenti della vecchia cristianità europea, abituati alla pompa e alla gloria dei paramenti papali e dei prelati della Chiesa in generale. Vale la pena ricordare che tali tradizioni risalgono agli imperatori romani, ma non hanno nulla a che fare con i poveri artigiani e contadini mediterranei di Nazareth.
Sorprendentemente, egli si presenta in primo luogo come vescovo locale di Roma. Poi come Papa per animare la Chiesa universale e, come lui stesso ha sottolineato, non con il diritto canonico, ma con l’amore.
Ha scelto il nome Francesco perché san Francesco d’Assisi è «l’esempio per eccellenza della cura e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità» (Laudato Sì, n. 10) e che chiamava tutti gli esseri con il dolce nome di fratello e sorella.
Non ha voluto vivere in un palazzo pontificio, ma in una foresteria, Santa Marta. Mangiava in fila come tutti gli altri e, con umorismo, commentava: così è più difficile che mi avvelenino.
La centralità della sua missione era posta sulla preferenza e la cura dei poveri, in particolare dei migranti. Disse onestamente: “Voi europei siete stati lì per primi, avete occupato le loro terre e ricchezze e siete stati ben accolti. Ora loro sono qui e non siete disposti a riceverli”. Con tristezza constata la globalizzazione dell’indifferenza.
Per la prima volta nella storia del papato, Papa Francesco ha ricevuto varie volte i movimenti sociali mondiali. Vedeva in loro la speranza di un futuro per la Terra, perché la trattano con cura, coltivano l’agro-ecologia e vivono una democrazia popolare e partecipativa. Spesso ripeteva loro i diritti che gli sono negati, le famose tre T: Terra, Teto e Trabalho. Devono iniziare da dove si trovano: dalla regione, perché è lì che si può costruire una comunità sostenibile. Con ciò ha legittimato un intero movimento mondiale, il bio-regionalismo, come via per superare lo sfruttamento e l’accumulazione da parte di pochi e garantire una maggiore partecipazione e giustizia sociale per molti.
Fu in questo contesto che ha scritto due straordinarie encicliche: “Laudato Sì: sulla cura della casa comune”, su un’ecologia integrale che coinvolge l’ambiente, la politica, l’economia, la cultura, la vita quotidiana e la spiritualità ecologica. Nell’altra, la “Fratelli tutti”, di fronte al degrado diffuso degli ecosistemi, lanciò il severo monito: «Siamo sulla stessa barca: o ci salviamo tutti o nessuno si salverà» (n. 34). Con questi testi, il Papa si pone in prima linea nel dibattito ecologico mondiale che va oltre la semplice ecologia verde e altre forme di produzione, senza mai mettere in discussione il sistema capitalista che, per sua logica, crea accumulazione da un lato al costo dello sfruttamento della grande maggioranza dall’altro.
Papa Francesco proviene dalla teologia della liberazione della corrente argentina, che sottolinea l’oppressione del popolo e l’esclusione della cultura popolare. Fu discepolo del teologo della liberazione Juan Carlos Scannone, che arrivò a citare in una nota a piè di pagina della Laudato Sì. Già come studente e ispirato da questa teologia, fece una promessa a se stesso: ogni settimana visitare, da solo, le favelas (“vilas miseria“). Entrava nelle case, si informava sui problemi dei poveri e infondeva speranza in tutti. Per anni portò avanti una polemica con il governo che, come politiche dello Stato, faceva assistenzialismo e paternalismo.
Reclamava dicendo: in questo modo i poveri non saranno mai liberati dalla dipendenza. Ciò di cui abbiamo bisogno è la giustizia sociale, radice della vera liberazione dei poveri. In solidarietà con i poveri, viveva in un piccolo appartamento, cucinava il proprio cibo, andava a prendere il suo giornale. Si rifiutava di vivere nel palazzo e di usare l’auto speciale.
Questa ispirazione liberatrice illuminò il modello di Chiesa che egli si proponeva di costruire. Non una Chiesa chiusa come un castello, immaginandola circondata da nemici da tutti i lati, proveniente dalla modernità con le sue conquiste e le sue libertà. A questa Chiesa chiusa egli contrappose una Chiesa in cammino verso i bisogni esistenziali, una Chiesa come ospedale da campo che accoglie tutti i feriti, senza chiedere loro quale sia il loro orientamento sessuale, la loro religione o ideologia: basta che siano esseri umani bisognosi.
Papa Francesco non si presenta come un dottore della fede, ma come un pastore che accompagna i fedeli. Chiede ai pastori di avere l’odore delle pecore, tale è la loro vicinanza e il loro impegno verso i fedeli, esercitando una pastorale di tenerezza e di amore.
Forse nessun papa nella storia della Chiesa ha dimostrato tanto coraggio quanto lui nel criticare il sistema attuale che uccide e produce due feroci ingiustizie: l’ingiustizia ecologica, che devasta gli ecosistemi, e l’ingiustizia sociale, che sfrutta l’umanità fino a versarne il sangue. Mai nella storia si è assistito a una tale accumulazione di ricchezza in poche mani. Otto persone possiedono individualmente più ricchezza di 4,7 miliardi di persone. È un crimine che grida al cielo, offende il Creatore e sacrifica i suoi figli e le sue figlie.
Come un pastore più che come medico, il suo messaggio è fondato soprattutto sulla figura storica di Gesù, amico dei poveri, dei malati, degli emarginati e degli oppressi. Fu assassinato sulla croce attraverso un duplice processo, uno religioso (offese alla religione del tempo per la sua pretesa di sentirsi Figlio di Dio) e l’altro politico, da parte delle forze di occupazione romane.
Non dava molta importanza alle dottrine, ai dogmi e ai riti che aveva sempre rispettato, poiché riconosceva che con tali cose non si raggiunge il cuore umano. Per questo si ha bisogno di amore, di tenerezza e misericordia. Una volta pronunciò una delle frasi più importanti del suo magistero: “Cristo è venuto per insegnarci a vivere: l’amore incondizionato, la solidarietà, la compassione e il perdono, valori che costituiscono il progetto del Padre che è il nucleo dell’annuncio di Gesù: il Regno di Dio. Lui preferiva un ateo sensibile alla giustizia sociale rispetto a un credente che frequenta la chiesa ma non ha alcun riguardo per il prossimo che soffre.
Un tema ricorrente nelle sue prediche è quello della misericordia. Per Papa Francesco la misericordia è essenziale. La condanna è solo per questo mondo. Dio non può perdere nessun figlio o figlia che ha creato nell’amore. La misericordia vince la giustizia e nessuno può porre limiti alla misericordia divina. Metteva in guardia i predicatori da ciò che era stato fatto per secoli: predicare la paura e instillare il terrore dell’inferno. Tutti, indipendentemente da quanto siano stati malvagi, sono sotto l’arcobaleno della grazia e della misericordia divina.
Logicamente, non tutto vale la pena in questo mondo. Ma coloro che hanno vissuto sacrificando altre vite, preoccupandosi poco di Dio o addirittura negandolo, attraverseranno la clinica di guarigione della grazia, dove riconosceranno le loro azioni malvagie e apprenderanno cosa sono l’amore, il perdono e la misericordia. Solo allora la clinica di Dio, che non è l’anticamera dell’inferno, ma l’anticamera del paradiso, si aprirà affinché anche loro possano partecipare alle promesse divine.
Con il suo appello all’azione a favore dei poveri, con la sua coraggiosa critica all’attuale sistema che produce morte e minaccia le basi ecologiche che sostengono la vita, con il suo amore appassionato e la sua cura per la natura e la Casa Comune, con i suoi instancabili sforzi per mediare le guerre in favore della pace, è emerso come un grande profeta che ha annunciato e denunciato, ma sempre suscitando la speranza che possiamo costruire un mondo diverso e migliore. Grazie a ciò, egli si dimostrò un leader religioso e politico rispettato e ammirato da tutti.
Indimenticabile è l’immagine di un papa che cammina da solo, sotto una leggera pioggia, in piazza San Pietro, verso la cappella della preghiera affinché Dio risparmiasse l’umanità dal coronavirus e avesse pietà dei più vulnerabili.
Papa Francesco ha onorato l’umanità e resterà nella memoria come una persona santa, gentile, premurosa ed estremamente umana. È grazie a figure come queste che Dio ha ancora pietà della nostra malvagità e follia e ci ha tenuti in vita su questo piccolo e meraviglioso pianeta.
Leonardo Boff ha scritto Francesco d’Assisi, Francesco di Roma. Una nuova primavera nella chiesa, Editrice Missionaria Italiana, 2014; La tenerezza di Dio-Abbà e di Gesù, Castelvecchi, 2024

D’Ambrosio: il pontificato delle sorprese
Alberto Bobbio
Alberto Bobbio intervista Rocco D’Ambrosio per L’Eco di Bergamo sul significato del pontificato di Francesco. Rocco D’Ambrosio, sacerdote della diocesi di Bari, è docente di filosofia politica alla Pontificia Università Gregoriana. Riprendiamo dal sito della associazione Cercasi un fine.
Dodici anni di sorprese e ora? Il professor Rocco D’Ambrosio, sacerdote della diocesi di Bari e docente di filosofia politica alla Pontificia Università Gregoriana, ragiona sul Pontificato di Jorge Mario Bergoglio e osserva: «C’è anche un po’ di smarrimento negli occhi e nel cuore di ricorda in queste ore Papa Francesco. Adesso dopo il funerale, in questa domenica, siamo un po’ come i discepoli chiusi nel Cenacolo e abbiamo timore. Bergoglio è stato con i suoi pregi e i suoi difetti un punto di riferimento per tanti dentro e fuori la comunità cattolica».
E dunque cosa bisogna fare?
Non dimenticare uno degli insegnamenti di Papa Francesco. Certo, a noi manca e mancherà la sua presenza fisica, come di tutte le persone che abbiamo amato e non ci sono più. Ma le persone che incontriamo nella nostra vita, dal Papa e chi ci ha fianco ogni giorno, sono doni del Signore. Francesco guardava il volto delle persone, ne toccava la carne, fino a soffrire con loro. Il servizio verso gli altri, sottolineava, non è mai ideologico, non serve le idee, ma le persone.
Come lo esprimeva?
Con i gesti dal primo, cioè il rifiuto della mantellina rossa quando si è affacciato per la prima volta alla Loggia delle Benedizioni dodici anni fa, fino all’ultimo la domenica di Pasqua quando è andato in Piazza per salutare le persone nonostante le sue condizioni di salute. La sorpresa è stata la cifra del suo Pontificato.
Cosa ha cambiato dal punto di vista dottrinale?
Contrariamente a quanto raccontano i suoi detrattori non ha detto nulla di nuovo. Ha dato piena attuazione al Concilio Vaticano II senza citarlo troppo, attuazione implicita. La sua posizione, che per molti è un’ossessione, contro i fabbricanti di armi è quella della Gaudium et Spes.
È stato anche un Pontificato politico?
Sì. Nelle encicliche anche in termini molto espliciti c’è sempre una parte in cui lui si riferisce alla comunità politica, altra frase del Concilio, e all’autorità politica. Dal suo punto di vista interno è stato il Pontificato più lontano dall’idea di un Papa re, per dirla con una battuta storica: gesti, simboli, luoghi e anche il funerale, come quello di un semplice cristiano.
La politica è quella che ha dato poco seguito ai suoi inviti a cambiare?
Vedremo. Al funerale c’erano tutti. Ho avuto l’impressione che nessuno volesse mancare in questo clima mondiale, in un contrappunto tra presenzialismo e fede. Non mettono in pratica, perché quello che chiedeva Papa Francesco non è molto facile, anche se in fondo è solo quello che dice il Vangelo. Anche al suo funerale ha continuato a parlare con molta franchezza, libertà e non servendo nessun padrone se non Dio. Lo ha ricordato il card. Giovanni Battista Re nell’omelia, scegliendo tra i punti centrali della missione di Bergoglio quelli che più danno fastidio a molti dei leader presenti.
Sul potere dentro la Chiesa cosa ha cambiato Francesco?
L’intuizione di procedere attraverso la sinodalità è stata eccezionale. Il Sinodo in termini laici è la revisione dei processi di governance, intuizione geniale, ma non affatto nuova. Già il Concilio Vaticano II aveva sollecitato a cambiare l’immagine della Chiesa piramidale. Se c’è stato un limite, secondo me, è che il Papa a volte in termini di governo non è stato abbastanza chiaro sulle norme e i regolamenti, creando un po’ di confusione. E gli oppositori ne hanno approfittato.
E ora? Chiudere i processi o continuare a consolidarli?
I processi quando iniziano a radicarsi è difficile estirparli dalle radici.
Un esempio?
La Messa in latino. I precedenti Pontefici hanno mostrato più tolleranza con vari decreti. Bergoglio ha detto una parola chiara: basta. Con Bergoglio sono finiti gli anni di tolleranza delle istanze pre-conciliari sulla liturgia.
Su cosa non si potrà tornare indietro?
Sul dialogo ecumenico e interreligioso e anche sul dialogo con il mondo. Bergoglio ha aperto ogni finestra possibile e sarà impossibile chiuderle.
Il pluralismo è stato uno dei punti qualificanti del Pontificato?
Sì. Se si ritiene che la Chiesa cattolica non sia l’unica religione e il suo stile l’unico ammesso, il Pontificato di Bergoglio ha assunto il pluralismo come archetipo. Francesco si è tenuto lontano dal metodo dello scontro tra modernismo e anti-modernismo della Chiesa dell’Ottocento. È andato a vedere le carte di ciò che è moderno, secondo il metodo conciliare della Gaudium et spes: l’autonomia delle realtà temporali può essere secondo Dio o contro Dio. Tornare indietro rispetto al Concilio non si può. Ma dobbiamo distinguere contenuti dalla prassi. Le scelte pratiche di un Papa sono anche il frutto della sua sensibilità, della sua cultura, della sua storia personale.
Insomma ogni Papa è diverso, ma dovrà restare la continuità con il Concilio. Oggi vedo, dopo appena una settimana dalla morte, il tentativo di normalizzare Bergoglio, un’operazione ambigua dentro e fuori la Chiesa. Certamente il Papa, come tutti i Papi, ha fatto errori, perché governare la Chiesa è difficilissimo. Ma qualcuno sta usando quegli errori per denigrare la persona. Francesco invece ha detto cose profetiche e non solo durante la pandemia, che resteranno nella storia della Chiesa e non sarà un piccolo errore di governo ad offuscare la sua grandezza. Chi lo critica non ama la Chiesa, perché ha portato la critica sui giornali. Invece il Vangelo chiede, se vedi che tuo fratello sta sbagliando, di rimproverarlo nel segreto. Chi non lo ha fatto ora dovrebbe tacere e se lo ho fatto dovrebbe tacere comunque se ama veramente la Chiesa.

In ricordo di lui
Heiner Wilmer
Ci sono parole che riassumono una vita. Ci sono vite che, pur complesse e sfaccettate, riescono a farsi riassumere in una parola – quando questo accade, tocchiamo il mistero profondo di una persona: la sua lotta, la sua speranza, la sua eredità. Per papa Francesco, questa parola è misericordia.
Ben prima di essere il fulcro del suo ministero, misericordia è stata per Jorge Maria Bergoglio un’esperienza: l’essere toccati dal palpito del cuore di Dio e il lasciarsi toccare dalla sua dedizione senza misura.
Fedele all’esperienza di un Dio che è misericordia
Bergoglio si è sentito guardato con misericordia da Dio ed è così che egli, da gesuita, vescovo e papa, ha guardato al mondo – amato senza limiti dal Dio che si fa corpo, carne, storia nel vissuto di Gesù. Quando si è toccati dalla misericordia di Dio, questa ti entra nelle ossa, fa corpo unico con la tua esistenza. Così è stato di papa Francesco, che è rimasto fedele a questa esperienza di Dio anche quando si è ritrovato a doversi vestire di bianco. La solennità del ministero assunto per la Chiesa e per il mondo non ha scalfito in nulla la tenerezza con cui quel Dio gli chiedeva di guardare e toccare la gente.
Il primo viaggio di papa Francesco lo ha portato a Lampedusa – perché lì lo spingeva il suo essere ministro di un Dio misericordioso. È andato in questo luogo, dove la sofferenza dei rifugiati scava ferite visibili nel cuore dell’Europa. Qui Francesco ha messo a nudo la globalizzazione dell’indifferenza, di una logica mondana che produce scarti dell’umano. Qui Francesco ha lanciato il suo monito, volto a destare i cuori assopiti di tutti noi: «Abbiamo disimparato a piangere».
Francesco non ha disimparato a piangere: ha pianto per la guerra in Ucraina; per i bambini di Gaza; per tutti quei frammenti di terza guerra mondiale che si va componendo dai suoi tanti pezzetti. Ha pianto per l’indifferenza dell’umanità. Ma non ha mai smesso di sperare.
Uno di noi
Chiunque l’abbia incontrato ha percepito che era un uomo del popolo, un fratello – non un sovrano. Un vescovo di Roma, non un sommo pontefice. Un papa in sedia a rotelle con un poncho nella basilica di San Pietro, una settimana prima di morire. Un papa che ha ringraziato per essere stato portato fra la gente, fra la sua gente, per benedirla insieme al mondo, il giorno prima di morire.
Un papa solo sotto la pioggia in piazza San Pietro, a pregare e benedire le persone della terra mentre il mondo era fermo per la pandemia. In quella sera, in quel vuoto misterioso, papa Francesco non ha predicato il Vangelo: lo ha incarnato. Da solo. Nella tempesta. Su una barca che rischiava di affondare. E ha detto: «Su questa barca ci siamo tutti».
Questo era il suo stile. Semplice, accessibile, ilare. Uno stile che costruiva ponti, non muri. Così che i tanti fossati che scaviamo tra di noi potessero trasformarsi da luoghi di separazione a cammini di incontro.
Il programma di papa Francesco era chiaro, basato su tre pilastri: misericordia; fratellanza; pace.
Come Gesù
Papa Francesco vedeva la Chiesa come un «ospedale da campo», un luogo di guarigione, un porto a cui tutti potessero approdare anche solo per un attimo. Perché la misericordia non sta chiusa nei palazzi, non si lascia rinchiudere nelle belle parole di libri e documenti, ma va in cerca dell’umano ferito e delle ferite dell’umano. La misericordia è la fede che si lascia guidare dallo Spirito, che non sai di dove viene né dove va – ma ne senti la voce che ti ingiunge di seguirlo.
Desiderava una Chiesa così, docile allo Spirito, errabonda lungo i sentieri delle vite delle persone e lungo i dirupi della storia umana. Per questo ha sottolineato ripetutamente che i sacramenti sono destinati alla cura, alla consolazione, alla riconciliazione – là dove sull’umano ferito spira leggera la brezza dello Spirito.
In nome del Dio che non conosce misura nell’amore, ha spalancato le porte della Chiesa anche a coloro che erano lontani. In nome del Dio che genera alla vita, ha aperto una nuova prospettiva per il creato, per l’ambiente e per la consapevolezza che la questione sociale e quella ecologica sono strettamente intrecciate fra di loro. Il grido dei poveri fa tutt’uno con quello della Madre Terra.
Come Gesù anche noi dovremmo lasciarci toccare dalle preoccupazioni e dai bisogni delle persone. Come Gesù anche noi dovremmo diventare guaritori che fasciano le ferite degli altri.
Come Gesù anche noi dovremmo essere prossimi agli altri, parlare con loro cuore a cuore, essere presenti gli uni per gli altri. Come Gesù anche noi dovremmo essere segno tangibile della vicinanza, tenerezza e coraggio di Dio.
Tutti fratelli e sorelle
Francesco ha parlato della «grande famiglia umana»; e ha impegnato le religioni, cattolicesimo e islam, a essere le cellule della sua edificazione globale. Come vescovo di Roma, ha esortato gli stati europei a prestare maggiore attenzione e impegno verso coloro che cercano protezione abbandonando i loro luoghi natii.
Ha letto la parabola del Buon Samaritano non solo in chiave individuale, ma anche collettiva. Non è solo il singolo che deve prendersi cura del prossimo che giace, percosso, sui margini della strada; anche i popoli forti devono prendersi cura di quelli feriti, sfruttati e oppressi.
A Venezia ha detto: «Il potere non è nelle mani dei grandi di questo mondo, ma nel popolo». È andato in prigione. Ha lavato i piedi ai detenuti. Ha fatto costruire docce per i senza tetto in piazza San Pietro.
Francesco non voleva una Chiesa come istituzione del potere, ma come comunità di dedizione che si prende cura di tutti e tutte – che ha a cuore ogni persona. Una Chiesa che non ha paura di scendere in strada, di sporcarsi col fango della vita umana, che non ha paura di uscire ammaccata dagli incontri con la vita reale della gente.
Voleva una Chiesa in uscita, ascoltatrice della voce dello Spirito e noncurante della destinazione a cui essa la conduce – e non una Chiesa che ruota solo intorno al proprio ombelico, ammaliata dall’immagine speculare di sé.
Shalom
Papa Francesco non ha mai inteso la pace come un semplice ideale, ma come un compito che viene dal profondo, dall’opera dello Spirito Santo. Come nel vangelo di oggi, dove ai discepoli barricati in una stanza per paura, Gesù dice «la pace sia con voi». Ha ripetuto più volte che «lo Spirito è il vero protagonista della Chiesa, noi siamo solo strumenti nelle sue mani».
Per questo ha pregato instancabilmente affinché lo Spirito ci insegni a percorrere vie di dialogo, perché la pace non nasce dai trattati ma dal cuore, dal mettersi l’uno di fronte all’altro ascoltandosi a vicenda, dal silenzio della preghiera.
Quando cadono le bombe, quando i popoli si lacerano, quando regna la violenza, secondo Francesco un pastore non può rimanere in silenzio. Lo Spirito di Dio ci spinge a ribellarci contro la guerra e l’odio, ci spinge a resistere ad oltranza alla violenza, ci spinge a impegnarci per la vita nel e del mondo.
Francesco credeva nella forza dolce ma potente dello Spirito, portatrice di uno scompiglio capace di abbattere tutti i muri: quelli tra i popoli; quelli tra le confessioni; ma anche quelli presenti nei nostri cuori.
Per lui la preghiera per la pace non era una fuga dal mondo, ma una rivoluzione silenziosa, perché lo Spirito vuole la vita non la morte.
E così vedeva per la Chiesa il compito di essere luogo di pace – non attraverso il potere, ma mediante la misericordia, attraverso l’opera dello Spirito che riconosce in ogni persona l’immagine di Dio.
In principio la gioia
Ed ora che la sua vita tra noi è terminata, sentiamo il dovere di gettare lo sguardo a quel principio misterioso che ha attraversato tutto il suo vissuto: la gioia. La gioia che viene dal Vangelo e la gioia per il Vangelo.
Si è detto molto su papa Francesco in questi giorni, ma quasi tutti hanno dimenticato questa dimensione fondamentale della sua fede e del suo ministero di vescovo di Roma. Eppure lui ci è tornato sopra molte volte, dopo avercela fatta assaporare con la sua prima esortazione apostolica Evangelii gaudium.
La gioia non è un sentimento estemporaneo, ma una disposizione fondamentale del cuore che ha incontrato il corpo della dedizione di Dio, che è stato toccato da esso. Quando questo accade, la gioia che salva te la porti in giro appiccicata al tuo corpo ovunque tu vada, come accade per il lebbroso guarito nel vangelo di Marco.
Papa Francesco desiderava una Chiesa la cui fede fosse imbevuta da cima a fondo da quel mistero dei misteri di cui parla Chesterton alla fine del suo libro Ortodossia: «Eppure c’è qualcosa che Gesù ha tenuto per sé. Lo dico con reverenza (…). C’era qualcosa che Egli nascondeva a tutti quando salì sulla montagna a pregare. C’era qualcosa che Egli celava costantemente attraverso improvvisi silenzi o frettolosi isolamenti. C’era una cosa che era troppo grande per Dio per mostrarla a noi mente Egli camminava sulla nostra terra – e io talvolta ho immaginato che fosse la sua gioia ilare».[1]
Una Chiesa per il terzo millennio
Questa gioia evangelica della fede è la forza che dà forma a una Chiesa sinodale – come comunità in cui tutti camminano insieme, non come istituzione di potere dove alcuni decidono dall’alto.
Per papa Francesco il Sinodo non era solo un evento a un incontro, ma uno stile. Lo stile di Gesù: ascoltare, discernere, cercare insieme la via. Essere sinodali significa prendersi sul serio gli uni gli altri, comprendere l’altro come inviato da Dio e scoprire insieme ciò che lo Spirito Santo vuole dirci oggi.
È la forma fondamentale della Chiesa, dice Francesco, perché solo così il popolo di Dio può crescere: nella verità, nella libertà, nella responsabilità – ma, soprattutto, nella gioia di essere cristiani.
Questo è confortante, perché significa che nessuno deve camminare da solo, che la Chiesa può essere un luogo in cui ogni voce conta e viene ascoltata, ogni ferita è vista e viene lenita. Ma ci chiama anche a seguire: cammina insieme a noi. Ascolta. Non chiedere prima: chi ha ragione? Ma, piuttosto: dove ci chiama lo spirito, insieme – mai senza l’altro?
***
Ora papa Francesco se ne è andato. Il lunedì di Pasqua alle 7.35. Nel momento luminoso della nostra fede nella risurrezione. Lui, il papa dei poveri, dei deboli, degli ultimi, proprio di quelli che nessuno vuole: loro erano a casa sua.
E il cerchio di una vita si chiude nel luogo che amava come nessun altro: Santa Maria Maggiore a Roma. Ci andava prima di ogni viaggio. Ci andava per trovare la pace. Per stare con Maria. Lì pregava. Lì piangeva. Lì trovava quel conforto che lo confermava nella gioia della fede. E ora riposa lì in pace.
[1] G.K. Chesterton: Orthodoxy. Christian Calssic Ethereal Library, Grand Rapids (MI), 112.
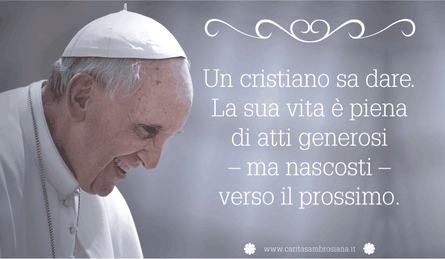
Francesco: parole della gente comune
Riccardo Cristiano
Francesco si è preso dei rischi, ma anche delle libertà: la libertà di un’espressione non calcolata, che poi qualche ufficio avrebbe corretto magari, ma intanto questo stile colloquiale passava, diventava normale. In un comunicazione sempre controllata non si prendono rischi ma tutto diviene più paludato.
Un pontificato non lungo quello di Jorge Mario Bergoglio, ma difficilmente la Chiesa cattolica potrà tornare ad essere quel che è stata prima di lui. In questa realtà nuova c’entra senz’altro il linguaggio di Francesco: un linguaggio rivoluzionario.
Mi attengo soltanto a questo non per dire che i nuovi dovranno parlare come lui, ma per dire che il suo linguaggio ha traghettato la Chiesa in un mondo a lei poco conosciuto, non quello dei teologi, dei dotti, degli esegeti, ma quello delle persone normali; ascoltare il Papa non è più un’impresa per dotti, ai “semplici” non sono più riservati soltanto i gesti. Anche le parole sono rivolte a loro.
Nell’epoca della comunicazione a mezzo social media, cioè in un tempo di rapporto diretto tra chi parla e chi ascolta, tra chi dice e chi recepisce, questo ha una valenza enorme.
Ignari di questo alcuni si sono attardati, ad esempio, a non comprendere i colloqui tra Francesco ed Eugenio Scalfari. Nei suoi resoconti, con aria divertita, qualcuno poteva obiettare che Scalfari commetteva “errori” dottrinali, attribuiva al Papa una parola invece che un’altra: ma quella frase non doveva arrivare ai sacrestani, a catechisti, ma a chi lontano dalla Chiesa a mezzo di una semplificazione forse erronea, o sgrammatica diciamo, poteva così capire la voce del Papa pur non essendo parte del suo mondo di fede, ma interessato alle sue considerazioni sul mondo, sulla vita (e sulla morte).
Dunque la prima novità è stata questo mettere la voce di un romano pontefice nella non perfetta interpretazione “teologica” di un “estraneo” a quel mondo, come tanti di noi.
In questo non c’è alcuna forma di imbroglio, ma una “commistione” di stili e linguaggi, per consentire una reciproca comprensione. Questo rimanendo “nel seminato” ufficiale, bollinato, non si sarebbe potuto ottenere.
Se vogliamo paragonare questo discorso “linguistico” con quello dei gesti, possiamo trovare il corrispettivo con l’apparizione del Papa al Festival di Sanremo. Luogo non certo santo, né aduso alle discussioni sulla patristica, ma momento di svago e di vita vissuta come la gente vuole viverla da milioni di persone, alle quali il Papa si è dunque rivolto, mettendosi sullo schermo di quelle che alcuni saccenti chiamano “canzonette” e anche “soubrette”.
Le risposte a braccio
Guardando più addentro al suo pontificato cogliamo inoltre come Francesco, che non era incline alle interviste prima di diventare pontefice, ha creato anche uno stile espressivo nuovo ed ulteriore, quello del Papa che “ risponde a braccio”.
Durante i voli Papali, ovviamente, i giornalisti erano invitati a presentare le loro domande per il Papa in anticipo e in forma scritta, poi alcune sarebbero stato scelte, magari con qualche “levigatura”. E il Papa aveva il tempo per pensare a cosa dire e non dire. Francesco ha voluto l’intervista senza rete: i giornalisti sul volo Papale hanno potuto chiedere quel che volevano al Papa.
In questo modo Francesco si è preso dei rischi, ma anche delle libertà: la libertà di un’espressione non calcolata, che poi qualche ufficio avrebbe corretto magari, ma intanto questo stile colloquiale passava, diventava normale. In un comunicazione sempre controllata non si prendono rischi, si ovatta il messaggio, lo si rende “compatibile”. Non ci sono rischi, ovviamente, ma tutto diviene più paludato, difficilmente si tratta di un modo di esprimersi che riesce a comunicare.
In alcuni casi questo stile, questo modo di esprimersi è stato decisivo, come quando, parlando in questo linguaggio “informale”, ha detto “chi sono io per giudicare?” . Una frase che è entrata nella storia di questo pontificato.
Ho notato che in tempi recenti, in tutte le interviste che ha dato – a differenze di quanto accade con i testi scritti, il Papa non si è mai riferito all’aborto “dal momento del concepimento”: ha sempre fatto riferimento al momento, soggiungendo che sopraggiunge assai presto, in cui tutti gli organi sono formati. Ha scelto questo come il momento in cui dire che c’è vita umana. Un segnale che non è stato colto?
Alle spalle di questo, se si volesse indagare, c’è tutta una lunga e importantissima scuola teologica, che include San Tommaso, non certo autori minori: se avessi ragione, non lo so, sarebbe un caso di messaggio che il nuovo stile non è riuscito a veicolare, anche per la scarsa volontà di dialogo dell’altro campo, convinto della sua verità.
Vettori insoliti, “esterni”, linguaggio informale: sono due grandi novità di questo pontificato che potrebbero o dovrebbero restare, comunque, nel pontificato che verrà. Si tratti di un “bergogliano” o no, tornare al vecchio sarebbe dannoso.
Ma la novità più profonda e significativa, a mio avviso, è un’altra e quella è un dono che quindi non può costituire un precedente, perché i doni chi non li ha non li può chiedere in prestito: parlo del linguaggio poetico.
Il linguaggio poetico
Il linguaggio poetico di Francesco lo conoscono tutti quelli che lo hanno sentito parlare e sanno che questa era la sua forza comunicativa, quella che svegliava, attraeva, rendeva vivi coloro che lo ascoltavano, scoprendosi così coinvolti anche se non credevano, per la forza vitale che il linguaggio poetico ha.
I neologismi che lui ha introdotto- è famoso il “balconear” per invitare a non fare così, a non limitarsi a osservare lo scorrere della vita dalla finestra, dal balcone di casa- ma anche il “disinstallarsi” riferito non alle app, ma all’azione che la Chiesa dovrebbe compiere per divenire “Chiesa in uscita”, sono espressioni immaginifiche che raggiungono e toccano gli uomini, le donne, i giovani, portando un messaggio importante che non ha bisogno di citazioni che allontanano, facendo sudare l’uditorio, che rimane lontano, diciamo difficilmente coinvolto se non tramite quei “mediatori culturali” che oggi sono ascoltati o seguiti con decrescente attenzione.
Anche le sue figure vere o presunte, come la vecchina che in parrocchia gli ha detto una frase che vuole dire ma semplicemente, tipo “Dio perdona sempre, altrimenti il mondo sarebbe finito da tanto tempo”, ha un senso poetico, perché ci chiede di immaginare la vecchina, la sua “cultura sapienziale”, non universitaria, alta, ma autentica, che ci parla con un’altra saggezza e che così ci dice di più.
Ma il linguaggio propriamente poetico è quello che apre orizzonti, risveglia. Faccio un esempio che mi ha sempre colpito: quando giunse per l’incontro interreligioso a Ur, in Iraq, realizzando il sogno da tanto tempo dei Papi di poter visitare i luoghi d’Abramo in Iraq, il Papa ha detto:
L’Oltre di Dio ci rimanda all’altro del fratello. Ma se vogliamo custodire la fraternità, non possiamo perdere di vista il Cielo. Noi, discendenza di Abramo e rappresentanti di diverse religioni, sentiamo di avere anzitutto questo ruolo: aiutare i nostri fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e la preghiera al Cielo.
Questo linguaggio che dall’oltre giunge all’altro è certamente poetico: possiamo usare le successive parole del Papa per capirlo in termini che riguardano i tre monoteismi, la loro fratellanza nella discendenza comune, ma anche per capire, come faccio io, che l’oltre è sempre tale, non può essere rinchiuso in una sola comprensione, riguarda e unisce le diversità senza omologarle, andando oltre ciascuna di loro.
Forse è per questo che nel testo torna più volte a parlare del cielo:
Gli occhi al cielo non distolsero, ma incoraggiarono Abramo a camminare sulla terra, a intraprendere un viaggio che, attraverso la sua discendenza, avrebbe toccato ogni secolo e latitudine. Ma tutto cominciò da qui, dal Signore che “lo fece uscire da Ur” (cfr Gen 15,7).
Il suo fu dunque un cammino in uscita, che comportò sacrifici: dovette lasciare terra, casa e parentela. Ma, rinunciando alla sua famiglia, divenne padre di una famiglia di popoli.
Anche a noi succede qualcosa di simile: nel cammino, siamo chiamati a lasciare quei legami e attaccamenti che, chiudendoci nei nostri gruppi, ci impediscono di accogliere l’amore sconfinato di Dio e di vedere negli altri dei fratelli. Sì, abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri.
In queste breve e non certo innovativa, o originale, escursione nei linguaggi di Francesco troviamo che il linguaggio esce dal ciclostile della forma nota, sperimenta sistemi idonei all’oggi, accorcia le distanze, come sanno fare solo i veri comunicatori, ma soprattutto porta il Vangelo e la sua predicazione in un tempo che ha modificato profondamente i sistemi di comunicazione.
Anche questo conferma che Francesco, il grande umanista di un tempo spaesato tra i nuovi ismi, come il sovranismo e il populismo, è stato un potente antidoto a queste novità preoccupanti.
Queste parole, il cui esempio più noto in termini di prossimità è il suo presentarsi dicendo “buongiorno”, o “buonasera”, come fa qualsiasi amico, qualsiasi compagno di viaggio, esempio dunque di prossimità che elimina la distanza che si era creata tra il Papa e i fedeli, la gente comune, sono state accompagnate dai suoi gesti più noti e ad esse collegati: abolire gli ori, le limousine, visitare le carceri, o i centri dove si trovano i migranti forzati.
Parola e gesto hanno composto un ritratto nuovo della Chiesa e del Papa vissuto e presentato come essere umano: la riforma più riuscita. Chi volesse smontarla avrà difficoltà a farlo, soprattutto per il linguaggio, che comunque ha dato inizio ad un’epoca ecclesiale nuova.

L'omaggio senza fine a Francesco: «Vi raccontiamo perché siamo qui»
Luca Liverani
24 aprile 2025
Dalla pace alla cura dei fragili, abbiamo raccolto alcune voci de più di 50mila fedeli che hanno voluto sostare in San Pietro davanti alla salma nelle prime 24 ore. «È stato il Papa dell'umiltà»
Non si è fermato nemmeno nella notte l'immenso afflusso di fedeli in fila per rendere omaggio a papa Francesco, la cui salma è esposta nella basilica di San Pietro. Stamattina la coda raggiunge i due chilometri di lunghezza e va da piazza Risorgimento a Porta Angelica. La coda, che comincia in piazza, fa diverse curve prima di arrivare in via di Porta Angelica dove le persone poi si incolonnano tra le transenne. Contrariamente a quanto previsto, ieri sera la basilica è rimasta aperta a oltranza dopo la mezzanotte: è stata chiusa alle 5.30 per poi essere riaperta alle 7, secondo il programma diffuso nei giorni scorsi. E secondo i media vaticani dalle 11 di ieri alle 11 di questa mattina, più di 50mila persone hanno reso omaggio ai Papa.
«Semplice. Diretto. Controcorrente. Coraggioso. Sorprendente. Spiritoso. Umano. Universale. Santo»: eccoli, gli aggettivi che ricorrono nelle parole di chi si è messo in fila per l'ultimo saluto a Francesco. E c’è veramente gente di tutti i tipi in questo brulichio di umanità che comincia a piazza Pia, si snoda lungo via della Conciliazione e si intruppa paziente nel serpentone che attraversa piazza San Pietro e arriva alla Basilica. Per vederlo, per salutarlo, per ringraziarlo, per pregarlo.
Ragazzi col Tau al collo, anziane col bastone, famiglie con figli piccoli e con figli grandi, stranieri dai look poco consoni alla situazione, coppie col passeggino. Cattolici praticanti e non, agnostici, atei. Una fiumana multicolore e multietnica che ha pochissime cose in comune, tranne una: questa enorme ammirazione per il Papa venuto “dalla fine del mondo” ma entrato subito in sintonia con un’umanità eterogenea. Con tutti e con ciascuno di loro.
Come Anna ed Elisabetta, due amiche di mezza età con due nomi biblici importanti. Hanno gli occhi pieni di luce dopo averlo salutato l’ultima volta. «Solo due ore», dicono quasi incredule. Vengono da Ladispoli, cittadina di mare in provincia di Roma. Cosa li ha colpiti di Francesco? «La semplicità, prima di tutto. Era uno di noi. Ma abbiamo capito la grandezza di quest’uomo leggendo la Evangelii Gaudium, con l’apertura ai laici, l’invito a farsi Chiesa in uscita. E la Fratelli tutti. Ancora di più con la Laudato si’, che ci ha fatto percepire il lamento flebile della Terra. Un dono che Dio ci ha affidato per custodirlo. Non per spremerlo».
Un Papa tanto diverso dai suoi predecessori, ma che a suo modo ha proseguito la loro opera. «Giovanni Paolo II ha spalancato le porte – dice Elisabetta – poi Benedetto XVI ci ha messo sui binari, con la sua delicatezza. E Francesco ci ha insegnato a camminare e a non fermarci. Col sorriso di papa Luciani». E ora? «Noi speriamo in un Francesco II. La gente ha paura che si ritorni indietro. Un nuovo Papa che non copi Bergoglio, ma che ne prosegua l’azione». Elisabetta e Anna ci provano a mettere in pratica il magistero di Francesco con il Circolo Laudato si’ Sacro Cuore di Ladispoli: «Abbiamo fatto uscire i preti dalle parrocchie», dicono sorridendo. Cioè? «Con la staffetta in bici di 140 chilometri “Alzati e pedala”, da Fiumicino a Civitavecchia. Ogni parroco ha raggiunto la parrocchia vicina consegnando all’altro la Laudato si’». Mariolina è romana di Roma, sulla sessantina, e non è voluta mancare. «Francesco mi è stato subito simpatico. Un papa moderno, che è riuscito ad avvicinare alla Chiesa tanta gente lontana, con la sua semplicità e col suo senso dell’umorismo».
Fabrizio ha 35 anni e al collo porta il lupetto della Roma. Romano? «Di Spinaceto», precisa, profondo sud romano. Cosa ti ha colpito di Francesco? «Pace, pace, pace. Lo ha ripetuto all’infinito. Era il Papa che ci voleva oggi che c’è troppa guerra, troppa». «Siamo di vicino Roma, non potevamo non venire», dicono Fabrizio e Cristina. Di dove? «Castelgandolfo. Certo, Francesco alla Villa Pontificia non è mai venuto e i negozianti non sono stati molto felici... Ma non importa, noi l’abbiamo amato tanto, quanto Giovanni Paolo II. Questo è stato un Papa che ha portato una ventata di novità. Un Papa controcorrente. Un Papa della gente».
Alessandra e Chiara sono amiche e colleghe, eleganti e curate più della media dei pellegrini. «Sono qui perché sono cattolica – racconta Alessandra – e venni a vedere anche papa Luciani con mia mamma, ero una ragazzina. Allora non c’era mica tutta questa gente. Con Giovanni Paolo II purtroppo non ho potuto, lavoravo. Stavolta ho voluto esserci, perché questo Papa mi ha colpito. Per il suo essere fuori dagli schemi, un latinoamericano, un po’ “populista”. Da quando si affacciò con quel sorprendente “buonasera” il giorno della sua elezione, per finire col mostrarsi senza falsi pudori in carrozzella. Per dirci “non vergognatevi della debolezza, sono anch’io come voi”. Ha comunicato tanto coi gesti». All’ingresso di sinistra del Colonnato Pasquale arriva con la moglie Barbara e i due figli grandi, Elena e Cosimo. Sono partiti da Benevento, torneranno subito in serata. Lo hanno fatto senza esitazioni, «per questo Papa dell’umiltà che ha voluto rompere gli schemi, rigettare certi simboli del potere papale. Ed è per questo che tanta gente gli si è avvicinata». Non solo: «Anche per l’attenzione per il Creato. È stato l’altro elemento che l’ha reso così importante».
Va di fretta e non si ferma a parlare col cronista l’uomo canuto e bassino. Dice solo due cose. La prima è da dove viene: «Dalla Sicilia». La seconda è il motivo per cui ha voluto salutare Francesco: «Perché è un santo». Basta e avanza. La signora anziana e distinta cammina faticosamente, una mano sul bastone, l’altra sottobraccio al figlio. «Quando si è mostrato in carrozzella – dice anche lei – mi ha colpito nel profondo. Non potevo non venire a dirgli grazie. Oggi quanto manca al mondo la sua benedizione e la sua presenza». Ed ecco un’altra famiglia che ha fatto ore di macchina prima che ore di fila. «Siamo calabresi, ma veniamo da Como», spiega Leonardo con moglie e figli. «Abbiamo cominciato all’una, siamo usciti quasi alle cinque». Ne è valsa la pena? «Assolutamente sì!», dice sgranando gli occhi, per far capire quanto è stata sciocca la domanda. Tutti diversi, tutti con lo stesso desiderio nel cuore.

L’ultima benedizione
Anita Prati
La preoccupazione per la conflittualità montante ad ogni angolo del pianeta ha accompagnato papa Francesco fino ai suoi ultimi respiri.
Rispondendo ad un messaggio di auguri di pronta guarigione inviatogli dal direttore del Corriere della Sera, lo scorso 18 marzo, dalla sua stanza d’ospedale al Policlinico Gemelli il Papa scriveva:
Caro Direttore, desidero ringraziarla per le parole di vicinanza con cui ha inteso farsi presente in questo momento di malattia nel quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più assurda.
L’assurdità della guerra si palesa ancor di più in tutta la sua drammatica insensatezza quando la si guarda da quel punto di osservazione privilegiato che è la malattia, luogo in cui si dispiega compiutamente tutta l’essenza dell’umana fragilità.
Dal suo letto d’ospedale papa Francesco ha levato un accorato appello, invitandoci a sentire tutta l’importanza delle parole. In un tempo in cui, in modo più o meno subdolo, torna a montare il clima di propaganda belligerante che avevamo conosciuto nei primi decenni del Novecento, il richiamo di papa Francesco risuona come una profezia: poiché le parole sono fatti che costruiscono i mondi che abitiamo, dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra.
***
È la proposta di un decisivo cambio di paradigma.
Proprio nei giorni in cui l’UE impegna i soldi dei suoi contribuenti per lanciare un video volto a promuovere un fantomatico kit di sopravvivenza utile a tenersi in vita per 72 ore in caso di minacce non meglio identificate, ma chiaramente identificabili con una bella guerra nucleare; proprio mentre i nostri governanti (e le nostre governanti) si arrabattano in tutti i modi possibili per giustificare l’investimento di fondi in piani di riarmo, a detrimento di istruzione e sanità; proprio mentre si cominciano a (re)introdurre anche nelle scuole progetti di rafforzamento della cooperazione civile-militare e sembra sempre più vicino il giorno in cui torneremo in piazza ad esercitarci nel passo d’oca; proprio mentre tutti i grandi (e le grandi) della terra si affannano a spiegarci la logica della guerra preventiva, sbeffeggiando il pacifismo come retaggio da hippy nostalgici e declinando come un insulto la parola «pacifista!», giacché l’idea-guida è che il Bene si può affermare solo sconfiggendo il Male a mano armata; proprio in giorni così, intrisi di irriducibile bellicosità, un uomo anziano, sulla soglia della morte, usa le sue ultime energie per richiamarci al dovere di sperare la pace.
Domenica 20 aprile, prima della benedizione Urbi et Orbi, impartita con un filo di voce dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, papa Francesco ha chiesto al maestro delle Celebrazioni Liturgiche Diego Ravelli di leggere il suo Messaggio Pasquale. Ci resteranno di lui queste ultime immagini, queste ultime parole: un uomo anziano e ammalato che osa, come pochi al mondo, continuare a credere che solo la pace ci salva dalla disumanità.
Se Cristo, nostra speranza, è risorto, sperare non è un’illusione, ma un dovere e una responsabilità:
Quanti sperano in Dio pongono le loro fragili mani nella sua mano grande e forte, si lasciano rialzare e si mettono in cammino: insieme con Gesù risorto diventano pellegrini di speranza, testimoni della vittoria dell’Amore, della potenza disarmata della Vita.
La potenza della Vita è disarmata e proprio per questo disarmante. Siamo circondati da volontà di morte, da conflitti e da violenze di ogni genere, ma la nostra esistenza non è fatta per la morte, è fatta per la Vita!
In questo giorno, vorrei che tornassimo a sperare e ad avere fiducia negli altri, anche in chi non ci è vicino o proviene da terre lontane con usi, modi di vivere, idee, costumi diversi da quelli a noi più familiari, poiché siamo tutti figli di Dio!
Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile!
***
Nel Messaggio di Francesco tornano, nominati uno ad uno, i luoghi della terra martoriati dalle guerre: il Medio Oriente, il Libano, la Siria; lo Yemen; l’Ucraina; il Caucaso Meridionale, l’Armenia e l’Azerbaigian; i Balcani occidentali; la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan e il Sud Sudan, il Sahel, il Corno d’Africa, la Regione dei Grandi Laghi; il Myanmar.
Su tutti, e prima di tutti, la Terra santa insanguinata:
Dal Santo Sepolcro, Chiesa della Risurrezione, dove quest’anno la Pasqua è celebrata nello stesso giorno da cattolici e ortodossi, s’irradi la luce della pace su tutta la Terra Santa e sul mondo intero. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo, il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Faccio appello alle parti belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi e si presti aiuto alla gente, che ha fame e che aspira ad un futuro di pace!
Cessate il fuoco! Chi raccoglierà questo appello di papa Francesco? Chi avrà il coraggio e si assumerà la responsabilità di osare sperare la pace?
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo.
I grandi e le grandi della terra, che in questi giorni affastellano tributi di cordoglio per la morte di papa Francesco, saranno capaci di raccoglierne l’eredità spirituale e fare in modo che, la sua, non rimanga una voce che grida solitaria nel deserto?
***
Il testamento di Francesco, redatto quasi tre anni fa, il 29 giugno 2022, si chiudeva con queste parole, che testimoniano tutta l’urgenza del suo sentire:
La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli.
Tornare a sperare che la pace è possibile: è questa il richiamo potente e la responsabilità che papa Francesco ci ha affidato con le sue ultime parole.
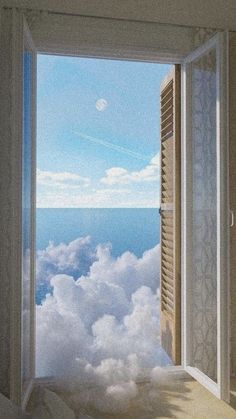
L’ultima omelia
Anita Prati
L’ultima omelia di Papa Francesco è stata l’omelia scritta per il giorno di Pasqua. A motivo della sua voce affaticata il papa non l’ha potuta leggere, ma ne ha affidato la lettura al cardinal Comastri. È un’omelia densa e breve, che si apre significativamente con il nome di Maria di Magdala e si chiude con una citazione dalla teologa e poeta Adriana Zarri.
Maria, dopo aver visto la pietra scostata dal sepolcro, corre a dirlo a Pietro e Giovanni; e Pietro e Giovanni, a loro volta, subito si mettono a correre verso il luogo della sepoltura di Gesù. Quella corsa è, per papa Francesco, molto più di un semplice dato narrativo:
“La corsa della Maddalena, di Pietro e di Giovanni dice il desiderio, la spinta del cuore, l’atteggiamento interiore di chi si mette alla ricerca di Gesù. Egli, infatti, è risorto dalla morte e perciò non si trova più nel sepolcro. Bisogna cercarlo altrove.”
Francesco ci consegna questo invito pressante, perentorio, e questa responsabilità: bisogna cercarlo altrove, il Signore della Vita. Non nei sepolcri, nei musei del tempo che fu, nelle storie imbalsamate, ma nella vita, nei volti e nelle storie vive dei fratelli e delle sorelle che camminano con noi lungo le strade di questo mondo. Dobbiamo cercarlo altrove, e cercarlo sempre:
“Cercarlo sempre. Perché, se è risorto dalla morte, allora Egli è presente ovunque, dimora in mezzo a noi, si nasconde e si rivela anche oggi nelle sorelle e nei fratelli che incontriamo lungo il cammino, nelle situazioni più anonime e imprevedibili della nostra vita. Egli è vivo e rimane sempre con noi, piangendo le lacrime di chi soffre e moltiplicando la bellezza della vita nei piccoli gesti d’amore di ciascuno di noi.”
In questo cercare, in questo cercarlo sempre, è la radice della nostra fede pasquale: una fede che non si adagia nella staticità del “si è sempre fatto così” e non si accomoda nella tranquillità delle rassicurazioni religiose, ma osa il coraggio inquieto della ricerca.
“Come Maria di Magdala, ogni giorno possiamo fare l’esperienza di perdere il Signore, ma ogni giorno noi possiamo correre per cercarlo ancora, sapendo con certezza che Egli si fa trovare e ci illumina con la luce della sua risurrezione.”
I passi svelti della Maddalena, di Pietro e di Giovanni, danno corpo alla speranza: non una semplice idea, una pia illusione, ma un movimento vitale che sostanzia di senso il nostro cammino.
“Non possiamo parcheggiare il cuore nelle illusioni di questo mondo o rinchiuderlo nella tristezza; dobbiamo correre, pieni di gioia. Corriamo incontro a Gesù, riscopriamo la grazia inestimabile di essere suoi amici. Lasciamo che la sua Parola di vita e di verità illumini il nostro cammino. “
L’omelia si chiude con una preghiera di Adriana Zarri: “Scrostaci, o Dio, la triste polvere dell’abitudine, della stanchezza e del disincanto; dacci la gioia di svegliarci, ogni mattino, con occhi stupiti per vedere gli inediti colori di quel mattino, unico e diverso da ogni altro.”
Gli occhi di papa Francesco, questa mattina, hanno accolto con stupore e gratitudine un mattino davvero nuovo.
Cercavo
Cercavo silenzi
di boschi e montagne,
di sguardi profondi,
di vento sul mare.
Cercavo passi
che riportano a casa,
che tracciano strade,
che camminano insieme.
Cercavo luce
a rischiarare la notte –
bagliori di fiamma,
tremolio di candele.
Cercavo acqua
che disseta la sete,
rinfresca la pelle,
inonda i pensieri.
Cercavo pane
per spezzare fatiche,
sostenere gli affanni,
carezzare il dolore.
Cercavo vino
per danzare la festa,
per cantare la vita,
liberare la gioia.
Cercavo parole
da riporre in silenzio
fra le pieghe del cuore –
parole da ascoltare,
parole da parlare,
parole da intrecciare
con legami d’amore.
Cercavo –
ho sempre cercato –
e Tu, ogni volta,
mi hai sempre trovato
Anita Prati

Francesco: un dono dello Spirito
Nel momento in cui riceviamo la drammatica, seppur attesa, notizia della morte di papa Francesco ci siamo rapidamente consultati in redazione. In attesa di un giudizio più ponderato e compiuto ci è parso importante fissare alcuni punti decisivi e alcune linee guida che hanno segnato il suo servizio petrino. Si tratta di guardare a Francesco con l’ottica di Francesco. A partire da quanto è possibile comprendere dai suoi scritti, dai suoi gesti, dalla sua vita e dai suoi indirizzi di governo si possono indicare gli orientamenti di maggior forza che ha inteso proporre e sostenere. Fra questi ve ne sono alcuni a nostro giudizio particolarmente riconoscibili.
Fedeltà al Vaticano II
Si può dire che tutti i pontificati post-conciliari lo hanno affermato, ma con tentativi di correzione e di contenimento. Francesco ha aperto porte e finestre, riprendendo la spinta innovativa dell’assemblea conciliare dei vescovi cattolici. In particolare, nei rapporti con la modernità ha archiviato ogni declinazione di neo-cristianità. La Chiesa, sacramento di salvezza, partecipa con tutti gli uomini e le donne al procedere storico, dando il proprio contributo di testimonianza, luce e senso evangelici senza pretendere di essere parte del potere politico o di condizionare le assemblee legislative.
Evangelizzazione prima della dottrina
Senza ignorare la centralità del deposito della fede, il compito odierno della Chiesa nella sensibilità di Francesco è quello di tornare all’annuncio del Vangelo ad ogni creatura, di uscire dai recinti consueti, di trasformare i propri linguaggi, di sporcarsi le mani con i vissuti di tutti. La scelta dei poveri perde ogni traccia ideologica per tornare al Vangelo sine glossa. Protagonista dell’impresa è l’intero popolo di Dio.
Sinodalità
La fatica degli ultimi anni di chiarire, fondare e praticare la sinodalità è indicativa di una Chiesa che, proseguendo il suo sforzo di comprensione sempre migliore della fondante manifestazione dell’Abbà di Gesù e della rivelazione trinitaria, si impegna a tradurle in una prassi concreta e condivisa nel tempo presente. Siamo ancora all’inizio. Il processo e l’investimento sono destinati a durare a lungo.
Religioni e confessioni cristiane
Davanti alla sfida della violenza con pretese religiose Francesco ha approfondito l’intuizione di Assisi (Giovanni Paolo II), aprendo dialoghi e confronti, in particolare con l’Islam e le fedi non monoteistiche. Contestualmente, ha riconosciuto di dover assumere una nuova centralità della Chiesa cattolica in ordine all’urgenza dell’unità cristiana, al dialogo con le altre confessioni. Ne va della credibilità del cristianesimo e della sua profezia in un mondo sempre più diviso e frammentato.
Il vento del Sud
Provenendo − come ebbe a dire la sera della sua elezione − dalla «fine del mondo», da un Paese periferico rispetto alla civiltà atlantica, Francesco ha incarnato e incoraggiato la crescita delle comunità cattoliche in continenti come l’Africa e l’Asia. Uno spostamento del baricentro ecclesiale che porta in sé cambiamenti profondi nell’autocoscienza della Chiesa, ben al di là della crescita del numero dei cardinali non occidentali.
Laici e donne
Se c’è una denuncia insistente nei suoi discorsi è quella contro il clericalismo, contro una indebita centralità dei vescovi e dei preti. Non per sminuire la rilevanza del ministero ordinato, ma per dare uno spazio effettivo al sensus fidei fidelium e agli innumerevoli carismi che lo Spirito suscita nelle comunità cattoliche. È stato talora accusato di approcciare la questione femminile in termini retorici, ma anche la semplice costatazione dei ruoli ecclesiali oggi riconosciuti alle donne, rispetto al passato recente, indica la sostanza dei passi compiuti.
Contro gli abusi
In fedeltà agli indirizzi avviati da Benedetto XVI, e sull’onda degli scandali svelati e cavalcati dai media di molti Paesi occidentali, Francesco ha definito la risposta canonica, teologica e spirituale davanti all’«intollerabile» della violenza sui piccoli e gli indifesi. Si potranno certo rilevare anche incertezze e rallentamenti, in particole per alcuni casi che lo hanno tangenzialmente coinvolto, ma è difficile negare la sua coerente volontà di affrontare il problema, anche quando esso ha coinvolto ecclesiastici di alto profilo e interi episcopati.
Libertà di ricerca
Solo chi non ha conosciuto il senso di liberazione del Concilio e le successive restrizioni al pensare teologico (dalla teologia della liberazione alla ricerca morale e all’ecclesiologia) può sorvolare sulla ricchezza di dibattiti e di ipotesi teologiche che hanno ripreso a correre in seno alla Chiesa con l’attuale pontificato. I loro limiti e fragilità non possono oggi essere attribuiti alle censure delle istanze vaticane, se non in piccola parte. Paradossalmente, le numerose – talora improponibili – critiche al suo magistero lo confermano.
Riforma della curia
Spostare l’asse di rotazione dalla dottrina all’annuncio del Vangelo, impedire concrezioni improprie di potere, sciogliere le cordate servili, internazionalizzare le presenze, ricambiare i responsabili, facilitare i rapporti con la conferenze episcopali e i vescovi: sono alcune delle importanti intenzioni che reggono la riforma. Le sue insufficienze e contraddizioni, che non mancano, non possono svalutare le preziose novità di indirizzo.
Ambiente, fratellanza, migrazioni
Sono i titoli di alcuni dei suoi testi fondamentali (encicliche, esortazioni, discorsi e gesti) sulle emergenze sociali e mondiali. Rappresentano lo sforzo del magistero pontificio davanti a sfide cruciali per la sopravvivenza dell’umanità. Consapevole della «dissonanza» rispetto alla cultura mediale corrente, Francesco non ha annacquato la genialità della dottrina sociale, affrontando la globalizzazione senza cedimenti al sistema tecnocratico. Essa rappresenta per lui un coerente sviluppo della riforma ecclesiale proposta con il suo grande documento programmatico, l’esortazione Evangelii gaudium.
Guerra ed egemonia
Francesco ha delegittimato la guerra andando oltre la dottrina della «guerra giusta» proprio nel momento in cui essa riappare «a pezzi» nel mondo e in Europa (Russia-Ucraina). C’è qualcosa di agonico e drammatico in questa volontà di resistere al fatto che la pur necessaria ridefinizione dell’egemonia mondiale debba avvenire con la violenza. Da qui si capisce il favore con cui Francesco guarda all’esperienza dell’Unione Europea, alla necessità di tenere aperti i contatti con Mosca e con Pechino e alle domande esigenti nei confronti della democrazia americana. Lo ha fatto perché ha percepito acutamente che c’è una vittima predestinata della distruzione del multilateralismo e della pace: la democrazia.
Fedeltà al Vangelo e acume storico legittimano l’indicazione di Francesco come dono dello Spirito.
Fonte: Settimananews

I gesti, le parole, gli abbracci: il Papa delle prime volte
Mimmo Muolo
Che tipo di Papa sarebbe stato non ci volle molto a capirlo, quel tardo pomeriggio del 13 marzo 2013. Il tempo di vederlo comparire sul balcone centrale della facciata della Basilica di San Pietro, di osservare il semplice vestito bianco, con nient’altro sopra se non la croce pettorale, di ascoltare il suo «buonasera» e le prime parole a braccio, dopo l’annuncio del nome che Jorge Mario Bergoglio aveva scelto per il suo ministero petrino. Francesco. Una novità assoluta nella bimillenaria storia dei papi.
Il pontificato “delle prime volte”
Cominciava così un pontificato “delle prime volte”, estremamente popolare, anche se non scevro da critiche (quasi tutte da “destra” e anche questa è una prima volta, almeno nella storia recente), ma sicuramente rivoluzionario per molti aspetti. A cominciare dal fatto che per la prima volta, appunto, era stato chiamato a guidare la Chiesa cattolica un latino-americano, circostanza che egli stesso sottolineò con un’espressione poi divenuta famosa: «Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo (il nuovo vescovo di Roma, ndr) quasi alla fine del mondo».
Ma insieme a questa frase, molto di quello che sarebbe avvenuto dopo, nei 12 anni di permanenza sulla cattedra di Pietro, fu come preconizzato in quel primo discorso da Pontefice.
La teologia del popolo, ad esempio, sua constante stella polare. La fratellanza, che tanto spazio avrebbe avuto nei suoi documenti e soprattutto nell’enciclica Fratelli tutti. La sua richiesta della preghiera del popolo affinché il Signore apponesse il sigillo della sua benedizione sul nuovo pontificato, ancor prima che fosse – come di consueto – il nuovo Papa a benedire il popolo. E il primo pensiero dedicato a Benedetto XVI, da pochi giorni (a quella data) Papa emerito, per inaugurare un rapporto di considerazione e affetto che sarebbe durato fino alla morte del suo predecessore, il 31 dicembre 2022.
La capacità di sorprendere e la naturale simpatia
Papa Francesco dimostrò fin dall’esordio la sua capacità di sorprendere. E di stabilire una sintonia immediata con i propri interlocutori, anche quelli più lontani, le personalità che fino ad allora avevano guardato alla Chiesa di Roma con sospetto e diffidenza, o magari con indifferenza, se non proprio con aperta ostilità. Quali saranno i frutti che questa naturale simpatia ha prodotto lo giudicherà la storia, ma è un fatto che papa Bergoglio abbia aperto canali di dialogo fino a poco tempo fa impensabili. Si pensi solo agli incontri con Eugenio Scalfari, sia pure al netto degli errori teologico-dottrinali anche gravi, attribuiti dal famoso giornalista al Papa nei suoi report su quei colloqui.
Nei giorni che seguirono l’elezione, in particolare, emersero sempre nuovi aspetti della personalità del Papa argentino, che gli guadagnarono un immediato e quasi totale favore popolare. Come ad esempio la scelta, subito dopo l’affaccio dal balcone, di tornare a Casa Santa Marta in pulmino con gli altri cardinali invece di utilizzare l'automobile papale. Oppure il gesto di recarsi personalmente alla Casa del Clero dove aveva soggiornato nei giorni precedenti al Conclave, per pagare il conto. E poi la decisione di rimanere a Santa Marta, anziché andare a risiedere nel Palazzo apostolico, non come scelta di povertà, ma di contatto con le persone, perché questo lo faceva stare bene, come spiegò egli stesso.
Povertà, pace, creato e misericordia
Anche il nome fu un’indicazione di programma: Francesco è l’uomo della povertà, della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato. «Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!», disse. Si aggiungerà poi la misericordia, a completare i quattro pilastri pastorali del suo magistero. Nel primo Angelus dopo la sua elezione, il 17 marzo, Bergoglio parlò della misericordia come di una parola che cambia il mondo» e lo «rende meno freddo e più giusto». E il 7 aprile, nella basilica di San Giovanni in Laterano, quando il nuovo Vescovo di Roma si insediò sulla sua cattedra, aggiunse: «Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio». Sono solo i primi accenni di tema che troverà il suo momento più alto nella celebrazione dell’Anno Santo straordinario della misericordia (2015-2016).
Nella Messa di inizio ufficiale del ministero petrino, il 19 marzo 2013, giorno di San Giuseppe, il Papa parlò anche di tenerezza, prendendo spunto proprio dal casto sposo di Maria, uno dei santi che gli erano più cari. «In lui – sottolineò - vediamo qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato». Quindi parlando del suo ruolo disse: «Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla Croce». Il che significa «aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelli che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità: chi ha fame, sete, è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo chi serve con amore sa custodire».
Su questi binari programmatici ecco che il primo anno di pontificato diventa una specie di fuoco pirotecnico delle novità. Il 23 marzo, ad appena dieci giorni dall’elezione al soglio di Pietro, papa Francesco si reca a Castel Gandolfo per visitare il papa emerito Benedetto XVI. È la prima volta nella storia che due papi si incontrano. Il 13 aprile 2013 un comunicato della Segreteria di Stato annuncia la formazione di un gruppo di cardinali «per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica Pastor bonus sulla Curia Romana». Nasce così il cosiddetto C8 (otto cardinali), che poi diverrà C9, con l’ingresso del segretario di Stato, Pietro Parolin. Questo gruppo, di cui viene nominato segretario l’allora vescovo di Albano, Marcello Semeraro (poi cardinale), sarà quello che insieme al Papa porterà alla riforma della Curia, ora codificata nella costituzione Praedicate Evangelium, pubblicata il 19 marzo 2022.
I viaggi
L’8 luglio 2013, poi, un po’ a sorpresa, Francesco dà inizio ai suoi viaggi, scegliendo una destinazione emblematica: Lampedusa. C'era stato da non molto l’ennesimo grave naufragio che aveva causato decine di morti tra i migranti. Si comprende così che, pur confermando la prassi dei viaggi papali, Bergoglio intende dare anche a questa attività un’impronta in linea con le proprie priorità pastorali. Periferie sempre al centro. Predilezione per i più poveri. Chiesa in uscita. In Europa, ad esempio, inizierà dall’Albania, non toccherà mai i grandi Paesi. Strasburgo e Marsiglia non furono visite alla Francia, ma al Parlamento Europeo e al Consiglio d’Europa nel primo caso, ai vescovi del Mediterraneo riuniti a convegno nel secondo (solo la periferica Ajaccio lo è stato, suo ultimo viaggio, il più breve), mentre in altri continenti visiterà preferibilmente contesti e situazioni, più che Paesi, con un occhio particolare ai diseredati e al dialogo con le altre religioni, musulmani in primis. Alcuni dei viaggi entreranno direttamente nella storia del Pontificato. Quello in Iraq, ad esempio, in pieno periodo Covid e dopo la fine della devastazione dell’Isis, il viaggio in Terra Santa, le due tappe nella Penisola arabica (Abu Dhabi e Qatar), le prime in assoluto per un Pontefice in quella regione, la visita all’Onu, a suo modo anche il Giappone (dove il Papa avrebbe voluto andare come missionario da giovane) e il sorvolo della Cina durante il viaggio in Corea del Sud. Francesco invece non ha fatto mai ritorno in Argentina, pur avendo viaggiato diverse volte in America Latina.
Tra i viaggi bisogna anche ricordare le Gmg. Grandiosa quella di Rio de Janeiro nel 2013 (suo primo viaggio all’estero, a pochi mesi dall’elezione), cui sono seguite quelle di Cracovia 2016, Panama 2019 e Lisbona 2023.
Il Concistoro
Il primo Concistoro per la creazione di nuovi cardinali si tenne invece il 22 febbraio 2014. E anche in questo ambito si intuì fin da allora che Francesco aveva in mente una sua “geopolitica” delle porpore, che non coincideva con quella codificata nel tempo rispetto alle sedi episcopali cosiddette cardinalizie. La sua preferenza è spesso andata a realtà periferiche e a Chiese che non avevano mai avuto un cardinale.
La libertà
Ma la libertà del Pontefice si esplica anche in altri campi: telefona agli amici, si reca di persona a comprare gli occhiali in un’ottica di via del Corso a Roma, compie alcune visite a sorpresa - quella del febbraio 2021 a casa della scrittrice di origine ebraica, Edith Bruck, sopravvissuta ai lager nazisti e quella a casa di Emma Bonino il 5 novembre 2024 -, festeggia i suoi compleanni e onomastici condividendo un pezzo di pizza o di torta con i clochard che vivono dalle parti di San Pietro. Non può più uscire da solo o prendendo la metropolitana, come faceva quando era arcivescovo di Buenos Aires, ma talvolta si concede piccole “licenze”. Soprattutto con e per i poveri, gli ammalati, gli emarginati, verso i quali dimostra la sua speciale predilezione. Dispone ad esempio che l’elemosineria diventi una specie di braccio operativo della sua carità immediata. E incarica l’elemosiniere Konrad Krajewski (che sarà insignito della porpora cardinalizia) di provvedere ai loro bisogni: docce, dormitorio, perfino il barbiere ogni lunedì, cure e visite mediche dedicate (specie nella giornata mondiale dei poveri, organizzata dall’arcivescovo Rino Fisichella), ma anche spettacoli al circo e concerti nell’Aula Paolo VI. Una volta viene organizzata anche una visita guidata nella Cappella Sistina.
Le parole e i gesti nuovi
È un Pontificato di gesti, oltre che di discorsi e documenti, quasi un’enciclica scritta con il linguaggio del corpo, con gli incontri che non ti aspetti, con gli abbracci agli ammalati, anche i più gravi. Lo stesso stile hanno il suo magistero e la sua predicazione. Soprattutto nelle messe mattutine a Santa Marta (consuetudine interrotta alla fine del periodo del Covid), che diventano un vero e proprio laboratorio di omiletica, in cui il Pontefice dà prova anche della sua capacità di parlare un linguaggio per immagini (“Chiesa in uscita”, appunto, per dire della missionarietà; “pastori con l’odore delle pecore” per raccomandare ai sacerdoti la vicinanza al popolo di Dio; “cristiani della domenica”, per stigmatizzare la distanza tra fede e vita di certi praticanti, e diverse altre espressioni tipiche).
Un’ulteriore grande novità, introdotta fin dal primo anno di Pontificato, è quella di celebrare la messa in coena Domini del Giovedì Santo non più nella Basilica di san Pietro, ma nei luoghi della sofferenza umana: carceri soprattutto (e si comincia con quello minorile di Casal del Marmo a Roma), ma anche nosocomi e centri di riabilitazione.
I documenti
Sono tutte linee che si ritrovano in maniera sistematica nell’esortazione Evangelii gaudium, promulgata nel novembre del 2013, vero e proprio documento programmatico del pontificato e che dà forma compiuta a idee portanti come quella della Chiesa in uscita, intesa come totalità del Popolo di Dio che evangelizza, il discorso sull’economia che uccide e sulle iniquità dei meccanismo del mercato, l’indicazione che il tempo è superiore allo spazio, la realtà superiore all’idea, l’unità prevale sul conflitto, il tutto è superiore alla parte. E poi le indicazioni sull’omiletica, la pace e il dialogo sociale e le motivazioni spirituali per l'impegno missionario.
Francesco anche per quanto riguarda i documenti segue una linea originale. Relativamente pochi, ma molto caratterizzati. Prima della Evangelii Gaudium era stata pubblicata l’enciclica Lumen Fidei (29 giugno 2013), quasi pronta già sotto il pontificato di Benedetto XVI, che però non l’aveva conclusa. Il nuovo Pontefice la fa propria, la completa e la pubblica dichiarando esplicitamente che si tratta di un testo praticamente scritto a quattro mani con il suo predecessore (altra circostanza inedita nella storia dei Papi).
Documenti fondamentali saranno l’enciclica sociale Laudato si', la prima dedicata interamente alla salvaguardia del creato, con la proposta innovativa dell’ecologia integrale (non esistono tante crisi, ma una sola che le comprende tutte) e poi Fratelli tutti, che ne costituisce l’ideale continuazione, e naturalmente Amoris Laetitia, uno dei documenti più commentati (e controversi, soprattutto per la questione della comunione ai divorziati risposati), frutto dei due sinodi dedicati alla famiglia tra il 2014 e il 2015. L'ultima enciclica è Dilexit nos sul Sacro Cuore.
Il Giubileo della misericordia
Il crescendo dei primi anni di pontificato giunge fino alla proclamazione, anche questa una sorpresa, dell’Anno santo straordinario della misericordia. Il Giubileo si svolge con modalità innovative. Il Papa dispone che siano aperte porte sante in tutte le diocesi del mondo. Ed egli stesso ne anticipa di qualche giorno l’inizio, fissato per l’8 dicembre 2015 aprendo il 29 novembre la porta santa della Cattedrale di Notre-Dame di Bangui nella Repubblica Centrafricana, durante il suo primo viaggio in Africa.
I tre momenti storici
Non mancano anche nella seconda fase del Pontificato i momenti storici. Se ne potrebbero indicare tre su tutti. In ordine di data:
- l’incontro del 12 febbraio 2016 a Cuba con il patriarca ortodosso di Mosca, Kirill, novità assoluta nella storia anche questa, che aveva fatto sperare in un definitivo disgelo con la parte numericamente più consistente dell’ortodossia, prima che l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin ricongelasse molto di questo rapporto.
- la preghiera sotto la pioggia del 27 marzo 2020 in una piazza san Pietro deserta, per chiedere la fine della pandemia (immagini anche queste rimaste nell’immaginario collettivo);
- la firma ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019 della Dichiarazione sulla fratellanza universale, insieme con il grande imam di Al-Azhar, quale base per costruire la pace e la convivenza tra i popoli.
I migranti, i poveri e l’Economy of Francesco
Il Papa ha approfondito negli anni molti dei temi enunciati già dall’inizio del Pontificato. L’attenzione agli ultimi e ai poveri, ad esempio, anche attraverso un altro modo fare economia. E nasce infatti “Economy of Francesco”, movimento di giovani economisti per cambiare le regole che troppo spesso non tengono conto della sostenibilità, lasciano indietro i più poveri e non rispettano l’ambiente. Il Pontefice si fa promotore anche di alcune iniziative simbolo, come il Sinodo per l’Amazzonia, con finalità non solo pastorale, ma anche legata alla salvaguardia del più grande polmone verde del mondo. Infine, emerge sempre più la questione della sinodalità, come modo di vivere la Chiesa e stabilire un nuovo contatto con il mondo (a questo tema sarà dedicato il doppio sinodo del 2023 e del 2024).
Il Papa alza sempre più spesso la sua voce in difesa dei migranti, chiedendo per loro accoglienza, protezione, promozione e integrazione. E compie ben due visite a Lesbo, l’isola greca dove c’è uno dei campi profughi più grandi d’Europa.
Gli appelli per la pace
Dall’invasione della guerra in Ucraina (24 febbraio 2022) e poi con le ostilità a Gaza (dopo l’inumano attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023), il Pontefice chiede con sempre più insistenza di fermare la violenza, paventando l’avvio di una terza guerra mondiale non più solo a pezzi. Sua la decisione senza precedenti di recarsi personalmente all’indomani dell’aggressione a Kiev nell’ambasciata russa presso la Santa Sede per cercare di parlare (inutilmente) con Putin. Sua anche l'idea di nominare suo inviato speciale per la pace il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, che, se non riesce a fermare le ostilità, quanto meno ottiene il rilascio di molti ostaggi, tra i quali soprattutto bambini ucraini portati in Russia.
L’impegno contro gli abusi nella Chiesa
Sono stati anche anni di lotta senza quartiere agli abusi sui minori all’interno della Chiesa. Francesco ha cercato di attuare una “politica” di tolleranza zero sul tremendo problema, introducendo norme severe per quei vescovi che dovessero coprire casi di loro conoscenza e istituendo una Commissione per la tutela dei minori, affidata alla presidenza del cardinale Seàn Patrick O’Malley. Francesco ha anche voluto una nuova sezione all’interno della Congregazione per la dottrina della Fede, quella disciplinare, chiamata a occuparsi dei delitti riservati alla Congregazione stessa, tra cui l’abuso di minori compiuto da chierici. In materia di abusi, però, non si possono omettere di ricordare alcune “sviste” come quella relativa all’episcopato cileno, prima difeso dal Pontefice, che poi, di fronte a prove inoppugnabili, ha dovuto prendere gli opportuni provvedimenti.
I rapporti con la Chiesa italiana
Sul fronte italiano il pontificato di Jorge Mario Bergoglio si è caratterizzato per un rapporto con l’episcopato italiano che potremmo definire di obbedienza dialettica da parte dei vescovi. Il Papa argentino ha chiesto una semplificazione delle strutture ecclesiastiche, sia per quanto riguarda le diocesi (portando avanti, specie negli ultimi tempi, un programma di accorpamento in persona episcopi, di quelle più piccole con altre territorialmente vicine), sia promuovendo un processo sinodale che tra il 2022 e il 2025 si è articolato in varie fasi.
Il Papa e i giornalisti
Innovativo è stato anche il suo rapporto con il mondo della comunicazione. Nell’itinerario di ritorno a Roma, durante i suoi viaggi, il Papa ha sempre tenuto conferenze stampa con i giornalisti al seguito, sui temi più vari. Decine le interviste concesse a testate di tutto il mondo. Così pure i libri, spesso scritti a quattro mani con i giornalisti, fino alle due recenti autobiografie.
Pure da questo punto di vista è stato un Papa delle prime volte. Un Papa che ha confermato fino all’ultimo giorno (emblematiche resteranno le foto dell'apertura della Porta Santa prima a San Pietro poi al carcere di Rebibbia, altra primizia assoluta, per il Giubileo in corso) la prima impressione suscitata nei fedeli quel 13 marzo 2013. Quando fu facile comprendere che tipo di Pontefice Jorge Mario Bergoglio sarebbe stato.
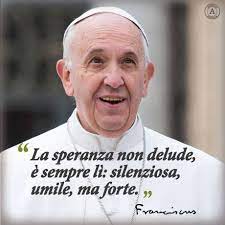
I sogni di papa Francesco
Antonio Dall'Osto
Nei documenti e discorsi di papa Francesco ricorre di continuo il verbo “sognare” o il termine “sogno”. E ciò fin dall’inizio, da quando ha detto di «sognare una Chiesa povera per i poveri» fino all’invito rivolto ai giovani alla Giornata mondiale di Lisbona nei giorni scorsi di «sognare alla grande».
Bisogna continuare a sognare
Attualmente, a dieci anni del suo pontificato, egli continua a sognare con lo sguardo rivolto a Dio, ma nello stesso tempo tenendo i piedi ben per terra. La rivista spagnola Vida Nueva, in occasione del viaggio del papa in Portogallo, ha colto l’occasione per intervistarlo, mettendo al centro due interrogativi imperniati su questo invito che sta alla base del suo programma di pontefice: il primo: «Quali sono i sogni di Dio oggi» e «Quali sono i suoi sogni per la Chiesa in questo momento della storia».
Non senza un pizzico di umorismo, ha ribadito di voler continuare a sognare e si è riferito a san Giuseppe dicendo: «Sono convinto che soffrisse di insonnia: Non riusciva a prendere sonno perché temeva che ogni volta che si addormentava Dio cambiasse i suoi piani attraverso i suoi sogni».
Ma, a parte gli scherzi, parlando seriamente ha affermato che «una persona che smette di sognare nella vita è una persona sosa, arrugada, insipida, avvizzita. (…) C’è sempre qualcosa da sognare, così io la penso. A volte sono programmi, altre volte proiezioni… Che ne so. Però bisogna sognare. Una persona, quando sogna, spalanca le porte e le finestre. Uno che non sogna, non ha futuro; ha un futuro ripetitivo, banale».
Sogno una Chiesa “in uscita”
Ma cosa sogna padre Jorge Begoglio oggi? Continua a sognare una «Chiesa povera e per i poveri»? La risposta è molto chiara:
«L’espressione che ho usato tempo fa è una Chiesa “in uscita”: vale a dire che non sai cosa ti aspetta, però non sta chiusa dentro di sé. Non sognare ti porta alla meschinità all’incapacità di essere generoso… Sogno una Chiesa “in uscita”, una Chiesa di periferia». «In effetti – ha precisato –, per fare un esempio, il prossimo concistoro è un sogno in questo senso. Se guardiamo al numero di cardinali di curia che c’erano dieci anni fa e che ci sono adesso, o alla riduzione del numero dei cardinalati legati alle storiche sedi episcopali, si parla di quella periferia che ora è al centro. C’è il nuovo cardinale di Juba (Sud Sudan), che non sarebbe mai stato preso in considerazione, o la nomina dell’arcivescovo di Penang (Malesia), che molti non sanno nemmeno dove sia».
«Questa è la Chiesa che sogno e che, tra l’altro, è quella degli Atti degli Apostoli: Parti, Medi, Elamiti… Quella mattina di Pentecoste, in cui tutti parlavano la loro lingua, ma tutti si capivano. Adesso deve succedere: ognuno dice la sua, ma tutti ci capiamo, anche se uno accentua di più questa cosa, l’altro quell’altra. Penso che sia la Chiesa che dobbiamo cercare, e non scandalizzarci, perché abbiamo tanto confuso l’essenziale con l’accidentale! Quando ti accartocci, ti rendi ridicolo…».
C’è una parte del mondo in guerra
Difficile però sognare in un mondo come quello di oggi, segnato da una terza guerra mondiale a pezzi…
«Sì, è complicato, certamente. La dimensione tragica di oggi è grave. Dalla fine della seconda guerra mondiale, ci sono stati conflitti in varie parti. Adesso stiamo affrontando la guerra in Ucraina, che ci fa paura perché è vicina. Ma chi pensa allo Yemen, chi pensa alla Siria, chi pensa a tutti quei luoghi in Africa, per esempio, nel Kivu, nella parte settentrionale della Repubblica Democratica del Congo dove non sono potuto andare? Siamo sempre in guerra, ma siccome è lontana…Allo stesso modo, ci sembra naturale, ad esempio, che i Rohingya vaghino per il mondo perché nessuno vuole accoglierli. Solo ciò che è vicino ci spaventa. A volte vedo la cupola di San Pietro e mi dico: “Se uno di questi pazzi lancia una bomba qui, è tutto finito”. Tuttavia, anche in queste circostanze, ci sono motivi di speranza».
Si sta realizzando il sogno che lei ha espresso dieci anni fa di una Chiesa “ospedale da campo”?
«Ci sono posti dove ciò avviene, dipende. A volte, la Chiesa diventa precipitosa nel voler essere un “ospedale da campo” e sbaglia perché accelera. Cadiamo così in una deriva in cui diamo una soluzione giusta come orientamento, ma non si prendono delle soluzioni partendo dalla contemplazione del Vangelo. Non si può riformare una Chiesa al di fuori dell’ispirazione evangelica. Le soluzioni sono molto efficaci, ma fuorvianti. È una trappola molto insidiosa: le soluzioni cercate non vengono dal Vangelo. Sono frutto del buon senso, della possibilità umana di ciò che si deve fare, ma non hanno espressione evangelica. Si prendono velocemente. Hanno ragione a voler risolvere un problema, perché la gente se ne va. Penso che sia quello che sta accadendo nel cosiddetto Cammino sinodale tedesco».
Scommetto sul cammino sinodale
Alla vigilia della prossima assemblea del Sinodo a Roma, il prossimo mese di ottobre, è stata occasione per tornare su uno dei temi che maggiormente gli stanno a cuore, la sinodalità.
«Continuo a scommettere sul processo sinodale avviato da san Paolo VI. Quando si è concluso il 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, le cose erano mature per varare un documento. L’ha elaborato un’équipe di teologi di prim’ordine e io l’ho sostenuto, perché ci permetteva il percorso per arrivarci. Negli ultimi dieci anni alcune cose però sono state perfezionate, non molte. Ad esempio, prima non era nemmeno venuto in mente di interrogare i laici. Se fosse un Sinodo solo per vescovi, allora che votino i vescovi, punto! e tutti fuori, stiano ad osservare! Durante il Sinodo per l’Amazzonia, per la “pausa” durante i lavori, c’era, accanto all’aula, un ufficio riservato al papa. Mi stavo recando lì. Il primo giorno cominciarono a venire le donne, per parlare del voto. È stato il punto di partenza di un dialogo sincero. Allora ho chiesto il parere ai teologi, che hanno fatto un rapido sondaggio e hanno detto: “Sì, le donne possono votare”. Ma il Sinodo era già iniziato. Se sono membri, possono votare. E mi sono detto: “Fare questo adesso può suscitare scandalo, lo lascio per il prossimo…”, che è adesso. Il sogno è maturato fino a prendere forma».
Un’altra domanda ha riguardato la sua responsabilità di essere alla guida una nave di 1.300 milioni di cattolici, con continui problemi seri sulla sua scrivania. Molti si aspettano oggi grandi cambiamenti… È tanta responsabilità sulle sue spalle, non perde il sonno?
«Il sonno non l’ho mai perso. È una grazia: arrivo alla sera così stanco che dormo. Grazie a Dio, non sono caduto nella tentazione dell’onnipotenza, di credere di poter risolvere tutto. Certo, da buon gesuita, mi sveglio prestissimo per sfruttare maggiormente il tempo…».
Lei – ha insistito l’intervistatore – ha molto coraggio nel proporre questi cambiamenti. Non le è mai venuto in mente di lasciar perdere qualche sogno troppo rischioso?
«Certo, e la prima reazione è un no. Ma poi chiedo consiglio, e vedo se si può fare o no. Bisogna misurare fino a che punto si può andare oltre il limite e fin dove no. Si prova una certa impotenza, ma penso che sia un bene, perché impedisce di credersi un dio o un essere onnipotente. Sono i limiti che la storia e la vita impongono. Ad esempio, non ho ancora osato mettere fine alla cultura di corte in curia».
Amo stare con la gente
Di fronte a proposte che una parte della Chiesa non è preparata ad accogliere ha sottolineato che bisogna insistere sulla formazione e soprattutto sul saper uscir fuori.
«In Argentina, sentivo un po’ di allergia quando vedevo pastori che si guardavano l’ombelico, con lo sguardo ripiegato su sé stessi. Penso a un vescovo, un grande teologo, ma come pastore era una nullità. Lanciava sempre messaggi di tipo: «Attento, bisogna dire la messa così… fare questo o quest’altro. I poveri sacerdoti erano soggetti al governo di quell’uomo. Ci sono pastori che non sono pastori».
Molto interessante, al termine dell’intervista, quanto Francesco afferma circa lo stile di vita che ha scelto per il suo pontificato, ovvero quello di rimanere il più possibile vicino alla gente comune, senza preferenze o privilegi.
«Dopo essere stato eletto ci fu un grande banchetto. Ero già preparato. Ricordo cosa è successo. Dopo aver parlato alla gente, dopo aver pregato per il papa precedente, sono uscito e c’era un ascensore pronto, tutto e per solo per me. Ma ho detto “Vado con gli altri”. E, quando sono uscito, c’era pronta una limousine. E ho detto ancora: “Vado in autobus assieme agli altri”. Fu allora che mi resi conto che era avvenuto un cambiamento delle cose mi aspettavano. Dopo il banchetto, ho chiamato il nunzio in Argentina e gli ho detto: “Dica che nessuno venga”, perché immaginavo che i vescovi volessero venire, e ho suggerito che i soldi per il biglietto fossero dati ai poveri. Poi ho chiamato Benedetto XVI per salutarlo. All’inizio non ha risposto, perché stava guardando la televisione, ma, quando sono riuscito a parlargli, ho notato che era contento. La mattina dopo non riuscivo a mettermi il colletto della talare, non so perché. Sono uscito e c’era il vescovo emerito di Palermo, e gli ho detto: “Aiutami”. “Sì, certo!”, mi ha risposto. Così pure quel giorno sono sceso a mangiare in sala da pranzo assieme a tutti gli altri. E lì iniziò la vita comune che continuo a condurre oggi. Non ho cambiato il mio stile di vita e questo mi ha aiutato. È stata un’intuizione del momento. Con questa naturalezza vivo le cose e le racconto».

Note su papa Francesco
Flavio Lazzarin
La profezia di Francesco non si rivela solamente in ciò che quotidianamente ci dice, ma emerge soprattutto nel fatto che il papa non smette di parlare. Evidentemente è cosciente di vivere in un’esposizione costante, che riserva ai suoi pronunciamenti l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, divisa tra assensi incondizionati, feroci dissensi o mute, maggioritarie, paludi indifferenti o opportuniste.
Decide di comportarsi secondo l’ispirazione della sua biografia, con le sue grandezze e i suoi limiti, e appare così agli occhi di molti come un originale e indisciplinato latino-americano.
Credo, però, che questa apparente disattenzione agli esiti delle sue frequenti esternazioni, al contrario, attacchi intenzionalmente e deliberatamente la fissità dogmatica e dottrinale delle teologie malate, che poco o niente riescono a dire agli uomini e alle donne di oggi, in questo tempo di crisi.
È frutto della Provvidenza dello Spirito la lotta di papa Francesco, che pare intendere i segni dei tempi e la crisi di un edificio millenario che ormai fa acqua da tutte le parti. E sceglie di affrontare la crisi della civilizzazione occidentale – e del cristianesimo con cui l’Occidente è tessuto – con la radicalità resa necessaria dalle tensioni teologiche e politiche che segnano questa stagione della storia.
Egli si comporta come se non fosse papa, come se non fosse un Capo di Stato, come se non esistesse la Curia. Con il suo comportamento si rifiuta di ripetere il copione secolare del pezzo fondamentale dell’ingranaggio istituzionale, sempre più distante dal Vangelo di Gesù.
Le cose, però non sono così semplici e la dialettica carisma-istituzione continua e continuerà ad accompagnare il cammino dei credenti.
È ovvio che i meccanismi ecclesiastici condizionano Francesco insieme ai nemici tradizionalisti che lo perseguitano. La contraddizione è inevitabilmente presente nella sua vita: non vive come un sovrano, ma, in contromano rispetto al cammino sinodale, è condotto a comportarsi come un sovrano monarchico, assoluto, solitario, indiscutibile. Il più delle volte vince la libertà carismatica, ma il peso dell’istituzione si fa sentire sempre, perché – che ci piaccia o no – è un aspetto ontologico costitutivo nella vita della Chiesa.
Avevamo, però, certamente bisogno, dopo la stagione di Giovanni XXIII e del Concilio, superata dalle successive restaurazioni, di una primavera carismatica. Ma, appunto, come per Francesco di Assisi, che ispira Giorgio Bergoglio, questa primavera del carisma, prima o poi si spegne, regolata dai canoni del diritto canonico e dalle reinterpretazioni moderate, ma sempre traditrici, degli stessi discepoli del carismatico, che, come il Santo di Assisi, vede tramontare e morire la profezia prima della sua stessa morte.
Può sfiorire la profezia, ma per chi legge la storia a partire dalla Croce, resta comunque la chiamata a comporre minoranze abramitiche, che, guidate dall’Agape, nonostante la loro piccolezza e irrilevanza, affrontano e vincono martirialmente gli inferni della storia.
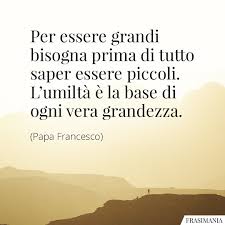
BIOGRAFIA
DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
Il primo Papa giunto dalle Americhe è il gesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, 76 anni, arcivescovo di Buenos Aires dal 1998. È una figura di spicco dell’intero continente e un pastore semplice e molto amato nella sua diocesi, che ha girato in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus.
«La mia gente è povera e io sono uno di loro», ha detto una volta per spiegare la scelta di abitare in un appartamento e di prepararsi la cena da solo. Ai suoi preti ha sempre raccomandato misericordia, coraggio e porte aperte. La cosa peggiore che possa accadere nella Chiesa, ha spiegato in alcune circostanze, «è quella che de Lubac chiama mondanità spirituale», che significa «mettere al centro se stessi». E quando cita la giustizia sociale, invita a riprendere in mano il catechismo, i dieci comandamenti e le beatitudini. Nonostante il carattere schivo è divenuto un punto di riferimento per le sue prese di posizione durante la crisi economica che ha sconvolto il Paese nel 2001.
Nella capitale argentina nasce il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti piemontesi: suo padre Mario fa il ragioniere, impiegato nelle ferrovie, mentre sua madre, Regina Sivori, si occupa della casa e dell’educazione dei cinque figli.
Diplomatosi come tecnico chimico, sceglie poi la strada del sacerdozio entrando nel seminario diocesano. L’11 marzo 1958 passa al noviziato della Compagnia di Gesù. Completa gli studi umanistici in Cile e nel 1963, tornato in Argentina, si laurea in filosofia al collegio San Giuseppe a San Miguel. Fra il 1964 e il 1965 è professore di letteratura e psicologia nel collegio dell’Immacolata di Santa Fé e nel 1966 insegna le stesse materie nel collegio del Salvatore a Buenos Aires. Dal 1967 al 1970 studia teologia laureandosi sempre al collegio San Giuseppe.
Il 13 dicembre 1969 è ordinato sacerdote dall’arcivescovo Ramón José Castellano. Prosegue quindi la preparazione tra il 1970 e il 1971 in Spagna, e il 22 aprile 1973 emette la professione perpetua nei gesuiti. Di nuovo in Argentina, è maestro di novizi a Villa Barilari a San Miguel, professore presso la facoltà di teologia, consultore della provincia della Compagnia di Gesù e rettore del Collegio.
Il 31 luglio 1973 viene nominato provinciale dei gesuiti dell’Argentina. Sei anni dopo riprende il lavoro nel campo universitario e, tra il 1980 e il 1986, è di nuovo rettore del collegio di San Giuseppe, oltre che parroco ancora a San Miguel. Nel marzo 1986 va in Germania per ultimare la tesi dottorale; quindi i superiori lo inviano nel collegio del Salvatore a Buenos Aires e poi nella chiesa della Compagnia nella città di Cordoba, come direttore spirituale e confessore.
È il cardinale Quarracino a volerlo come suo stretto collaboratore a Buenos Aires. Così il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno riceve nella cattedrale l’ordinazione episcopale proprio dal cardinale. Come motto sceglie Miserando atque eligendo e nello stemma inserisce il cristogramma ihs, simbolo della Compagnia di Gesù. È subito nominato vicario episcopale della zona Flores e il 21 dicembre 1993 diviene vicario generale. Nessuna sorpresa dunque quando, il 3 giugno 1997, è promosso arcivescovo coadiutore di Buenos Aires. Passati neppure nove mesi, alla morte del cardinale Quarracino gli succede, il 28 febbraio 1998, come arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale residenti nel Paese, gran cancelliere dell’Università Cattolica.
Nel Concistoro del 21 febbraio 2001, Giovanni Paolo II lo crea cardinale, del titolo di san Roberto Bellarmino. Nell’ottobre 2001 è nominato relatore generale aggiunto alla decima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, dedicata al ministero episcopale. Intanto in America latina la sua figura diventa sempre più popolare. Nel 2002 declina la nomina a presidente della Conferenza episcopale argentina, ma tre anni dopo viene eletto e poi riconfermato per un altro triennio nel 2008. Intanto, nell’aprile 2005, partecipa al conclave in cui è eletto Benedetto XVI.
Come arcivescovo di Buenos Aires — tre milioni di abitanti — pensa a un progetto missionario incentrato sulla comunione e sull’evangelizzazione. Quattro gli obiettivi principali: comunità aperte e fraterne; protagonismo di un laicato consapevole; evangelizzazione rivolta a ogni abitante della città; assistenza ai poveri e ai malati. Invita preti e laici a lavorare insieme. Nel settembre 2009 lancia a livello nazionale la campagna di solidarietà per il bicentenario dell’indipendenza del Paese: duecento opere di carità da realizzare entro il 2016. E, in chiave continentale, nutre forti speranze sull’onda del messaggio della Conferenza di Aparecida nel 2007, fino a definirlo «l’Evangelii nuntiandi dell’America Latina».
Viene eletto Sommo Pontefice il 13 marzo 2013.
La parola chiave del lettore:
Siete occhi che guardano e che sognano!
Continuate a sognare, a inquietarvi, a immaginare parole e visioni che ci aiutino a leggere il mistero della vita umana e orientino le nostre società verso la bellezza e la fraternità universale.
Aiutateci ad aprire la nostra immaginazione perché essa superi gli angusti confini dell’io, e si apra alla realtà tutta intera, nella pluralità delle sue sfaccettature: così sarà disponibile ad aprirsi anche al mistero santo di Dio. Andate avanti, senza stancarvi, con creatività e coraggio!
Papa Francesco